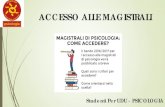Centonze prog sos c
-
Upload
iva-zigghyova-martini -
Category
Health & Medicine
-
view
396 -
download
4
description
Transcript of Centonze prog sos c

SCUOLA INTERATENEO DI SPECIALIZZAZIONE
PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA
SIS ________________________________________________________________________________
CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE
PER IL SOSTEGNO ALL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALLIEVI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
A.A. 2008/2009
Multimedialità e Apprendimento
SPECIALIZZANDO: Liberato CENTONZE
SUPERVISORE: prof.ssa Lorenza CARELLI

Multimedialità e Apprendimento
2
INDICE GENERALE
1 FASCICOLO DEI PROCESSI E DEI PRODOTTI...................................................................3
1.1 Mappa Concettuale .......................................................................................................3
1.2 Diario di bordo...............................................................................................................4
1.3 Indice ragionato ............................................................................................................7
1.3.1 Sezione A: La Tecnologia dell’Educazione...........................................................7
1.3.2 Sezione B: La Patologia..........................................................................................9
1.3.3 Sezione C: Integrazione scolastica e programmazione Individualizzata ......10
1.4 Modello teorico di riferimento e collegamento all’attività progettata .................12
1.4.1 Cornice storica sulla tecnologia dell’educazione...............................................12
1.4.2 Multimedialità e comunicazione didattica..........................................................17
1.4.3 Le immagini nella didattica per alunni con disabilità.......................................21
1.4.4 Alcuni suggerimenti per utilizzare MS PowerPoint ...........................................23
1.4.5 Le patologie ...........................................................................................................24
1.5 Dossier di documentazione........................................................................................29
1.5.1 Intervento didattico ..............................................................................................29
1.5.2 Schede bibliografiche e sitografiche ..................................................................42

Multimedialità e Apprendimento
3
1 FASCICOLO DEI PROCESSI E DEI PRODOTTI
1.1 Mappa Concettuale
Tirocinio Attivo
Secondaria II Grado
presso
Disturbo generalizzato dello sviluppo
patologia
Ritardo mentale medio
Limitazioni Cognitive
• Dislessia • Disgrafia • Discalculia
associato
Comporta gravi
indirizzo
Comunicazione Digitale e multimedialità
Informatica
Sperimentazione autonoma
Canali input integri
Didattica Multimediale
richiedono supporta
utilizza
Apprendimento Costruttivista
MS PowerPoint 2007
Strumento software
Ambiente Favorevole
considerato
Feuerstein
In accordo
Teoria della Modificabilità Cognitiva
• Visivo • Uditivo
Personal Computer
Attraverso uso
Compensatore di attenzione
ruolo promuove
• Soggetto attivo • Riflessivo • Interattivo • Affettivo • Realistico • Cooperativo
Autonomia
Sintesi Vocale
per acquisire
attraverso

Multimedialità e Apprendimento
4
1.2 Diario di bordo
Settembre - Ottobre 2008: Maturo la decisione di inscrivermi al corso SIS.
Prima di frequentare il corso SIS, e la conseguente attività di tirocinio, non avevo maturato
un’esperienza come insegnante di sostegno. Mentre, come insegnante curricolare, ho avuto
nelle mie classi alunni portatori di handicap. L’incapacità di affrontare la loro integrazione
nella classe, di rendere il loro apprendimento significativo, di predisporre percorsi educativi e
didattici appropriati alle differenze individuali, mi ha spinto ad intraprendere questo percorso
formativo, convinto che le diversità, intese anche come azione didattica, costituiscano una
ricchezza per tutti gli allievi, per trovare la giusta modalità, lo stile di apprendimento, che può
anche non rientrare in quelle azioni didattiche ritenute normali.
Dicembre 2008: Primo incontro con il supervisore di tirocinio
L’11 dicembre 2008 è stato il primo giorno di frequenza al corso SIS in cui i diversi supervisori
di tirocinio hanno illustrato le modalità di svolgimento del corso, l’orario previsto per le
lezioni, e la suddivisione in gruppi per i diversi laboratori. Questo è stato anche il giorno in cui
con il supervisore, la prof.ssa Lorenza CARELLI, abbiamo discusso più nel dettaglio l’attività
di tirocinio, le modalità di svolgimento, i tempi, e l’ordine e grado delle scuole coinvolte.
In tale occasione ho potuto esprimere le mie preferenze per la scelta degli Istituti, pertanto ho
avuto la possibilità di svolgere l’attività di tirocinio attivo con un docente che conoscevo già,
che stimo molto, con cui condivido le metodologie didattiche a carattere multimediale, per cui
maturavo l’idea che la tematica da trattare nel portfolio avrebbe avuto una dimensione
tecnologica.
Gennaio – Febbraio 2009: Frequenza ai corsi e laboratori
In questo periodo ho maturato nuove conoscenze, ho acquisito nuove terminologie relative
all’handicap, ho sviluppato nuove competenze nei diversi laboratori per affrontare l’azione
didattica in presenza di allievi con bisogni educativi speciali. È stato il momento per
comprendere le patologie, per conoscere i processi mentali che sottostanno all’apprendimento,
e come questi siano compromessi a causa di menomazioni fisiche, e di conseguenza come
orientare l’attività didattica permettendo al disabile di superare o ridurre la condizione di
svantaggio.
Durante questo cammino fondamentale è stata la lezione del prof. Martinelli in cui si affermava
che l’intelligenza umana è plastica, cioè modificabile, per tutti gli individui, anche in situazione
di handicap, a patto di trovare i giusti ambienti favorevoli all’apprendimento. Convinto del
fatto che la tecnologia costituisca un’opportunità nel processo di integrazione scolastica degli
allievi disabili, ma per essere colta necessita di maggiori conoscenze e capacità progettuali, ho
pensato che uno strumento potente come il computer potesse aiutare a creare la giusta
situazione favorevole all’apprendimento; è stata questa l’occasione per analizzare i corsi
seguiti, e le lezioni in programma nell’ottica di ricercare nel computer, e in tutte le attività

Multimedialità e Apprendimento
5
didattiche connesse, gli spunti e i suggerimenti per attuare in modo più efficace ed efficiente gli
insegnamenti ricevuti.
Marzo 2009: Incontro con docente accogliente scuola secondaria II grado
Nei primi giorni di marzo è avvenuto il primo incontro con il docente accogliente presso la
scuola secondaria di II grado, che già conoscevo, con cui ho subito istaurato un rapporto
costruttivo e propositivo all’attività di tirocinio che mi accingevo a svolgere. Durante questo
incontro, il docente accogliente mi ha illustrato l’allievo che segue maggiormente, fornendomi
una descrizione analitica molto accurata, indicandomi le strategie didattiche adottate che mi
hanno subito “suggerito” come tema del portfolio la didattica multimediale, visto che di fatto è
la strategia di insegnamento/apprendimento maggiormente utilizza. Inoltre l’Istituto già dispone
della strumentazione adeguata allo svolgimento di questa attività in quanto, nell’indirizzo di
Informatica, si è scelto di svolgere una sperimentazione autonoma in Comunicazione Digitale e
Multimedialità.
Marzo 2009: Individuazione del titolo e ricerca delle informazioni e materiale per il portfolio
A fronte dell’incontro con il docente accogliente, e alla conseguente scelta della tematica da
trattare nel portfolio, che riguarda l’apprendimento in un contesto multimediale, è seguita la
visita al Centro multimediale di documentazione pedagogica della Città di Torino. Durante la
visita ho avuto modo di consultare l’archivio informatico per ricercare i materiali e i libri che
potessero aiutarmi nella progettazione dell’intervento didattico e nella stesura del portfolio.
Molti altri spunti e suggerimenti sono stati tratti dalla Rete che si configura oggi, attraverso i
motori di ricerca, un ottimo strumento per ricercare autori che hanno affrontato in passato
l’argomento. In particolare, la ricerca si è focalizzata sulla stesura di presentazioni
multimediali, capaci di esaltare l’accesso multicanale delle informazioni, attraverso i canali di
input visivo ed uditivo, che per l’allievo seguito costituiscono un mezzo di comunicazione
integro.
Marzo - Aprile 2009: Attività di tirocinio presso la scuola secondaria II grado
L’attività di tirocinio attivo è stato il momento più intenso e significativo del percorso di studio
affrontato, sia per le emozioni suscitate sia per la difficoltà che comportava. Il primo scoglio da
superare è stato l’instaurazione di una relazione aperta, rivolta alla conoscenza reciproca,
particolarmente impegnativa in quanto l’allievo presenta una ridotta capacità
affettivo/relazionale. In questa occasione il mio ruolo si è limitato all’osservazione dell’allievo
e del gruppo classe, per acquisire la giusta modalità di comportamento e per muovere i primi
passi in una realtà poco conosciuta. È stato fondamentale l’apporto del docente accogliente che
ha saputo organizzare al meglio il mio inserimento in classe, aprendo l’allievo alla mia
presenza, incoraggiandolo all’idea di costruire insieme un percorso didattico finalizzato alla
valutazione orale nella materia di Sistemi. Conquistata la fiducia dell’allievo, abbiamo deciso

Multimedialità e Apprendimento
6
col docente accogliente di preparare durante le ore di laboratorio delle slide in MS PowerPoint,
per affrontare lo studio delle reti di calcolatori, ed in particolare il funzionamento dei
dispositivi di interconnessione. Pertanto i momenti salienti del tirocinio attivo sono stati quelli
in cui con l’allievo abbiamo “costruito” una rete di calcolatori, attraverso uno strumento
software, ed attraverso le animazioni grafiche ne abbiamo spiegato il comportamento,
corredando il tutto con descrizioni sonore. Tuttavia, il momento che mi ha particolarmente
colpito è stata la fase di valutazione in cui io e l’allievo eravamo ormai complici, avevamo
studio e ripassato profondamente il materiale sviluppato, ed eravamo pronti ad affrontare
l’interrogazione orale. È stata un’intensa gioia vedere l’allievo, davanti a tutto il gruppo classe,
rispondere in modo preciso e puntuale alle domande poste con una grande approvazione del
docente curricolare.
Maggio 2009: Stesura finale portfolio
Devo innanzitutto dare merito al lavoro del docente accogliente, che non solo mi ha guidato
nella realizzazione dell’intervento didattico, ma ha saputo realizzare continuità orizzontale e
una profonda sinergia grazie alle capacità relazionali, alla intelligente professionalità ed alla
generosità di cui solo poche persone dispongono.
Preziosi sono stati anche i suggerimenti finali del supervisore per la stesura del portfolio, per la
rielaborazione di tutti i materiali reperiti e prodotti, e gli spunti offerti per migliorare il lavoro.
La stesura del portfolio è stata importante per riflettere su tutto il percorso formativo svolto, per
trovare una sintesi a tutti gli insegnamenti ricevuti, sviluppare le idee che giorno dopo giorno
ho maturato, valorizzare l’esperienze fatte e rafforzare le conoscenze acquisite, cogliendo
l’occasione di estenderle attraverso i testi consultati per approfondire la tematica scelta.

Multimedialità e Apprendimento
7
1.3 Indice ragionato
Per la stesura del portfolio sono stati consultati diversi testi, i quali sono suddivisi in tre sezioni:
la prima riguarda i temi relativa alla Tecnologia dell’Educazione, all’Apprendimento
Multimediale, per ricavarne il quadro teorico di riferimento; la seconda riguarda aspetti più
specifici della patologia, l’approccio terapeutico e/o riabilitativo seguito; la terza e l’ultima
riguarda il problema dell’integrazione scolastica degli allievi disabili sul piano socio-
pedagogico e normativo.
1.3.1 Sezione A: La Tecnologia dell’Educazione
A1: Antonio Calvani, “Che cos’è la tecnologia dell’educazione”, Carrocci Editore, Roma 2004
Il testo è stato consultato per sviluppare la cornice storica sui modelli teorici di riferimento che
si sono succeduti lungo lo sviluppo della Educational Technology, in particolare si è analizzato
il comportamentismo, il cognitivismo, per giungere al costruttivismo.
Con l’obiettivo di far emergere i tratti essenziali della tecnologia dell’educazione il volume si
articola in diversi capitoli. Inizialmente è presentato un breve quadro di come gli addetti ai
lavori considerano la tecnologia dell’educazione e una sintesi storica dei riferimenti culturali di
maggior rilievo che hanno condizionato il suo sviluppo. Successivamente il volume si sofferma
sui temi caratteristici dell’area, quali l’Instructional Design, l’E-learning, il Collaborative
Learning, la comunità di pratica, e su alcuni tratti tipici del modo di operare dell’esperto di
tecnologia dell’educazione.
A2: Antonio Calvani, “Educazione, comunicazione e nuovi media. Sfide pedagogiche e
cyberspazio” , UTET Università, Torino 2001
Il libro è stato consultato per approfondire il tema della Media Education, analizzando le
relazioni soggetto-media e le loro implicazioni formative, nonché il ruolo dell’insegnante di
fronte alle nuove tecnologie in ambienti di apprendimento mutevoli e flessibili.
Il volume offre una introduzione, rivolta ad educatori e studenti, nei riguardi dell’area che si
viene generando dall’incontro tra educazione, media e tecnologia. Il volume è articolato in
quattro parti: nella prima si presentano i concetti e le definizioni preliminari; nella seconda si
rivolge l’attenzione alle modalità d’incontro tra educazione e media; nella terza si presenta un
quadro storico dello sviluppo della Education Technology, dei suoi principali riferimenti
teorici; nella quarta si tratta dei recenti sviluppi di Internet e delle sue implicazioni nell’ambito
della formazione e sperimentazione didattica.
A3: Ezio Roletto, “Apprendimento delle scienze e didattiche disciplinari”, IRIDIS, Torino
2002

Multimedialità e Apprendimento
8
Il libro tratta ampiamente il problema dell’apprendimento delle discipline scientifiche, dei
conseguenti metodi di insegnamento descrivendo i vari modelli teorici di riferimento
evidenziandone pregi e difetti. Ampio spazio è riservato al modello di apprendimento
“didattico”, fornendone i fondamenti epistemologici e psicologici e delineando il ruolo
dell’insegnante. Il libro è stato consultato per il approfondire le tematiche relative al
costruttivismo e le sue implicazioni al processo di insegnamento/apprendimento.
A4: Mammarella, Cornoldi, Pazzaglia, “Psicologia dell’apprendimento multimediale”, Il
Mulino, 2004
Il libro è stato consultato per illustrare il modello costruttivista di Meyer (SOI Model of
Learning) e l’apprendimento multimediale in generale. Infatti, in questo volume si analizzano
le componenti cognitive, metacognitive ed emotivo-motivazionali, dell’apprendimento
multimediale, proponendo un modello teorico comprensivo delle diverse variabili e delle loro
relazioni. È analizzato il ruolo svolto da attenzione, memoria, motivazione ed emozioni
nell’apprendimento multimediale e fino a che punto queste variabili possono facilitarlo o
impedirlo.
Gli autori forniscono una chiave di lettura dell’apprendimento multimediale centrata sulle
conoscenze, competenze e atteggiamenti del soggetto che apprende.
A5: Laura Fiorini, Massimo Greco, “Proposte didattiche con Powerpoint”, Editrice La Scuola,
Brescia, 2005
Il libro è stato consultato per trarre spunto dall’esperienze professionali degli autori nell’uso di
PowerPoint, per mettere in pratica alcuni indirizzi di ricerca nel campo della psicologia circa i
processi cognitivi e l’apprendimento, come il costruttivismo, ritenendo fondamentale la
costruzione attiva della conoscenza.

Multimedialità e Apprendimento
9
1.3.2 Sezione B: La Patologia
B1: Maria Bruna Fagiani, “Lineamenti di psicopatologia dell’età evolutiva”, Carrocci Editore,
Roma 2002
Il libro è stato utilizzato per inquadrare le patologie di riferimento (Disturbi generalizzati dello
sviluppo), e associati (Ritardo Mentale) e i conseguenti disturbi specifici di apprendimento.
L’autore del testo è la prof.ssa Fagiani di Neuropsichiatria Infantile e Psicopatologia dell’Età
Evolutiva, ed è rivolto principalmente a chi opera nel settore dell’età evolutiva come educatori
ed insegnanti e si configura come uno strumento facilmente utilizzabile anche da chi non abbia
ampie nozioni nel campo medico in generale e nel campo psichiatrico in particolare. Ampio
spazio è stato dato alle patologie tipiche dell’infanzia, nonché ai problemi derivanti da
situazioni ambientali patogene o “difficili” che si traducono in un disagio e in problemi di
adattamento con conseguenti riflessi sul comportamento dei minori che vi si trovano coinvolti.
B2: Maria Rosa Pizzamiglio, “La riabilitazione neuropsicologica in età evolutiva”, Franco
Angeli 2003
Il testo è stato consultato per approfondire il tema della riabilitazione neuropsicologica in età
evolutiva in quanto consente di far emergere da una situazione di difficoltà e sofferenza reali
possibilità di interazione e comunicazione con l’ambiente. La Terza Parte del testo tratta nello
specifico i disturbi generalizzati dello sviluppo e le tecniche di trattamento.
Nel volume si evidenzia come attraverso lo studio delle teorie dei processi cognitivi sia
possibile creare degli strumenti riabilitativi che facilitino lo sviluppo di abilità importanti e
fondamentali, quali il linguaggio, l’attenzione, la cognizione spazio-temporale e la memoria.
Inoltre, è presentato il complesso compito del riabilitatore il quale richiede oltre alla capacità di
modulare progressivamente la terapia neuropsicologica, anche il ruolo di coordinare le figure
significative che interagiscono con il bambino, la famiglia e la scuola.

Multimedialità e Apprendimento
10
1.3.3 Sezione C: Integrazione scolastica e programmazione Individualizzata
C1: Mario Martinelli, “L'handicap in classe. Tra individualizzazione e programmazione”,
Brescia, La Scuola 1998
L’autore del testo è il prof. Martinelli, docente di Didattica Speciale, con il quale abbiamo
affrontato un percorso di studi rivolto ad ampliare le conoscenze teorico-pratiche acquisite nei
precedenti corsi SIS. L’argomento principale del libro è l’integrazione delle diversità nella
scuola dell’autonomia, ed i temi e problemi ad essa connessi, al fine di acquisire conoscenze,
competenze, comportamenti, metodi e strumenti di lavoro per affrontare la pratica
dell’insegnamento in situazioni caratterizzate da bisogni educativi speciali. Il testo è
organizzato in una prima parte introduttiva, una seconda dedicata alla continuità orizzontale e
verticale ed all’accoglienza, in cui vengono descritti gli organi e gli enti utili alla formazione
della comunità di sostegno ai fini dell’integrazione. L’ultima parte presenta due esperienze
differenti.
C2: Marisa Pavone, “Personalizzare l’integrazione”, Brescia, La Scuola 2004
L’autrice del testo è la prof.ssa Pavone, docente di Pedagogia Speciale, con cui abbiamo
ampiamente trattato il problema l’integrazione scolastica degli studenti disabili. Il volume mi è
servito per approfondire il concetto di educabilità, riabilitazione e il ruolo che la scuola deve
svolgere per la riduzione del deficit e superare l’handicap.
Il libro si propone di evidenziare una rinnovata spinta di qualità al cammino dell’inclusione,
attraverso alcuni dispositivi: i piani di studio personalizzati; la differenziazione e la flessibilità
sul piano didattico, metodologico, organizzativo; l’integrazione tra i segmenti scolastici, con le
famiglie e con le istituzioni dell’extrascuola.
Il testo si sviluppa in tre parti. Nella prima viene analizzato il concetto di persona, la
prospettiva evolutiva e il nuovo strumento di classificazione delle condizioni di salute e
disabilità da cui scaturiscono nuove indicazioni per la formulazione delle diagnosi e per la
progettazione educativa. Nella seconda parte si prende in esame il funzionamento della scuola-
comunità di apprendimento impegnata ad accogliere, conoscere ed accompagnare ogni
studente. L'ultima parte guarda alla prospettiva del futuro, illustrando le caratteristiche di un
progetto educativo personalizzato che si orienta nell’ottica del progetto di vita.
C3: AA.VV., “Handicap e Scuola: l’integrazione possibile.”, Editore Gruppo Solidarietà, 1998
Il libro è stato indicato durante il laboratorio di Progettazione Individualizzata della prof.ssa
Tomasini, in cui ho maturato maggiori competenze nell’analisi della Diagnosi Funzionale, al
fine di redigere in modo consapevole, insieme ai soggetti coinvolti, il Profilo Dinamico
Funzionale e il Piano Educativo Individualizzato. Per approfondire gli argomenti sopra citati è
stato fondamentale il cap. 4 Dario Janes, “Diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale e

Multimedialità e Apprendimento
11
piano educativo: saper leggere le risorse di scuola, sanità e famiglia”. Tuttavia il volume è stato
consultato per fare il punto sullo stato dell’integrazione scolastica degli handicappati dopo le
prime normative e la sentenza della Corte Costituzionale analizzando, in particolare, i problemi
che vengono posti all’integrazione dalle situazioni di gravità verificando quali condizioni
permettono di realizzare un ambiente disponibile all’accoglienza.
C4: Salvatore Nocera, “Il diritto all’integrazione nella scuola dell’autonomia”, Erickson,
Trento, 2001
Il testo è stato utilizzato durante il corso di Pedagogia Generale, tenuto dalla prof.ssa Ferrero,
per una lettura pedagogia della normativa vigente sull’integrazione scolastica. Particolare
attenzione ho rivolto alla lettura della legge-quadro 104/92, che rappresenta la normativa di
riferimento per l’handicap, e nello specifico gli articoli riguardanti l’integrazione scolastica.
Il volume è suddiviso in aree tematiche. La prima parte dell’opera ripercorre criticamente il
cammino seguito dalla normativa sull’integrazione nella scuola italiana, dalle origini sino a
oggi. La seconda analizza le prospettive dell’integrazione scolastica alla luce delle profonde
innovazioni normative degli ultimi anni tra cui l’autonomia. La terza parte del lavoro si
focalizza sugli strumenti operativi che possono fare da supporto all’integrazione. Infine,
l’ultima parte, redatta da Andrea Canevaro, si compone di due interviste ad altrettante figure
chiave dell’integrazione scolastica del nostro Paese.

Multimedialità e Apprendimento
12
1.4 Modello teorico di riferimento e collegamento all’attività progettata
1.4.1 Cornice storica sulla tecnologia dell’educazione
Come ogni disciplina anche la “tecnologia dell’educazione”, cioè il settore disciplinare che
propone, sviluppa, analizza ed usa modelli teorici desunti dalle teorie dell’apprendimento e dai
sistemi ICT (Information and Comunication Technologies) per realizzare innovazione didattica,
si avvale dei propri riferimenti, si correda di particolari metodologie e strumentazioni, di
specifici ambiti mentali e professionali. L’insieme di questi apparati teorici si sedimentano
attraverso un processo che risente anche di mutamenti nei sistemi culturali di riferimento, di
cambiamenti di paradigma che alimentano nuovi modi di pensare da cui discendono nuovi
modi di pensare e ulteriori strumenti concettuali.
La tecnologia dell’educazione1 si sviluppa nel contesto statunitense a partire dagli anni
cinquanta del secolo scorso, sotto la spinta del comportamentismo di Skinner che proponeva di
estendere gli studi sperimentali sul comportamento condizionato degli animali anche ai
processi di apprendimento degli esseri umani. Presupposto del comportamentismo è che si può
solo studiare il comportamento esterno e che nulla dunque si può dire su quanto accade
all’interno dell’individuo, in quanto scatola nera chiamata mente, quindi non ci si interessa alle
strutture e ai processi interni, ma è più realistico interessarsi delle entrate (input) e uscite
(output), e di comportamenti osservabili attesi come risultato dell’apprendimento.
Nacquero così molti studi sull’istruzione programmata e sull’utilizzazione di macchine per
l’apprendimento. Secondo il comportamentismo, le conoscenze e le abilità di un individuo si
possono ridurre all’insieme delle risposte date da quell’individuo all’insieme complesso degli
stimoli che il suo ambiente gli offre. L’apprendimento umano, quindi, si può ridurre
all’induzione di comportamenti desiderati, attraverso un rinforzo positivo. Il processo di
apprendimento è concepito in modo cumulativo, senza rotture né ricostruzioni, ciò implica che
è necessario suddividere i saperi complessi in elementi costitutivi più semplici. Nella sua forma
più tipica l’allestimento di un programma di istruzione programmata avviene attraverso un
processo del tipo:
• si isola il concetto che si vuole fare apprendere;
• si analizza e/o scompone il suo contenuto elencando tutti i singoli concetti che entrano
in gioco;
• si analizza nuovamente il contenuto di ogni concetto e in modo ricorsivo si giunge agli
atomi della materia da insegnare, a un livello che si presuppone comprensibile
dall’allievo.
A questa concezione dell’apprendimento si richiamano le pedagogie per obiettivi,
l’apprendimento gerarchico, il CAL (Computer Assisted Learning) in cui si cercò di
1 Antonio Calvani, “Che cos’è la tecnologia dell’educazione”, Carrocci Editore, Roma 2004

Multimedialità e Apprendimento
13
razionalizzare il lavoro degli insegnanti, fornendo un approccio “scientifico-razionale”
all’educazione, e formulando adeguate teorie dell’istruzione sottoponendole ai controlli propri
del metodo scientifico. In questo contesto gli apprendimenti non sono cose mentali, ma
comportamenti che possono essere prodotti, previsti, osservati e misurati. Quindi, per valutare
in modo adeguato si deve predisporre di un modello gerarchico degli apprendimenti, nel quale
ogni obiettivo di un determinato livello ingloba gli obiettivi di rango inferiore. Il tentativo più
radicale e sistemico di attenersi alle metodologie proposte è rappresentato dal mastery learning,
traducibile come “apprendimento per la maestria o della padronanza”, che è un modello di
azione didattica che mira ad un apprendimento efficace per il più alto numero di allievi. E’ una
modalità di organizzazione didattica molto attenta alle diversità individuali nei ritmi e nei tempi
di apprendimento che prevede la definizione operativa degli obiettivi, il frazionamento del
contenuto in unità significative, l’elaborazione di prove in grado di verificare il raggiungimento
o meno degli obiettivi delle unità didattiche individuate, la strutturazione di attività integrative
e di recupero da proporre a quegli allievi che non avessero raggiunto ancora livelli adeguati ed
infine il controllo che gli allievi non affrontino l’unità successiva se non hanno conquistato il
minimo indispensabile di dominio delle conoscenze e competenze previste dalle unità
precedenti.
Il modello di apprendimento proposto fu criticato per evidenti limiti. In primo luogo risulta
restringente legare le capacità a comportamenti osservabili, e in secondo l’attività intellettuale
risulta frammentata, a causa dell’esigenza di formulare gli obiettivi in modo gerarchico,
sminuzzando i compiti, ed infine appare inadeguata la convinzione secondo la quale per far
progredire l’allievo da un livello di conoscenza ad un altro superiore sia sufficiente organizzare
un certo numero di tappe intermedie, ognuna delle quali presenti una piccola difficoltà che
l’allievo è in grado superare.
Alla fine degli anni cinquanta viene alla luce, in reazione al comportamentismo e all’insegna
del concetto che anche la mente può essere oggetto di studio, una nuova componente culturale
che condizionerà profondamente la storia della tecnologia dell’educazione: la rivoluzione
cognitivista. I psicologi cognitivisti criticarono questo approccio di Skinner e ritennero che non
si debba puntare l’attenzione solo al comportamento, ma anche ai processi interni, agli stati
mentali, che permettono ad un soggetto di compiere determinate azioni. Quindi nella
progettazione di ambienti di apprendimento non si deve puntare solo al raggiungimento di
determinati obiettivi didattici, ma si deve tener conto soprattutto del loro aspetto qualitativo,
della loro flessibilità e trasferibilità in altri contesti.
Negli anni sessanta prende sempre più piede la metafora dell’essere umano come elaboratore di
informazioni e si pensa che il cervello possa essere un servomeccanismo di tipo cibernetico.
Uno degli apporti più significativi del cognitivismo alla didattica riguarda l’importanza delle
preconoscenze nel processo di apprendimento, una dimensione a cui ha rivolto molta attenzione
Ausubel2: “Se dovessi considerare in un unico principio la psicologia dell’educazione direi che
il fattore più importante che influenza l’apprendimento sono le conoscenze che lo studente già
possiede”. Mentre per i sostenitori del mastery learning, dalle conoscenze pregresse dipende
2 Ezio Roletto, “Apprendimento delle scienze e didattiche disciplinari”, IRIDIS, Torino 2002

Multimedialità e Apprendimento
14
cosa un soggetto può apprendere, per Ausubel le conoscenze pregresse hanno influenza sul
come si apprendono, il che porta a distinguere due tipi di apprendimento: mnemonico e
significativo. Quest’ultimo si produce quando i nuovi saperi che il soggetto deve acquisire
possono essere integrati in un struttura cognitiva già esistente che funziona come punti di
attracco e ne facilita l’acquisizione e, quindi, la memorizzazione. L’apprendimento scaturisce
dal mettere in relazione elementi che sopraggiungono dall’esterno con preconoscenze già
possedute dal soggetto. Al concetto di preconoscenza si aggiunge la nozione di advance
organizer (anticipatore), intendendo con questo termine ogni strumento informativo che
funziona come ponte cognitivo in quanto si lega alle conoscenze che il soggetto già possiede,
dando così origine ad una nuova struttura in grado di incorporare i nuovi saperi, oggetto di
apprendimento. Un altro concetto basilare nella riflessione del cognitivismo è quello di
metacognizione, cioè il meccanismo di controllo che permette alla nostra mente di decidere le
strategie migliori in un’attività di apprendimento.
Dal cognitivismo si sviluppa l’intelligenza artificiale che si propone di realizzare uno dei sogni
più ambiziosi cui l’uomo abbia mai aspirato, quello di dar vita a una macchina capace di attuare
comportamenti “intelligenti” tali che osservatori esterni non possano distinguerli da
comportamenti umani.
Sia l’approccio comportamentista sia quello cognitivista, che hanno dominato negli anni
settanta, hanno sottolineato l’importanza di una strutturazione ordinata, lineare, razionale del
percorso di apprendimento, con un consapevole perseguimento di obiettivi definiti da un
attento controllo del processo gestito tramite rinforzi e feedback, lasciando il minor spazio
possibile a fenomeni casuali, e senza mai evocare l’importanza del contenuto, ossia l’oggetto
del sapere, e del contesto, ossia delle condizioni in cui l’apprendimento si realizza. Tuttavia, le
molte ricerche condotte sulle concezioni difformi degli allievi mettono in evidenza che gli
ostacoli che si oppongono all’apprendimento sono molteplici e di varia natura, specifici di ogni
contenuto e contesto. Il modello di insegnante che si afferma è quello di detentore di un sapere
che deve essere comunicato all’allievo.
Nel corso degli anni ottanta diventano sempre più forti i segni di insoddisfazione verso modelli
gerarchico-sequenziali, e più in generale verso il paradigma di taglio oggettivistico e
razionalistico basato sulla fiduciosa premessa che all’educazione possono essere trasferiti i
metodi della ricerca scientifica. In primo luogo in un suggestivo lavoro di Winograd e Flores3 si
mette in discussione le aspettative relativa all’intelligenza artificiale, per cui l’equazione
calcolatore-cervello appartiene a una tradizione razionalistica abbandonata, si tratta piuttosto di
progettare macchine capaci di ampliare le potenzialità umane sul piano della comunicazione e
collaborazione. Si sottolinea così la centralità della tecnologia come ambiente per la
costruzione della conoscenza. Da queste idee deriva un’area di sviluppo tecnologico conosciuta
come CSCW (Computer Supported Collaborative Work), che consiste in software usato da
gruppi anziché da singoli individui con lo scopo di favorire lavoro collaborativo e forme di
creazione collaborativa di conoscenza. Sono anni in cui l’idea che la conoscenza scientifica sia
una rappresentazione oggettiva, misurabile e che si sviluppi in forma lineare e progressiva
3 Winograd T., Flores F., Calcolatori e conoscenza. Un nuovo approccio alla progettazione delle tecnologie dell'informazione, Milano, Mondadori, 1987

Multimedialità e Apprendimento
15
viene sempre più messa in discussione e si sottolinea il suo carattere di costruzione negoziata e
multidimensionale.
Nei primi anni novanta gradualmente un nuovo quadro teorico si fa luce, il termine con cui si
contrassegna la svolta, rispetto ai tradizionali modelli della conoscenza, è il “costruttivismo”, in
cui un ruolo importante in questo passaggio lo ha Bruner che ha lamentato il particolare
carattere assunto dal cognitivismo nel cui sviluppo ha prevalso l’”elaborazione
dell’informazione” rispetto alla “ricerca del significato”4.
I concetti principali che caratterizzano il costruttivismo sono tre: la conoscenza è il prodotto di
una costruzione attiva del soggetto, è ancorata ad un contesto, e si svolge attraverso forme
particolari di collaborazione e negoziazione sociale.5
Al centro viene posta la “costruzione del significato”, processo attivo, non predeterminabile, e
quindi l’attenzione del progettista di formazione si sposta dall’organizzazione sequenziale degli
interventi didattici, al concetto di “ambiente di apprendimento”. Un ambiente di apprendimento
è uno spazio reale e/o virtuale in cui coloro che apprendono possono lavorare aiutandosi
reciprocamente avvalendosi di una varietà di risorse e strumenti informativi in attività di
apprendimento guidato o di problem solving; intorno ad ogni soggetto va dunque allestito un
variegato repertorio di risorse di apprendimento, tecniche organizzative ed interpersonali, in
modo che questi possano trovare un clima congeniale e gli appigli più idonei per procedere
nella forma ottimale. Sintetizzando le implicazioni educative che discendono da un filosofia
costruttivista, gli ambienti di apprendimento dovrebbero:
• presentare compiti autentici piuttosto che astrarre;
• offrire molteplici rappresentazione della realtà;
• Evitare semplificazioni rappresentando la naturale complessità del mondo reale;
• Porre l’attenzione sulla costruzione della conoscenza e non sulla sua trasmissione e
riproduzione;
• Offrire occasioni di apprendimento desunte dal mondo reale, basate su casi, piuttosto
che su sequenze istruttive predeterminate;
• Alimentare pratiche riflessive;
• Permettere costruzioni di conoscenze dipendenti dal contesto e dal contenuto;
• Favorire la costruzione cooperativa della conoscenza attraverso la negoziazione sociale.
Il costruttivismo si configura, oggi, come un complesso e variegato arcipelago teorico
composto da psicologi, epistemologi, informatici, scienziati cognitivi, pedagogisti, ricercatori
didattici.
Diversi sono i filoni teorici che si identificano in questo approccio (costruttivismo radicale,
interazionista, sociale, situazionista, socio-culturale) ma tutti condividono l’affermazione che
“l’istruzione non è causa dell’apprendimento, essa crea un contesto in cui l’apprendimento
4 Bruner J. (1992), La ricerca del significato. Per una psicologia culturale, Bollati Boringheri, Torino 5 Jonassen D.H. (1994),Thinking technology: toward a costructivistic design model, Educational technology, n. 34

Multimedialità e Apprendimento
16
prende posto come fa in altri contesti” quali la famiglia o il gruppo dei pari. Quindi,
“l’insegnante non determina l’apprendimento. L’apprendimento è un processo in fieri, che può
utilizzare l’insegnamento come una delle tante risorse strutturali. A questo riguardo,
l’insegnante e i materiali d’istruzione diventano risorse per l’apprendimento in molti modi
complessi”6.
6 Varisco B.M. , Costruttivismo socio-culturale, Carocci, Roma, 2002

Multimedialità e Apprendimento
17
1.4.2 Multimedialità e comunicazione didattica
Il problema, da un punto di vista pedagogico e didattico, riguarda il rapporto tra media e
apprendimento: come deve modificarsi la comunicazione didattica quando essa avviene
attraverso canali diversi da quelli tradizionali (lezione in presenza, libri), ossia attraverso la
multimedialità? Come comunicare contenuti di apprendimento in modo efficace senza causare
sovraccarico cognitivo?
Comunicare un contenuto didattico non significa trasmettere semplicemente informazioni, ma
attivare processi cognitivi complessi come trasferire quanto si è appreso da un contesto a un
altro, imparare oltre che ovviamente comprendere e ricordare.
Non sono molti gli studi empirici che si sono soffermati su come rendere efficace una
comunicazione didattica multimediale. Uno dei pochi autori che ha cercato di affrontare in
termini scientifici simili problematiche, rispetto alla comunicazione testuale o multimediale, è
stato lo psicologo californiano Richard Mayer.
Il contributo offerto da Mayer sul tema della multimedialità, ampliandolo e integrandolo con
altre linee di ricerca per rispondere principalmente alle seguenti domande: come presentare
contenuti informativi in modo significativo per l’apprendimento? Quali sinergie didatticamente
rilevanti si possono instaurare tra il testo e l’immagine?
Mayer, tenendo conto da una parte del carattere costruttivo dell’apprendimento e avvalendosi
dall’altra di teorie cognitive classiche, come quella del carico cognitivo di Sweller e la teoria
del doppio codice di Paivio, suggerisce una serie di tecniche su come presentare/comunicare i
contenuti didattici7 e formula alcuni fondamentali principi su come progettare interfacce
multimediali8.
La teoria della doppia codice di Paivio9 sostiene che un evento può essere rappresentato in
memoria mediante due codici:
• Verbale: che contiene le informazioni di cui ci serviamo quando usiamo le parole;
• Non verbale o immaginifico: che contiene le informazioni per generare le immagini
che corrispondono ad oggetti naturali.
Ogni sistema è ulteriormente suddiviso in sottosistemi e i due sistemi simbolici comunicano tra
loro attraverso relazioni tra immagini e parole.
La teoria del carico cognitivo di Sweller si focalizza sul concetto di risorse cognitive disponibili
durante l’esecuzione di un compito, su come esse vengano utilizzate durante l’apprendimento e
direzionate verso obiettivi specifici di apprendimento, in modo da non determinare un
sovraccarico cognitivo.
7 Richard E. Mayer, “Multimedia Learning”, Cambridge University Press, New York, 2001 8 Richard E. Mayer, “The Cambridge Handbook of Multimedia Learning”, Cambridge University Press, New York, 2005 9 Mammarella, Cornoldi, Pazzaglia, “Psicologia dell’apprendimento multimediale”, Il Mulino, 2004

Multimedialità e Apprendimento
18
Le tecniche e i principi teorizzati da Mayer si basano sul SOI model of learning una teoria della
cognizione di carattere costruttivista incentrata su tre processi cognitivi: selezionare
informazioni (S), organizzare informazioni (O) ed integrare informazioni (I). Il modello può
essere schematizzato nel seguente modo:
Figura1: Modello di apprendimento Costruttivista di Mayler (SOI model of learning)
Più analiticamente, secondo Mayer, nel corso del processo di apprendimento lo studente
compie tre operazioni fondamentali: seleziona le informazioni rilevanti attraverso due canali
distinti e paralleli (visivo e uditivo); organizza nella working memory le percezioni visive o
uditive selezionate in un modello mentale visivo o verbale coerente, connettendo cioè in modo
appropriato (ad es. attraverso una relazione di tipo causale) le percezioni selezionate; integra
infine le nuove rappresentazioni visive o verbali, utilizzando le conoscenze preesistenti, nella
long-term memory, e ottenendo una rappresentazione integrata del materiale presentato. Le
assunzioni di fondo sono invece che esperienze visive e uditive sono elaborate in distinti e
separati canali e ciascun canale di elaborazione è limitato nella sua capacità di trattare
informazioni.
Secondo Mayer la comunicazione multimediale può migliorare l’apprendimento, ma solo ad
alcune condizioni. Occorre infatti tener conto che lo studente apprende meglio:
• da parole unite a immagini, piuttosto che solamente da parole (principio di
multimedialità);
• quando le parole e le immagini corrispondenti sono vicine tra loro sulla pagina o sulla
schermata (principio di contiguità spaziale);
• quando le parole e le immagini corrispondenti sono presentate simultaneamente
piuttosto che successivamente (principio di contiguità temporale);
• quando le parole, le immagini o i suoni estranei sono esclusi (principio di coerenza);

Multimedialità e Apprendimento
19
• quando le animazioni sono accompagnate da narrazione audio, piuttosto che da testi
scritti sullo schermo (principio di modalità);
• da animazioni accompagnate solo da narrazione audio piuttosto che accompagnate sia
da narrazione che da testi sullo schermo (principio di ridondanza).
La multimedialità con uso di immagini, testi, audio, ecc. ha quindi di per sé un valore aggiunto,
a patto però di evitare il sovraccarico cognitivo, derivante dall’eccessivo impiego di un singolo
canale (visivo o uditivo).
Sempre basandosi sul modello precedente, Mayer indica alcune tecniche per migliorare la
presentazione dei contenuti e promuovere l’apprendimento, facilitando l’attivazione dei tre
processi cognitivi di selezione, organizzazione e integrazione delle informazioni.
Innanzitutto, per aiutare lo studente a selezionare le informazioni rilevanti e significative lo
psicologo californiano propone alcune tecniche:
• evidenziare le informazioni più importanti attraverso l’uso di titoli, corsivo, grassetto,
sottolineature, dimensioni del carattere, spazi bianchi, ripetizioni dei concetti
importanti, icone, immagini, ecc.;
• aggiungere delle domande e/o esplicitare gli obiettivi didattici in modo da richiamare
l’attenzione sui contenuti rilevanti;
• fornire delle sintesi riepilogative;
• eliminare le informazioni irrilevanti e adottare uno stile conciso, in modo da ridurre il
“rumore”.
Inoltre, Mayer indica in che modo poi è possibile facilitare il processo di organizzazione delle
nuove informazioni e aiutare lo studente a mettere in relazione le rappresentazioni selezionate,
così da costruire una rappresentazione mentale coerente.
Premettendo che il processo di costruzione di rappresentazioni mentali coerenti dipende dalla
capacità dello studente di riconoscere la struttura concettuale del testo, in questo caso, è
pertanto utile:
• strutturare in modo chiaro e comprensibile il testo, ossia esplicitare le relazioni
concettuali esistenti tra le sue parti (confronto comparazione, relazione causa effetto,
classificazione, grado di generalità, ecc.);
• fornire una “scaletta” dei passaggi critici;
• segnalare i passaggi attraverso parole chiave;
• offrire rappresentazioni grafiche attraverso cui mettere in relazione i nuovi concetti
(schemi, mappe concettuali).
Infine Mayer ci suggerisce come aiutare lo studente ad attivare e utilizzare le conoscenze
pregresse, quelle cioè “depositate” nella memoria a lungo termine, e in che modo facilitarlo nel
processo di integrazione delle nuove rappresentazioni attraverso le conoscenze preesistenti.
In questo caso, si può far uso di:

Multimedialità e Apprendimento
20
• anticipatori (advance organizer) contenenti ad esempio analogie;
• illustrazioni multiframe, cioè per esempio presentazioni simultanee di una stessa
spiegazione in formati diversi (animazione e narrazione);
• esempi;
• domande.
Un ruolo fondamentale nelle comunicazione multimediale è svolto dalle immagini le cui
funzioni principali sono:
• Decorativa: può trattarsi di riproduzioni di oggetti o di eventi che non si riferiscono alle
informazioni contenute nel testo, in questo caso le immagini non hanno particolari
ricadute sull’apprendimento;
• Rappresentativa: si tratta di immagini che guidano l’attenzione su un elemento del testo,
orientando i processi di selezione dell’informazione;
• Organizzativa: sono immagini che aiutano il lettore a cogliere i legami tra le
informazioni contenute nel testo;
• Interpretativa o esplicativa: nel caso di immagini che illustrano il funzionamento di
processi o sistemi in termini di causalità, attivando processi di integrazione.

Multimedialità e Apprendimento
21
1.4.3 Le immagini nella didattica per alunni con disabilità
L’immagine è solitamente considerata una ripetizione/ricostruzione della realtà e in base a
questo parametro, chi la osserva ripresenta una realtà già vista e conosciuta, o aiuta a scoprire
un aspetto impensato del mondo, o mostra ciò che non è consentito vedere per esperienza
“diretta”.
L’attenta osservazione di una immagine può essere un ottimo esercizio per stimolare e
soddisfare la curiosità, la voglia di capire, la ricerca di un significato, attirare e mantenere
l’attenzione degli alunni o per facilitare la comprensione di un concetto.
Nel lavoro didattico con alunni in difficoltà di apprendimento10 o in situazione di disabilità, il
ricorso alle immagini è più frequente e il rischio di utilizzare immagini non adeguate è alto. Il
“rischio” viene aumentato dal fatto che non sempre è possibile disporre di immagini relative a
ciò di cui si sta parlando, perciò si rimedia come si può e si utilizza quel che si trova.
D’altra parte, con tutti i problemi cui si deve quotidianamente far fronte, soprattutto quando si
opera in attività di sostegno, certamente quello della scelta costante di immagini adeguate è un
problema che facilmente viene tralasciato. Eppure non è un problema di poco conto. Quando le
immagini debbono essere strumenti, stimoli, mediazioni per il conseguimento di conoscenze,
occorre per esse una accurata scelta ed una attenta calibratura, altrimenti non solo non viene
introdotta alcuna facilitazione nel processo di apprendimento ma si rischia addirittura di
produrre confusione e fraintendimenti.
Nel contesto di uso delle immagini in attività didattiche con alunni in situazione di disabilità
dobbiamo affidare alle immagini almeno tre funzioni:
• stimolazione percettiva
• memoria/recupero di sensazioni ed esperienze
• proposizione di informazioni
Per svolgere queste funzioni le immagini debbono essere strutturate e presentate in modo tale
da costituire delle vere e proprie provocazioni per l’alunno. Provocazioni che possiamo porre:
• a livello sensoriale;
• a livello emotivo;
• a livello cognitivo.
D’altra parte è proprio in una giusta alternanza tra questi tre livelli di provocazione che
normalmente si dovrebbe collocare un intervento di sostegno.
E’ ovvio che le immagini, per poter costituire delle provocazioni a livello sensoriale, emotivo e
cognitivo debbono essere ideate e realizzate con particolari cure e attenzioni, non intesa in
senso tecnico di realizzazione, ma le immagini necessitano di alcuni elementi “catalizzatori”, in
10 Angelo Vigo, Le immagini nella didattica per alunni con disabilità, http://www.cstlodi.it/immagininelladidattica.pdf

Multimedialità e Apprendimento
22
grado di trasformarle in strumenti, stimoli, mediazioni o in provocazioni per apprendere. Un
primo elemento “catalizzatore” potremmo individuarlo nel piacere di vedere. Ai bambini piace
vedere, piace osservare, piace subire il fascino degli stimoli visivi.
Ma ci sono altri elementi catalizzatori come ad esempio l’intimità, la padronanza, la possibilità
di agire, cioè sensazioni molto particolari di cui un bambino, e soprattutto un bambino in
situazione di disabilità, ha bisogno per sentire una situazione di apprendimento come
significativa per sé.
L’intimità riguarda ciò che è più profondo, ciò che sta “più dentro”. Per provare una
sensazione di intimità, in una situazione scolastica, occorre poter sentire le attività proposte
dall’insegnante come qualcosa di perfettamente aderente alle proprie esigenze, come una
risposta ai propri intimi e profondi bisogni.
La padronanza è un’altra sensazione di cui il bambino ha bisogno per poter imparare, ma la
padronanza non è da intendere solamente come la capacità di controllo e di dominio di un
oggetto o di un evento, ma vuol dire ritrovare, nel clima e nell’ambiente in cui è inserito, delle
oggettive condizioni di operatività indipendentemente dalle sue specifiche condizioni
psicofisiche.

Multimedialità e Apprendimento
23
1.4.4 Alcuni suggerimenti per utilizzare MS PowerPoint
Cliff Atkinson è il curatore dell’unico blog11 che a livello mondiale si occupa esclusivamente dell’ecologia di PowerPoint, e si rifà agli studi degli anni novanta di Richard Mayer che hanno analizzato le modalità di apprendimento e l’uso integrato di parole e immagini secondo tre concetti chiave:
• doppio canale: la mente ha due canali di apprendimento, quello visivo e quello verbale; • capacità limitata: in ogni canale riusciamo a far passare poche informazioni alla volta; • elaborazione attiva: chi ascolta ritiene non tutto quello che gli viene proposto, ma solo
quello che gli serve.
Su questa base Atkinson consiglia di scrivere le presentazioni PowerPoint seguendo 4 principi:
• principio di segnalazione: scrivere un titolo chiaro che sintetizzi il contenuto della pagina in ogni pagina;
• principio di segmentazione: se si assimila meglio un concetto alla volta, ogni slide deve essere dedicata a un solo tema;
• principio di modulazione: una slide non è una pagina formato A4 e una slide piena di testo “chiude” il canale visivo;
• principio di multimedialità: usare la grafica per tradurre i concetti in immagini e le immagini per fornire suggestioni.
11 Cliff Atkinson, Beyond Bullets blog, http://www.beyondbullets.com

Multimedialità e Apprendimento
24
1.4.5 Le patologie
Disturbi generalizzati dello sviluppo
I disturbi generalizzati dello sviluppo12 rappresentano un capitolo molto complesso e dibattuto,
essendo ancora in corso di studio e verifica la causa scatenante e lo sviluppo patogenetico. Le
diverse correnti di pensiero hanno nel tempo strutturato differenti sistemi di classificazione che
risentono delle ipotesi teoriche di base. Di conseguenza anche per quanto concerne l’approccio
terapeutico e/o riabilitativo si registrano diverse strategie, che rendono ancor più complesso il
compito di fornire una presentazione il più possibile esaustiva e chiara di questa problematica.
Tali disturbi rappresentano peraltro situazioni cliniche di grande impatto in tutti gli ambiti della
vita, sociale e di relazione (famiglia, scuola, lavoro), e pertanto meritano di essere trattati in
maniera specifica.
Attualmente i sistemi di classificazione più frequentemente utilizzati, su cui vi è un diffuso
consenso sono DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) ed ICD-10
(International Classification of Diseases).
I Disturbi generalizzati dello sviluppo rappresentano una distorsione dello sviluppo di base che
riguarda la comunicazione, verbale e non verbale, le capacità sociali e l’attività immaginativa.
Sono inoltre compromesse funzioni psicologiche di base quali l’attività motoria, l’attenzione, la
percezione sensoriale, l’umore ed il funzionamento intellettivo. Nel DSM viene precisato
inoltre la frequente associazione con ritardo mentale.
Secondo il DSM-IV si riconoscono all’interno di questo capitolo i seguenti distinti disordini:
• Disturbo Autistico
• Disturbo di Rett
• Disturbo Disintegrativo della fanciullezza
• Disturbo di Asperger
• Disturbo Generalizzato dello Sviluppo Non Altrimenti Specificato (NAS)
L’ICD-10, che raggruppa questi disturbi sotto la dicitura di Sindromi da Alterazione Globale
dello Sviluppo Psicologico, oltre alle cinque sindromi elencate, inserisce anche:
• Autismo atipico
• Sindrome iperattiva associata a ritardo mentale e movimenti stereotipi
Il disturbo di più frequente riscontro clinico è la Sindrome Autistica le cui caratteristiche
distintive sono la menomazione:
• dell’interazione sociale
12 Maria Bruna Fagiani, “Lineamenti di psicopatologia dell’età evolutiva”, Carrocci Editore, Roma 2002

Multimedialità e Apprendimento
25
• della comunicazione verbale e non verbale
• del comportamento e della attività immaginative
Per la formulazione della diagnosi di autismo, oltre alla compromissione nelle tre aree,
l’esordio dei sintomi deve avvenire entro i tre anni di vita.
Per quanto concerne la menomazione qualitativa nelle interazioni sociali reciproche, essa si
evidenzia nell’incapacità di comportamenti non verbali come il contatto oculare, la mimica
facciale, la postura ed i gesti comunicativi, nell’incapacità di sviluppare relazioni con i coetanei
appropriate
rispetto al livello di sviluppo, nella mancanza di condivisione spontanea di esperienze con gli
altri, nella mancanza di reciprocità sociale ed emozionale. Tali manifestazioni risultano sempre
presenti nel disturbo ma possono variare nel corso nella vita e nei differenti contesti ed essere
d’intensità variabile da soggetto a soggetto, a seconda del grado di disturbo presentato, essendo
possibile riscontrare nell’Autismo un’ampia gamma di modalità di presentazione.
Il bambino autistico potrebbe essere in grado di interagire da un punto di vista fisico, in attività
di gioco corporee, ma non essere in grado di entrare in un gioco immaginativo o in cui gli
venga richiesta la capacità di cooperare.
La menomazione qualitativa nella comunicazione interessa sia l’area verbale che non
verbale, in maniera diversa a seconda dell’età e della profondità del disturbo.
Si manifesta con un ritardo o la totale assenza del linguaggio, con linguaggi atipici per tono,
volume o estensione della voce, con comparsa di ecolalie e neologismi. Dove è presente un
linguaggio, esso è caratterizzato da ripetitività di contenuti, incapacità di usare e comprendere
un linguaggio metaforico, figurato, di tipo simbolico. Il gioco immaginativo e simbolico, che si
correla con la comparsa di una comunicazione adeguata, appare anch’esso povero e ripetitivo.
Un elemento caratteristico della sindrome è la presenza di comportamenti stereotipati che
tendono a ripresentarsi frequentemente nel corso della giornata, apparentemente non finalizzati,
fino a divenire in alcuni casi l’unica attività effettuata. Le stereotipie gestuali (es. movimento di
sfarfallamento o di rotazione con le mani, spesso in visione laterale) tendono a diminuire in
frequenza nel corso della vita e molto spesso si modificano, talora divenendo più complesse od
inserite in una attività rituale più articolata.
Per quanto concerne il trattamento educativo13 gli interventi più frequenti devono in primo
luogo prevedere un approccio individualizzato, perché a dispetto delle classificazioni, gli
individui affetti da autismo presentano personalità differenti e background sociali molto vari.
In secondo luogo deve prevedere una continuità strutturale in quanto il soggetto autistico ha la
necessità di ritrovare le stesse persone che si occupano di lui, le stesse insegnanti, una ritmicità
costante nelle attività da svolgere, nei tempi e luoghi in cui queste vengono svolte, su cui
costruire piccole e lente modificazioni che mirino a renderli più flessibili senza disorientarli o
disorganizzarli.
13 Maria Rosa Pizzamiglio, “La riabilitazione neuropsicologica in età evolutiva”, Franco Angeli 2003

Multimedialità e Apprendimento
26
In terzo luogo i bambini sono di solito in grado di lavorare con un unico pensiero alla volta e
quindi le istruzioni devono essere date una per volta, in maniera semplice e priva di ambiguità
o possibili interpretazioni. Accanto alle istruzioni verbali è utile associare talvolta una
spiegazione gestuale o un modello da imitare.
In quarto luogo va ricordato che questi bambini presentano una difficoltà di pianificazione ed
organizzazione, oltre ché spaziale anche temporale, e pertanto ogni compito deve essere portato
a termine prima di iniziare il successivo.
Ritardo mentale
Il ritardo mentale14 è una condizione clinica complessa, caratterizzata dalla presenza di un
deficit cognitivo, che produce una azione di distorsione complessiva, più o meno massiccia,
della personalità del soggetto e delle sue possibilità di adattamento per cui per es. l’incidenza di
disturbi psichiatrici nei soggetti con ritardo mentale è diverse volte superiore a quella in
soggetti normodotati. I disturbi psichiatrici che più comunemente si associano al ritardo
mentale sono i Disturbi da Tic, il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività, i Disturbi
dell’Umore, i Disturbi da Movimenti Stereotipati ed i Disturbi Generalizzati dello Sviluppo.
Secondo l’ICD-10 il ritardo mentale rappresenta una condizione di interrotto o incompleto
sviluppo psichico, caratterizzata soprattutto da compromissione delle abilità che si manifestano
durante il periodo evolutivo e che contribuiscono al livello globale di intelligenza, cioè quelle
cognitive, linguistiche, motorie, affettive e sociali.
Il ritardo mentale è valutato attraverso misurazioni standard che tengono conto della
definizione di intelligenza che pur essendo intuitivo come concetto, risulta difficile da definire.
Infatti, l’atto intelligente non è solo operazione di pensiero, ma è il risultato della
collaborazione tra pensiero, funzioni e attività psichiche che del pensiero non fanno parte,
come: affettività, interesse, motivazione. Si può, peraltro, tenere presente il fatto che la capacità
di risolvere problemi, comprendere, stabilire nessi logici è attività psichica suscettibile di
misurazione, sulla base della ovvia constatazione che ogni individuo è in grado di comprendere
o risolvere problemi entro un certo grado di difficoltà. La valutazione qualitativa di tale
capacità dà la misura dell’intelligenza. L’efficienza intellettiva è, peraltro, rappresentata dal
livello di complessità delle operazioni logiche che ogni individuo può formulare. Per giungere
alla misurazione dell’intelligenza si è quindi introdotto i concetto di età mentale, cioè il livello
di efficienza intellettiva relativo al livello di maturazione delle funzioni cognitive di un
determinato soggetto, e per permettere il confronto tra soggetti di età diverse, si è giunti al
calcolo del Quoziente di Intelligenza (QI), ottenuto dividendo il valore dell’età mentale per il
valore dell’età cronologica. Quando un soggetto raggiunge al test un’età mentale uguale all’età
cronologica, il valore del QI sarà 100%, questo è il valore della media normale seguendo una
distribuzione statistica dei risultati. Valori di QI inferiore alla media normale indicano un
ritardo nello sviluppo delle funzioni cognitive, mentre un valore superiore alla media normale
indica una maggiore sviluppo delle stesse funzioni.
14 Maria Bruna Fagiani, “Lineamenti di psicopatologia dell’età evolutiva”, Carrocci Editore, Roma 2002

Multimedialità e Apprendimento
27
Il cut-off stabilito (QI inferiore a 70) è per certi versi del tutto arbitrario, non rispondendo a
considerazioni di natura anatomo-funzionale, né di strutturazione neuropsicologica, né tanto
meno di natura psicodinamica, ma è bensì formulato sulla base di considerazioni puramente
statistiche, di distribuzione e descrizione dei dati.
I risultati ottenuti mediante strumenti testali vanno comunque confrontati con una valutazione
clinica globale del funzionamento cognitivo e pertanto necessitano di essere effettuati da
persone esperte e competenti, che conducano inoltre una indagine approfondita sui
comportamenti del soggetto nei diversi ambiti di vita (famiglia, scuola, centri ricreativi).
Va infatti sottolineato che le abilità intellettive ed il funzionamento sociale, oltre ad essere
complesse da valutare, tendono a modificarsi nel tempo, spontaneamente ed in relazione ad
interventi di tipo psico-educativo e riabilitativo.
Il DSM-IV specifica in base al punteggio raggiunto al test intellettivo diversi sottotipi di ritardo
mentale, che rappresentano anche dei livelli di progressiva gravità del disturbo:
• Livello QI tra 50-55 e 70 corrisponde ad un ritardo mentale LIEVE (nell’adulto
corrisponde ad un’età mentale di 9-12 anni)
• Livello di QI tra 35-40 e 50-55 corrisponde ad un ritardo mentale MODERATO
(nell’adulto corrisponde ad un’età mentale di 6-9 anni)
• Livello di QI tra 20-25 e 35-40 corrisponde ad un ritardo mentale GRAVE (nell’adulto
corrisponde ad un’età mentale di 3-6 anni)
• Livello QI inferiore a 20-25 corrisponde ad un ritardo mentale GRAVISSIMO o
PROFONDO (nell’adulto corrisponde ad un’età mentale inferiore a 3 anni)
Quando il QI non è ottenibile per la mancata collaborazione del soggetto ai test standardizzati
ma si presume essere inferiore al valore limite di 70 si parla di ritardo mentale di GRAVITA’
NON SPECIFICATA.
Per ogni livello di QI sono stati inoltre descritti i corrispondenti livelli di comportamento
adattivo attesi (vedi ICD-10):
• Nel RITARDO MENTALE LIEVE si osservano frequentemente difficoltà
dell’apprendimento in ambito scolastico, mentre nell’età adulta molto sovente
raggiungono una autonomia lavorativa, relazioni sociali soddisfacenti, e risultano in
grado di contribuire al benessere della società.
• Nel RITARDO MENTALE MODERATO si associa a marcati ritardi dello sviluppo
durante l’infanzia, pur potendo sviluppare un certo grado di indipendenza nella cura di
sé, discrete abilità scolastiche e capacità comunicative. Per essere inseriti in un ambito
sociale e lavorativo necessitano abitualmente di un supporto.
• Nel RITARDO MENTALE GRAVE è quasi sempre indispensabile un supporto
continuo.
• Nel RITARDO MENTALE GRAVISSIMO vi è una grave limitazione nella cura di sé,
nella continenza, nella comunicazione e nella mobilità.

Multimedialità e Apprendimento
28
Il ritardo mentale grave è solitamente identificabile già nel 1° anno e la gravità è precisabile a
3-4 anni, il ritardo mentale lieve-medio è solitamente identificabile in età prescolare.
Con l’aumentare della scolarizzazione, del benessere economico ed il rendersi sempre più
complesso del sistema sociale e lavorativo, i ritardo mentale di grado lieve tendono a divenire
sempre più frequentemente e precocemente manifesti, in età scolare, mentre rimanevano
frequentemente inosservati e ben integrati nella società pretecnologica. Sempre in relazione al
mutamento sociale si correla altresì il rilievo che nei soggetti affetti da ritardo mentale si
osservano talvolta buone prestazioni specifiche, come ad es. abilità di letto-scrittura, in assenza
di un pari sviluppo delle capacità adattive. E’ vero al contempo che la nostra società richiede
comportamenti adattivi sempre più elevati che potrebbe determinare un aumento del numero di
soggetti che non appaiono in grado di soddisfarvi, anche in presenza di capacità cognitive
adeguate all’età, come spesso si osserva nei gruppi etnici isolati o che non si riconoscono nei
valori della società in cui vivono (es. popolazioni Rom o emigrati da paesi africani). Questa
osservazione penso possa dare una misura della difficoltà di stabilire il confine tra normalità
intellettiva e ritardo mentale, anche avvalendosi di strumenti il più possibile oggettivi, quali i
test.

Multimedialità e Apprendimento
29
1.5 Dossier di documentazione
1.5.1 Intervento didattico
Presentazione dell’allievo e del contesto scolastico
Gianluca è l’allievo seguito durante l’attività di tirocinio attivo presso la scuola secondaria di
secondo grado.
In un primo momento l’attività svolta, dopo un’intensa discussione con in docente accogliente,
rivolta alle descrizione dell’alunno, si è concentrata sull’osservazione in classe per rafforzare
la conoscenza dell’allievo, funzionale alla progettazione di un intervento educativo
individualizzato. Una conoscenza intesa come uno “svelarsi reciproco”, che va incontro
all’altro, lasciando gli spazi necessari alla progettazione. In tal senso l’analisi della diagnosi
funzionale ha permesso di avere una descrizione analitica e delle compromissioni e delle
potenzialità di recupero, evidenziabili nello stato psico-fisico dell’alunno.
Gianluca è una ragazzo di 17 anni, nato prematuro, che ha trascorso 6 mesi in incubatrice,
correndo il rischio di non riuscire a sopravvivere, e che gli ha sicuramente comportato un
ritardo mentale medio. Dall’analisi funzionale risulta che la sindrome prevalente è un disturbo
generalizzato dello sviluppo associato ad un ritardo mentale medio. In particolare, le capacità
intellettive sono mediamente compromesse, il deficit motorio è lieve, mentre le capacità
relazionali e affettive sono gravemente danneggiate. Gianluca presente problematiche
relazionali, necessaria sempre della mediazione di un educatore, invece sul piano
dell’autonoma personale non presenta particolari problemi, ma incontra delle difficoltà nelle
autonomie sociali, nel mettersi in relazione con il gruppo soprattutto in fase di conoscenza. Da
un punto di vista linguistico riesce ad esprimersi in modo adeguato. Le capacità motorie sono
inficiate da continui movimenti delle mani legati all’instabilità emotive. Infine, da un punto di
vista cognitivo presenta un deficit medio, conosce il concetto di numero ma non manipola bene
le quantità.
Dalla mia osservazione in classe è emerso che Gianluca da un punto di vista linguistico non
presenta grossi problemi, anzi rispetto ai compagni possiede buone capacità espressive, che gli
consentono di articolare espressioni verbali a volte evolute, con un vocabolario ricco di parole,
dovuto sicuramente al fatto che trascorre molte ore della giornata ad ascoltare trasmissioni
televisive, soprattutto sportive dove il linguaggio non è infantile ma rivolto ad un pubblico
adulto. Allo stesso modo comprende pienamente il significato dei discorsi fatti, pertanto per
quanto riguarda la comprensione verbale possiamo considerarlo alla pari dei compagni, sempre
limitatamente a quelle che sono le reali capacità cognitive.
Da un punto di vista motorio presenta delle difficoltà, e sappiamo come lo sviluppo delle
funzioni psicomotorie sia fondamentale per l’educazione cognitiva del soggetto in quanto
l’evoluzione delle seconde, è tributaria dello sviluppo della prima. In particolare, presenta
difficoltà di coordinamento dei movimenti che si manifesta sia nella deambulazione (solleva
maggiormente la gamba rispetto al dovuto) sia nella manipolazione di oggetti. Stranamente,
mentre Gianluca parla e comprende discretamente, allo stesso tempo però non riesce a leggere

Multimedialità e Apprendimento
30
adeguatamente (dislessia), presenta le manifestazioni più frequenti che sono la dislessia visivo-
semantica, la dislessia fonologica, cioè ha delle difficoltà nell’analisi della parola scritta, per
estrarre una rappresentazione grafemica, che attraverso un processo di conversione fonologica
porta alla produzione della parola orale. In pratica, Gianluca non riesce a ricostruire una
rappresentazione mentale della parola scritta, ma la parola la conosce.
Allo stesso modo, non riesce a scrivere (disgrafia), cioè non riesce ad attuare l’analisi acustica
della parola per ottenere una rappresentazione fonologica, che attraverso il sistema semantico,
consente di ottenere la rappresentazione ortografica e quindi dei grafemi che compongono la
parola scritta. Questa analisi porta a dire che Gianluca ha una produzione grafica paragonabile
a quella di un bambino di 4 anni, che non ha ancora raggiunto uno stadio adeguato di sviluppo
delle funzioni psicomotorie, corporee, sensoriali, percettive. Presenta quei sintomi tipici della
disgrafia, quali il tratto irregolare, grafia discontinua, lettere slegate, mancata chiusura di forme
tendenzialmente circolari.
Da un punto di vista matematico presenta forti difficoltà (discalculia), anche semplicemente nel
contare un numero di oggetti superiore a 40, cioè per Gianluca non esistono numeri sopra il 40,
mentre diventa quasi impossibile la soluzione di problemi aritmetici e geometrici di media
complessità. Gianluca conosce i numeri come parole, anche numeri grandi, ma non li domina
come quantità. Riesce solo a controllare quantità che si possono rappresentare su due mani,
quindi mentre riesce a sommare 3+4, diversamente, diventa difficile sommare 30+40=70, e
anche proponendogli i risultato lui potrebbe leggerlo come 7 e 0, o addirittura 0 e 7, cioè
presenta problemi di allineamento. Infatti, è noto come l’allineamento delle cifre è alla base
delle possibilità di realizzare i calcoli matematici rispettando con la giusta collocazione i
rapporti di quantità numerici. Inoltre, si nota come la mancanza di un’adeguata organizzazione
spazio-temporale sia responsabile della mancata acquisizione della matematica in quanto la
numerazione è una successione di elementi nel presente, come la percezione temporale.
Per quanto concerne gli obiettivi dell’integrazione scolastica, l’allievo è fortemente integrato,
svolge le lezioni regolarmente in classe, motivato ed aiutato dalla presenza di un PC. Partecipa
attivamente alle attività scolastiche, quali lo sviluppo di trasmissioni rivolte alla Web Radio
dell’Istituto, prestandosi ad effettuare interviste su vari argomenti di interesse, come musica,
sport, attualità, e non solo, partecipa anche con i compagni alle attività ricreative, presso il bar
dell’Istituto, durante l’intervallo, manifestando una sufficiente autonomia, una buona capacità
di relazionarsi, ed una buona socializzazione indispensabile per una convivenza civile e
responsabile. Inoltre, un piano di interventi che porti l’alunno a raggiungere risultati
apprezzabili sul piano dell’integrazione sociale coinvolge il concetto di “Rete Sociale”, intesa
come un insieme di attori che realizzino attività, relazionate tra loro, con modalità e strumenti
diversi, con l’obiettivo comune di focalizzare l’attenzione sui bisogni specifici delle persone
con gravi problemi per costruire insieme un processo di integrazione e un progetto di vita. In
tale contesto si colloca l’ippoterapia che Gianluca svolge. L'ippoterapia consiste nella
induzione di miglioramenti funzionali psichici e motori attraverso l’attento uso dei numerosi
stimoli che si realizzano nel corso della interazione uomo-cavallo. E’ noto, infatti, come lo
sport sia elemento fondamentale di tutte le persone, e ancor di più per i disabili, in quanto non
rappresenta solo un mezzo per il recupero psicofisico del disabile, ma anche uno stimolate

Multimedialità e Apprendimento
31
mezzo di integrazione sociale. Oltre allo sport, gli educatori, messi a disposizione dagli enti
locali presenti sul territorio, coinvolgono Gianluca in attività teatrali con lo scopo di potenziare
l’autonomia socio-personale.
Progettazione intervento didattico
A fronte di queste considerazioni derivanti da un’attività osservativa, con il docente accogliente
abbiamo sviluppato un intervento didattico sfruttando le abilità residue. Nel dettaglio la
comunicazione con l’alunno sfrutta i canali di input residui che sono: il riconoscimento delle
immagini, di forme, e il canale uditivo che è intatto. Inoltre, si sono presi in considerazione i
compensatori di attenzione, cioè quali sono le attività che lo attraggono, lo interessano, quindi
quali sono i fattori che catalizzano l’attenzione lungo i canali di input. Il docente accogliente ha
riscontrato precisamente: la musica, i cartoni animati, il calcio e aspetti sportivi in generale,
attualità, mezzi e strumenti tecnologici e soprattutto il personal computer. Di conseguenza,
l’intersezione dei due punti precedenti ha come risposta che la didattica multimediale permette
di affrontare gli apprendimenti curricolari passando da uno o più di questi elementi. Questo
aspetto è fortemente supportato dalla scuola in quanto il Piano dell’Offerta Formativa prevede
una specializzazione in Informatica con una sperimentazione autonoma in "Multimedialità e
Comunicazione Digitale". Pertanto presso l’Istituto è presente un laboratorio multimediale dove
è possibile sviluppare attività didattiche con un contenuto tecnologico estremamente elevato
rispetto agli standard.
Tutto questo prende spunto da Feuerstein15 il quale sottolinea il fatto che ogni allievo è
modificabile, proprio perché appartiene al genere umano dove l’intelligenza è plastica, quindi è
modificabile, però deve trovarsi in un ambiente favorevole, pertanto l’obiettivo è la ricerca
delle giuste condizioni ambientali favorevoli all’apprendimento, che con l’allievo seguito
risulta essere la presenza del PC in classe e il laboratorio multimediale.
La scelta di attuare un intervento didattico multimediale si colloca all’interno di una
programmazione a lungo termine che ha come obiettivo finale mettere Gianluca nella
condizione di operare al meglio con un strumento potente quale il PC. Infatti, per far si che
Gianluca possa acquisire una maggiore autonomia è necessario che impari a lettere almeno
attraverso sintesi vocale, cioè lui non è in grado di leggere, ma se qualcuno lo fa per lui è in
grado di capire il significato, sempre compatibilmente con quelle che sono le sue capacità
cognitive. Pertanto un software dotato di scanner per “leggere” il testo con la possibilità di
essere riprodotto con voce sintetica si configura come uno strumento di maggiore autonomia
futura.
Nello specifico l’intervento didattico ha focalizzato l’attenzione sull’analisi delle immagini,
rivolta a rafforzare la capacità di discriminazione delle forme, sia nella dimensione, che nella
collocazione spaziale (destra, sinistra, in alto e in basso, in primo piano e sfondo) all’interno
15 Vittorio Venuti, Lorenza Carelli, “Manuale per l’integrazione scolastica degli alunni disabili”, Euroedizioni , Torino, 2007

Multimedialità e Apprendimento
32
della dimensione iconografica. L’intervento educativo è stato pensato e contestualizzato
durante una lezione di Sistemi di Elaborazione e Trasmissione dell’Informazione in cui la
classe era impegnata nello studi delle Reti di Calcolatori e degli apparati di interconnessione
(Hub, Switch e Router). Ovviamente, una tale attività è estremamente complessa per Gianluca,
però l’obiettivo che ci siamo prefissati è stato quello di arrivare a comprendere il
funzionamento degli apparati di rete citati, attraverso la realizzazione di presentazioni
multimediali animate in cui si simula il comportamento del dispositivo, arricchite da una
descrizione sonora alcune volte prodotta direttamente dall’alunno. In questo modo abbiamo
compreso con l’aiuto di un’immagine in movimento le caratteristiche dei vari dispositivi
oggetto di studio, e i loro diverso comportamento, raggiungendo l’obiettivo minimo prefissato,
in sintonia con la programmazione di classe.
Scheda sintetica dell’intervanto didattico
Unità Didattica
Reti di calcolatori ed apparati di interconnessione
Prerequisiti: • Conoscenze di base su hardware e software • Conoscenze minime sulla rete telefonica fissa • Conoscenze minime sul sistema postale
Descrittore:
• Reti locale di calcolatori • LAN – Local Area Network
• Regole per il trasferimento dei dati • Commutazione di pacchetto
• Apparati di rete e loro funzionamento: Hub, Switch e Router Obiettivi Specifici:
• Conoscere il concetto di rete e reti di calcolatori • Conoscere come è costituita una rete locale • Conoscere i dispositivi di interconnessione e il loro funzionamento macroscopico • Conoscere il concetto di rete globale (Internet) e il funzionamento degli apparati di
interconnessione interessati (Router) Obiettivi Generali:
• Promuovere maggiori competenze nell’uso del Personal Computer • Migliorare le capacità motorie per eseguire movimenti fini attraverso l’uso del
mouse • Migliorare le capacità affettivo/relazionali attraverso l’uso del calcolatore per
suscitare sensazioni di sicurezza, padronanza e adeguatezza alla vita scolastica • Promuovere una reale integrazione scolastica attraverso l’uso del Personale
Computer in classe • Rafforzare la capacità di discriminazione delle forme, sia nella dimensione, che
nella collocazione spaziale Strumenti:
• Personal computer • MS PowerPoint 2007

Multimedialità e Apprendimento
33
• MS Paint • DSpeech • Audacity • Rete Internet
Spazi:
• Classe • Laboratorio multimediale • Laboratorio sistemi
Verifica:
Colloquio orale con il docente curricolare in cui verranno esposte le slide prodotte con eventuali domande di approfondimento da parte del docente. Suddivisione oraria:
• Lezione 1 (3 ore): Definizione del concetto di rete di calcolatori e in particolare reti locali a stella.
• Lezione 2 (3 ore): Definizione dell’apparato di rete Hub e funzionamento. • Lezione 3 (3 ore): Definizione dell’apparato di rete Switch e funzionamento. • Lezione 4 (3 ore): Definizione dell’apparato di rete Router e funzionamento. • Lezione 5 (3 ore): Rivisitazione generale del materiale prodotto e verifica finale.
Finalità generali:
Aumentare le competenze nell’uso del personal computer per giungere alla fine del quinto anno ad una buona padronanza dello strumento per utilizzare programmi di sintesi vocale per acquisire una maggiore autonomia sociale.

Multimedialità e Apprendimento
34
Materiale prodotto
Prima lezione
Figura2: Slide prodotta durante la prima lezione

Multimedialità e Apprendimento
35
Innanzitutto, durante la prima lezione abbiamo reperito in Internet tutte le immagini
necessarie per la realizzazione della presentazione multimediale in MS PowerPoint. In
particolare, abbiamo rintracciato le immagini per i PC della rete, le immagini relative ai
dispositivi di rete, l’immagine relativa ai messaggi/dati (una busta da lettere). Il primo
concetto esaminato è stato quello di rete locale a stella. Per avere una rappresentazione più
precisa, nella presentazione è stata aggiunta un’immagine schematica del concetto esposto,
corredata da una descrizione sonora, ottenuta attraverso sintesi vocale con il programma
DSpeech. Successivamente nella presentazione sono stati aggiunti i vali elementi che
costituiscono la rete, con una animazione grafica a comparsa, e con un sonoro descrittivo
dell’elemento inserito.

Multimedialità e Apprendimento
36
Seconda lezione
Figura3: Slide prodotta durante la seconda lezione

Multimedialità e Apprendimento
37
Durante la seconda lezione abbiamo esaminato il comportamento dell’Hub. In un primo
momento, attraverso il programma MS Paint, disponibile sul PC, abbiamo realizzato la rete
interconnettendo i PC con il dispositivo oggetto di studio creando così un’immagine di una
rete a stella. In un secondo momento abbiamo aggiunto alla presentazione multimediale, una
seconda diapositiva contenente l’immagine creata ed abbiamo inserito le animazioni
necessarie per muovere lungo l’immagine della rete la lettere, cioè i dati, in modo del tutto
simile a come avviene nella realtà. Anche in questo caso ogni singolo passo di avanzamento
dell’animazione è arricchito da una descrizione sonora prodotta questa volta dall’allievo nel
laboratorio multimediale attraverso il programma Audacity. In questo caso abbiamo osservato
con l’allievo che l’Hub è un dispositivo poco utilizzato oggigiorno, in quanto replica i
messaggi a tutti i destinatari intasando la rete, e il concetto è fortemente evidenziato dallo
moltiplicazione delle lettere che si hanno durane l’animazione grafica.

Multimedialità e Apprendimento
38
Terza lezione
Figura4: Slide prodotta durante la terza lezione

Multimedialità e Apprendimento
39
Sostanzialmente identica alla seconda solo che abbiamo cambiato il dispositivo oggetto di
studio (lo switch) e abbiamo introdotto il concetto di indirizzo MAC per il PC al fine di
“spedire” la lettera al solo destinatario del messaggio. Per giungere alla comprensione del
funzionamento si è rappresentato il fenomeno facendo una similitudine con il sistema postale
riscoprendo nello switch il ruolo di “postino”.

Multimedialità e Apprendimento
40
Quarta lezione
Figura5: Slide prodotta durante la quarta lezione

Multimedialità e Apprendimento
41
Durante la quarta lezione abbiamo esposto il concetto di rete internet, l’abbiamo rappresentato
come una nuvola grande a cui sono connesse le varie reti a stella precedentemente studiate
(nuvole più piccole), e abbiamo individuato il dispositivo responsabile di tali collegamenti.
Sempre attraverso animazione grafica abbiamo intuito il ruolo svolto dal router, paragonandolo
ad un vigile urbano, situato ad incrocio stradale, che da informazioni per smistare il traffico alle
varie macchine passanti, che nel nostro caso è la lettera, e cioè i dati.

Multimedialità e Apprendimento
42
1.5.2 Schede bibliografiche e sitografiche
SCHEDA BIBLIOGRAFICA
N° rif. A1 (indice ragionato)
TESTO ESAMINATO
Autore: Antonio Calvani
Titolo del libro: Che cos’è la tecnologia dell’educazione
CASA EDITRICE: Carrocci
CITTA’: Roma
ANNO: 2004
Concetto: Il volume costituisce una guida introduttiva alla tecnologia dell’educazione e si sofferma su
temi caratteristici dell’area, quali l’instructional design, l’e-learning, il collaborative learning, la
comunità di pratica, e su alcuni tratti tipici del modo di operare dell’esperto di tecnologia
dell’educazione. Definizioni e citazioni: La tecnologia dell’educazione è una disciplina che studia i cambiamenti prodotti dall’utilizzo dei media nel campo dell’apprendimento e che si propone di fornire le conoscenze teoriche e gli strumenti necessari alla progettazione e all’allestimento di sistemi e ambienti formativi in contesti come la scuola, l’azienda, l’università. Eventuali rimandi ad altri testi o autori: Varisco, Jonassen, Bruner, Winograd Eventuali note o commenti:

Multimedialità e Apprendimento
43
SCHEDA BIBLIOGRAFICA
N° rif. A2 (indice ragionato)
TESTO ESAMINATO
Autore: Antonio Calvani
Titolo del libro: Educazione, comunicazione e nuovi media. Sfide
pedagogiche e cyberspazio
CASA EDITRICE: UTET Università
CITTA’: Torino
ANNO: 2001
Concetto: Il volume offre una introduzione, rivolta ad educatori e studenti, nei riguardi dell’area che si
viene generando dall’incontro tra educazione, media e tecnologia. Il volume è articolato in
quattro parti: nella prima si presentano i concetti e le definizioni preliminari; nella seconda si
rivolge l’attenzione alle modalità d’incontro tra educazione e media; nella terza si presenta un
quadro storico dello sviluppo della Education Technology, dei suoi principali riferimenti
teorici; nella quarta si tratta dei recenti sviluppi di Internet e delle sue implicazioni nell’ambito
della formazione e sperimentazione didattica. Definizioni e citazioni: La Media Education, campo disciplinare di confine tra scienze dell’educazione e della
comunicazione, si propone di produrre riflessioni e strategie operative in ordine ai media intesi
come risorsa integrale per l’intervento formativo. Eventuali rimandi ad altri testi o autori: Rivoltella P. C., Marazzi C., Zanacchi A. Eventuali note o commenti:

Multimedialità e Apprendimento
44
SCHEDA BIBLIOGRAFICA
N° rif. A3 (indice ragionato)
TESTO ESAMINATO
Autore: Ezio Roletto
Titolo del libro: Apprendimento delle scienze e didattiche disciplinari.
CASA EDITRICE: IRIDIS
CITTA’: Torino
ANNO: 2002
Concetto: Il testo si propone di analizzare i diversi modi di intendere l’apprendimento, analizzando il
comportamentismo, il cognitivismo ed il costruttivismo. Inoltre, è ampiamente trattato il
problema dell’apprendimento delle discipline scientifiche, dei conseguenti metodi di
insegnamento descrivendo i vari modelli teorici di riferimento evidenziandone pregi e difetti.
Ampio spazio è riservato al modello di apprendimento “didattico”, fornendone i fondamenti
epistemologici e psicologici e delineando il ruolo dell’insegnante. Definizioni e citazioni: Comportamentismo: Se si è chiamati a mettere in atto un comportamento di adattamento a un
ambiente esterno, rispondendo a determinati stimoli.
Cognitivismo: Se si mettono in moto le proprie strutture e capacità cognitive per assegnare un
significato e un valore alla realtà esterna.
Costruttivismo: Se si costruiscono degli artefatti concreti attraverso un processo cooperativo tra
più persone. Eventuali rimandi ad altri testi o autori: Skinner B.F., Bloom B.S., Bruner J.S., Ausebel D.R., Piaget J., Vygotskij L.S. Eventuali note o commenti:

Multimedialità e Apprendimento
45
SCHEDA BIBLIOGRAFICA
N° rif. A4 (indice ragionato)
TESTO ESAMINATO
Autore: Mammarella, Cornoldi, Pazzaglia
Titolo del libro: Psicologia dell’apprendimento multimediale
CASA EDITRICE: Il Mulino
CITTA’: Torino
ANNO: 2004
Concetto: Questo volume analizza l’apprendimento multimediale nelle sue componenti cognitive,
metacognitive e emotivo-motivazionali, proponendo un modello teorico comprensivo delle
diverse variabili e delle loro relazioni. Qual è il ruolo svolto da attenzione, memoria,
motivazione ed emozioni nell’apprendimento multimediale e fino a che punto queste variabili
possono facilitarlo o impedirlo? Nel rispondere a tali interrogativi gli autori forniscono una
chiave di lettura dell’apprendimento multimediale centrata sulle conoscenze, competenze e
atteggiamenti del soggetto che apprende. Il volume può offrire utili spunti operativi e di
riflessione a insegnanti, psicologi e professionisti che operano nell’ambito dell’educazione e
della comunicazione, e a quanti, a vario titolo, desiderino approfondire le variabili psicologiche
implicate nell’apprendimento multimediale. Definizioni e citazioni: La teoria della doppia codifica dell’informazione: sostiene che un evento può essere
rappresentato in memoria mediante due codici, uno verbale e uno non verbale o immaginifico.
La teoria del carico cognitivo:si focalizza sul concetto di risorse cognitive disponibili durante
l’esecuzione di un compito, su come esse vengano utilizzate durante l’apprendimento in modo
da non determinare un sovraccarico cognitivo. Eventuali rimandi ad altri testi o autori: Paivio A., Chandler e Sweller, Mayer R. Eventuali note o commenti:

Multimedialità e Apprendimento
46
SCHEDA BIBLIOGRAFICA
N° rif. A5 (indice ragionato)
TESTO ESAMINATO
Autore: Laura Fiorini, Massimo Greco
Titolo del libro: Proposte didattiche con Powerpoint
CASA EDITRICE: Editrice La Scuola
CITTA’: Brescia
ANNO: 2005
Concetto: La riforma della scuola, con l’introduzione dell’informatica, ha reso necessario coniugare
buona didattica e nuove tecnologie: l’insegnamento con il computer diventa così un aspetto
rilevante del curricolo fin dall’inizio del percorso scolastico.
PowerPoint è un potente strumento di supporto all’attività didattica e permette agli studenti di
utilizzare la multimedialità a fini cognitivi, di esporre un argomento in maniera chiara e
conforme all’obiettivo e al destinatario e aiuta a coordinare differenti linguaggi (verbale,
iconico ecc.). Gli autori, in questo testo, hanno scelto di riportare le proprie esperienze
professionali nell’uso di PowerPoint, tenendo conto anche di alcuni indirizzi di ricerca nel
campo della psicologia circa i processi cognitivi e l’apprendimento, come il costruttivismo,
ritenendo fondamentale la costruzione attiva della loro educazione da parte dei ragazzi. Definizioni e citazioni: Eventuali rimandi ad altri testi o autori: Eventuali note o commenti:

Multimedialità e Apprendimento
47
SCHEDA BIBLIOGRAFICA
N° rif. B1 (indice ragionato)
TESTO ESAMINATO
Autore: Maria Bruna Fagiani
Titolo del libro: Lineamenti di psicopatologia dell’età evolutiva
CASA EDITRICE: Carrocci
CITTA’: Roma
ANNO: 2002
Concetto: Questo libro, rivolto principalmente a chi opera – come gli educatori e gli insegnanti – nel
settore dell’età evolutiva, intende porsi come uno strumento facilmente utilizzabile anche da
chi non abbia ampie nozioni nel campo medico in generale e nel campo psichiatrico in
particolare. Il testo tratta ampiamente le patologie tipiche dell’infanzia, che si manifestano
nell’adolescenza e che sfumano da un lato in quelle dell’adulto e dall’altro in quelle di età più
precoci, nonché ai problemi derivanti da situazioni ambientali patogene o “difficili” che si
traducono in un disagio e in problemi di adattamento con conseguenti riflessi sul
comportamento dei minori che vi si trovano coinvolti, basti pensare all'abuso o all'adozione.
Brevi cenni relativi alle principali teorie dello sviluppo e a quelle riguardanti la genesi dei
disturbi trattati. Definizioni e citazioni: Disturbi generalizzati dello sviluppo: sono alterazioni dello sviluppo caratterizzate da compromissione grave e generalizzata in diverse aree dello sviluppo, quali la interazione sociale e la capacità di comunicazione, e dalla presenza di comportamenti, attività, interessi abnormi. Eventuali rimandi ad altri testi o autori: Marcelli, Gilberg Eventuali note o commenti:

Multimedialità e Apprendimento
48
SCHEDA BIBLIOGRAFICA
N° rif. B2 (indice ragionato)
TESTO ESAMINATO
Autore: Maria Rosa Pizzamiglio
Titolo del libro: La riabilitazione neuropsicologica in età evolutiva
CASA EDITRICE: Franco Angeli
CITTA’: Milano
ANNO: 2003
Concetto: La riabilitazione neuropsicologica in età evolutiva è particolarmente importante, perché
consente di far emergere da una situazione di difficoltà e sofferenza reali possibilità di
interazione e comunicazione con l'ambiente.
Il bambino infatti, a prescindere dalla gravità del suo quadro clinico, impara ad utilizzare le
strategie e gli strumenti più adatti ad affrontare efficacemente le problematiche inerenti la sua
crescita, modificando le proprie risposte a seconda delle richieste che gli vengono rivolte.
Attraverso lo studio delle teorie dei processi cognitivi è possibile creare degli strumenti
riabilitativi che facilitano lo sviluppo di abilità importanti e fondamentali, quali il linguaggio,
l'attenzione, la cognizione spazio-temporale e la memoria.
Quello del riabilitatore cognitivo in età evolutiva è un compito complesso, perché richiede oltre
alla capacità di modulare progressivamente la terapia neuropsicologica, anche il ruolo di
coordinare le figure significative che interagiscono con il bambino, la famiglia e la scuola. Definizioni e citazioni: Un grave disturbo nei bambini affetti da autismo è l’ultraselettività dello stimolo, che rappresenta l’incapacità di utilizzare tutti i suggerimenti provenienti dall’ambiente esterno. Eventuali rimandi ad altri testi o autori: Ciesielski, Lovaas Eventuali note o commenti:

Multimedialità e Apprendimento
49
SCHEDA BIBLIOGRAFICA
N° rif. C1 (indice ragionato)
TESTO ESAMINATO
Autore: Mario Martinelli
Titolo del libro: L'handicap in classe. Tra individualizzazione e
programmazione
CASA EDITRICE: La Scuola
CITTA’: Brescia
ANNO: 1998
Concetto: L’argomento principale del libro è l’integrazione delle diversità nella scuola dell’autonomia, ed
i temi e problemi ad essa connessi, al fine di acquisire conoscenze, competenze,
comportamenti, metodi e strumenti di lavoro per affrontare la pratica dell’insegnamento in
situazioni caratterizzate da bisogni educativi speciali. Il testo è organizzato in una prima parte
introduttiva, una seconda dedicata alla continuità orizzontale e verticale ed all’accoglienza, in
cui vengono descritti gli organi e gli enti utili alla formazione della comunità di sostegno ai fini
dell’integrazione. L’ultima parte presenta due esperienze differenti. Definizioni e citazioni: “…il deficit…può anche ritenersi difficilmente modificabile…è sul lato handicap che, invece ci
si può e ci si deve impegnare per ottenere miglioramenti significativi” Eventuali rimandi ad altri testi o autori: Piaget, Vygotskij Eventuali note o commenti:

Multimedialità e Apprendimento
50
SCHEDA BIBLIOGRAFICA
N° rif. C2 (indice ragionato)
TESTO ESAMINATO
Autore: Marisa Pavone
Titolo del libro: Personalizzare l’integrazione
CASA EDITRICE: La Scuola
CITTA’: Brescia
ANNO: 2004
Concetto: Il libro si propone di evidenziare una rinnovata spinta di qualità al cammino dell’inclusione,
attraverso alcuni dispositivi: i piani di studio personalizzati; la differenziazione e la flessibilità
sul piano didattico, metodologico, organizzativo; l’integrazione tra i segmenti scolastici, con le
famiglie e con le istituzioni dell’extrascuola.
Il testo si sviluppa in tre parti. Nella prima viene analizzato il concetto di persona, la
prospettiva evolutiva e il nuovo strumento di classificazione delle condizioni di salute e
disabilità da cui scaturiscono nuove indicazioni per la formulazione delle diagnosi e per la
progettazione educativa. Nella seconda parte si prende in esame il funzionamento della scuola-
comunità di apprendimento impegnata ad accogliere, conoscere ed accompagnare ogni
studente. L'ultima parte guarda alla prospettiva del futuro, illustrando le caratteristiche di un
progetto educativo personalizzato che si orienta nell’ottica del progetto di vita. Definizioni e citazioni: Concetto di educabilità: Essere educabile significa apertura alla possibilità di orientarsi verso
una propria meta. La possibilità di migliorare, proponendo all’allievo una difficoltà maggiore
per migliorare, intesa come concetto di progetto di assistenza adeguato alle sue possibilità
anche in presenza di minorazione o malattia. Eventuali rimandi ad altri testi o autori: Eventuali note o commenti:

Multimedialità e Apprendimento
51
SCHEDA BIBLIOGRAFICA
N° rif. C3 (indice ragionato)
TESTO ESAMINATO
Autore: AA.VV.
Titolo del libro: Handicap e Scuola: l’integrazione possibile
CASA EDITRICE: Gruppo Solidarietà
CITTA’: Brescia
ANNO: 1998
Concetto: Il volume fa il punto sullo stato dell’integrazione scolastica degli handicappati ad oltre venti
anni dalle prime normative e a dieci dalla sentenza della Corte Costituzionale che sancisce il
diritto alla frequenza anche nella scuola superiore; analizza, in particolare, i problemi che
vengono posti all’integrazione dalle situazioni di gravità verificando quali condizioni
permettono di realizzare un ambiente disponibile all’accoglienza. Tra i temi affrontati nel
volume: l’integrazione nella scuola di tutti: conquiste definitive e problemi aperti; le novità
delle riforme (autonomia scolastica, disegno di legge sulla parità...); gravità e irrecuperabilità;
la qualità dell’integrazione: come costruirla, come valutarla; quale didattica; diagnosi
funzionale, profilo dinamico, piano educativo individualizzato; rapporto tra scuola e servizi
socio-sanitari; il ruolo della famiglia. Definizioni e citazioni: Diagnosi Funzionale, Profilo Dinamico Funzionale e Piano Educativo Individualizzato.
Eventuali rimandi ad altri testi o autori: Mariangela Giusti, Dario Ianes, Marisa Pavone, Mario Tortello, Riziero Zucchi. Eventuali note o commenti:

Multimedialità e Apprendimento
52
SCHEDA BIBLIOGRAFICA
N° rif. C4 (indice ragionato)
TESTO ESAMINATO
Autore: Salvatore Nocera
Titolo del libro: Il diritto all’integrazione nella scuola dell’autonomia
CASA EDITRICE: Erickson
CITTA’: Trento
ANNO: 2001
Concetto: Il volume propone un approfondito studio sull’analisi della normativa italiana sull’integrazione
scolastica degli alunni in situazione di handicap, ed è suddiviso in quattro aree tematiche.
La prima parte dell’opera ripercorre criticamente il cammino seguito dalla normativa
sull’integrazione nella scuola italiana, dalle origini sino a oggi. La seconda analizza le
prospettive dell’integrazione scolastica alla luce delle profonde innovazioni normative degli
ultimi anni tra cui l’autonomia. La terza parte del lavoro si focalizza sugli strumenti operativi
che possono fare da supporto all’integrazione. Infine, l’ultima parte, redatta da Andrea
Canevaro, si compone di due interviste ad altrettante figure chiave dell’integrazione scolastica
del nostro Paese. Definizioni e citazioni: Art. 13 legge 104/92: L’integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle
classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, …, anche
attraverso… sussidi tecnici e didattici specifici… Eventuali rimandi ad altri testi o autori: Eventuali note o commenti: