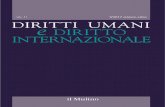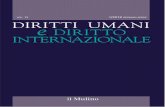Cataldi
description
Transcript of Cataldi

Luigi Cataldi Madonna
L’ontologia sperimentale di Christian Wolff*
0. Premessa
In questo articolo tenterò di mostrare che l’ontologia wolffiana non è un’ontolo-gia formale, come le è stato abitualmente rimproverato, ma è un’ontologia speri-mentale1, basata sull’interpretazione della coscienza come attività sperimentalein grado di determinare l’affidabilità delle percezioni, esterne e interne. Questaontologia è ovviamente un ingrediente fondamentale del progetto wolffiano di co-stituire una filosofia sperimentale universale2.
Nel primo paragrafo considero il posto dell’ontologia nel sistema metafisicowolffiano e l’opportunità di affiancare al solito approccio logico un approcciopsicologico che mostra meglio del primo l’aderenza dell’ontologia wolffiana allarealtà. Nel secondo paragrafo discuto la nozione di esperienza mentale che Wolffmette a fondamento del principio di contraddizione. Proprio questa esperienzapsicologica rappresenta l’autentico punto di partenza per l’indagine metafisicae garantisce la referenzialità della nostra conoscenza. Nel terzo paragrafo pren-do in considerazione la distinzione tra necessario e contingente e la distinzionetra necessità assoluta e necessità ipotetica. In questo contesto merita particola-re attenzione il tentativo wolffiano di separare la certezza dalla necessità. L’ulti-mo paragrafo è dedicato alla concezione wolffiana dell’esistenza come comple-
«Quaestio», 9 (2009), 253-268 • 10.1484/J.QUAESTIO.1.100705
* Le opere di C. WOLFF vengono citate secondo l’edizione dei Gesammelte Werke (d’ora in poi GW),hrsg. v. J. École, H.W. Arndt, Ch.A. Corr, J. Hoffmann, M. Thomann, Olms, Hildesheim-New York 1962-2001. La Deutsche Metaphysik e le relative Anmerkungen sono citate secondo la traduzione di R. CIAFAR-DONE, Metafisica tedesca con le Annotazioni alla Metafisica tedesca, Bompiani, Milano 2003.
1 «Pertinent haec examina ad Ontologiam experimentalem, atque idcirco de iis uberius dicemus,quando ex instituto in his Horis subsecivis docebimus, quomodo philosophia experimentalis ultra arctosejus limites ad quamcunque philosophiae partem sit extendenda». WOLFF, Horae subsecivae Marburgen-ses, vol. I, p. 345.
2 «eidem tamen locus est in omni philosophia, ipsa Theologia naturali. Quamobrem aliquoties me jammonuisse memini, quod detur etiam Theologia naturalis experimentalis, immo philosophia experimenta-lis ad omnes omnino philosophiae partes extendatur». WOLFF, Psichologia empirica, § 459.

254 Luigi Cataldi Madonna
mentum possibilitatis. Questa concezione è una tappa importante di quel pro-cesso di rinnovamento dell’ontologia che portò alla desistenzializzazione dell’es-senza.
1. Il posto dell’ontologia
L’ontologia occupa una posizione centrale nella filosofia wolffiana. Insieme allacosmologia, alla psicologia e alla teologia naturale essa costituisce la Metafisi-ca tedesca3, ovvero la metafisica che funzionò da modello incontrastato per ilpensiero europeo del Settecento fino alla Dialettica trascendentale, dove co-munque diventa l’oggetto principale della critica kantiana. Persino dei criticidella metafisica insospettabili come gli enciclopedisti attingono volentieri e spu-doratamente dalle opere wolffiane nel comporre le voci di natura metafisica del-l’Enciclopédie4.
Wolff pretende che le scienze debbano essere organizzate secondo un ordineben preciso che impone di far precedere ciò grazie al quale il seguente vienecompreso e dimostrato5. Così le scienze che contengono i principi dovranno ve-nir prima delle scienze che invece li mutuano dalle prime6. Questo è lo stessoordine che deve seguire l’esposizione delle dottrine filosofiche7. Poiché l’onto-logia è la scienza dell’ente in generale o delle proprietà generali dell’ente, ov-vero «di ciò che è comune a ogni ente», essa sta a fondamento non solo della me-tafisica, ma anche di tutto il sistema delle scienze ed è perciò chiamata anche«filosofia prima»8.
Wolff descrive così chiaramente questa concezione nel Discursus praelimi-naris de philosophia in genere (1728) da non dare adito a dubbi. C’è solo un ec-cezione all’ordine che Wolff attribuisce all’albero delle scienze: la logica, pur de-rivando i suoi principi dall’ontologia e dalla psicologia9, deve essere trattata pri-ma di tutte le altre scienze: «primo omnium loco pertractanda»10. L’eccezionetuttavia è soltanto apparente. La diversa prospettiva nella successione ontolo-
3 WOLFF, Deutsche Metaphysik, § 99.4 Cf. a riguardo il bel saggio di S. CARBONCINI, Lumière e Aufklärung. A proposito della presenza della
filosofia di Christian Wolff nell’Encyclopédie, «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», classe diLettere e Filosofia, serie III, vol. XIV/4, 1984, pp. 1297-1335.
5 WOLFF, Discursus praeliminaris, § 113.6 WOLFF, Discursus praeliminaris, § 87.7 WOLFF, Discursus praeliminaris, § 115.8 WOLFF, Discursus praeliminaris, § 73.9 WOLFF, Discursus praeliminaris, § 89.10 WOLFF, Discursus praeliminaris, § 88.

L’ontologia sperimentale di Christian Wolff 255
gia/logica dipende dal contesto diverso: nel contesto della giusticazione l’onto-logia precede la logica, ma nel contesto della scoperta è la logica a precederel’ontologia. Per Wolff il primum cognoscendi non coincide con il primum essen-di: ordine della conoscenza e ordine dell’essere sono piani paralleli, ma non spe-culari, la cui linea di demarcazione è la coscienza, assente nel piano implicitodell’essere. In Wolff l’arte della giustificazione è basata quasi esclusivamentesulla teoria della dimostrazione, ma l’ars inveniendi è un metodo che, pur se ba-sato sulla dimostrazione e sulla conseguenza logica, contempla anche inferenzenon deduttive e probabilistiche, considerazioni matematiche e combinatorie gra-zie alle quali questa ars dovrebbe guidare e potenziare i giochi associativi e lecombinazioni semantiche dell’immaginazione.
Comunque logica e ontologia condividono i principi fondamentali – il prin-cipio di contraddizione e il principio di ragion sufficiente – e molti concetti on-tologici presentano una chiara parentela con la logica. Quindi l’approccio logi-co all’ontologia wolffiana è legittimo. Ma non è legittimo averlo ritenuto l’unicopossibile. Ce n’è almeno un altro meno evidente, ma allora certamente più in-novativo sul quale la storiografia ha richiamato l’attenzione soprattutto recente-mente: l’approccio psicologico11. Anzi l’approccio psicologico sembrerebbeprioritario. Infatti la logica deriva i suoi principi non solo dall’ontologia, ma an-che dalla psicologia, soprattutto quelli riguardanti le operazioni delle facoltà co-gnitive12.
I concetti dell’ontologia wolffiana non sono vuoti, come potrebbe indurre apensare la chiave di lettura logica, proprio perché la loro materia è fornita pre-valentemente da contenuti psicologici acquisiti attraverso l’esperienza mentale.In altre parole è la psicologia che sostanzia l’apparato concettuale dell’ontolo-gia. Da questo punto di vista l’ontologia wolffiana acquisisce un significato e unaconfigurazione diversi. Comunque essa perde quel «carattere generalissimo,astratto e formale» che gran parte della storiografia – soprattutto filokantiana efiloidealistica – le aveva contestato13.
Mentre l’ontologia si occupa del generale, la psicologia assicura il suo ag-gancio con il particolare e con l’esperienza, che rappresenta per Wolff l’unicoinizio possibile di ogni forma di conoscenza (empirica o razionale). La simboliz-
11 Cf. p. es.: P. KOBAU, Essere qualcosa. Ontologia e psicologia in Wolff, Trauben, Torino 2004; O.-P.RUDOLPH / J.-F. GOUBET (Hrsg.), Die Psychologie Christian Wolffs. Systematische und historische Untersu-chungen, Niemeyer, Tübingen 2004; F.L. MARCOLUNGO (a cura di), Christian Wolff tra psicologia empiricae psicologia razionale, GW, III/106, Wolffiana III, 2007.
12 WOLFF, Discursus praeliminaris, § 89.13 M. CAMPO, Cristiano Wolff e il razionalismo precritico, Vita e Pensiero, Milano 1939, p. 197. Em-
blematica di questa prospettiva è la dura critica di Mariano Campo al mentalismo di Wolff. RingrazioGualtiero Lorini per aver richiamato la mia attenzione su questo aspetto della sua interpretazione.

256 Luigi Cataldi Madonna
zazione del singolare inizia invece più tardi, con la libera attività dell’immagi-nazione controllata e guidata dall’intelletto14. L’intelletto si serve di due fornito-ri per i suoi concetti: l’oculus corporis e l’oculus mentis15, ovvero l’occhio del sen-so esterno e quello del senso interno16. Non c’è altro modo di accedere alla ma-teria per la concettualità wolffiana: i contenuti derivano sempre dall’esperien-za17, la ragione riguarda soltanto le possibili connessioni di questi contenuti:«Ratio est facultas nexum veritatum universalium intuendi seu perspiciendi»18.
2. Esperienza mentale e contraddizione
Il punto di massima congiunzione tra ontologia e psicologia – e al tempo stessomodello del connubio tra ragione ed esperienza – è l’interpretazione del princi-pio di contraddizione. Nel § 27 della Ontologia Wolff mette a fondamento di que-sto principio una peculiare esperienza mentale che può essere intesa come unaversione psicologica del cogito19: «Eam experimur mentis nostrae naturam, ut,dum ea judicat aliquid esse, simul judicare nequat, idem non esse». Questaesperienza mentale rappresenta per Wolff l’attività originaria e fondamentaledell’anima: «experientia, ad quam hic provocamus, obvia est, ut alia magis ob-via censeri nequeat: ea enim presto est, quamdiu mens sui sibi conscia». Pro-prio questa esperienza mentale accompagna ogni nostra percezione (esterna ointerna) ed è il fondamento della coscienza dell’impossibilità di percepire unostato di cose diversamente da come lo si percepisce. Essa ci consente di identi-ficare il contenuto percettivo ed è proprio da questa identificazione che ha ori-gine la conoscenza.
L’identificazione dei contenuti di coscienza è resa possibile dal connubio trail flusso determinato dal coesistere e dal succedersi delle sensazioni e l’espe-
14 WOLFF, Logica latina, § 665.15 WOLFF, Logica latina, § 146.16 WOLFF, Logica latina, §§ 30-31.17 «In philosophia itaque principia ab experientia derivando, quae demonstrantur experimentis ac ob-
servationibus confirmanda & cognitioni mathematicae una opera danda est» (WOLFF, Discursus praelimi-naris, § 34).
18 WOLFF, Psichologia empirica, § 483.19 Già Descartes usa qualche volta le espressioni “experientia” o “experimentum mentis” per riferir-
si al cogito e all’intuizione; cf. a riguardo H.W. ARNDT, Metodo scientifica pertractatum. Mos geometricusund Kalkülbegriff in der philophischen Theorienbildung des 17. und 18. Jahrhunderts, De Gruyter, Berlin-New York 1971, p. 61. Tschirnhaus considera il cogito il «primo principio, o prima esperienza», «di cuiio faccio esperienza in me stesso, e che non posso assolutamente neanche negare»; E.W. von TSCHIRNHAUS,Medicina mentis, sive artis inveniendi praecepta generalia (Lipsiae 1695), tr. it. di M. Sanna, Guida, Na-poli 1987, p. 401.

L’ontologia sperimentale di Christian Wolff 257
rienza mentale basata sull’impossibilità di concepire diversamente il contenutopercepito. Questo connubio consente di produrre interruzioni nel flusso di co-scienza e di determinarne i segmenti individuando e precisando i loro contorni.Quindi il connubio, tanto invocato da Wolff e posto a fondamento di tutto il suopensiero, si realizza già nella prima fase della conoscenza: la fase della sempli-ce apprensione. Questa identificazione dei contenuti di coscienza sta alla basedella concezione wolffiana del riferimento linguistico e della costruzione sim-bolica20. Infatti l’atto di identificazione si perfeziona e si consolida attraversol’imposizione di segni agli stati di cose individuati nel flusso della coscienza.Proprio grazie a questa capacità di simbolizzare le sensazioni private dando lo-ro un nome si arriva alla conoscenza generale. Generalizzare per Wolff non è al-tro che simbolizzare, ovvero fare in modo che qualcosa sia il segno di qualchealtra cosa. E non è certo un caso che uno dei capitoli dell’Ontologia sia dedica-to proprio alla natura dei segni.
L’esperienza mentale dell’impossibilità di percepire un contenuto diverso daquello che effettivamente si percepisce ricorre spesso negli esempi wolffiani:«Solem lucere cognoscimus ad ea attenti, quae visu percipimus. Unde esperien-tia constare dicitur, quod Sol luceat. Similiter ad nosmet ipsos attenti cognosci-mus, nos non posse assensum praebere contradictoriis, v. gr. non posse sumeretanquam verum, quod simul pluat, vel non pluat»21. Il ricorso a un esempio em-pirico, l’esperienza della luce del sole (o della pioggia) mostra che Wolff consi-dera questa esperienza mentale come fondamentale ed efficace rispetto a tutti icontenuti percettivi, di qualsiasi natura essi siano (empirici o razionali). Tutte lepercezioni, esterne o interne, devono essere passate al vaglio di questa espe-rienza per essere ammesse come conoscenze: tutte derivano «ex propriis expe-rimentis, in seipso [...] factis»22, da «experimento in te ipso facto»23. È proprioquesta esperienza a consentire l’applicazione del principio di contraddizione aicontenuti concreti e ad assicurare la certezza della loro identificazione, ponen-doli così al di fuori di ogni dubbio. L’esperienza mentale serve a mettere il con-tingente sotto la protezione e la capacità determinante del supremo principiodell’ontologia, che è il custode e la fonte di ogni certezza: «quo posito, poniturcertitudo in cognizione humana; quo sublato, tollitur omnis certitudo»24. Quin-
20 Riguardo al rapporto tra identificazione e riferimento linguistico cf. J.R. SEARLE, Speech Acts: AnEssay in the Philosophy of Language, Cambridge University Press, Cambridge 1969, tr. it. di G.R. Car-dona, Bollati Boringhieri, Torino1992.
21 WOLFF, Logica, § 664.22 WOLFF, De Voluptate ex Virtute percipienda, in Horae subsecivae Marburgenses, vol. II, p. 60.23 WOLFF, Psichologia empirica, § 79.24 WOLFF, Ontologia, § 55

258 Luigi Cataldi Madonna
di questa rappresentazione sperimentale della coscienza funziona come un tri-bunale per qualsiasi esperienza possibile.
Grazie a questa esperienza mentale il soggetto epistemico percepisce la suaimpotenza rispetto a un mondo assolutamente indipendente, che oppone resi-stenza a ogni nostro tentativo di modificare lo stato di cose percepito. La faticapsichica legata a questo sforzo consente di considerare questa esperienza men-tale non come una semplice esperienza che accade di per sé e per la quale si ri-chiede solo l’attenzione alle nostre percezioni25. Questo tipo di esperienza men-tale sembra avvicinarsi piuttosto alla nozione di esperimento, dato che la realiz-zazione degli esperimenti al contrario delle esperienze dipende dal nostro inter-vento, dal nostro sforzo26. Wolff le riconosce comunque una connotazione speri-mentale e mette proprio questa nozione di esperienza alla base del suo progettonon solo di un’ontologia sperimentale, ma anche di una filosofia sperimentaleuniversale. La conoscenza viene concepita da Wolff come un’azione e non comeuna visione; il vedere non è altro che uno sperimentare.
Ora può sorprendere il fatto che Wolff consideri questa esperienza mentalecome il «Fundamentum principii contradictionis»27, cioè come il fondamento diun principio indimostrabile riguardo al quale è perciò impossibile concepirequalcosa di più fondamentale. Qualche anno più tardi, nella Psichologia empi-rica, questa stessa esperienza sarà considerata prima «Fundamentum cognitio-nis exixtentiae animae»28 e poi «Principium cognoscendi» della propria esi-stenza29. E la certezza di questo fondamento risulterebbe cartesianamente pro-prio dall’esercizio del dubbio30.
Il progetto wolffiano di una filosofia sperimentale universale, che dovrebbecombinare la funzionalità dell’anima con i dati empirici provenienti dal mondoesterno o dall’anima stessa, si basa proprio sulla convinzione che la coscienzaeserciti un continuo controllo dei contenuti risultanti da questa attività speri-mentale e ne garantisca la certezza. Questa rappresentazione sperimentale del-la coscienza consente a Wolff di estendere l’arte sperimentale oltre l’ambito del-la sola fisica: «ceterum experimentatio posset quoque ad omnem philosophiam
25 Per quanto riguarda i diversi significati di esperienza in Wolff cf. il mio saggio Erfahrung und In-tuition in der Philosophie von Christian Wolff, in J. STOLZENBERG / O.-R. RUDOLPH (Hrsg.), Christian Wolffund die europäische Aufklärung (Akten des 1. Internationalen Christian Wolff - Kongresses, 2004), GW,III, Wolffiana II.2, 2007, pp. 173-193.
26 «Experientia, quae versatur circa facta naturae, quae nonnisi interveniente opera nostra contin-gunt». WOLFF, Psychologia empirica, § 456; cf. anche Anmerkungen, § 99.
27 WOLFF, Ontologia, § 27.28 «Nos esse nostri rerumque aliarum extra nos constitutarum conscios quovis momento experimur».
WOLFF, Psichologia empirica, § 11.29 WOLFF, Psichologia empirica, § 13.30 WOLFF, Psichologia empirica, § 12.

L’ontologia sperimentale di Christian Wolff 259
reliquam estendi, atque sic Philosophiae experimentalis notio amplior evaderet,quam ubi vulgo ad solam Physicam experimentalem nomen istud restringitur»31.
Ora com’è possibile che Wolff metta un’esperienza a fondamento del princi-pio supremo della sua ontologia? Anche in questo caso Wolff non deroga dai suoiprincipi epistemologici: la conoscenza, di qualsiasi genere essa sia, deve sem-pre prendere l’avvio da esperienze, da cose singolari. Così proprio un’esperien-za, una conoscenza singolare ci permette di conoscere l’universalità del princi-pio di contraddizione32. Evidentemente bisogna fare attenzione nel valutare ilruolo fondante di questa esperienza mentale. Poiché il principio di contraddi-zione è un principio indimostrabile, questa esperienza mentale rappresenterà si-curamente il suo fondamento epistemico, ma non quello logico. Il principio dicontraddizione non può certamente derivare da questa esperienza mentale, an-che se soltanto quest’ultima ce ne fa conoscere l’esistenza e l’efficacia. In altreparole senza questa esperienza mentale sarebbe impossibile conoscere e am-mettere «sine probatione»33 l’universalità e la necessità del principio di con-traddizione.
Come abbiamo già detto (§ 1), nella filosofia wolffiana ordo cognoscendi e or-do essendi procedono paralleli, ma in direzioni inverse: epistemologicamente ilfundamentum è l’esperienza mentale, mentre ontologicamente il fundamentumè il principio di contraddizione. Tra i due fondamenti sussiste una parentela so-stanziale. In effetti quest’esperienza mentale non è altro che un’applicazione34,o meglio una psicologizzazione del principio di contraddizione. Detto in altre pa-role: la necessità ontologica dipende epistemologicamente dalla necessità spe-rimentata, subita dal soggetto. L’intenzione di Wolff in questo caso è chiara: l’e-sercizio continuo di questa esperienza mentale avrebbe dovuto dimostrare la fer-tilità epistemica del principio di contraddizione, ovvero la sua capacità di con-tribuire anche alla crescita del sapere e non soltanto alla determinazione dellasua consistenza logica.
31 WOLFF, Discursus praeliminaris, § 107.32 Questo approccio al principio di contraddizione non è molto differente da quello adottato da Locke
(cf. ivi anche nota 70) .33 WOLFF, Ontologia, § 28.34 Leibniz fa questa osservazione riguardo agli esempi di conoscenza intuitiva addotti da Locke. La
conoscenza intuitiva non sarebbe altro che «una sussunzione o applicazione del principio di contraddi-zione a ciò che l’intelletto fornisce per se stesso»: Nouveaux Essais sur l’entendement (Amsterdam-Leip-zig 1765), in Opere filosofiche, tr. it. di M. Mugnai e E. Pasini, Utet, Torino 2000, vol. II, I, I, § 18, p. 59.Per Leibniz «la massima generale...è il “principio”, mentre “la negazione” d’un’idea di un’altra opposta[...] ne è l’applicazione». LEIBNIZ, Nouveaux Essais, tr. it. cit., vol. II, I, I, § 18, p. 59.

260 Luigi Cataldi Madonna
3. Necessità, contingenza e certezza
Malgrado il tentativo di dimostrare il principio di ragion sufficiente35, la contin-genza resta sempre per Wolff qualcosa di irriducibile alla necessità. Questa con-vinzione è incontestabile e pervade tutta la sua opera, ma non si può negare chela dimostrazione del principio di ragion sufficiente sembra mettere in pericolol’autonomia della contingenza. Tuttavia la dimostrazione wolffiana è un effettivopunto debole soltanto se viene considerata separatamente dall’istanza wolffianadi salvaguardare la contingenza e l’esperienza, come hanno fatto purtroppo mol-ti avversari di Wolff – tutti legati più o meno al pietismo – tra i quali primeggia-no Crusius e Kant. Con la dimostrazione del principio di ragion sufficiente Wolffvuole salvaguardare la verità e l’efficacia di un principio, allora molto contro-verso, grazie al quale si poteva sancire la reciproca connessione spazio-tempo-rale tra gli enti nel mondo36 e, quindi, l’unicità del mondo37.
Wolff intende l’impresa scientifica come un continuo reddere rationem deglieventi reali e perciò bisognava poter invocare un principio che assicurasse l’e-sercizio continuo di questa attività razionalizzante. Ora proprio il principio di ra-gion sufficiente garantisce la relazione di conseguenza tra i pensieri e la rela-zione di causalità tra gli enti. Il suo riferimento al principio di contraddizione,da cui dipende ogni certezza, avrebbe assicurato che ogni proposizione empiri-ca fosse posta «ausser allen Zweifel»38.
La distinzione tra necessità e contingenza mostra in modo inequivocabilel’autonomia che il contingente gode nel sistema wolffiano. La nozione di im-possibilità, intesa come ciò che implica contraddizione39, gioca un ruolo pri-mario nell’elaborazione dei concetti ontologici e aiuta a modellare anche la no-zione di necessità: qualcosa è necessario se la sua negazione è impossibile oimplica contraddizione40; in questo caso è anche immutabile41. Il contingente,invece, viene definito come ciò la cui negazione è possibile – ovvero non im-plica contraddizione42 – e come mutabile43. Poiché le essenze non sono altro
35 Anche Leibniz tentò di dimostrare il principio di ragion sufficiente, ma, più prudente di Wolff, nonpubblicò la sua dimostrazione e non fece, pare, altri tentativi; cf. l’Anhang in R. ZOCHER, Leibniz’ Erkennt-nislehre, De Gruyter, Berlin 1952.
36 WOLFF, Deutsche Metaphysik, §§ 543-548.37 WOLFF, Deutsche Metaphysik, § 549.38 WOLFF, Deutsche Metaphysik, § 10.39 WOLFF, Ontologia, § 79.40 WOLFF, Ontologia, § 279.41 WOLFF, Ontologia, §§ 292-293.42 WOLFF, Ontologia, § 294.43 WOLFF, Ontologia, § 296.

L’ontologia sperimentale di Christian Wolff 261
che possibilità44 sono anche necessarie45, ma sono sempre contingenti riguar-do alla loro realtà46; ovvero «la realtà degli enti non appartiene alla loro es-senza»47. Esse sono fondate nell’intelletto divino, ma non sono creazioni diDio48. Nel regno delle essenze l’intelletto divino non può cambiare nulla «a suopiacimento»49. Le essenze dipendono da Dio soltanto perché qualcosa per es-sere possibile deve essere «rappresentato dall’intelletto divino»50.
Mentre l’ente necessario – cioè Dio – ha nella sua essenza la ragione suffi-ciente della propria esistenza51 ed è quindi assolutamente indipendente; l’entecontingente non ha la ragione sufficiente della sua esistenza nella sua essenza52
e dipende perciò da qualcos’altro. Ricorrendo all’argomento leibniziano deimondi possibili Wolff fa dipendere l’esistenza del contingente dalla libera scel-ta di Dio, condizionata soltanto dal suo calcolo – di natura probabilistica, ma conrisultati assolutamente certi –, dei gradi di perfezione degli infiniti mondi pos-sibili53. Wolff paragona il necessario ai numeri razionali, interamente scompo-nibili fino ai loro elementi ultimi, e il contingente ai numeri irrazionali, scom-ponibili invece all’infinito54. Anzi, per evitare qualsiasi dubbio riguardo alla ne-cessità di tenere rigorosamente distinti il necessario e il contingente, Wolff ag-giunge un’affermazione che non ammette repliche: «se si ritengono identici ilnecessario e il contingente, è come se in matematica si volesse considerare iden-tici numeri razionali e numeri irrazionali»55. Nemmeno Dio può modificare o an-nullare la natura del contingente56. Nella filosofia wolffiana il contingente oc-cupa uno spazio ontologico inviolabile.
Wolff distingue tra una necessità assoluta che deriva dall’essenza dell’entee una necessità ipotetica che «ha la ragione della [sua] necessità fuori di sé»57.
44 WOLFF, Deutsche Metaphysik, § 35.45 WOLFF, Ontologia, § 303.46 WOLFF, Deutsche Metaphysik, § 576.47 WOLFF, Deutsche Metaphysik, § 544.48 WOLFF, Deutsche Metaphysik, § 40 e §§ 975-976.49 WOLFF, Deutsche Metaphysik, § 994.50 WOLFF, Deutsche Metaphysik, § 975.51 WOLFF, Ontologia, § 309.52 WOLFF, Ontologia, § 310.53 WOLFF, Deutsche Metaphysik, §§ 980-82 e § 984.54 WOLFF, Deutsche Metaphysik, § 580.55 WOLFF, Deutsche Metaphysik, § 581.56 WOLFF, Deutsche Metaphysik, §§ 969-970.57 WOLFF, Deutsche Metaphysik, § 576; cf. anche Ontologia, § 315. Cf. a riguardo R. CIAFARDONE, Ne-
cessitas absoluta e necessitas hypothetica nella concezione wolffiana del mondo, in L. CATALDI MADONNA
(Hrsg.), Macht und Bescheidenheit der Vernunft. Beiträge zur Philosophie Christian Wolffs. Gedenkband fürHans Werner Arndt, GW, III/98, 2005, pp. 171-183.

262 Luigi Cataldi Madonna
Se la necessità non è implicata nell’essenza di qualcosa, allora è ipoteticamen-te necessario che questo qualcosa sia in questo modo piuttosto che in un altro58.Alla necessità assoluta ripugna ovviamente la contingenza59, che invece sembraidentificarsi con la necessità ipotetica: «quod hypothetice necessarium est, in secontingens est»60. Così la serie dei contingenti, che costituiscono il mondo at-traverso la loro reciproca determinazione, non contiene la ragione sufficiente delperché sia così e non altrimenti61 e, perciò, può essere soltanto ipoteticamentenecessaria62. Quindi al regno delle essenze spetta la necessità assoluta, mentreal mondo delle realtà compete soltanto la necessità ipotetica, fondata nel nessoattuale delle cose63.
Per consolidare la posizione e l’autonomia della necessità ipotetica la certez-za viene svincolata dalla necessità assoluta. Wolff cerca di persuaderci che l’in-dubitabilità non deve essere considerata più un contrassegno essenziale dellacertezza, come voleva invece Descartes. L’emancipazione della certezza dalla ne-cessità, cioè dall’impossibilità del dubbio, permetteva la sua utilizzazione ancheper il regno dei contingenti, che restano comunque dubitabili perché la loro ne-gazione è sempre possibile. Anzi necessità ipotetica e certezza tendono ad iden-tificarsi e insieme al contingente costituiscono una triade indissolubile. SecondoWolff la necessità ipotetica non meriterebbe nemmeno il nome di necessità pro-prio perché la sua negazione non implica contraddizione – come invece richie-derebbe la definizione della necessità – e «dovrebbe essere chiamata soltantocertezza»64; ma «la certezza non rende assolutamente necessario un ente»65.Quindi la certezza non deve riguardare più soltanto gli enti assolutamente neces-sari, ma può riguardare anche gli enti contingenti e le proposizioni empiriche.
La concezione delle proposizioni indubitate ci aiuta a capire meglio le in-tenzioni di Wolff per il quale sembrano esistere due specie di certezza: una cer-tezza indubitabile e una certezza indubitata. La prima, più forte, è prodotta dal-l’impossibilità del dubbio; la seconda, più debole, è prodotta dalla semplice as-senza del dubbio. Tuttavia, pur se la certezza indubitabile ha uno stato modalepiù forte di quella indubitata, Wolff evita di rimarcare le rispettive differenze etende a considerarle identiche66. È probabile che in questo caso abbia giocato
58 WOLFF, Ontologia, § 320.59 WOLFF, Ontologia, § 317.60 WOLFF, Ontologia, § 318.61 WOLFF, Ontologia, § 322. 62 WOLFF, Ontologia, § 323.63 WOLFF, Deutsche Metaphysik, §§ 574-575.64 WOLFF, Deutsche Metaphysik, § 578.65 WOLFF, Deutsche Metaphysik, § 564.66 Riguardo alle ragioni di questa mancata differenziazione cf. il mio articolo Wahrscheinlichkeit und

L’ontologia sperimentale di Christian Wolff 263
un ruolo l’idea – allora abbastanza diffusa – che la negazione di tutti i contraridi una proposizione possa equivalere alla negazione della sua contraddittoria.Ovviamente questa convinzione funziona solo se la classe dei contrari è una clas-se finita. Comunque l’omissione di questa condizione potrebbe essere stata qual-che volta anche intenzionale per evitare una frattura eccessiva tra il regno delnecessario e il regno del contingente.
Come abbiamo già visto (§ 2) il principio di contraddizione è per Wolff la fon-te di ogni certezza. Nel § 10 della Deutsche Metaphysik Wolff sostiene che gra-zie al principio di contraddizione non solo una proposizione necessaria «ma an-che una proposizione di cui facciamo esperienza è posta al di fuori di ogni dub-bio, allo stesso modo in cui, nel nostro caso, esperiamo proprio questo, che cioèsiamo coscienti di noi stessi». L’esperienza della nostra coscienza è intesa, car-tesianamente, come il modello di tutte le proposizioni che il principio di con-traddizione riesce a porre «ausser allen Zweifel»; e questa funzione riguarda tut-te le proposizioni: razionali ed empiriche.
Cerchiamo di chiarire meglio questa concezione. Prendiamo ad esempio unaproposizione indimostrabile (a) «il triangolo ha tre angoli» e la proposizione em-pirica (b) «ora il sole splende». Per constatare l’impossibilità della negazione di(a) basta fare attenzione ai termini stessi della proposizione: «terminis intellec-tis patet»67. L’unica possibilità per noi per sottrarci alla sua imposizione è di-strarre da essa la nostra attenzione: bendare il nostro oculus mentis. Tuttavia sei sensi sono sani e se la connessione e il corso delle cose non muta (quindi subconditione), non possiamo sottrarci nemmeno all’imposizione di (b). Nel mo-mento in cui noi esperiamo lo stato di cose “il sole splende”, anche la negazio-ne della proposizione (b) è impossibile. La sola possibilità di sottrarci ad essa èquella di chiudere gli occhi: bendare l’oculus corporis.
Quindi l’unica vera differenza tra le due proposizioni è l’assenza del riferi-mento temporale in (a), che è invece presente in (b). La certezza di (a) vale intutti i mondi possibili; la certezza di (b) vale soltanto nel nostro mondo e soltan-to nel momento in cui viene esperito lo stato di cose che descrive. Ma la forzadell’ imposizione degli stati di cose che descrivono (a) e (b) è la stessa: in en-trambi i casi noi esperiamo una ripugnanza alla loro negazione. Soltanto chel’impossibilità della negazione di (b) è necessariamente connessa all’istanta-neità dell’esperienza di (b). Quindi nel caso delle proposizioni empiriche l’effi-
wahrscheinliches Wissen in der Philosophie von Christian Wolff cit., pp. 117-120. P. es. troviamo questaconcezione esplicita in Crusius per il quale la «propositio contradictoria alle contrarias unter sich fasset»:Ch.A. CRUSIUS, Weg zur Gewißheit und Zuverläßigkeit der menschlichen Erkenntniß (Leipzig 1747), rist.anast. in Die philosophischen Hauptwerke, hrsg. v. G. Tonelli, Olms, Hildesheim 1965, vol. III, § 442; cf.anche § 367.
67 WOLFF, Logica latina, § 262.

264 Luigi Cataldi Madonna
cacia del principio di contraddizione è limitata all’istantaneità dell’esperienza.Del resto il principio di contraddizione richiede per definizione la simultaneitàe può essere che questa sua caratteristica abbia indotto Wolff a credere in unasua certa analogia con l’istantaneità dell’esperienza, che la simultaneità sem-brava adattarsi bene ad afferrare. Nella dimensione dell’attualità, dell’hic etnunc, la certezza delle proposizioni empiriche si mostrava identica a quella del-le proposizioni razionali.
Certo in questo caso si intersecano, a volte confusamente, due prospettive di-verse: logica e psicologica. Ma la concezione wolffiana presenta aspetti convin-centi. La necessità che produce la certezza empirica è evidentemente di naturapsicologica, ma il modo di interpretarla è modellato sulla necessità logica. An-che per lui, come per Leibniz, la teoria dei mondi possibili costituisce il collan-te tra necessità assoluta e necessità ipotetica. Malgrado abbia la stessa forza im-positiva della necessità assoluta, dalla necessità ipotetica non segue che glieventi opposti sono «impossibili ma soltanto che non possono anche verificarsicontemporaneamente»68; e proprio qui Wolff rimanda di nuovo al § 10 dedicatoal principio di contraddizione. L’impossibilità della contraddittoria che caratte-rizza il mondo delle verità eterne, si traduce nel nostro mondo nell’impossibilitàdel verificarsi simultaneo degli opposti, che comunque appartiene anch’essa al-le prestazioni epistemiche del principio di contraddizione.
4. L’esteriorità dell’esistenza
Secondo Wolff è impossibile dedurre l’esistenza dalla possibilità. Questa regola èinviolabile ed evidenzia il primato dell’esistenza: «quod existit, id est possibile»69;ma «quod possibile est, id non ideo existit»70. È certamente valida l’inferenza dal-l’esistenza alla realtà, ma non il contrario: «ab existentia ad possibilitatem valetconsequentia», ma «a possibilitate ad existentiam non valet consequentia»71.
La possibilità è, dunque, un contrassegno insufficiente della realtà. La resi-stenza del possibile/impossibile, che produce in noi una repugnantia a concepi-re qualcosa diversamente da come la si concepisce, è una condizione necessa-
68 WOLFF, Deutsche Metaphysik, § 568. Ho preferito tradurre “zugleich” con “contemporaneamente”piuttosto che con “insieme”.
69 WOLFF, Ontologia, § 170.70 WOLFF, Ontologia, § 171.71 WOLFF, Ontologia, rispettivamente §§ 170 e 171. Cf. anche: «Se cioè conosco che qualcosa è pos-
sibile, non posso per questo motivo ammettere che effettivamente esso esista o sia esistito in precedenzaoppure esisterà in futuro» (Deutsche Metaphysik, § 13); «ognuno sa: A posse ad esse non valet Consequen-tia; dal fatto che qualcosa può essere non consegue che esso è reale» (Amerkungen, § 286).

L’ontologia sperimentale di Christian Wolff 265
ria, ma non sufficiente a determinare la realtà attuale. Grazie a questa resisten-za possiamo conoscere soltanto l’indipendenza dei possibili dal nostro intellettoe dalla nostra volontà, ma non la loro realtà. Per esempio ci sono pensieri che siimpongono a noi con assoluta necessità e tuttavia non sono reali perché «nonpossiamo conferire loro alcuna realtà fuori dell’anima»72. Per spiegare la diffe-renza tra possibilità e realtà Wolff propone di concepire l’esistenza come un com-plementum possibilitatis73. Quindi perché qualcosa diventi esistente si deve ag-giungere «ancora qualcosa di più» alla sua possibilità, «mediante cui il possi-bile ottenga il suo riempimento. E questo riempimento del possibile è propriociò che chiamiamo realtà»74. La concezione di Wolff è chiara almeno per unaspetto: il complemento – ovvero la realtà – è un’aggiunta, qualcosa di esternoal possibile, e non è certo contenuto in esso.
Qui non ci interessa vedere se questo complemento è fondato anche in Wolff, co-me in Leibniz, su un conatus del possibile verso l’esistenza, né ci interessa saperese e come questa tensione del possibile possa influenzare la volontà divina nell’at-to della creazione, cioè nella scelta del mondo attuale tra gli infiniti mondi possibi-li. È probabile che Wolff in questo contesto non si discosti molto da Leibniz75.
Qui ci interessa soltanto vedere se è possibile individuare i contrassegni chedistinguono l’esistente dal possibile e che dovrebbero costituire gli ingredientidel complementum. Già i termini usati per designare l’esistenza (“complemen-tum”, “Erfüllung”, “noch was mehreres”) designano in modo inequivocabile l’e-steriorità dell’esistenza rispetto al possibile; essa non è né un modo né un predi-cato della possibilità. L’esistenza è un vero e proprio oltrepassamento del possi-bile, non un suo ampliamento. Nell’ontologia wolffiana c’è una cesura netta traessenza ed esistenza che non può essere ricucita mediante procedure esclusiva-mente razionali. L’essenza non ha nulla dell’esistenza se non la sua possibilità.E l’esistenza non può assolutamente essere dedotta dalla possibilità. Questa con-cezione è il culmine di quel processo di rinnovamento dell’ontologia che, par-tendo dalla scolastica, arrivò gradualmente alla «désexistentialisation de l’es-sence»76, a privare cioè l’essenza di ogni riferimento esistenziale. Come dice
72 WOLFF, Deutsche Metaphysik, § 1053.73 WOLFF, Ontologia, § 174. Cf. a riguardo J. ÉCOLE, La definition de l’existence comme le complément
de la possibilité et les rapports de l’essence e de l’existence selon Christian Wolff, «Les Études philoso-phiques», 1-2 (1996), pp. 261-273.
74 WOLFF, Deutsche Metaphysik, § 14. In questo caso ho preferito tradurre “Erfüllung” con “riempi-mento” piuttosto che con “compimento”.
75 Riguardo a questa problematica in Leibniz rimando di nuovo al mio articolo Der metaphysische Pro-babilismus von Leibniz cit.
76 J. ÉCOLE, La notion d’être selon Wolff ou la «désexistentialisation de l’essence», in S. CARBONCINI / L.CATALDI MADONNA (a cura di), Nuovi studi sul pensiero di Christian Wolff, GW, III/31, 1992, pp. 157-173.

266 Luigi Cataldi Madonna
giustamente École77, rispetto alla loro distinzione il primato spetta all’esistenzae non all’essenza. È impossibile dedurre le esistenze dalle essenze, mentre èpossibile inferire le essenze dalle esistenze.
Per accedere al tema dell’esistenza Wolff sceglie il concetto di ordine, inte-so come «la somiglianza del molteplice nella connessione reciproca delle sueparti»78. Il primo contrassegno degli esistenti è, quindi, la loro connessione reci-proca, che si realizza quando uno di loro «continet rationem sufficientem coexi-stentiae, vel successionis alterius»79. Se questo non accade le cose non possonoessere intese come connesse e quindi non saranno nemmeno reali. Anzi perquanto riguarda l’esistenza le cose reciprocamente connesse sono anche reci-procamente dipendenti80. E proprio da questa reciproca connessione di tutti gliesistenti deriva la definizione wolffiana di mondo, cioè «una serie di enti mute-voli, che sono l’uno accanto all’altro o seguono l’uno all’altro ma che, nel loro in-sieme, sono conessi l’uno con l’altro»81. Ovviamente ci sono anche altri con-trassegni del mondo e degli esistenti oltre alla mutabilità: p. es. la loro «finitu-do»82. Ma in che cosa consiste questo ordine, da cui poi tutte queste caratteri-stiche sembrano derivare?
L’ordine che caratterizza gli esistenti non è altro che il loro essere inseriti nel-le coordinate spazio-temporali. Il tempo, come ordo successivorum83, e lo spazio,come ordo simultaneorum84, costituiscono insieme, e soltanto insieme, l’ordinedella connessione reciproca degli esistenti. Sebbene si acquisisca la nozione ditempo dalla successione dei nostri pensieri85, questi hanno inevitabilmente unadimensione temporale, ma non hanno comunque una realtà al di fuori dell’ani-ma. Manca loro lo spazio per poter conquistare il diritto a esistere. Lo stesso sem-bra valere per gli enti semplici ai quali Wolff riconosce la possibilità di riempi-re lo spazio in qualità di punti, ma non quella di una vera e propria realtà86.
Tuttavia riguardo all’esistenza dei semplici la posizione di Wolff resta equivoca.I semplici non sono empiricamente riconoscibili nemmeno immaginando un po-tenziamento degli organi di senso con mezzi artificiali quali il microscopio o altri87.
77 ÉCOLE, La notion d’être selon Wolff cit., p. 171.78 WOLFF, Deutsche Metaphysik, § 132; cf. anche Ontologia, § 472.79 WOLFF, Cosmologia, § 10; cf. anche Deutsche Metaphysik, § 545.80 WOLFF, Cosmologia, § 14 e § 58.81 WOLFF, Deutsche Metaphysik, § 544; cf. anche Cosmologia, § 48.82 WOLFF, Cosmologia, § 50.83 WOLFF, Ontologia, § 572.84 WOLFF, Ontologia; § 589.85 WOLFF, Deutsche Metaphysik, § 94 e § 736.86 WOLFF, Deutsche Metaphysik, § 602 e § 81.87 WOLFF, Deutsche Metaphysik, § 83.

L’ontologia sperimentale di Christian Wolff 267
Ma sembrano esistere solo in virtù del ragionamento che dato il composto deve esi-stere anche il semplice88. Comunque per Wolff lo spazio sembra avere un primatorispetto al tempo nella determinazione dell’esistenza. L’ordine spaziale sembra ne-cessariamente implicato dagli esistenti: cose ordinate solo temporalmente, peresempio i pensieri, non esistono; mentre le cose ordinate spazialmente non posso-no non esistere89.
Spazio e tempo sono i contrassegni dell’esistenza e sono insieme, quindi, ilcomplementum possibilitatis. La connessione attuale delle cose non è altro che ilmodo univoco – «in un modo e non in un altro» – in cui il tempo e lo spazio «so-no riempiti» perché è impossibile, «che spazio e tempo identici possano essereriempiti contemporaneamente in modo diverso»90. Gli esistenti riempiono lospazio-tempo, ma allo stesso tempo è questo riempimento che li rende esistentie che costituisce il complementum della loro possibilità. E proprio questo mododi riempimento dello spazio e del tempo a determinare la natura della composi-zione del mondo e, quindi a consentire la reciproca connessione degli esistenti.La differenza tra il possibile e l’esistente è tutta qui, ma non è poca: soltanto at-traverso il suo inserimento nella dimensione spazio-temporale il possibile con-quista la sua condizione di esistente e può ricevere quella «omnimoda determi-natio» che deve caratterizzare gli enti singolari, cioè gli individui91. Le coordi-nate spazio-temporali non sono deducibili dall’intelletto, ma possono essere cat-turate soltanto dalla conoscenza a posteriori. Infatti soltanto la sensibilità ci con-sente di conoscere l’esistenza.
Riconoscendo l’esteriorità dell’esistenza rispetto al possibile, l’ontologia spe-rimentale di Wolff mette fuori causa qualsiasi tipo di approccio aprioristico allarealtà. Realismo e carattere aposteriori del tempo e dello spazio sono punti sal-di della sua filosofia che stanno alla base della sua concezione non analitica del-l’esistenza e della realtà. Spazio e tempo non ci sarebbero se non ci fossero esi-stenti che li riempissero, malgrado essi restino diversi da questi esistenti92. Co-me ordini di relazione, spazio e tempo non possono mutare nulla nella costitu-zione delle cose93; sono vuoti e, quindi, ininfluenti rispetto alle cose94. In altreparole spazio e tempo sono reali, ma non hanno alcuna funzione costitutiva ri-
88 «Là dove sono enti composti, devono esserci anche enti semplici»; WOLFF, Deutsche Metaphysik, §76.
89 Il confronto dei §§ 46, 96 e 97 della Deutsche Metaphysik sembra autorizzare questa interpretazio-ne.
90 WOLFF, Deutsche Metaphysik, § 573.91 WOLFF, Logica latina, § 74; Ontologia, § 227.92 WOLFF, Ontologia, § 574 e § 600.93 WOLFF, Deutsche Metaphysik, § 99.94 WOLFF, Deutsche Metaphysik, §§ 593-594.

268 Luigi Cataldi Madonna
spetto alla realtà. Le linee fondamentali di questa concezione a posteriori dellospazio e del tempo presenteranno poi dei vantaggi rispetto alle concezioni aprio-ristiche nel riuscire a contemplare la possibilità di spazi non-euclidei. La filo-sofia di Wolff non ci insegna certo come passare dal possibile all’esistente, macome poter indagare le strutture profonde della realtà e reddere rationem cosìdell’esistente.