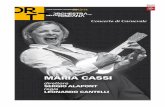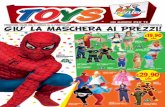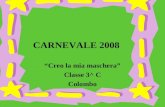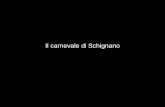CARNEVALE: IL TRIONFO DEL FUOCO · Carnevale su Don Ant ... contribuito anche all’introduzione...
-
Upload
truongthuan -
Category
Documents
-
view
218 -
download
0
Transcript of CARNEVALE: IL TRIONFO DEL FUOCO · Carnevale su Don Ant ... contribuito anche all’introduzione...

SOMMARIOCarnevale: il trionfo del fuoco . . . . . . . . . . . . . .1Serafino CamilliAlcuni aspetti del Carnevale in Offida . . . . . . . .2Vitale TravagliniCarnevale su Don Antò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2Don Luciano CarducciSpigolature storiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3Nicola SaviniRuit Hora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3Marco Mercolini TinelliLa Congrega: un emozione semplice e vera . . . .4Alberto Premici Li moccule e la pizza onta . . . . . . . . . . . . . . . . . .5Serafino CamilliIl Carnevale disceso dal paganesimo italico . . . .5Vitale TravagliniL’inno ufficiale del carnevale offidano . . . . . . .6Giancarlo PremiciUna Memoria storica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6Vitale TravagliniCarnevale al Serpente Aureo . . . . . . . . . . . . . . . .6Valeria TozziIl Carnevale scandito dalle parole . . . . . . . . . . . .8Vitale TravagliniAncora un po di storia del Carnevale . . . . . . . . .9Giancarlo PremiciFeste Picene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10Michele AngeliniIl Vecchione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11Mario Vannicola
L’arrivo del Carnevale ci ha spinti apresentare, con un certo anticipo,
il terzo numero di Ophys nel qualeviene dato ampio risalto alla manifesta-zione folcloristica tradizionale che lanostra cittadina segue con orgoglio epassione.
Oltre a tutti i punti salienti che lacaratterizzano (bov fint, veglionissimi alteatro Serpente Aureo, vlurd, grandimascherate per grandi e piccoli), vienedato spazio anche alle curiosità e notesu una manifestazione che, anche neiperiodi non certo felici per la storialocale, si è svolta sempre con continui-tà, facendosi sempre più apprezzare siadagli offidani che dai forestieri. Ciò hacome risultato il fatto che ormai la mani-festazione può competere alla pari conquelle più famose che si svolgono inaltre zone, in quanto ricca di spontanei-tà e buon umore.
In questo numero riportiamo anchealcune notizie sulla Banca di CreditoCooperativo Picena di Castignano, ope-rante da tempo anche ad Offida e cheha accettato la collaborazione per la
pubblicazione di Ophys.Presentiamo anche alcune manifesta-
zioni folcloristiche, come la sfilata dei“Moccoli” ed altre, che in questo perio-do si svolgono nella cittadina deiTemplari e meritano di essere meglioconosciute ed apprezzate da quanti siinteressano delle tradizioni locali.
Un ringraziamento, quindi, alla BCCPicena e un saluto a tutti i castignanesiche si adoperano per mantenere in vitale tradizioni locali e, in special modo, ilCarnevale. Naturalmente un doverososaluto a tutti gli offidani che seguono lanostra pubblicazione e a quanti, in que-sti giorni, fanno appello al buon sensoperché la tradizione del “Carnevale piùpazzo del mondo” venga rispettata e, altermine, possano guardare le ceneri delgran falò alimentato dai resti dei“VLURD” con piacere, anche se conrammarico, perché sembrano ricordareche il periodo della gran baldoria è ter-minato e la vita ricomincia.
A tutti l’augurio di BUON CARNEVA-LE da parte della redazione e dei colla-boratori di Ophys.■
Anno 2 - nuova serieNumero 3
COPIA GRATUITAOffida, Febbraio 2003
Periodico del Centro Studi“Guglielmo Allevi” - Offida
CARNEVALE: IL TRIONFO DEL FUOCODI SERAFINO CAMILLI
Offida - Carnevale 1947
1

2
Voglio ricordare, a proposito delCarnevale in Offida, alcune
manifestazioni ormai scomparse.Ai veglioni famosi al Teatro
Serpente Aureo, in parallelo, con piùsemplicità ma con più brio ed allegra
partecipazione si svol-gevano le “recite” alcinema Aurora.Questo locale, cheinsisteva su parte del-l’area ora occupatadall’enoteca regionaledella Vinea, era statoinaugurato negli annicinquanta dopo i lavo-ri di consolidamento edi restauro per i danniprovocati dal terremo-to del ’43 con unmemorabile concerto
preparato e diretto dai maestriGiuseppe Mestichelli e GiuseppeDesantis, con musica di Verdi, Puccini,Mascagni, Perosi. Questo cinemaAurora si animava per la vivacità e l’im-pegno dei ragazzi e dei giovanidell’Azione Cattolica che si esibivano in
scenette, balletti, piccoli complessimusicali; palestra di giovani attori egiovani musicisti per la gioia e la sod-disfazione di genitori e nonni.Animatori e presentatori delle serateerano con la loro verve comica Pippolu Ciaff ed Ezio Baffò.
Non mancavano per arricchire le sera-te i dolci tipici di Carnevale: sfrappe ecastagnole a profusione, e per concluderenon poteva mancare la rumorosa e coin-volgente visita della congrega delCiorpento.
Al giovedì grasso poi si svolgeva,nella chiesa del monastero delle mona-che benedettine, il cosiddetto“Carnevale santificato”: ore di adorazio-ne durante le quali si avvicendavano diora in ora uomini e donne, giovani edadulti per momenti di riflessione e dipreghiera.■
CARNEVALE SU DON ANTO’DI DON LUCIANO CARDUCCI
ALCUNI ASPETTI DEL CARNEVALE IN OFFIDADI VITALE TRAVAGLINI
Al vivace quadro di valori nelCarnevale celebrato in Offida
possono contribuire a dotare di una giu-sta cornice gli argomenti che vengonoesposti.
Il Carnevale scaturito dai giorni.Allo sviluppo del cristianesimo è con-nessa l’affermazione della più grandefesta profana dell’umanità, quella delCarnevale. Nel corso del 300 d.C. furo-no definiti in quaranta i giorni del digiu-no quaresimale precedente la festivitàpasquale, e nelle Ceneri come primogiorno di tale periodo, caratterizzato dalrito dell’aspersione della cenere sul capodei peccatori.
Proprio la ritualità dell’imposizionedella cenere ai penitenti fa supporre,con fondamento, l’esistenza di feste alle-gre ma anche di forme trasgressive cheandarono sotto il nome di Carnevale.
I divertimenti Carnevaleschi non sor-sero all’improvviso dal nulla, ma si rife-cero a quelli pagani delle genti italicheed in modo particolare ai saturnali chesi svolgevano a Roma, ove la cristianitàaveva il suo centro fatto dai luoghi sacrie dall’apparato amministrativo.
La diffusione del cristianesimo hacontribuito anche all’introduzione dellasettimana, ossia del periodo di settegiorni in cui era suddiviso un mese.D’origine babilonese, come quarta partedel mese lunare di ventotto giorni, s’im-pose attraverso l’interpretazione ebraicae cristiana, che si sovrappose alla setti-mana astrologica, diffusa nel mondogreco-romano, che assegnava un giornodella settimana a ciascuno dei sette pia-neti conosciuti. Da Roma l’uso si diffuse
in tutto l’occidente tramite il cristianesi-mo che per lungo tempo per motivi reli-giosi si oppose alla diffusione della ter-minologia mitologica, sostituendo adessa l’indicazione dei giorni della setti-mana, in rapporto alla Domenica, ossiadies dominicus o feria prima, come illunedì era feria seconda, ecc.
Da queste notizie storiche si desumeche la chiesa cattolica, calcolando i qua-ranta giorni della quaresima, dovevafarla iniziare nel mercoledì della sestasettimana precedente entrato nell’usocomune, col nome delle Ceneri.Pertanto veniva a cadere di martedì l’ul-timo giorno di Carnevale che iniziavauna settimana prima col giovedì dettograsso perché la gente indugiava adabbondanti mangiate, poiché il venerdìera, poi di digiuno ed astinenza. Con laDomenica dedicata alle funzioni sacre, ilCarnevale era ridotto a due o tre giornidi feste. Negli statuti offidani redatti nel1524, sembra che si dovesse privilegiareil giovedì grasso ed il giorno delle cene-ri perché era vietato di amministrare lagiustizia (iuria civilia in ultima die feria-ta = giorno festivo). Si può supporre aquei tempi appunto, un Carnevale didue o tre giorni, compreso l’ultimo, ilmartedì. Quando nel 1600 si realizzò lacostruzione di un teatro, una strutturamobile nel salone del palazzo comuna-le, al pomeriggio della Domenica veni-vano messe in scena allegre farse conun epilogo che invitava alla concordia icittadini. Si può anche credere che l’atti-vità Carnevalesca abbia contribuito allosviluppo ed ampliamento della stessastruttura nel tempo poiché, ancora alla
fine del 1800, si svolgevano commedieburlesche nel nuovo teatro nell’ultimaDomenica di Carnevale. Col passare deltempo assunse grande risalto l’ultimogiorno di Carnevale, per l’importanza el’originalità di alcune manifestazioni,come i velurd. Dall’inizio del 1800 risul-tano impegnati anche il pomeriggio e lasera del venerdì con la caccia al toro obue (oggi finto) donato in beneficenzaalla popolazione per il Carnevale. Nellacronica del settimanale OPHYS si facenno nel mercoledì, al trimmulieratoche sembrerebbe fosse stata una formadi Carnevale per i bambini dell’epoca,oggi organizzato nel pomeriggio del gio-vedì grasso, in cui si svolgono manife-stazioni di alcune congreghe.Attualmente risultano occupati dalCarnevale tutti i giorni dal giovedì gras-so al martedì. Il sabato pomeriggio sisvolgono spettacoli in piazza, seguiti delgrande veglione serale. La Domenicavede nella giornata, esibizioni dimaschere ed il veglione mascherato. Dal17 di Gennaio, ingresso del Carnevale,cominciano le esibizioni di alcuni grup-pi Carnevaleschi mentre le Domeniche,cosiddette degli amici e dei parenti,sono motivo di riunioni conviviali. Iveglioni hanno avuto una nuova conno-tazione, perché il primo, d’apertura, èper i soci della Pro Loco che organizzail Carnevale, mentre quello dell’ultimaDomenica è d’obbligo mascherato. Cosìda un Carnevale di breve durata si èpassati, nel volgere dei secoli, a festedisseminate in un lungo periodo.■
Pippo lu Ciaff presenta al Cinema Aurora

3
SPIGOLATURE STORICHEDI NICOLA SAVINI
Nel ’68 la “Congrega delCiorpento”, altamente fregan-
dosene di pseudo - rivoluzioni assai dimoda, pur con qualche vicissitudine,giungeva starnazzando al XX anniver-sario di sua fondazione.
Quell’anno la Pro Loco diede allestampe per la prima volta e, se nonerro, fu anche l’ultima, un vivace gior-naletto: “Il Muraglione”, diretto dall’a-mico Tonino Carino, già a quei tempidinamico “gazzettiere”.
Essendo uscito sotto Carnevale,quasi totalmente ad esso fu dedicato.Con la sola eccezione dell’iniziale artico-lo di fondo dove, con nobile intento, sidelineava un bel programma, invero unpoco ambizioso, per non dire utopistico.
La grande festa imminente, come sidiceva, fece la “parte del leone” nelfoglio, con rievocazioni, con descrizio-ni efficaci delle varie sceneggiate.
L’unico dei fondatori del“Ciorpento” ancora in servizio attivo,onorato pertanto del titolo “GranTropeo”, volentieri accettò la propostadi buttar giù due righe per ricordare l’e-vento. Sono quelle seguenti; riesumatee pubblicate adesso da Ophys. Ruit
hora “Fugge il tempo”, terribilmenteveloce, come dice il titolo latino, libe-ramente tradotto. Quest’anno, infatti, la“Congrega del Ciorpento” ne compie55 (10 febbraio), e si prepara per rea-lizzare in piazza la LVI Epopea.
L’autore delle due distanziate note-relle, che è, ovviamente, la stessa facciasbronzea, pur se divenuto ormai l’egre-gio “Fondator Vetusto”, vuole alfinrivolgere ai Congregati, ai carnevalieritutti: bacchico, squillante augurio difelici sbronze con strombazzate varie,in ottimo Carnasciale Aufidico 2003!
“Lu Ciorpento cià vind’ ann”Venti anni fa, nel primo pomeriggio
di giovedì grasso, un’allegra comitivadi amici, in gran parte studenti, smal-titi i fumi dell’ultimo veglione, discute-va animatamente un importante edurgentissimo problema. Si trattava diorganizzare in breve tempo una spiri-tosa mascherata che avesse il potere dirisollevare un po’ le sorti del languenteCarnevale offidano, di quel Carnevaleche pure aveva alle spalle secoli displendide tradizioni, le cui origini risa-livano all’era gentile con i baccanali ele dionisiache. (Allevi, A Zonzo perOffida). Tutti d’accordo perciò sullostile del “camuffamento”: perfetta ade-renza all’antico spirito carnascialescoed ispirazione alle leggende del luogo,pur con spiccate caratteristiche satiri-
che d’attualità. Nacque così la“Congrega del Ciorpento” in omaggioal mitico serpente aureo, da cui la cittàderiva l’etimologia del suo nome. Ilsimulacro in oro massiccio fu sempreattivamente ricercato da insigniarcheologi, ultimo fra i quali, in ordinedi tempo, ma primo per serietà d’inten-to e preparazione scientifica il Monel-Pelons che credette di localizzarlo sottoil selciato, nel bel mezzo della “piazzaa baccalà”. Una gagliarda statuettalignea del dio pagano della virilità,Priapo, opera pregevolissima di unmisterioso artista orientale, tale“Maestro Lu Ciaf”, venne, fra il genera-le entusiasmo, prescelta a simbolo delCiorpento.
Fin dall’esordio la Congrega sipreoccupò che la sua manifestazionenon si limitasse alla sfilata, muta edinsulsa anche se sfarzosa, di mascheree carri allegorici, tanto di moda ainostri giorni in quelle località che van-tano un Carnevale di fama internazio-nale, ma volle che fosse soprattuttoazione; azione scenica con attorideclamanti e coro, come nella tragediagreca.
La prima istoria era di ispirazionebiblica: Adamo era cacciato non dalparadiso terrestre ma dalle braccia diEva. Venivano naturalmente coinvoltinel fatto personaggi e situazioni più omeno scabrose del momento. Così di
RUIT HORADI MARCO MERCOLINI TINELLI
Carnevale, tempo di trasgressioni,di feste pazze. Tempo di balli in
maschera, di gruppi mascherati. Tempodi scherzi, di frizzi e lazzi. Una festa perstare insieme, dunque, che dalla nottedei tempi serve all’uomo per gettaredietro le spalle le preoccupazioni quo-tidiane, per scaricarsi, almeno una voltal’anno, dei problemi che lo assillano. IlCarnevale, insomma, è voluttà e piace-re. Nel Medio Evo era, soprattutto, tra-sgressione contro il potere, in partico-lare contro quello temporale dellaChiesa. In quel periodo dell’anno, veni-va eletto pubblicamente Re Carnevale,simbolo dell’autorità suprema, poi sot-toposto a processo popolare, percossoe detronizzato. A rappresentare il Reveniva designato il “Buffone”, primavestito con panni regali, poi ingiuriatoe bastonato. Era la rivincita del popolocontro i governanti. Ma sempre e in
qualsiasi periodo della storia si potevaveramente fare tutto ciò che uno avreb-be desiderato come recita il detto “ACarnevale ogni scherzo vale”? Sembraproprio di no! Nel ‘600, infatti, poteva-no mascherarsi solo i ricchi. Nel 1626due contadini che in tempo diCarnevale si erano travestiti da eremitie chiedevano l’elemosina venneroaddirittura decapitati. Al re Enrico III diFrancia che si abbandonava ad atteg-giamenti poco regali e, mascherato,andava in giro con i suoi fedelissimi abastonare ed insolentire la gente, fuproibito di uscire dalla reggia per tuttoil periodo di Carnevale (sembra stranoper un re, ma è proprio così). Al giova-ne principe di Ligne, durante un balloin maschera, si trovò preso nel mezzoda due audaci e graziose mascherineche, con carezze e baci, fecero capiredi avere intenzioni inequivocabili.
L’austero precettore del giovane, però,lo sottrasse a tanta esuberanza provo-candogli, certamente, un grosso dispia-cere. A seguito di intemperanze, licen-ziosità, malcostume e violenze verifica-tesi in certi periodi, ci furono severediffide e proibizioni. Tra le tante, una dirilievo: la riprovazione di San CarloBorromeo alla fine del ‘500, “per i graviabusi dei Carnevali lombardi”. Inoltre,in un discorso contro il Carnevale, cosìebbe ad esprimersi un anonimo venetodel ‘600: “Ma qual notte può essere piùtenebrosa, ed oscura, spaventevole aibuoni? Coperto l’uomo sotto una tene-brosa maschera, se apposta l’inimicospensierato, lo offende e non è cono-sciuto”. Insomma, anche il “Semel inanno licet insanire” del poeta latinoOrazio ha le sue regole e i suoi limiti.■

4
LA CONGREGA: UN’EMOZIONE SEMPLICE E VERADI ALBERTO PREMICI
seguito, talché il Ciorpento partecipò,sempre in chiave satirica, alle più sva-
riate avventure: dalla storia romanaalle imprese spaziali, dall’opera lirica
al festival di S. Remo, dalfilm lubrico alle seduteparlamentari.
Alla fine del rito avvie-ne ogni volta il prodigio. Ilprezioso scrigno contenen-te il simulacro è apertomagistralmente da manipurissime: il Ciorpentoerge fulmineo il suo capopurpureo fra l’attonitaammirazione delle genti.
Col passare del tempovi è stata una certa inevi-tabile evoluzione. Nuoviadepti, amanti delle dolcimelodie, arricchirono laparte musicale con l’ap-porto di tamburi e gran-
casse, regolarmente sfasciati tutti glianni, talché la Congrega in marcia dàl’impressione – armoniosa – dell’avvici-narsi di un uragano. Sopravvive sem-pre però la recita, sia in prosa che inversi; ed ancora adesso nella citatapiazza si declama con voce stentoreal’ultimo capitolo dell’eroica “historia”.E giovano certo a dar vigore al discorsotonanti boati vinosi che erompono dalgargarozzo dell’oratore dopo le ciclopi-che libazioni propiziatorie.
Si può dire, infine, che non furonodel tutto vane le speranze di quei gio-vani di venti anni fa, in quanto la“Congrega del Ciorpento” ha recatoindubbiamente un suo contributo allamaggiore gloria del Carnevale offida-no.
IL GRAN TROPEO
La frenetica vita che si conduce,unita ai cambiamenti della storia
o a fatti quotidiani, ci distoglie talvoltadal gusto per le cose semplici e vere.Molte di queste sono ancora integre,nella loro essenza, proprio in piccolecittadine come la nostra; il Carnevaleche bussa alle porte ne offre un riccorepertorio. Una di queste è ritrovarsi inun ambiente qualsiasi, a parlare perore, con amici e conoscenti davanti adel buon vino; ed assume maggiorvalenza se la si vive all’interno di unacongrega.
Molti offidani sono legati alle tantecongreghe, sette o gruppi, che animanoquesto periodo e vi partecipano viven-done ogni momento con attaccamentoe passione, cercando di farla sopravvi-vere ad ogni costo anche se a voltenascono dissidi interni; si adoperanoper migliorarla, ne decantano le “gesta”e si attaccano ad essa quasi con mor-bosità.
Pochi giorni fa, riordinando l’elencoufficiale dei componenti della miaamata Congrega del Ciorpento, ho fatto
due conti e mi sono accorto che hoampiamente superato i 25 anni di “mili-tanza” in essa.
Quanti ricordi… serate e notti pas-sate a preparare il Carnevale o a rivive-re la storia vera ed i momenti più esal-tanti di un gruppo di amici che, varca-to il portone di palazzo Mercolini,dimenticano praticamente tutto; cambialo sguardo con il quale ci si saluta, c’èpiù calore umano (oltre che corporeo),ci si stringe intorno al solito tavolo edavanti al grande focolare acceso pertempo pronto per accogliere bruschettee salcicce varie per tutti. E’ un ambien-te magico, familiare e soprattutto benconservato; qui tutto è fermo da moltidecenni ed è così che lo vogliamo conle solite cose al solito posto.
Poi l’attenzione verso le prolusionilatineggianti del Serenissimo, interrottesistematicamente dal Bimbo Osceno(Bruno) e le “dettagliate” relazioni delCassiere (Tito); inevitabilmente il ricor-do va a quelli che non sono più tra noie che tanto hanno dato al nostro soda-lizio. Qualcuno dei presenti si assenta
con lo sguardo; immaginoche in quel preciso istantevoglia il congregato o l’a-mico caro che non c’è più,ancora lì, magari per unattimo, coinvolto nell’inevi-tabile e ripetuta sbicchiera-ta che scandisce ogninostro incontro.
Ho vissuto molte delle55 “epopee” dellaCongrega, come Marco ledefinisce con enfasi; alcu-ne con bei ricordi, altremeno, magari per proble-
mi o accadimenti esterni; tutte però conla consapevolezza di essere parte inte-grante di un’esperienza irripetibile, dicui si parlerà per molto tempo, anchequando essa non esisterà più, seppurtutti noi siamo convinti della sua“immortalità”.
In essa ho conosciuto e frequentatopersone e personaggi diversi, tutti conun aneddoto, un fatterello, un sborniasolenne o una camuffata da ricordare. Equello che forse fa grande la Congregaè la continuità e l’appartenenza; unaparte sostanziale di essa poi rinnova talivalori con la costante frequentazione enon solo davanti ad una tavola imban-dita.
A volte si organizzano gite edescursioni, pubblicazioni, riconosci-menti, targhe, ed anche mostre d’artee fotografiche in ricordo di cari con-gregati. Non posso e non voglio riper-correre qui la storia e l’essenza delCiorpento; ai molti altri offidani, coin-volti in gruppi simili, auguro però lamia stessa fortuna. Li invito a preser-vare e mantenere con cura le propriecongreghe, siano esse piccole o gran-di, giovani o vecchie, non importa;tenendo però sempre ben presenteche è un gioco, una farsa, insommauna carnevalata e ad essa tutto varicondotto con sano spirito goliardico.
All’interno delle Congreghe, oltre aldivertimento, forse è possibile recupe-rare il vero valore dell’amicizia, oggisempre più raro o dannatamente vilipe-so per altri interessi, per rancori, inutiliinvidie, per scarsa intelligenza, tutto ciòinsomma che teniamo a debita distanzadal nostro focolare, già vivo in attesadel prossimo Carnevale.■
Prima immagine della Congrega del Ciorpento - 1° marzo 1949Alcune foto dell’anno di fondazione (1948) sono andate irrime-diabilmente perse.

5
Icastignanesi sono orgogliosi delloro Carnevale e si adoperano
per renderlo ogni anno più spettaco-lare e gradito specialmente ai fore-stieri. Negli ultimi giorni largo spazioviene dato alla manifestazione“Bambini in maschera” e a quellagastronomica del giovedì grasso dovei turisti potranno gustare specialitàlocali e la famosa “pizza onta” annaf-fiata dai classici vini di produzionelocale come Templaria, Gramelot edaltri.
Il martedì grasso la conclusionecon carri mascherati, maschere singo-le e a gruppi che animeranno vie epiazze ballando al ritmo della bandalocale in costume scozzese. La baldo-ria continuerà fino a sera quando,richiamati dal grido “…fora, fora limoccule!” e dal rullare dei tamburi,spunteranno, come per incanto, centi-naia di lampioncini colorati che sfile-ranno fino a piazza San Pietro, ilpunto più alto della cittadina. Qui,una specie di battaglia fra i mocculeaccesi precede il rogo finale e lo spe-gnersi del fuoco e la spettacolarità deifuochi artificiali segnano la fine del
Carnevale. Sulle origini di questa manifesta-
zione non si hanno notizie precise equalcuno afferma che potrebbe esse-re stata ispirata da quella che si svol-geva a Roma nel 1700 quando, l’ulti-mo giorno di Carnevale, ognuno usci-va di casa in maschera portando ilproprio moccolo.
Più interessante ci appare quantoci disse un castignanese verace alcunianni fa: “E’ una manifestazione che cipiace e cerchiamo di renderla semprepiù benaccetta al pubblico”.
Sulla manifestazione dei “moccu-le” alcuni anni fa i bambini dellescuole elementari scrissero una poe-sia nella quale, tra l’altro, si legge:“Viva la baldoria, viva l’euforia per ilCarnevale che sta volando via! …fora,fora li moccule!, fora fora li moccule!.Siamo giunti oramai in piazza S.Pietrocon li moccule assai belli si sentonotutti un po’ pazzerelli. Quanta folla,che allegria! Ogni moccule vorrebbescappar via. Ma ahimè, nel gran fuocovengono bruciati e così si chiude lafesta di tutti i mascherati!” Negli annipassati il Carnevale si chiudeva con i
veglionissimi al teatro comunale cheora è chiuso, ma sicuramente nonmancheranno feste nei locali pubblicicittadini.■
“LI MOCCULE E LA PIZZA ONTA”DI SERAFINO CAMILLI
IL CARNEVALE DISCESO DAL PAGANESIMO ITALICODI VITALE TRAVAGLINI
Il Carnevale, ufficializzato dalleritualità cattoliche, si ricollegava
alle feste pagane delle popolazioni ita-liche, in genere scherzose, licenzioseed oscene. Le principali erano LEATELLANE nel meridione, I FESCEN-NINI in Etruria, I BACCANALI ed ISATURNALI nel Lazio, LE PRIMAVERESACRE nel Piceno.
LE ATELLANE. Rappresentazioniteatrali molto usate dagli Osci, inCampania, e portate a Roma nel I seco-lo a.C.,da attori di Atella (Potenza).Erano brevi farse di carattere popolareche seguivano la rappresentazione diun dramma: I personaggi di solitoerano quattro: Maccus lo scioccobonaccione, Pappus il vecchio bab-beo, Buccus il boccaccione, Dossenusil gobbo scaltro gradasso e scroccone.Le composizioni si rifacevano alla vitaquotidiana del popolo della campagna,espressa, con vivace realismo, in formaspregiudicata, sarcastica e spesso osce-na.
I FESCENNINI. Il termine vienegeneralmente collegato alla città etru-sca di Fescennium, luogo di originedei buffoni itineranti, che inscenavano
dialoghi, rozzi ed osceni, a scopo d’in-trattenimento. In origine erano versimordaci e licenziosi che si scambiava-no i contadini nei giorni di festa,coprendosi il viso con maschere fattecon scorze degli alberi. A Roma servi-vano anche a vivacizzare gli spettacolidi danza e musica di origine etrusca.Allo spirito dei fescennini si riallaccia-vano le battute licenziose, in occasionedelle feste nuziali.
I BACCANALI. Feste orgiasticheche, legate al culto di Dioniso (Bacco),penetrarono a Roma nel II secolo a.C.,dalla Magna Grecia, passando perl’Etruria. All’inizio erano feste notturneche si celebravano tre volte l’anno, cuipartecipavano solo donne anziane edonorate. Successivamente si uniforma-rono al più trasgressivo modello etru-sco, per la partecipazione di uomini edonne, con ogni genere di efferatezze,scostumatezze e fatti scandalosi.Finché, ritenuti pericolosi per l’ordinemorale e sociale, furono abolite condecreto del senato.
I SATURNALI. Erano le feste nel-l'antica Roma in onore di Saturno, diodella semina, più popolari e diffuse
fino all'avvento del cristianesimo e sicelebravano dal 17 al 23 Dicembre,dopo il termine delle semine. La parteufficiale consisteva in un solenne sacri-ficio nel tempio della divinità, seguitoda un pranzo pubblico, durante il qualei partecipanti si scambiavano auguri dibenessere e felicità. Nel periodo dellefeste, patrizi e plebei in concorde soli-darietà, si davano alla gioia più sfrena-ta, a dissolutezze e schiamazzi.
Deponevano la toga, si travestivanoin modo goffo, mettendo sul capo ilpileo: un berretto rotondo senza falde.Molti, poi, comparivano per le stradecon il viso sporco di fuliggine. Durantele riunioni private, tra parenti ed amici,che consistevano in mascherate, pranzi,scostumatezze, trasgressioni e vere eproprie orge, era consuetudine scam-biarsi ogni genere di regali. Gli schiavigodevano della più ampia libertà neidivertimenti e nel linguaggio, ed ipadroni concedevano loro d’imbandiresontuosi banchetti. Si pensa che isaturnali, le feste più importanti nellaRoma antica, abbiano originato ilCarnevale, diffusosi poi con il cristiane-simo, che, proprio in Roma aveva la

6
sede e le chiese. In epoca imperiale aRoma, le onoranze per il dio Saturnoerano fatte con giorni di licenza sfrena-ta, ma senza spargimento di sangue,mentre in altre località si concludevanocon un sacrificio cruento, una specie diregicidio-deicidio. La storia di S.Dasio,che viene riportata in seguito, è la testi-monianza più tragica dell’orgia di que-ste feste invernali.
LE PRIMAVERE SACRE. Eranofeste delle popolazioni picene, concui dedicavano alla divinità tutti imaschi nati in primavera, i quali, poi,divenuti adulti ,si staccavano dalnucleo famigliare principale, per for-mare, altrove, una nuova comunità.
Conclusione. Di tali feste qualcosa sopravvive in
alcune realtà Carnevalesche d’Italia. InOffida sembra non trovarsi tracce diquesti divertimenti pagani, però si pos-
sono ricercare parallelismi ed affinità. Aifescennini potrebbero essere avvicinatele storie cantate,da alcuni giovani delluogo,per inneggiare al serpente, comesimbolo fallico. Il fantoccio, re-divinitàsecondo la descrizione di GuglielmoAllevi, portato in piazza nell’ultimo gior-no di Carnevale su un trono e seguito dauna moltitudine di gente, farebbe pen-sare ad un dio Saturno. Purtroppo Allevinon ci tramanda il modo con cui si sba-razzavano di questo simulacroCarnevalesco: se veniva bruciato o but-tato nei dirupi sottostanti Offida. L’addioa Ninetta potrebbe riecheggiare il distac-co, nelle primavere sacre picene, veden-dovi un faceto saluto di qualche giova-ne, che si doveva allontanare per trova-re lavoro altrove. Infine le congreghe,dal latino cum grege (col gregge), ciriportano a modi ed aspetti di feste agro-pastorali.■
Isoldati romani di stanza aDurostorum, nella bassa Mesia,
vicino al Danubio, durante il regno diDiocleziano, solevano celebrare iSaturnali nel modo seguente. Tre giorniprima della festa sorteggiavano fra loroun uomo giovane e bello, che venivaabbigliato come Saturno. Andava poi ingiro seguito da uno stuolo di militari,per dar sfogo in piena litbertà a tutte lesue passioni e per soddisfare tutti i suipiaceri. Finiti i tre giorni, durante lafesta a Saturno, si tagliava la gola con leproprie mani sull’altare del dio. Nel 303d.C. fu tirato a sorte il soldato cristianoDasio, che rifiutò di fare la parte di undio pagano e di macchiare i suoi ultimi
giorni con gravissimi peccati. Resisté,con fermezza, ad ogni minaccia ed inti-midazione e, di conseguenza, fu deca-pitato dal soldato Giovanni il venerdì20 Novembre, com’è riportato dal mar-tirologio cristiano. Le reliquie del Santofurono portate ad Ancona per metterleal sicuro, quando la Mesia fu invasa daibarbari. Sono conservate nella criptadella Cattedrale di Ancona, in un sarco-fago di marmo bianco con un’iscrizionein greco, che dice: “Qui giace il Santomartire Dasio, portato da Durostorum”.Fino al 1650 il sarcofago si trovava sottol’altare maggiore della chiesa diS.Pellegrino o degli Scalzi.■
UNA MEMORIA STORICA - Dai saturnali fiorì un santo: San DasioDI VITALE TRAVAGLINI
Quest’anno, per la prima voltadopo dodici anni, torniamo a
teatro per i veglioni di Carnevale. Il lungo tour de force che si conclu-
derà martedì 4 marzo con la tradiziona-le sfilata dei v’lurd prevede ben cinqueserate danzanti, tra cui il veglionemascherato della domenica e il veglio-ne del lunedì con l’entrata delle“Congreghe”; la sfilata delle mascheredei bambini, come di consueto, si terràil giovedì grasso.
E’ inutile dire che cosa rappresenti eabbia rappresentato il Teatro SerpenteAureo nella storia offidana. Da sempreluogo di svago e del divertimento sfre-nato a suon di musica e di vetri infran-
ti durante il periodo di Carnevale, ilnostro Teatro è stato anche protagoni-sta, in stagioni diverse, di rappresenta-zioni come l’Operetta, sia da parte dicompagnie “forestiere” che di dilettantilocali. Sul suo palcoscenico si sonoalternati personaggi diversi della storialocale; ma la mia memoria mi riportasoprattutto al periodo delle recite sco-lastiche (delle vere e proprie operetteteatrali per l’impegno e la preparazioneprestati) e ad alcuni nomi, tra coloroche vi hanno partecipato: come nonricordare le memorabili sfuriate deiProfessori Fides Talamonti e SerafinoCamilli che, con amore e passione, cer-cavano di trasmetterci l’arte difficile del
recitare. Ad una di noi questo riuscìperfettamente; ed è con emozione edun velo di tristezza che ricordo TizianaCapecci, vibrante e gioiosa interprete ditante operette, rimasta nei cuori di noitutti.
Ma è soprattutto al Carnevale che lamemoria di noi offidani è legata, e alCarnevale di quest’anno che, come me,molti miei concittadini aspettano conimpazienza e, credo, curiosità.
Nel frattempo, i ricordi dei veglionipassati riaffiorano portando con sé isapori e l’atmosfera di un tempo.Ricordo ancora la moltitudine di gentedi quelle serate di tanti anni fa, quandoper entrare dovevi farti strada a fatica
CARNEVALE AL SERPENTE AUREODI VALERIA TOZZI
L’INNO UFFICIALE DELCARNEVALE OFFIDANO
DI GIANCARLO PREMICI
Si tratta di “Addio mia bella addio”(ovvero “La partenza del soldato”
o “Addio del volontario”) definita dalGori nel suo canzoniere nazionale,la più popolare gentile canzone chesia stata scritta e cantata da coloroche combatterono le guerre dell’in-dipendenza dal 1848 al 1878. Lamusica, per quanto è stato possibileaccertare, è di autore ignoto, mentrei versi, dapprima attribuiti al ripanoLuigi Mercantini, poi al Poerio, sonoin realtà di Carlo Bosi, avvocato fio-rentino, conosciuto anche con lopseudonimo di “Bassocrilo fiorenti-no”. Ma come mai è stato adottatocome inno del Carnevale offidano?Una possibile ipotesi potrebbe esse-re la seguente: prima del 1848 ilCarnevale offidano non aveva uninno particolare, bensì svariati cantipopolari caratteristici della culturacontadina. Al ritorno dalla guerrad’indipendenza, molti giovani offida-ni ripetettero i canti patriottici cheavevano intonato sui campi di batta-glia. Quello che piacque di più per ilsuo ritmo e motivo facilmente orec-chiabile fu appunto “l’addio delvolontario”; piacque tanto che daallora fu adottato come inno ufficia-le del Carnevale. Da quel tempo nonc’è persona che a Carnevale non loabbia canticchiato, suonato ofischiettato almeno una volta.■

7
facendo attenzione a non farti calpesta-re più di dieci volte! Come dimenticare,poi, le scorpacciate a suon di musicae di “frappe e castagnole” consumatecomodamente seduti nel palco o for-tuitamente e maldestramente sullescale, tra un Ordine e l’altro, in unandirivieni di gambe e voci. Saràancora così? Ritroveremo la stessaatmosfera di allora?
Certo, quest’anno e quelli che ver-ranno saranno un po’ diversi a mio pare-re. Per ragioni di sicurezza e di decenzanon sarà più possibile portare da man-giare all’interno dei locali; né sarà per-messo fumare, a meno che si decida difare una doccia collettiva. D’altrondesarebbe un peccato mortale distruggereo solo sporcare la bellezza e la preziosi-tà di quanto ci è stato restituito: un tea-tro piccolo ma bellissimo, un vero gioiel-lo del nostro passato che dobbiamoimpegnarci a preservare per quest’anno
e, soprattutto, per quelli che verranno.Durante le due serate inaugurali del
20 e 21 dicembre scorsi, accompagnatidalle consuete e inevitabili polemichema fortunatamente arricchiti da duesplendidi concerti, tutti gli interventihanno posto l’accento sull’importanza
che il Teatro Serpente Aureo ha rivesti-to in passato, non solo per noi cittadinidi Offida ma per tutti i cultori dell’artee della musica.
Alla luce di ciò e alla memoria delnostro passato e dei nostri ricordi,auguro un Buon Carnevale a tutti voi!■
Ricordi nel Teatro Serpente Aureo

8
IL BOVE FINTO(lu bov’ fint’)
La colonna è veraL’hanno riempita di cementoPer farla durare nel tempo.I mattoni sono finti: disegnati intor-no.Il sangue: acqua rossa, colorata.L’anello è vero: di ferro.Tutto un sovrapporsi di finto al veroDi vero al finto.Questa è la verità!“La storia si ripete sempre due volte:la prima volta come tragedia,la seconda come farsa”.Lu bov’ fint’.Una volta vero in carne ed ossa.Oggi falso di legno e stoffa.Nessuno sa quando si è trasformatoSolo le corna vere ci ha lasciato.Mezzo uomo e mezzo bove.Muore e risorge il venerdìdelle ceneri;chissà da quanti anni.Veniva mattato.Battuto oggi alla colonna, porta i segni di una volta.Gli spaccano la testaDi compensato disegnato.Il rito è completato.Come una bara viene portatoDa spalle barcollanti di vinoAl frastuono di trombe e tamburiLungo lo stesso giro fatto da vivo,al canto:“Addio Ninetta addioo l’armata se ne vae se non partissi anch’iosarebbe una viltà”
Addio ninetta Addio…..
FRANCO CARDARELLI(Offida 20 maggio 1988)
Come i balli e la musica destanoun notevole interesse anche le
parole usate nel periodo Carnevalesco.LU BROCCOLO. Varietà di cavolo
con infiorescenza a forma di palla dicolore verde, che cresce durante l’in-verno. Si consuma cucinato in varimodi e costituisce un alimento dimagro. Per tale motivo è entrato nelloscherzo di Carnevale. In Offida lo por-tava in giro la LA GIOIA (NazzarenoCostantini), nell’ultimo giorno diCarnevale e viene offerto alla personada prendere in burla, appunto misterbroccolo, alla chiusura dell’ultimoveglione.
IL CIORPENTO (IL SERPENTE).Concezione fallica entrata nel
Carnevale offidano con il nome di ser-pente.
LU CIUFELITT (ZUFOLETTO).Piccolo strumento fatto a mano, costi-tuito da un cilindro, in genere di canna,con un taglio trasversale all’imboccatu-ra. Usato dai giovani per far clamoredurante la manifestazione del bovefinto.
LE CONGREGHE. AssociazioniCarnevalesche sorte tra parenti ed
amici, per vivere al meglio il Carnevalein Offida. La parola deriva dal latinocum grege (col gregge).
LU DOMINO. Abito da maschera, afoggia di mantello con cappuccio, dif-fuso in epoche passate forse comeparodia di sfarzose maschere signorili.
LU FESTINE. Festa, specie notturna,che in tempi passati si svolgeva nellecampagne nelle rimesse e nei granai,con balli, suoni e rinfreschi.
LU FRACASSO. Si racconta che nelgiovedì grasso, le padelle fanno fracas-so.
LU GUAZZARO’. Indossato duranteil Carnevale fin dal 1600, è una speciedi tunica di tela ruvida e resistente,adoperata da contadini ed artigianidurante il lavoro. L’uso Carnevalescoserviva ad evitare di sporcarsi ed a ren-dere i movimenti più liberi. Si può sup-porre una contrapposizione salace conle maschere sfarzose, poiché era porta-to da gente umile.
LA SARACA (SARACCA O SALAC-CA). Un genere di pesce salato edessiccato, di facile conservazione.Sinonimo di un’alimentazione povera edi magro; questa ha trovato ampio spa-zio nelle maschere popolari che lamostrava appesa a varie parti delcorpo. In Offida era affezionato a que-sto camuffamento scherzoso GiuseppeLorenzi, becchino, che per tale motivoebbe il soprannome di Saraca.
LU SAMMUCHE (IL SAMBUCO).Arbusto a foglie composte, con fioribianchi raccolti ad ombrello. E’ simbo-lo di sterilità negli scherzi di Carnevalein Offida.
LU VELURD. Fascio di canne, coninterno di paglia, trasportato acceso perle vie di Offida, nella sera del martedìgrasso. Parola dialettale da begurdo,torneo cavalleresco medievale, contor-nato da feste, parate e luminarie.
IL VEGLIONISSIMO. In genere conquesto nome viene indicato il ballo chesi svolge in teatro o in un salone, dallasera del lunedì fino al mattino del mar-tedì grasso. ■
IL CARNEVALE SCANDITO DALLE PAROLEDI VITALE TRAVAGLINI
Il Grande Puffo con il Ciorpento delle Nevi
AGENDA CARNASCIALESCA
22 febbraio: Veglione - Teatro Serpente Aureo - ore 22,0027 febbraio: GIOVEDI’ GRASSO - bambini in maschera - Teatro Serpente Aureo - ore 15,0028 febbraio: BOVE FINTO - ore 14,00l° marzo: Veglione - Teatro Serpente Aureo - ore 22,002 marzo: Frchì in maschera - Piazza del Popolo - ore 15,002 marzo: Veglionissimo in maschera - Teatro Serpente Aureo - ore 22,003 marzo: Veglionissimo - Teatro Serpente Aureo - ore 22,004 marzo: Carnevale in Piazza e, all’imbrunire, sfilata dei VLURD22 marzo: Premiazione dei gruppi mascherati - Teatro Serpente Aureo - ore 22,00

Si deve ritenere che il Carnevaleabbia origini remotissime e sia da
collegare a quelle feste che, presso tuttii popoli, si celebravano per propiziarsil’anno nuovo. Già nell’antico Egittofurono in uso, fino al 527 a.c., festeg-giamenti che si svolgevano conmascherate. In un giorno stabilito unbue con le corna dipinte, infiocchettatee coperto di un drappo finemente lavo-rato, percorreva le vie con un fanciullosulla groppa. Lo seguiva, cantando inni,una gran folla di uomini, donne, vecchie giovani con travestimenti e maschere.Per sette giorni duravano i divertimen-ti, i banchetti, le danze e le maschera-te, fino al sacrificio dell’animale cheavveniva tra le preghiere dei sacerdoti.Questa tradizione, accertata anche inNubia, Etiopia e Mesopotamia, si tra-smise in grecia con il nome di bacca-nali. Un uomo travestito da dio bacco,con la fronte inghirlandata di edera,procedeva su un carro trainato da buoi,mentre ammassati nelle strade uomini edonne in maschera cantavano e danza-vano licenziosamente. Tali feste passa-rono a Roma, dove vennero dette avolte Lupercali a volte Saturnali esopravvissero fino al 492 d.c., quando ilPapa Gelasio I li fece sopprimere sosti-tuendoli con la festa della purificazionedella Vergine o candelora, che al pari dimolte altre solennità religiose, è lasostituzione di un rito sacro a un ritopagano.
Secondo un’altra versione, è piùprobabile che la candelora si siasovrapposta alla festa in onore diCerere, che le donne pagane celebra-vano a metà febbraio, portando in girotorce e candele accese. Le feste luper-cali, che secondo leggenda sarebberostate istituite dagli stessi Romolo eRemo in onore della lupa che li avevaallattati, avevano inizio il quindicesimogiorno di febbraio; per sette giorni sisospendeva ogni attività. Nei primisecoli dell’era cristiana, tutte questefeste avevano ormai perduto il lorosignificato originario, assumendo ilcarattere di riti plebei, improntati allapiù sfrenata licenza ed oscenità. Già dalII secolo d.C., si può ritenere che ilprocesso di acquisizione alla cultura eciviltà romana fosse ormai completatoin tutti i territori dell’impero. Eppureanche i costumi romani, venendo acontatto con altre civiltà, si modificaro-no; la festa delle calende di gennaio,introdotta in Gallia, divenne una stranae bizzarra mascherata: gli uominiindossavano abiti femminili, oppure si
coprivano con pelli di capra e scortan-do carri allegorici si riversavano nellestrade dando vita ad uno sfrenato spet-tacolo di ogni sorta di oscenità. Comegià avvenuto per tanti riti pagani, lachiesa, desiderosa di estendere il pro-prio controllo su ogni aspetto della vita,cercò, con qualche ritocco di tinta e diforma, di accogliere nel proprio ceri-moniale anche queste manifestazionidisordinate, che continuavano a resiste-re nella tradizione popolare. Fu cosìche i baccanali furono ribattezzati connomi diversi, assumendo, a secondadei luoghi, la denominazione di festadell’asino, festa dei pazzi, Carnevale,ma conservando, nella sostanza, ilcarattere di festa della trasgressione edel rovesciamento.
Il Carnevale della nostra città con-serva ancora due manifestazioni origi-nali ed interessanti: il bove finto e li“velurd”.
Il bove finto,è la rievocazio-ne delle caccedei tori, cheavvenivano perle vie e piazze oall’interno diuno steccato(origine venato-ria della tauro-machia), anchecon l’utilizzo dicani opportuna-mente addestra-ti. E’ importanteanche la tradi-zione oralmente
tramandata che vuole come in Offida untempo veniva donato da parte dei mag-giorenti, un bue da mangiare durante lefeste di Carnevale. L’animale, prove-niente dalla campagna, era accolto fuoriporta dai macellai e da una folla, soprat-tutto fanciulli, che festante lo accompa-gnava al macello, che si trovava oveattualmente è l’ingresso del teatro ser-pente aureo; è per questo motivo cheancora oggi viene simbolicamente mat-tato nell’antistante colonna.
“Li velurd” servivano ad illuminaree riscaldare, unitamente a più piccolimoccoli, le feste di Carnevale.“L’accendono ad un capo, se lo caricanosulle spalle e così percorrono a gruppi levie e le piazze urlando e bevendo, men-tre le donne sotto i portici se la spassa-no coi moccoletti”
(Michele Angelini estratto dall’ar-chivio per le tradizioni popolari, Vol. XIpagina 3).■
…ANCORA UN PO’ DI STORIA DEL CARNEVALE.DI GIANCARLO PREMICI
G.D.Tiepolo - Il commiato di Pulcinella - SA, collezione privata- riconoscibili i “nostri” vlurd -
Vecchia stampa con la rappresentazione della “caccia al toro”, antico spettacolo di tauromachia
9

10
Continuiamo la pubblicazione deglistudi di Michele Angelini presentando,un po’ in ritardo, questo scritto riguar-dante le tradizioni tra l’epifania - il 6gennaio - e S. Giovanni il 24 giugno.Integriamo l’articolo con i versi dellaPasquella e alcune annotazioni postedall’autore stesso nella copia conserva-ta in A.M.A.V. b. 20.a fasc. 28
Valeria Tozzi e Mario Vannicola
FESTE PICENE: La " Vecchia " dell’Epifania ed i
pronostici d’amore di S. GiovanniNEL PICENO ED ALTROVE
La sera dell’Epifania o Pasquettafrotte di donne vanno cantando per levie di Offida, salutando di casa in casacon versi di circostanza che finisconosempre col ritornello:
E la Pasquella evvive! evvive!Vive Pasque e Bufanie!
So venuta ‘mà Rosa,Te so pertate le mela roseTe so capate le più belle.L’anno novo e la Pasquelle;E’ la Pasquella ecc…‘N questa casa ce sta ‘na sposa,Bianca e rossa come ‘na rosa,Bianca e bella come ‘na stella,L’anno novo e la PasquellaE’ la Pasquella ecc…Se ce date ‘na boccia de vinoPè lavà Gesù Bambino,Pe lavà ‘là faccia bellaDeh ci date buona Pasquella.E’ la Pasquella ecc…E ‘si fiji che ci avétePozza avè bona fortunaO marite o moja bellaL’anno novo e la PasquellaE’ la Pasquella ecc…Vede ù lume su la porteQuacche cuose a noi ce porteE ce porte la pollastrellaL’anno novo e la PasquellaE’ la Pasquella ecc…Se ce date ‘na forma de caceCe faremo li maccaroniChe la suche de pollastrellaL’anno novo e la PasquellaE’ la Pasquella ecc…Se non danno nulla:Tanti chiuove sta ‘n quessa portaTanti diaveli ve se portaVe se porta ‘n carne e pelleL’anno novo e la PasquelleE’ la Pasquella ecc…
Quella sera a noi bambini veniva la"Vecchia" o "Befana", alla quale fin daNatale avevamo già scritta la nostrabrava letterina di rispettose richieste; e,o ci lasciava i desiderati regali in uncestello appeso alla catena del focolare,o giungeva in persona, tutta vestita dinero, con una grossa gobba, con unvocione da far paura, ma carica d’ogniben di Dio. Era generalmente il servo dicasa camuffato in tal guisa; ma chi loriconosceva?
Pel nostro popolo, la Befana arrivada Corfù; essa però si limita ad annun-ziarsi soltanto col dire:
So’ venuta da l’Oriente,Porto roba a tutta gente.Ma non è vero che a tutti porti roba.
Gli adulti ed i bimbi grandicelli chehanno già capito che chi compera iregali sono la mamma ed il papà, nonavranno mai doni dalla Vecchia. Peressi la Befana si è affogata nel venireper mare da Corfù. I ragazzi cattivi poi,invece di dolci, vesti, frutta e giocattoli,ricevono una corda ed un nerbo di bueper essere bastonati. Ma non in questosolo giorno, la Befana è oggetto ditimore o di speranza pel bambino.Tutto l’anno, se egli piange, la mammava sotto la cappa del camino a chiama-re la Vecchia perché scenda a prender-lo e portarlo via. Se cambia i denti, ilfanciullo va a nascondere quello cadu-to in una fessura del focolare.Domattina ci troverà un dono.
Se tiene in mano qualche oggettoche possa fargli del male, i parentidestramente glielo tolgono ed è laBefana che lo à portato via.
Insomma è essa la temuta giudica-trice dei bimbi, la loro severa e vigilan-te amica, la sola autorità indiscutibileper essi1.
Ad imitazione della Vecchia, c’è pergli adulti il vecchione, ricorrenza checade nel dì di S.Antonio (17 Gennaio) eche serve a quello scambio di strenne,che altrove si fa a Natale o a Capod’Anno.
Per l’Epifania inoltre abbiamo un’al-tra costumanza, comunissima del restoin tutta Italia.
Nella giornata un bambino nudo èandato – con quel freddo – a cogliereramoscelli di olivo, e la sera, al saltare
o no di quelle foglioline messe sul-l’aiuola calda del fuoco, la giovinettachiede responsi di amore2. Non altri-menti le fanciulle valacche gettano sulfuoco i propri capelli e se crepitano netraggono auspicio che avranno unbuon marito. Oppure nascondono sottoil guanciale un ramo di basilico e senella notte esse vedranno in sognol’immagine dell’amato, è segno cheentro l’anno andranno spose. Vannopure in giardino con gli occhi bendati alegare due rami d’albero e se i due ramisono d’arbusto differente, si mariteran-no nell’anno3.
In Russia, l’ultima notte dell’anno, lafanciulla colloca due specchi l’uno rim-petto all’altro, disponendo due candeleinnanzi ad ogni specchio. Seduta inmezzo e guardando in uno degli spec-chi essa vede un’infinita fuga di stanzeilluminate: - in fondo in fondo, a mez-zanotte, le apparirà il predestinato4.
In certe località francesi sonovi lePâques fleuries. A Natale, tornandodalla messa di mezzanotte le giovinettecolgono un ramoscello di melo e lopongono in una bottiglia piena d’ac-qua: se a Pasqua qualcuna dellegemme sarà sbocciata, la ragazza nel-l’annata andrà a marito.
A Brindisi, pel S. Giovanni colgonodei fiori gialli, comunissimi in campa-gna, che hanno la forma di piccolicardi; ne bruciano i petali e poi lolasciano all’aperto, durante la notte, colgambo immerso in un bicchier d’acqua.Se al mattino si trova la corolla rifiorita,la persona a cui l’auspicio è votato, saràfortunata.
A Pesaro, le fanciulle traggono oro-scopi d’amore facendo cadere, la seradi S. Giovanni, una chiara d’uovo inuna bottiglia d’acqua che poi lascianofuori nella notte. Al mattino, dallaforma presa della chiara sospesa nelliquido, deducono l’arte o professionedel futuro marito. Lo stesso avviene inAncona, ma, come in Toscana, sostitui-scono alla chiara d’uovo il piomboliquefatto.
Pure a Pesaro nella notte di SanGiovanni, i giovanotti vanno rubandogiori dai balconi delle ragazze e le con-tadine delle prossime colline scendonoa mare a bagnarsi.
1 L’uso e la credenza nella Befana fu argomento della curiosa dissertazione del Manni, ripubblicata non è guari da G. Pitrècon l’aggiunta di notizie mitologiche sul medesimo ente in Italia e fuori. V. Istorica notizia dell’origine e del significatodelle Befane. Palermo, Tip. del " Giornale di Sicilia", 1893. Vedi anche Pitré La Befana in Italia Archivio 1893 pag. 348
2 Presso i Greci le foglie di lauro parlavano bruciando: scoppiettando era buon augurio, bruciando in silenzio cattivo.Anche in sardegna deve esserci qualche cosa di simile (Archivio… 1893 pag. 333)
3 G. Brun, Le nozze valacche.
4 Nouvelle Revue, An. I. Paris, 1893.
FOLKLORE OFFIDANO

11
Il mattino poi c’è gran mercato difiori e di agli.
I primi sono scambiati fra le personeche vogliono dimostrarsi reciproca affe-zione; l’aglio invece è simbolo di dispet-to.
Far mangiare l’aglio all’amantesignifica in tutte le Marche come inToscana ed a Roma5, lasciarlo per sce-glierne un altro: perciò donare l’aglio inquel giorno è offesa o scherzo.
S. Giovanni e l’aglio vanno ancorainsieme in Valtellina, ma ben diversa-mente e ben più praticamente. Lassù inquel giorno legano le foglie della pian-ta per farne venire più grosso il bulbo.
S. Giovanni à ovunque costumanzespeciali. A raccoglierle tutte, ci si fareb-bero, anzi, ci si sono fatti dei libri6; maper tornare al Piceno aggiungerò chealtro prognostico d’amore le nostre con-tadine traggono in quel giorno da un’er-ba che chiamano l’erba dell’amore e cheassomiglia molto al basilico. Mettono
alcune foglie di quell’erba su un braccioe attendono se ci fa la piaga o no dicen-do:Se me vò bè, (l’innamorato) famme ‘narose,Se no, famme ‘na piaghe vermenose.
Nella notte di San Giovanni lemamme in Ancona fanno attingere unsecchio d’acqua di mare che al matttinomettono a bollire con fiori di campogarofani e con uno spicchio d’aglio.Serve a far la lavanda ai figliuoli perpreservarli dagli effetti dell’invidia.
Anche nella notte di San Giovanni,in Offida, espongono all’aperto, allaserena come dicono loro, un vaso d’ac-qua riempito di petali di rose. Il lavarsicon quell’acqua profumata il mattinosuccessivo preserva pure dall’invidia.
Come a Pesaro, qui, a S. Giovannic’è scambio di fiori; ma con più solen-nità i mazzi sono inviati nelle caseinsieme a chicche ed oggettini graziosi.Chi li riceve, rifà il dono il dì di S.
Pietro e simile scambio di fiori in dettacircostanza, rinnovato fra due personeper un triennio, crea il legame di com-parato, legame rispettato quanto quelloche nasce al fonte battesimale e che à isuoi obblighi ed i suoi diritti7.
Befana, S. Antonio, S. Giovanni:feste di gioie famigliari, gentili tradizio-ni perpetuate dalle madri e dagli aman-ti; sono giorni che sempre ed ovunqueci legano ai nostri cari e che ci fannosentire più amara la nostalgia dellacasa. Per essi si vorrebbe restare sem-pre giovani, sempre amati!
(Estratto dall’Archivio per le tradi-zioni popolari, Vol. XIII. - PalermoCarlo Clausen, editore, 1894). Nellapresente pubblicazione sono state inse-rite alcune note aggiunte posteriormen-te dall’autore nella copia conservata inA.M.A.V. b. 20.a fasc. 28
Michele Angelini
Due sono gli argomenti che avreidesiderato scrivere nel primo
numero di Ophys del 2003; i 200 annidall’acquisto di casa Micheli e l’avanza-mento della pratica di riconoscimentodi notevole interesse storico artisticodel Museo Aldo Sergiacomi. Il presentenumero abbiamo deciso di dedicarlo alCarnevale e, mi perdonerà il lettore se,parlerò di questo pensando ad altro.
Una delle prime testimonianzesulla permanenza offidana della fami-glia è poi direttamente ricollegabile aquesto periodo… e la tentazione è piùforte della volontà resa debole dal sen-timento.
Sin dal 1804, l’anno dopo averacquistato il palazzo dai fratelli Vitali,Gianfrancesco Micheli ottiene, nonsenza difficoltà, un palchetto per lapropria famiglia nell’antico teatro dilegno attivo a quell’epoca nella SalaConsiliare del Comune. I divertimentidi questo periodo consistono principal-mente in commedie organizzate daglistessi condomini e dalle ancor vive tra-dizioni della Caccia al Bue (allora incarne ed ossa) e dei Velurd(e).
E’ pur degno di nota che dal 1816,
e forse anche prima, il Teatro ospitafestini – antenati diretti dei veglioni –ma queste famiglie preferiscono ballarenelle ampie sale dei palazzi offidaniprimi fra tutti il Cipolletti, oggiMercolini Tinelli e, dalla fine del seco-lo, lo stesso Palazzo Comunale con lanobile fuga di sale e il palazzo Terraniospiteranno serate danzanti rimastecelebri.
Così tra commedie e veglioni aTeatro - dove i nonni ricordavano sirestava pure per la cena portata lì dallacameriera con la cesta – battaglie diconfetti con le maschere della piazzadalle finestre di casa Mercolini, veglio-ni e altri divertimenti, si giunge alpomeriggio del martedì. Allora, mentrele donne e i bambini se la spassanocon i moccoletti sotto i portici i giova-ni, sottratte le camicie da notte allerispettive mogli e sorelle, si gettanonella fiumana di fuoco dei velurd perl’ultimo scintillante saluto alCarnevale… non mi dilungo su questoindescrivibile pomeriggio che si ripete-rà e che tutti vivremo – come da sem-pre – il prossimo 4 marzo.
Il Carnevale viene però festeggiato
solennemente dal suo primo giorno: il17 gennaio S. Antonio Abate.
Era, anzi, è ancor oggi il giorno delVECCHIONE; una figura burbera, terro-re di più e più generazioni di bambiniche al pari della munifica befana vieneda Corfù portando doni.
Doni che la tradizione pretende“utili” anche per il carattere proprio diquesta figura dedicata principalmenteagli adulti.
Il dono è accompagnato a un brevesermone che il Vecchione, con ariagrave, non senza rimproveri e minac-ciosi movimenti del bastone, dedica adpersonam a ogni familiare che ascoltapentito in riverente atteggiamento.
Oggi è un parente, ieri il servo dicasa o un contadino di famiglia spessoaccompagnato da un socio con funzio-ne di spalla e da qui l’effettivo valoreammonitore del personaggio.
L’origine di questa figura, burbera ebenefica al tempo stesso, si perde,come tutte le tradizioni, nell’oblio deisecoli.
La sua ragione si deve probabilmen-te al monito dato ai giovani nell’ultimomomento utile prima di perdersi nel
5 Cantano nel contado toscano ed a Roma (V. Corazzini, Letter. Popol., pag. 166 e 271):E lo mio amore m’à mandato un foglio,E sigillato co’ no stuccio d’aglioE dentro mi ci à messo "non ti voglio".
6 Chi volesse far raffronti, vegga il Pitré, Spettacoli e Feste (S. Giovanni Battista), Palermo 1881. – Usi e Costumi, Credenze e Pregiudizi, vol II (Il Comparatico); Pal. 1889, e la notadi pp. 282 – 83. Cfr. pure tutte le 12 annate dell’Arch. Delle tradizioni popolari.Qui reputo opportuno avvertire per una volta tanto il lettore che tutte le costumanze riportate in questi appunti, e delle quali non si è indicata la fonte, sono state vedute o senti-te da me.
7 In Sardegna pel S. Giovanni esiste o esisteva pure il comparato, ma con differente e più solenne cerimoniale. V. Lamarmora, Voyage en Sardaigne.
FESTE PICENE – IL VECCHIONEDI MARIO VANNICOLA

12
© Centro Studi “Guglielmo Allevi” - Piazza del Popolo, 17 - 63035 OFFIDA (AP) - tel.0736880009 fax 0736880907e-mail: [email protected] - web: www.ophis.it
Direttore responsabile: Serafino Camilli. Segreteria di redazione, realizzazione, grafica, web: Alberto Premici.Hanno collaborato: Don Luciano Carducci, Marco Mercolini Tinelli, Vitale Travaglini, Serafino Camilli, Nicola Savini, Giancarlo Premici,
Alberto Premici, Mario Vannicola, Valeria Tozzi,Un ringraziamento particolare alla Dott.ssa Nadia Colletta per la gentile e competente collaborazione prestata.
Impaginazione: Carla D’Angelo - Stampa: La Nuova Stampa - Offida (AP) Reg. Trib. di Ascoli Piceno l’11 maggio 2002.
INVITIAMO TUTTI A COLLABORARE CON OPHYS inviando i propri articoli via e-mail, fax o recapitandoli direttamente in segreteria
DISTRIBUZIONE GRATUITA
Da qualche anno la Banca di Credito Cooperativa Picena ha aperto una succursale anche ad Offida la quale,come le altre della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo, non persegue l’obiettivo del semplice profit-to, ma ha lo scopo di contribuire alla promozione ed allo sviluppo della comunità sostenendo gli investimenti dellefamiglie e delle piccole e medie imprese. Sono banche a responsabilità sociale perché hanno obiettivi di valoriz-zazione dell’impresa ma non di lucro individuale. La Banca di Credito Cooperativo Picena è una banca che vive evuole vivere la sua responsabilità sociale, che viene concretizzata nel soddisfare i bisogni finanziari dei soci e deiclienti ricercando il miglioramento continuo della qualità e della convenienza dei prodotti e servizi offerti. Molteplicisono anche le iniziative a favore di attività culturali, sportive, sociali e di volontariato presenti nel territorio.
Serafino Camilli
Comunicazioni.A breve tutti i numeri di Ophys saranno consultabili sul sito www.ophis.it, portale della città di Offida, che dedicherà
ampio spazio al periodico e darà la possibilità di scaricare liberamente l’articolo preferito.Ciò soprattutto a beneficio deitanti offidani che risiedono all’estero e che ne hanno fatto espressa richiesta. La distribuzione del prossimo numero è pre-vista per il periodo pasquale. Tutti possono contribuire inviando i propri articoli al seguente indirizzo e-mail :[email protected] oppure [email protected] o consegnandoli direttamente in segreteria (Piazza del Popolo, 17 – tel.0736 880009 – fax.0736 880907) su supporto informatico.
Il Centro Studi “Guglielmo Allevi”, insieme ad altri collaboratori e sostenitori, intende promuovere anche lo studio e laconservazione del dialetto locale; per tale motivo ha in animo la produzione e realizzazione di una commedia dialettalenel Teatro Serpente Aureo, con interpreti, comparse e musicanti locali, il cui soggetto verta su fatti ed aneddoti del passa-to. Invitiamo tutti quelli che insieme a noi vogliono concretizzare l’idea a contattarci.A.P.
vortice del divertimento più sfrenato dicui Offida è da sempre celebre.
E’ una lieta ricorrenza certo festeg-giata ancor oggi al principio del nuovomillennio come per tutto l’ottocento, ilnovecento…
Giunge al desinare e, con l’amplia-mento della famiglia, possono accadereanche buffi incidenti come questofedelmente riportato in una corrispon-denza del patriarca Cesare Micheli del17 gennaio 1902 “Carissima Figlia,Siamo tutti nella camera da pranzodopo aver io fatto una incorpacciata dimaccheroni ti scrivo ringraziandoti delVecchione che Zia Flavia con il suo servoPeppino della Cassa ben mascheratifecero bene la loro parte come per tantevolte zia Flavia l’ha fatto. Poco dopo illoro arrivo si sente bussare alla porta earriva un altro Vecchione, che io chiamogiovane, e questo pure disimpegna la suaparte bene, è questo di Nicolina…”.
L’anno prima si era tentato di forni-re di maggiore autorità il personaggio,ammantandola di mistero ma senzagrande esito “Offida 17 gennaio 1901Ieri sera arrivò ora solita non uno madue Vecchioni, Vecchio e Nuovo grazie,scriverò a lungo le circostanze, ringra-ziami Zia Flavia… Il personaggio chereò i doni venne di fuori del territorio,ben mascherato ma Peppino con certidati precedenti indovinò la provenien-za…”. Come può immaginarsi la visitafiniva in scherzo ma, nel ringraziarenon si dimentica di dichiarare “mi ado-pererò per quanto posso di mettere inpratica i suoi consigli”.
E’antica anche la tradizione deldono utile che in questo caso ilVecchione Offidano invia alle due anti-che organizzatrici: “Siccome ilVecchione è decrepito non può farglineppure la sicurtà inforcando gli occhia-li per cucire i due grembiuli, e non aven-
do potuto trovare anima viva mandaacciò che li faccia cucire. Avverte cheuno è per la carissima Olimpia e l’altroper la Zia”
Mi è piaciuto qui inserire qualchebrano di un secolo fa quando questopersonaggio, spesso da me interpreta-to, lo era dalle mie rispettive trisnonnaFlavia Massei e bisnonna OlimpiaMicheli con la complicità di un intimodi famiglia; il compare PeppinoSergiacomi che alla Cassa di Risparmiooffidana di cui era custode deve ilsoprannome.
E col ricordo di questi concludo questabreve reminiscenza con un pensiero di affet-tuosa gratitudine ad Aldo Sergiacomi che mifece parte dell’eco di queste care personerimastogli nella memoria proprio nei localidi quel laboratorio aperto a tutti con unincomparabile gesto di amore dalla moglieLicia alla quale dedico questo mio scritto.■