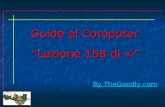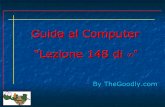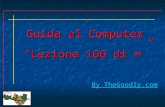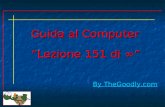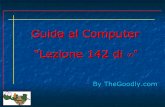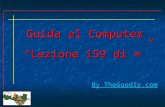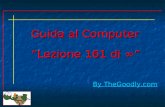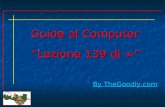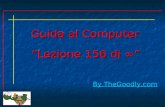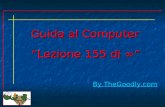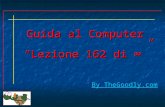Cap. 8.1
-
Upload
eyefab-oftal2432 -
Category
Documents
-
view
237 -
download
3
description
Transcript of Cap. 8.1
Capitolo 8 • Aspetti medico-legali | 359
Complicanzeed errorinella chirurgia dello strabismo
8aSpetti meDiCo-legali
CostantinoSchiaviUnità Operativa di Oftalmologia Universitaria
Policlinico S. Orsola-Malpighi – Bologna
Le complicanze della chirurgia dello strabismo possono essere suddivise in complicanze ane-stesiologiche, complicanze intra-operatorie e complicanze post-operatorie. Gli errori nella chi-rurgia dello strabismo possono essere qualitativi o quantitativi: i primi comprendono gli errori dia-gnostici e quelli di tecnica chirurgica; i secondi comprendono invece le ipo- e le ipercorrezioni. Le complicanze della chirurgia dello strabismo devono essere note all’oculista e di esse deve es-sere informato il paziente prima dell’intervento affinché il consenso al trattamento sia realmente informato. Complicanze ed errori nella chirurgia dello strabismo possono coinvolgere la responsa-bilità professionale del medico oculista.
Complicanze
ComplicanzeanestesiologicheLo strabismo infantile richiede l’anestesia gene-rale mentre quello dell’adulto può essere gesti-to sia in anestesia generale che loco-regionale oppure topica, a seconda del tipo di intervento,
360 | GLI STRABISMI E LE ANOMALIE DELLA MOTILITÀ OCULARE
del tipo di paziente, delle preferenze del chirur-go e del tipo di organizzazione della struttura sanitaria.Le complicanze anestesiologiche nella chirurgia dello strabismo sono estremamente rare. Per in-terventi in anestesia generale, la mortalità in ca-sistiche molto ampie anche se non recenti, è in-torno a 1-2:10.00010. Peraltro, col miglioramento delle tecniche anestesiologiche e rianimatorie, questi valori sono destinati a ridursi ulterior-mente. Trattandosi poi di chirurgia di elezione, da effettuarsi senza alcun criterio di urgenza, il paziente deve godere di buona salute per poter essere sottoposto all’anestesia generale. Questo fattore riduce ulteriormente i rischi dell’aneste-sia generale. Le principali cause di morte durante l’anestesia generale per interventi di strabismo sono l’arresto cardiaco e lo shock anafilattico. Fattori di rischio conosciuti per l’anestesia ge-nerale sono: livelli sierici elevati di creatinfo-sfochinasi (CPK) che comportano un rischio di ipertermia maligna2, intolleranza ad un agente anestetico con potenziale rischio di shock, por-firia e sensibilità al suxametonio. Tra le complicanze della chirurgia dello strabi-smo più frequenti, sia che si tratti di interventi in anestesia generale che loco-regionale che, infi-ne, topica, vi è la bradicardia causata dalla stimo-lazione vagale indotta dalle manovre di ingaggio con gli uncini da strabismo di un muscolo retto oppure dell’obliquo inferiore. Sono soprattutto le manovre rapide ed energiche di uncinamento e di trazione muscolare che causano bradicardia. Raramente questa giunge sino all’arresto car-diaco. L’utilizzo preventivo di atropina inoculata endovena durante l’induzione dell’anestesia ge-nerale riduce il rischio di bradicardia. Nel caso in cui si verificasse la bradicardia anche in un paziente preventivamente atropinizzato, vanno sospese temporaneamente le manipolazioni chi-rurgiche sui muscoli extraoculari e va sommini-strata una dose addizionale di atropina. Normal-mente, dopo uno o due minuti dall’inoculazione di atropina il ritmo cardiaco aumenta e l’inter-vento può essere ripreso12. Le complicanze dell’anestesia loco-regionale sono quelle delle iniezioni retro- o parabulbari: perforazione bulbare, ematoma orbitario, occlu-
sione dell’arteria centrale della retina, trauma di un muscolo e di un ramo nervoso.
Complicanzeintra-operatorieLe emorragie intra-operatorie sono complican-ze frequenti negli interventi di strabismo. De-vono essere prevenute possibilmente evitando manovre alla cieca con strumenti taglienti o acu-minati. Possono essere provocate da traumatismi accidentali di un muscolo durante le manovre di apertura della congiuntiva e della capsula di Te-none, oppure durante le manovre di isolamento di un muscolo. Per evitare queste lesioni acci-dentali, è opportuno non perdere i riferimenti anatomici durante l’intervento. L’uso di suture di trazione serve, oltre che a esporre bene il campo operatorio, ad evitare rotazioni inavvertite del bulbo oculare lungo l’asse sagittale durante l’in-tervento che potrebbero alterare i rapporti ana-tomici fra muscoli adiacenti e favorire pertanto lesioni accidentali di un muscolo. In presenza di emorragia, si deve tentare di dominarla con una cauterizzazione mirata. Vanno evitate cauteriz-zazioni disseminate che possono provocare gravi alterazioni cicatriziali post-operatorie. L’impiego di elettrocauterio in campo umido è da preferirsi perché con questa tecnica l’energia termica non si propaga alle zone circostanti. In presenza di ematoma sottocongiuntivale, que-sto deve essere asportato prima della chiusura della congiuntiva. Devono pertanto essere elimi-nati sangue, coaguli sottocongiuntivali e, spesso, il tessuto sottocongiuntivale infarcito di sangue. La congiuntiva non va richiusa prima di avere dominato il sanguinamento. Gli ematomi musco-lari sono gestibili con maggior difficoltà. Spesso occorre incidere il perimisio per favorire la fuo-riuscita del sangue. Perforazionisclero-coroidealiLe perforazioni accidentali sclero-coroideali sono divenute piuttosto rare dopo l’avvento degli aghi spatolati. La prevalenza delle perforazioni acci-dentali in corso di chirurgia dello strabismo varia da 0.4% a 1.5%, a seconda delle casistiche1, 3,11,13,14.Questi valori aumentano anche notevolmente negli interventi di miopessia retro-equatoriale, probabilmente per la maggior difficoltà tecnica
Capitolo 8 • Aspetti medico-legali | 361
nell’applicare le suture sclerali in sede retro-equatoriale, anche se giova ricordare che lo spes-sore sclerale in sede retro-equatoriale è maggiore che non in prossimità dell’inserzione dei muscoli retti. Il rischio di perforazione è maggiore negli occhi con miopia elevata in cui è infatti oppor-tuno non eseguire interventi di recessione con-venzionale con suture che devono attraversare ed essere fissate su di una sclera molto sottile. In tali casi è più opportuno eseguire recessioni con ansa (“hang-back”) in cui le suture che formano un’ansa cui è appeso il muscolo sono fatte passa-re nella sclera attraverso l’originaria inserzione del muscolo stesso ove lo spessore è maggiore. Altra situazione di rischio è quella dell’interven-to di recessione del retto inferiore contratturato in un paziente distiroideo con ipotropia restritti-va. Spesso l’occhio non può essere ruotato in alto durante l’intervento per la forte contrattura del retto inferiore. Le manovre di uncinamento e di disinserzione del retto inferiore risultano quindi complicate perché di fatto eseguite sotto cattiva visualizzazione se non, addirittura, alla cieca con rischio quindi di perforazione sclerale al momen-to della disinserzione del tendine dalla sclera.La perforazione sclero-coroideale rappresenta una complicanza grave per l’elevato rischio di endoftalmite e distacco di retina. Nel dubbio di perforazione, occorre osservare attentamente il fondo oculare ed inviare al chirurgo retinico il paziente quanto prima in caso di distacco di re-tina. Va inoltre instaurata una terapia antibiotica per via endovenosa con tempestività. In assen-za di lesioni retiniche evidenti, la retina andrà comunque sottoposta a controlli ravvicinati nei giorni successivi.In caso di lacerazione che si può verificare du-rante il passaggio sclerale troppo superficiale di una sutura, questa deve essere subito suturata con vicryl 7-0 o 8-0.
Perditadiunmuscolo(“lostmuscle”)La perdita di un muscolo è una temibile compli-canza della chirurgia dello strabismo che riguar-da generalmente i muscoli retti i quali, una volta disinseriti dalla sclera, tendono a retrarsi nell’or-bita posteriore. I muscoli obliqui invece, una volta distaccati dal bulbo, non hanno tendenza a
retrarsi poiché, a differenza dei muscoli retti, la loro origine funzionale è posta davanti all’equa-tore. La perdita di un muscolo retto può essere dovuta a scivolamento del muscolo dal miosta-to dopo la sezione della sua inserzione sclerale, oppure a errata applicazione delle suture, come succede quando queste siano fatte passare attra-verso alla capsula e non alle fibre muscolari che pertanto possono retrarsi e scivolare verso l’or-bita posteriore all’interno della capsula (“slipped muscle”). La perdita muscolare più pericolosa è quella del retto mediale perché questo è l’unico muscolo extraoculare privo di connessioni con strutture adiacenti. Infatti, il retto superiore ha connessioni con il grande obliquo, il retto late-rale e il retto inferiore hanno connessioni con l’obliquo inferiore. Queste connessioni limitano lo scivolamento dei muscoli retti in caso di per-dita del muscolo e ne facilitano il recupero. In caso di perdita del retto mediale, il chirurgo deve tentarne il recupero immediato esplorando con attenzione la zona mediana dell’orbita. Occorre esplorare attentamente la capsula di Tenone e le sue connessioni con la capsula del retto mediale. Spesso si riesce a recuperare il muscolo. In caso di recupero non riuscito, è preferibile chiudere la congiuntiva e programmare una RMN o TAC dell’orbita per meglio localizzare il muscolo per-duto e per poterne pianificare il recupero con un successivo intervento. La perdita di un muscolo può avvenire anche nel periodo post-operatorio, sia nell’immediato che nelle settimane successive. Le cause sono la dei-scenza delle suture che si sciolgono prima che il muscolo si sia riattaccato alla sclera, oppure la non corretta apposizione delle suture stesse quando queste fissano alla sclera solo la capsula del muscolo e non l’intero spessore del musco-lo. Ciò causa lo scivolamento graduale, parziale o completo delle fibre muscolari verso l’orbita posteriore all’interno della capsula ancorata. Cli-nicamente la perdita di un muscolo retto si ma-nifesta con una deviazione a grande angolo, in-comitante per un evidente deficit funzionale del muscolo perso. In questi casi occorre program-mare con sollecitudine un intervento chirurgico in cui si tenterà il recupero del muscolo perso. Se il recupero non riesce, allora si dovrà ricorrere a
362 | GLI STRABISMI E LE ANOMALIE DELLA MOTILITÀ OCULARE
un intervento di trasposizione dei muscoli retti limitrofi sull’inserzione del muscolo perso. Se, ad esempio, si è perduto il retto mediale, allora si eseguirà una trasposizione dell’intero corpo mu-scolare del retto superiore e di quello inferiore15.
StuporpupillareUna non infrequente complicanza intra-operato-ria della chirurgia dello strabismo è una midriasi transitoria, spesso irregolare e settoriale, che si instaura temporaneamente al momento del di-stacco chirurgico di un muscolo retto o dell’obli-quo inferiore dalla sclera. La causa di questa mi-driasi è probabilmente da ricercare nel rilascio di sostanze ad attività neuro-trasmettitrice liberate dal tessuto muscolare al momento della sezione del tendine9. A parte casi eccezionali, lo stupor pupillare si risolve spontaneamente nel giro di pochi minuti o poche ore e non richiede alcun trattamento.
Complicanze post-operatorie
InfezioniLe infezioni sono una complicanza rara e tutta-via pericolosa della chirurgia dello strabismo. Le endoftalmiti sono una temibile complicanza del-le perforazioni sclero-coroideali. La prevalenza delle endoftalmiti dopo chirurgia dello strabismo è molto variabile a seconda delle casistiche1, ma non comunque superiore a 1:30.000 interventi8. Un’altra potenzialmente grave complicanza in-fettiva è rappresentata dalla cellulite orbitaria che richiede l’ospedalizzazione per una pronta terapia antibiotica per via generale. In caso di cellulite orbitaria è necessario anche esegui-re una RMN o TAC dell’orbita per evidenziare l’eventuale presenza di una raccolta ascessuale che richiede un drenaggio chirurgico18.
MiositeLa miosite è una complicanza non infrequente dei re-interventi di strabismo che colpisce il mu-scolo sul quale si reinterviene. Clinicamente la congiuntiva bulbare soprastante il muscolo rio-perato si presenta iperemica e chemotica, si ha una caratteristica congestione dei vasi episcle-
rali e la motilità oculare può essere limitata sia nel campo d’azione del muscolo interessato che in quello opposto. La presenza di miosite dopo re-intervento è stata dimostrata con la RMN. Nel sospetto di miosite, va prescritta una terapia ste-roidea per os per 10-20 giorni.
AscessiegranulomidellesutureGli ascessi delle suture sono eventi rari che si verificano entro una settimana dall’intervento e sono dovuti all’utilizzo di materiale di sutura contaminato. Vanno incisi chirurgicamente sot-to copertura antibiotica topica o anche sistemi-ca. I granulomi che insorgono in corrispondenza dei punti di sutura sono anch’essi complicanze rare dopo l’entrata in uso di nuovi materiali ri-assorbibili. Rappresentano reazioni non di tipo allergico al materiale di sutura. Altre volte sono causati invece da materiale estraneo quale tal-co presente sui guanti chirurgici o frammenti di ciglia caduti inavvertitamente nel campo opera-torio. I granulomi a partenza dalle suture mu-scolari sono sottocongiuntivali, possono tendere ad ingrandirsi, danno fastidio e rappresentano spesso un problema estetico poiché determina-no dilatazione e congestione vascolare congiun-tivale ed episclerale. A volte una terapia steroi-dea topica è sufficiente a risolvere il granuloma. Altre volte è necessaria l’asportazione chirurgi-ca che nel bambino richiede purtroppo una nuo-va narcosi.
DellencornealiSi tratta di ulcere corneali asettiche limbari che si formano rapidamente, anche nel corso di po-che ore, dopo interventi per strabismo e che van-no identificate prima possibile durante il decorso post-operatorio per il rischio che il collirio a base di steroide generalmente prescritto dopo l’inter-vento, possa provocarne l’estensione superficia-le e profonda. Si formano sulla cornea limbare in corrispondenza del punto in cui è stato aperto lo sportello congiuntivale. Possono formarsi anche dopo interventi in cui si è utilizzata un’apertu-ra al fornice della congiuntiva, ma sono molto più frequenti dopo interventi in cui si è eseguita un’apertura al limbus. Vanno trattate con la so-spensione del collirio steroideo, la somministra-
Capitolo 8 • Aspetti medico-legali | 363
zione di unguenti cicatrizzanti, lacrime artificiali e bendaggio occlusivo per alcuni giorni6.
CisticongiuntivaliSi possono formare per una non accurata chiu-sura del lembo congiuntivale oppure per l’inclu-sione di cellule epiteliali e mucipare caliciformi al di sotto del piano congiuntivale quando viene chiuso il lembo congiuntivale. Si pensa che sia lo scorrimento del filo di sutura durante l’appo-sizione dei punti congiuntivali che possa favori-re l’inclusione di cellule superficiali al di sotto del piano congiuntivale. Generalmente le cisti congiuntivali non sono curabili con colliri anti-infiammatori. In taluni casi, se il paziente è adul-to, può essere tentato lo svuotamento della cisti con un ago sterile. In tali casi il rischio è che la cisti si riformi. Spesso è necessaria la rimozione chirurgica della cisti che, nel bambino, richiede la narcosi.
IschemiadelsegmentoanterioreL’ischemia del segmento anteriore è una rara e temibile complicanza della chirurgia dello stra-bismo che colpisce prevalentemente soggetti di oltre 40 anni sottoposti a chirurgia su tre muscoli retti di un occhio in un unico intervento oppure in due o più interventi eseguiti però a distanza di meno di sei mesi l’uno dall’altro. In realtà esistono delle eccezioni, per cui l’ischemia del segmento anteriore dopo chirurgia dello strabismo può col-pire anche soggetti più giovani, oppure pazienti sottoposti a intervento su due soli muscoli retti in un occhio5. L’età e la presenza di patologie va-scolari sistemiche sono fattori di rischio. Si sup-pone che il distacco dal bulbo di tre muscoli retti di un occhio, specie dei retti verticali, durante un unico intervento o anche in più interventi ese-guiti però in maniera ravvicinata, possa ridurre drasticamente l’apporto ematico al segmento anteriore per la sezione delle arterie muscolari. In alcuni pazienti, specie se non giovani, l’appor-to sanguigno dalle arterie muscolari di un unico muscolo retto integro associato a quello delle arterie ciliari posteriori lunghe può non essere sufficiente. L’ischemia del segmento anteriore si manifesta precocemente, di solito entro 24 ore, per cui è sempre indicato nei pazienti operati
per strabismo un controllo al biomicroscopio il giorno successivo all’intervento. Il rapido rico-noscimento della patologia e il suo pronto trat-tamento impediscono che si instaurino le com-plicanze potenzialmente gravi, come le sinechie posteriori e la cataratta complicata. L’ischemia del segmento anteriore deve essere prevenuta non programmando in soggetti ultraquarantenni o vasculopatici interventi che prevedano il di-stacco contemporaneo dal bulbo di tre muscoli retti in un occhio. In casi in cui sia indicata una chirurgia su tre muscoli retti di un occhio, si pos-sono programmare due interventi, il secondo a distanza di almeno sei mesi dal primo, oppure si può utilizzare la tossina botulinica su uno dei muscoli da indebolire al posto della chirurgia in modo da ottenere una chemiodenervazione del muscolo senza comprometterne la vascolarizza-zione. Anche l’incisione chirurgica al fornice è considerata meno pericolosa rispetto all’apertu-ra limbare e può essere quindi preferita nei casi a rischio. C’è anche chi consiglia di utilizzare una tecnica chirurgica che consente di spostare l’in-serzione di un muscolo retto lasciandone integra la vascolarizzazione. Con tale tecnica che richie-de l’uso del microscopio, si risparmia il foglietto superficiale del muscolo retto che contiene i vasi muscolari e si distacca e si recede o reseca solo il foglietto sottostante rappresentato dal musco-lo propriamente detto. Questa tecnica è efficace nel risparmiare la vascolarizzazione muscolare ma richiede tempi operatori molto maggiori del-le tecniche classiche. Per tale motivo, di fatto, è poco impiegata. La terapia dell’ischemia del segmento anteriore è sovrapponibile a quella di una iridociclite e si basa su colliri steroidei, mi-driatici e, talora, anche su steroidi per os per 10-20 giorni onde evitare complicanze gravi come le sinechie posteriori, l’atrofia dell’iride, la seclusio pupillare e la cataratta complicata.
ModificazionirefrattiveModificazioni refrattive transitorie possono riscontrarsi dopo chirurgia dello strabismo. Esse sono dovute alle variazioni della tensio-ne esercitata dai muscoli indeboliti o rinforzati sui meridiani corneali. In caso di astigmatismo pre-esistente all’intervento, si può anche avere
364 | GLI STRABISMI E LE ANOMALIE DELLA MOTILITÀ OCULARE
una modifica dell’asse dell’astigmatismo se l’in-tervento ha avuto un effetto torsionale. Gene-ralmente queste modificazioni refrattive sono di lieve entità e hanno tendenza spontanea a scomparire nell’arco di 3-4 mesi. Non è pertanto utile modificare la correzione ottica subito dopo l’intervento chirurgico ma conviene verificare la refrazione 3-4 mesi dopo l’intervento.
Diplopiapost-operatoriaLa diplopia post-operatoria può essere una di-plopia residua oppure una diplopia insorta ex novo dopo l’intervento. Una diplopia residua è tipica di uno strabismo normosensoriale, conco-mitante o paralitico, operato in maniera insuffi-ciente oppure eccessiva. In quest’ultimo caso la diplopia si inverte e cioè, ad esempio, da crociata diviene omonima o viceversa, oppure se prima dell’intervento la seconda immagine era vista più in alto con uno dei due occhi, in caso di iper-correzione dopo l’intervento viene vista più in basso. Anche una diplopia insorta ex novo dopo l’intervento rappresenta un problema delicato perché il paziente esperisce dopo l’intervento un disturbo visivo mai conosciuto prima. Il rischio di diplopia deve essere valutato prima dell’inter-vento e il paziente deve esserne a conoscenza. Prima di ogni intervento di strabismo, in pazienti di età superiore a sei anni, va eseguito un test di previsione di diplopia post-operatoria. La previ-sione di diplopia si può effettuare ad angolo cor-retto sia in ambiente con le stecche dei prismi di Berens, sia al sinottoforo. Con la stecca dei filtri rossi di Bagolini si può poi misurare la densità dello scotoma di soppressione. Nello strabismo normosensoriale, paralitico o concomitante, la precisione dell’intervento chirurgico rappresen-ta il fattore anti-diplopico più importante. In tali forme di strabismo poi, i movimenti fusionali aiu-teranno a garantire la visione binoculare singola anche in presenza di un angolo residuo di devia-zione. Negli strabismi non normosensoriali con soppressione e corrispondenza retinica anomala, un fattore prognostico negativo è rappresenta-to dall’ambliopia profonda di un occhio. In tali casi infatti, i meccanismi anti-diplopici come la soppressione sono probabilmente deboli e in-sufficienti a garantire visione binoculare singola
dopo che l’intervento chirurgico modifica l’ango-lo di strabismo riducendolo a valori vicini all’or-totropia. Normalmente in età infantile la diplopia post-operatoria non rappresenta un problema. Il bambino impara rapidamente a sopprimere o a trascurare la seconda immagine in maniera tan-to più rapida quanto più giovane è l’età, senza bisogno di particolari provvedimenti terapeutici. Più complicata può essere invece la gestione di una diplopia post-operatoria in un adulto. In pre-senza di un buon allineamento degli assi visivi, si dovrà invitare il paziente a non ricercare as-siduamente la seconda immagine ma a tentare di trascurarla. Ciò è definito “trascuratezza della seconda immagine” e altro non è se non un ade-guamento psicologico alla diplopia che assomi-glia a quello che tutti i soggetti sani dal punto di vista oculare hanno per la diplopia fisiologica. La prognosi è spesso positiva e il paziente non lamenterà più il disturbo dopo giorni o settima-ne dall’intervento. Altre volte si può agire sulla correzione ottica favorendo, ad esempio, la fissa-zione di un occhio rispetto all’altro, oppure sarà opportuno prescrivere una correzione prismati-ca. In caso di diplopia post-operatoria e cattivo risultato chirurgico per ciò che riguarda l’alline-amento degli assi visivi, andrà riprogrammato un ulteriore intervento. Se dai test pre-operatori in un adulto risulta una diplopia ad angolo corretto che però scompare ipocorreggendo la deviazio-ne, si può discutere con il paziente a che grado di correzione mirare con l’intervento e, possibil-mente, programmare un intervento con tecnica regolabile. È il paziente che deve scegliere tra una correzione totale dello strabismo con pro-babile diplopia post-operatoria o una correzio-ne parziale che garantisce assenza di diplopia post-operatoria ma un risultato sull’allineamento degli assi visivi incompleto. Una forma di diplo-pia post-operatoria frequente è quella torsionale che si ha dopo intervento chirurgico di recessio-ne dell’obliquo inferiore per deficit congenito o inveterato dell’obliquo superiore. Tale diplopia torsionale è dovuta all’effetto inciclotorsorio dell’intervento di recessione dell’obliquo inferio-re in un soggetto che possedeva un adeguamen-to sensoriale binoculare all’exciclotorsione dovu-to al deficit congenito dell’obliquo superiore. In
Capitolo 8 • Aspetti medico-legali | 365
ogni caso, la prognosi di questo tipo particolare di diplopia post-operatoria è molto buona perché ha tendenza alla risoluzione spontanea nell’arco di poche ore o di alcuni giorni.La prognosi delle diplopie post-operatorie è non raramente positiva poiché spesso il disturbo si ri-solve spontaneamente. È comunque importante che il paziente sia sempre informato della pos-sibilità di diplopia post-operatoria prima dell’in-tervento e che sia preparato ad affrontare questa complicanza serenamente, senza paure spesso irrazionali. Purtroppo si incontrano pazienti cui è stato inculcato da oculisti e ortottisti una sorta di terrore nei confronti della diplopia post-ope-ratoria ai quali può risultare difficile, se non im-possibile, proporre l’intervento correttivo.
errori nella chirurgia dello strabismo
Scopo della chirurgia dello strabismo è il rialli-neamento degli assi visivi che può comportare un perfetto ripristino della visione binoculare e la scomparsa della diplopia in pazienti normo-sensoriali, oppure una migliore sovrapposizione, cioè più simile a quella fisiologica, dei due cam-pi visivi nello strabismo congenito senza visione binoculare normale. In caso di strabismo conge-nito non normosensoriale con alternanza di fissa-zione, il riallineamento chirurgico rende poi più rapido il passaggio della fissazione da un occhio all’altro, rendendo più agevole l’atto visivo17. Da queste considerazioni deriva che il risultato otti-male o, comunque, sufficiente di un intervento di strabismo è diverso, a seconda che si tratti di uno strabismo normosensoriale oppure di uno strabismo senza visione binoculare normale. In uno strabismo normosensoriale concomitante o paralitico un risultato sufficiente dell’atto chirur-gico sarà la scomparsa o la riduzione della diplo-pia almeno nelle posizioni principali di sguardo anche con l’ausilio di un’eventuale correzione prismatica. Oppure, in caso di strabismo inco-mitante, l’ampliamento del campo di sguardo bi-noculare. Nello strabismo con visione binoculare normale e ampiezza fusiva, l’atto chirurgico è aiu-tato dai movimenti fusionali che consentono una fissazione bi-foveolare. Nei casi invece di strabi-
smo non normosensoriale, che è rappresentato soprattutto dallo strabismo congenito o a insor-genza precoce, un totale allineamento binocula-re non è ottenibile con la chirurgia o con nessun altro provvedimento terapeutico. In questi casi il successo della chirurgia è rappresentato dall’ot-tenimento di una deviazione post-operatoria di piccola entità e cioè entro le 10 diottrie prisma-tiche, che viene definita “a piccolo angolo” o “mi-crotropia” che, come detto, consente di ottene-re una sovrapposizione dei due campi visivi più simile a quella fisiologica. Per tutte queste con-siderazioni, la correzione chirurgica dello stra-bismo è pertanto da considerarsi un intervento di tipo ricostruttivo della visione e non di natura principalmente estetica e ciò modifica il profilo di responsabilità professionale. Ha significato puramente estetico solo l’intervento per elimina-re lo strabismo di un occhio non veggente. Come detto nell’introduzione, gli errori nella chirurgia dello strabismo possono essere riassunti in errori di quantificazione dell’intervento che provocano ipo- o iper-correzioni, errori diagnostici ed errori di tecnica chirurgica.
IpercorrezionieipocorrezioniLe ipercorrezioni e le ipocorrezioni rappresenta-no spesso degli errori di dosaggio della chirur-gia oppure il risultato di errori di valutazione del difetto refrattivo o del rapporto accomodazione/convergenza. In altri casi, una modesta ipercor-rezione o ipocorrezione della deviazione rappre-senta il risultato voluto, o per eliminare il rischio di diplopia post-operatoria, o per ridurre il ri-schio di recidiva della deviazione. Ad esempio, l’esotropia consecutiva con diplopia omonima causata da ipercorrezione di una exo-deviazione, se entro le 15 diottrie, ha di solito una prognosi molto positiva in quanto tende a risolversi spontaneamente o con l’ausilio di pri-smi a membrana il cui potere venga gradualmen-te ridotto. Una leggera ipercorrezione è quindi il risultato ideale dell’intervento per le exodevia-zioni, poiché vi è sempre una certa tendenza alla recidiva dell’exodeviazione stessa e una modesta esotropia consecutiva rende meno probabile tale recidiva. Se l’esotropia consecutiva è superiore alle 15 diottrie invece, è probabile che non rece-
366 | GLI STRABISMI E LE ANOMALIE DELLA MOTILITÀ OCULARE
da e diventi costante. In questi casi si dovrà veri-ficare se con una correzione ottica o con prismi il paziente potrà essere gestito oppure se è neces-saria una correzione chirurgica. L’ipercorrezione della exodeviazione in un bambino deve essere gestita tempestivamente con lenti e prismi per prevenire la perdita della visione binoculare. Nell’immediato post-operatorio può essere utile in questi casi un bendaggio alternato per alcuni giorni che, da un lato impedisce la diplopia e l’in-staurarsi degli adeguamenti sensoriali, dall’altro favorisce la riduzione dell’exotropia. L’exotropia consecutiva dovuta a ipercorrezione di una esotropia, rappresenta spesso una situa-zione poco stabile destinata ad accentuarsi nel tempo, trattandosi spesso di pazienti non nor-mosensoriali privi di ampiezza fusiva. Nel caso di esotropia essenziale infantile, è considerato risultato post-operatorio migliore una esotropia residua a piccolo angolo che non una exotropia residua a piccolo angolo la quale generalmente tende a peggiorare col trascorrere del tempo. Una exotropia consecutiva è destinata poi ad ac-centuarsi con l’insorgere della presbiopia. Nelle deviazioni consecutive causate da ipercorrezio-ne chirurgica dello strabismo, si può tentare di agire sulla correzione ottica per ridurre l’ango-lo di deviazione. Nelle esotropie consecutive, ad esempio, si potrà aumentare la correzione ottica ipermetropica o ridurre quella miopica. Viceversa si farà nelle exotropie consecutive. In presenza di alterazioni della motilità oculare indotte dalla chirurgia quali deficit muscolari da eccessiva recessione o iperfunzioni da eccessiva resezione (“tight muscle”), così come in presen-za di angoli di deviazione consecutiva superiori a 15 diottrie prismatiche, tali provvedimenti non sono in genere sufficienti e spesso occorre ricor-rere a un nuovo intervento chirurgico. In caso di ipercorrezione che richieda un intervento chi-rurgico, spesso è necessario riavanzare musco-li eccessivamente recessi; altre volte si devono recedere muscoli eccessivamente resecati. Nella programmazione del reintervento è comunque assolutamente indicato valutare accuratamen-te la motilità oculare oltre che la deviazione e comportarsi di conseguenza. Non è pertanto ob-bligatorio rioperare i muscoli precedentemente
operati, ma è preferibile prefiggersi di corregge-re lo strabismo normalizzando la motilità ocula-re. Questo comportamento fu consigliato già 40 anni fa da Cooper ed è conosciuto come legge di Cooper4.Per quanto riguarda gli strabismi verticali, le iper- o le ipo-correzioni manifeste sono un’eve-nienza abbastanza frequente anche in presenza di visione binoculare normale fondamentalmen-te perché i movimenti fusionali verticali hanno di solito un’ampiezza molto contenuta nei sogget-ti normosensoriali. Le ampiezze fusive verticali sono invece patologicamente molto sviluppate in soggetti con deficit congenito dell’obliquo superiore. Ciò rappresenta una garanzia di suc-cesso chirurgico in questa che è la forma di strabismo verticale più frequente. In questi casi infatti basta ridurre la deviazione verticale con una recessione dell’obliquo inferiore ipsilaterale per migliorare significativamente il quadro clini-co. Ciò che è da evitare è un’ipercorrezione che generalmente non è compensabile ad opera del-le ampiezze fusive verticali patologiche le quali funzionano per un occhio ipertropico ma nulla possono se tale occhio diviene ipotropico. Nel caso invece della paralisi acquisita del 4° ner-vo cranico, l’assenza di ampiezze fusive vertica-li obbliga a una precisione chirurgica assoluta non sempre facile da ottenere. La chirurgia sul grande obliquo può dare non infrequentemen-te origine a ipo- o ipercorrezioni, non essendo facilmente quantificabile soprattutto per le fre-quenti varianti anatomiche del tendine rifles-so e della sua inserzione bulbare che possono confondere e trarre in inganno il chirurgo. Ad esempio, un eccessivo tucking del tendine rifles-so in caso di paralisi dell’obliquo superiore può causare una sindrome di Brown jatrogena che costringe di solito a reintervenire7. Sono soprat-tutto i tucking in cui la parte duplicata del ten-dine del grande obliquo viene fissata alla sclera quelli che determinano con maggiore frequenza una sindrome di Brown jatrogena. Tale ancorag-gio andrebbe pertanto limitato alle forme con deficit totale dell’obliquo superiore. La recessione del retto inferiore nell’ipotropia del paziente distiroideo o nella paralisi del gran-de obliquo controlaterale presenta invece una
Capitolo 8 • Aspetti medico-legali | 367
elevata tendenza a determinare nel tempo una ipercorrezione e cioè una ipertropia. Di ciò an-drebbe tenuto conto quando si effettua una re-cessione del retto inferiore, anche con tecnica regolabile, dove il risultato ideale della chirurgia dovrebbe essere una lieve ipocorrezione dell’ipo-tropia.
ErroridiagnosticiGli errori diagnostici nello strabismo sono pur-troppo frequenti. Da un errore diagnostico de-riva spesso un’indicazione chirurgica e un in-tervento chirurgico errati che generano spesso quadri clinici postoperatori complessi e di non facile soluzione. Gli errori diagnostici riguarda-no più spesso strabismi complessi, specie stra-bismi verticali. Un quadro emblematico è quello rappresentato da un originario deficit congenito dell’obliquo superiore con l’occhio paretico fis-sante, iperfunzione dell’obliquo inferiore dell’oc-chio fissatore, torcicollo con capo inclinato su spalla controlaterale, ipotropia e pseudo ptosi palpebrale dell’occhio controlaterale non pare-tico. Questo quadro, tutt’altro che infrequente, viene spesso scambiato per una paralisi parcella-re del 3° nervo cranico dell’occhio controlaterale con deficit del retto superiore e dell’elevatore palpebrale. Basandosi su questa diagnosi errata, viene quindi operato il retto superiore e, talvolta, anche l’elevatore palpebrale dell’occhio non pa-retico per correggerne l’ipotropia e la ptosi che è in realtà una pseudo ptosi. Questo tipo di inter-vento non normalizza la motilità oculare e non corregge il torcicollo e complica comunque la gestione successiva del paziente. Altri errori co-muni riguardano l’età alla quale viene prescritto ed effettuato l’intervento. Ad esempio, l’esotro-pia di un bambino ipermetrope elevato non deve essere operata precocemente ma bensì dopo i quattro anni per l’elevata tendenza all’exotropia consecutiva anche spontanea nei primi anni di vita. In tali casi la terapia di scelta è la correzione ottica totale dell’ipermetropia e, se necessario, l’intervento dopo i quattro anni. Al contrario, un’esotropia acuta normosensoriale deve essere operata o trattata con tossina botulinica entro breve tempo dall’insorgenza se il bambino ha un’età inferiore a sei anni onde evitare la perdi-
ta della visione binoculare normale e lo sviluppo delle alterazioni sensoriali tipiche dello strabi-smo congenito. Altri errori diagnostici riguarda-no la non corretta valutazione dell’errore refrat-tivo, dell’elemento accomodativo e del rapporto convergenza accomodativa e accomodazione. L’errore più frequente è rappresentato dalla ipercorrezione chirurgica di una esotropia acco-modativa in cui sia stato sottovalutato e quindi ipocorretto il difetto ipermetropico, Al paziente non viene prescritta la correzione ottica totale dell’ipermetropia, come si dovrebbe, ma bensì una correzione parziale e sulla base dell’angolo di deviazione con tale correzione viene sottopo-sto a intervento. Il paziente viene poi lasciato con correzione ottica insufficiente fino alla scuola se-condaria o superiore quando di solito non riesce più ad avere un’acuità visiva sufficiente senza la correzione ottica adeguata. La prescrizione della correzione ottica totale comporta allora il netto miglioramento dell’acuità visiva ma contempora-neamente la slatentizzazione dell’exodeviazione consecutiva.
ErroriditecnicaLe tecniche chirurgiche che si utilizzano per la correzione dello strabismo sono essenzialmente tecniche di indebolimento, tecniche di rinforzo dell’azione muscolare e tecniche di supplenza dell’azione di un muscolo paralizzato ad opera di muscoli sani limitrofi. Numerose sono le varianti di queste tecniche di rinforzo o di indebolimento e ciascun chirurgo ha le proprie preferenze per-sonali legate soprattutto all’esperienza. Se mol-teplici sono le tecniche, molteplici sono pure gli errori di tecnica. Tra i più frequenti ricordiamo quelli che vengono compiuti nell’intervento di miopessia retro-equatoriale di un retto mediale dove l’errore risiede spesso nel punto sclerale dove vengono fissate le suture che, anziché esse-re a 13 millimetri dall’inserzione muscolare per essere realmente retro-equatoriale, è situato a distanza minore. È la difficoltà ad esporre il cam-po operatorio in sede così posteriore la causa principale di tale errore tecnico. L’errore inficia spesso l’efficacia dell’intervento che ha lo scopo di bloccare l’azione del retto mediale quando questo si contrae nella visione per vicino piutto-
368 | GLI STRABISMI E LE ANOMALIE DELLA MOTILITÀ OCULARE
Figura 1. Exotropia ad “A” consecutiva in esiti di miectomia degli obliqui inferiori associata a recessione dei retti mediali in originaria esotropia essenziale
sto che nello sguardo per lontano. Un ancoraggio troppo anteriore non consente in genere di cor-reggere l’esotropia per vicino. Altri errori riguardano, ad esempio, la dislocazio-ne verticale inavvertita di un muscolo orizzontale durante gli interventi di recessione. Se non viene rispettata scrupolosamente la direzione del mu-scolo durante la misurazione della recessione e l’apposizione delle suture, il muscolo può esse-re dislocato verticalmente e ciò può poi causare una deviazione verticale. Tra gli errori di tecnica più diffusi vi è l’interven-to di miectomia degli obliqui inferiori che taluni attuano sistematicamente nell’esotropia essen-ziale infantile assieme alla recessione dei retti mediali anche in casi con modesta elevazione in
adduzione e assenza di atteggiamento alfabetico a “V”. In tali casi non infrequentemente la mie-ctomia degli obliqui inferiori risulta un interven-to di indebolimento eccessivo di tali muscoli che determina a sua volta l’iperfunzione secondaria degli obliqui superiori che hanno azione abdutto-ria nello sguardo in basso . Ciò determina lo svi-luppo di atteggiamento ad “A” e una exodevia-zione secondaria, dapprima solo nello sguardo in basso, poi anche in posizione primaria. Molte delle exotropie consecutive di pazienti operati in giovane età per esotropia infantile sono in realtà degli originari atteggiamenti ad “A” da indebo-limento eccessivo degli obliqui inferiori causa-to dalla miectomia16 (Figura 1). La recessione degli obliqui inferiori è un intervento meglio
Capitolo 8 • Aspetti medico-legali | 369
graduabile che va senz’altro preferito alla mie-ctomia. Consente infatti di ottenere un indeboli-mento anche solo parziale dell’obliquo inferiore, riducendo il rischio di exotropie consecutive con atteggiamento ad “A”. L’incidenza delle complicanze della chirurgia del-lo strabismo può essere ridotta con il progressivo
miglioramento delle tecniche anestesiologiche, dei materiali di sutura e delle attrezzature chi-rurgiche, nonché con i moderni microscopi ope-ratori che facilitano la visualizzazione del campo operatorio. L’incidenza degli errori diagnostici e di tecnica chirurgica deve invece essere ridotta con il progresso delle conoscenze.
1. BErGErrW,HaasEW. Complications in strabismus sur-gery. Strabismus 5:67-72, 1997
2. BErGmaN GA. Idiopathic malignant hyperthermia. Arch Ophthalmol 93:232-234, 1975
3. CIBIs GW. Incidence of inadvertent perforation in strabi-smus surgery. Ophthalmic Surgery 23:360-361, 1992
4. CoopEr EL. The surgical management of seconda-ry exotropia. Trans Am Acad Ophthalmol Otolaryngol 65:595-608, 1961
5. FraNCEtd,sImoNJW. Anterior segment ischemia syn-drome following muscle surgery. The AAPOS experien-ce. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 23:87-91, 1986
6. FrEsINam,CamposEC. Corneal dellen as a complica-tion of strabismus surgery. Eye 23:161-163, 2009
7. HErvouEtF,CHEvaNNEsH. Syndrome of the sheath of the superior oblique. Ann Ocul (Paris):857-865, 1966
8. ING mr. Infection following strabismus surgery. Ophthalmic Surg 22:41-43, 1991
9. JamEsCB,ElstoNJs. Effect of squint surgery on pupil-lary diameter. Br J Ophthalmol 79:991-992, 1995
10. KNoBloCK r, lorENz a. Über ernste Komplikationen nach Schieleoperationen. Klin Monatsbl Augenheilkd 141:348-353, 1962
11. KusHNErBJ,luCCHEsENJ,mortoNFv. Variation in axial
B I B L I O G R A F I A
length and anatomical landmarks in strabismic pa-tients. Ophthalmology 98:400-406, 1991
12. mIlotJ,JaCoBJl,BlaNCvF,HardyJF. The oculocar-diac reflex in strabismus surgery. Can J Ophthalmol 18:314-317, 1983
13. morrIs rJ, rosEN pH, FElls p. Incidence of inadver-tent globe perforation during strabismus surgery. Br J Ophthalmol 74:490-493, 1990
14. NoEl lp,Bloom JN,ClarKEWN,BaWazEEr a. Retinal perforation in strabismus surgery. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 34:115-117, 1997
15. plaGErda,parKsmm. Recognition and repair of the “lost” rectus muscle. A report of 25 cases. Ophthalmo-logy 97:131-137, 1990
16. sCHIavIC,BEllusCIC,duCaa,CamposEC. Consecutive “A” alphabetic pattern after conventional weakening surgery of the inferior oblique muscles to correct eleva-tion in adduction in essential infantile esotropia. Trans. 27th Meeting E.S.A., Firenze, J. T.de Faber ed., Swets & Zeitlinger Publishers, 2002, pp. 73-76
17. sCHIavIC,BolzaNIr,BENassImG,BEllusCIC,CamposEC. Visual recognition time in strabismus: small-angle versus large-angle deviation. Eur J Ophthalmol 14:200-205, 2004
18. WIlsoNmE,paulot. Orbital cellulitis following strabi-smus surgery. Ophthalmic Surg 18:92-94, 1987