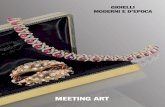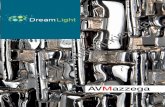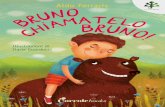Bruno Latour – Non siamo mai stati moderni
-
Upload
lorenzo-ruzzene -
Category
Science
-
view
233 -
download
11
description
Transcript of Bruno Latour – Non siamo mai stati moderni

Corso di laurea specialistica inSociologia e Ricerca Sociale
Sociologia della Scienza - Modulo BProf. Massimiano Bucchi
Bruno Latour – Non siamo mai stati moderniSaggio di antropologia simmetrica
Lorenzo Ruzzene [128048]
Anno Accademico 2007-2008

“Non siamo mai stati moderni”. Con questa affermazione, per certi versi provocatoria,
Bruno Latour ha intitolato uno dei suoi testi più noti [Bucchi, 2002: 118] e tradotti1 della
sua carriera. In essa si è distinto nello studio dei processi microsociali della scienza,
analizzando la vita di laboratorio con approccio etnografico [Latour & Woolgar, 1979],
facendo così emergere le negoziazioni che avvengono tra tutti i soggetti coinvolti [Bucchi,
2002: 79]. Teoria sviluppata successivamente [Latour, 1987] e denominata «actor-network
theory». In “Non siamo mai stati moderni”, risalente al 1991, percorre ovviamente lo
stesso filone di studi, e all'interno si trovano applicati gli studi dell'autore.
Torniamo al titolo dell'opera che intendo trattare: non solo dunque la modernità non è al
momento presente, ma addirittura non è mai esistita. Ecco perciò spiegato il sottotitolo
dell'opera, “Saggio di antropologia simmetrica”: se non siamo (mai stati) moderni, come
possiamo considerare premoderni gli “altri” venuti prima o semplicemente lontani da noi?
Ovviamente la questione è più complessa di quella brevemente presentata, ma può
essere sufficiente per introdurre la tesi del testo (per altro ben argomentata nonostante il
ridotto numero di pagine). È quindi necessario spiegare che cosa per Latour caratterizza
la modernità, quale presunta differenza dovrebbe presentare rispetto al passato e nelle
popolazioni che solitamente non consideriamo tali, cercando di comprendere quale
lettura viene fatta di questo periodo storico e cosa l'ha resa possibile.
Iniziamo con quest'ultimo punto, che corrisponde a quello con cui l'autore introduce il
saggio. Nello sfogliare un quotidiano (oggi potremmo aggiungere navigando in Internet), si
ha a che fare con notizie alquanto particolari: il buco dell'ozono, il virus dell'AIDS, il
trattamento degli embrioni, l'introduzione di contraccettivi, e l'elenco potrebbe continuare
a lungo. Ciò che forse non nota una persona comune, oramai abituata a tale stato di
cose, è che in tali questioni sono coinvolti numerosi protagonisti, che a rigor di logica non
dovrebbero essere comparabili, ovvero scienziati, policy makers, industriali e cittadini,
spesso presenti in forma organizzata. Analizzando la situazione con un punto di vista
classico, e quindi suddividendo un fatto tra varie discipline, si nota che queste notizie
sono veri e propri «guazzabugli» di scienza, tecnologia, politica, religione, diritto, e così
via. Pochi si preoccupano di ciò, eppure tutti (noi «moderni») siamo stati educati al fatto
che natura e società sono due scomparti ben distinti, dove la prima è il mondo delle cose,
ordinato da leggi certe e universali, mentre la seconda è il mondo degli uomini, dove poco
1 Mantenendo, fortunatamente, sempre lo stesso titolo nelle più di venti lingue in cui è stato stampato. Vedi http://www.bruno-latour.fr/livres/livres.html .
1

o nulla è determinabile, e dove avvengono frequenti conflitti. Cosa sono allora questi fatti
che non è possibile ascrivere né alla natura e né alla cultura univocamente? Latour li
definisce «ibridi», che non possono essere spiegati tramite le discipline pure, ma
solamente analizzando la «rete sottile» che costituisce il tessuto del nostro mondo. La
tendenza degli analisti, dei critici, è invece quella di dicotomizzare qualsiasi evento,
cercando di negare qualsiasi tipo di commistione tra i «fatti» e gli interessi, la politica o più
generalmente il potere [p.11-13].
In questi due gruppi di pratiche si sostanzia la novità dell'era moderna: da una parte
avviene una creazione per traduzione, mediazione, dove ibridi di natura e cultura
proliferano; dall'altra per depurazione si producono due aree completamente distinte, gli
umani e i non umani. Il fatto appassionante, che forse richiede qualche ulteriore elemento
per essere compreso, è che senza il primo insieme non avrebbe senso il secondo, ed è
proprio quest'ultimo a rendere possibile il primo [p.22-23].
Questa intesa comune per Latour prende il nome di «Costituzione», proprio come quelle
politiche, leggi fondamentali dello Stato. La Costituzione moderna è però caratterizzata
dal fatto di ripartire e definire “gli umani e i non umani, le loro proprietà e relazioni, le
competenze e le divisioni in gruppi”. Ed è questo che gli antropologi moderni dovrebbero
essere in grado di spiegare, dato che quando studiano popolazioni «non moderne» non
operano distinzioni tra conoscenze, poteri e pratiche [p.27-28]. Rimane però un dubbio.
Ammettendo, d'altronde con poche riserve, che quanto detto è ciò che avviene da secoli
nel rapporto scienza-società, dove la prima si pretende «vergine» da influenze esogene, e
la seconda ritiene di poter risolvere i propri problemi solamente al suo interno, e quindi tra
gli uomini, resta aperta la questione di quando sia nata questa scissione.
Scopriamo che l'inizio della redazione della Costituzione è rappresentato da due figure
paradigmatiche per le due sfere: Thomas Hobbes e Robert Boyle2, noti ai più come
rispettivamente (se serve precisarlo) politologo e scienziato. Quello che però molti non
sanno è che entrambi, nel XVII secolo, discutevano degli stessi argomenti, ed in particolar
modo di quale dovesse essere la ripartizione tra i poteri scientifici e politici [p.28].
L'intuizione di trattare assieme queste due figure non è originale [Shapin & Schaffer, 1985;
Bucchi, 2002: 762], e Latour stesso non nega ai due studiosi del cosiddetto «programma
forte» (SSK) [Bucchi, 2002: cap.3] il merito. Sarà invece originale la nuova lettura che
2 Thomas Hobbes (1588-1679) tra i fondatori della teoria dello Stato moderno e Robert Boyle (1627-1691), tra i fondatori della Royal Society, noto soprattutto per la legge dei gas recante il suo nome.
2

l'autore ne farà, ma procediamo con ordine. Shapin e Schaffer ci mostrano come ai tempi
di Hobbes e Boyle la demarcazione tra scienza e società non fosse affatto scontata. In
primo luogo, pochi sanno che Hobbes ha scritto anche di scienza e, viceversa, Boyle di
teoria politica. I due si trovano d'accordo quasi su tutto (volevano il Re, un Parlamento,
una Chiesa docile e unificata, ed entrambi erano adepti della filosofia meccanicista). La
loro più profonda divergenza era invece riguardo alla sperimentazione e al ragionamento
scientifico, alle forme di argomentazione della politica, e soprattutto alla «pompa
pneumatica», autentica protagonista della vicenda [p.29].
Mentre nel periodo infuriano guerre civili, Boyle offre un ragionamento non apodittico
(dimostrato logicamente, evidente, inconfutabile), ma un metodo di argomentazione che
si basa sulla doxa. Ovvero sostiene di essere in grado di realizzare il vuoto tramite la sua
pompa3, e questo viene testimoniato grazie alla presenza di figure credibili, persone
benestanti e di buona fede. Ecco dunque nascere il «matter of fact», di un fatto attestato
tramite l'osservazione di un fenomeno prodotto artificialmente in laboratorio. Grazie a
queste circostanze perfettamente controllabili, Boyle ritiene di poter conoscere la natura
dei fatti. Ha trasformato quella che era una debolezza, in una forza [p.30-31].
Anche Hobbes, come si è detto, voleva mettere fine alle guerre civili che incombevano in
quella fase storica. Ritiene però che non ci debba essere trascendenza affinché ciò
avvenga, perciò i cittadini non devono poter invocare un'entità superiore (che sia la
Natura o Dio) che non sia controllata dal sovrano. Proprio per questo, l'argomentazione di
Hobbes non può nemmeno fondarsi sull'opinione, ma sul calcolo puro, una dimostrazione
matematica che porta tutti i cittadini assieme a rispettare il contratto sociale, pur di
affrancarsi dallo stato di natura [p.31-32]. Mentre Hobbes cerca di unificare e ridurre la
cause di conflitto tra gli uomini, Boyle presenta una divisione pronta a farli nuovamente
combattere. Non solo, ma tutto questo per l'osservazione di un fenomeno che più
discutibile non potrebbe essere, ovvero il «vuoto», in uno spazio (il laboratorio) dove lo
stato non dovrebbe, per Boyle, esercitare alcun controllo. Inoltre se i gentiluomini che
fanno da testimoni a Boyle si trovano d'accordo sul fenomeno osservato, questo non
avviene perché si tratta di una dimostrazione matematica accettabile da chiunque, ma “il
frutto delle esperienze osservate da sensi ingannevoli, esperienze che restano inesplicabili
e poco conclusive” [p.33]. Tutto questo terrorizza Hobbes, che ammonisce il Re con
l'affermazione “Vedrete doppio”, in quanto teme una nuova separazione tra conoscenza e
3 Si veda http://www.princeton.edu/~his291/Jpegs/Air_Pump.JPG .
3

potere, e [ivi].
Proseguiamo con i meriti di Shapin e Schaffer. La loro opera è brillante per Latour in
quanto costringe a passare per uno strumento (la pompa ad aria), studiando assieme le
pratiche scientifiche, il contesto religioso, politico e culturale. È una prospettiva che
quindi molto si avvicina all'approccio di Latour, che si interessa alle pratiche e alle reti,
considerando l'intero contesto nel quale avvengono le scoperte scientifiche [p.34]. Non si
comprenderebbe altrimenti quanto il metodo di costruzione di un «matter of fact» di Boyle
si avvale del repertorio proveniente dal diritto penale e dall'esegesi biblica, ed il fatto che i
testimoni per risultare affidabili dovevano essere uomini di fede. C'è però una novità:
prima di Boyle i testimoni potevano essere solo umani o divini. Con la pompa ad aria si
vede la nascita di un nuovo tipo di testimone, che la Costituzione riconosce come
affidabile, ovvero i «non umani» [p.37], i quali “hanno più peso dei palombari ignoranti”,
facilmente manipolabili [Shapin & Schaffer, 1985: 218; cit. ivi]. Sorge allora la questione
che se la scienza non si fonda sulle idee ma su una pratica e ha luogo all'interno di uno
spazio sperimentale, come fa a diffondersi? Grazie all'estensione della rete, che oltre ad
estendersi si stabilizza in tutta Europa, facendo diventare la pompa ad aria una routine nei
laboratori. Non potrebbe essere altrimenti, dato che per Latour nessuna scienza può
uscire dalla rete della sua pratica [p.38].
Fino ad ora la lettura che Latour fa dell'opera di Shapin e Schaffer non presenta differenze
di rilievo. Hobbes ha creato le principali risorse di cui disponiamo per parlare del potere:
rappresentanza, sovrano, contratto, proprietà e cittadini. Boyle elabora i repertori per
parlare della natura: esperienza, fatto, testimonianza e colleghi. I due studiosi del
programma forte però non sviluppano a fondo il loro studio. Mantengono perciò
un'asimmetria di fondo, in quanto non si rendono conto che si trattasse di una «doppia
invenzione» [p.39]. Infatti terminano il testo sostenendo “La conoscenza, proprio come lo
Stato, è un prodotto dell'agire umano. Hobbes aveva ragione” [Shapin & Schaffer, 1985:
344; cit. p.41]. Quello non vedono è che anche Hobbes inventa e crea quello che a
tutt'oggi è a fondamento del linguaggio politico (potere, interesse, politica). In pratica
fanno passare la politica come l'unica spiegazione valida, “vedono doppio” anche loro,
usando la stessa asimmetria di Hobbes [p.41-42]. Si tratta di un approccio che
rimprovera al filone SSK, quello di essere costruttivista per la natura ma realista per la
società [p.117-118]. Detto questo, si oppone allo stesso concetto di cultura, creato
4

mettendo la natura tra parentesi. Esistono invece »nature-culture», senza la necessità di
separare qualcosa che si forma unito [p.126-129].
Resta il fatto che Hobbes e Boyle hanno «inventato» la Costituzione moderna, o per
meglio dire iniziato a costruirne i pilastri. Si tratta di dissociare la rappresentazione delle
cose tramite il laboratorio dalla rappresentanza dei cittadini mediante il contratto sociale4.
Boyle propone di rappresentare gli oggetti, in quanto non possono parlare, Hobbes di
rappresentare gli eletti perché non potrebbero parlare tutti assieme. Ora però che
mostriamo maggior fatica nel suddividere in due i fenomeni, dovremmo notare come i due
significati di rappresentanza tendono a riavvicinarsi, proprio come nel XVII secolo, dove la
simmetria era ancora visibile [p.42].
Non si deve però pensare che che queste «due garanzie» si contraddicano tra di loro. Tra
esse vi è una sorta di check and balances, si sostengono a vicenda [p.43], permettono di
mettere in atto il doppio gioco dei moderni, utilizzando le scienze naturali per “criticare le
false pretese del potere e le scienze umane per criticare quelle naturali”5 [p.52; Bucchi,
2002: 121]. Detto ancora meglio “Qualunque cosa facciamo noi, per quanto criminali,
imperialisti si possa essere, riusciamo a evadere dalla prigione del sociale o del
linguaggio, e accedere alle cose stesse attraverso una provvidenziale scappatoia, quella
della conoscenza scientifica.” [p.123]
Rimane da capire perché proprio ora (in questi ultimi decenni) sia possibile con maggiore
facilità osservare e superare la Costituzione moderna. La causa di ciò è dovuta agli
avvenimenti del «miracoloso 1989», dove oltre al fallimento del socialismo (risoluzione del
dominio dell'uomo sull'uomo), si verifica anche la crisi della natura data per scontata, del
naturalismo (dominio dell'uomo sulla natura). Queste due componenti hanno fallito prese
singolarmente, e da quella data simbolica possiamo ravvisare il disincanto della
modernità. Per quanto non ci sarebbe stato altro modo (la Costituzione) di raggiungere un
tale sviluppo scientifico, di benessere e di non belligeranza, la caduta del muro di Berlino
e le conferenze sullo stato del pianeta hanno permesso di comprendere che bisogna
modificare la rotta [p.19-21].
Il testo ovviamente esamina la questione molto più approfonditamente. Dopo aver
introdotto la sua tesi (cap.1) ed aver esplicato quali sono le caratteristiche della
4 Nella nostra lingua i due termini sembrano rimandare a due significati diversi, mentre il francese «représentation» e l'inglese «representation» sono utilizzabili per entrambi i contesti.
5 Vedi anche la prefazione di G. Gorello [p.7-10], anche in www.eleuthera.it/files/materiali/prefazionegiorellolatour.pdf .
5

Costituzione moderna (cap.2), nei successivi capitoli si occupa più in specifico dell'errore
perpetuato dalle filosofie «moderne» (cap.3), della debolezza del relativismo che in
determinate forme si rivela ingenuamente complice della Costituzione (cap.4), ed infine
propone la soluzione operabile in luce a quanto diagnosticato (cap.5), proposta che sarà
più compiutamente sviluppata nei lavori più recenti [Latour, 1999]. Per quanto mi sia
soffermato in particolare sui primi due capitoli, il nocciolo della questione dovrebbe
essere già emerso. Ritorna più chiaro che mai nell'ultima parte del testo, dove questa
affascinante catena argomentativa ci conduce a considerare come una diversa forma di
democrazia, un «Parlamento delle cose», ci possa consentire di risolvere le
problematiche così evidenti negli ultimi anni, senza però perdere i vantaggi che la
Costituzione ha portato. Dando piena rappresentanza alle reti quindi, non negandola a chi
spetta in quanto ha contribuito a costruire ciò su cui decide, si evita di gestire le «cose»
nei laboratori, e gli uomini nelle aule dei Parlamenti [Bucchi, 2006: 149-151], dato che “la
metà della nostra politica si da nelle scienze e nelle tecniche. L'altra metà della natura si
verifica nelle società. Riattacchiamole insieme: ecco che ricomincia la politica” [p.176].
Possiamo anche essere stati moderni, ma di certo ora non possiamo più esserlo nello
stesso modo [p.174].
Una lettura di forte impatto, per questo non esente da critiche6, che ben si presta ad
essere inserita ad introduzione del nostro corso, a patto che non si sia digiuni riguardo al
rapporto tra scienza e società, visti i riferimenti presenti nel testo. Uno stile che ho già
definito provocatorio, e che solitamente non considererei in grado di arricchire il dibattito,
ma che se letto con attenzione e fino alla fine consente di apprezzare gli sforzi stilistici di
Latour, e di notare la presenza di maggiori sfumature nell'argomentazione. Temo di non
aver colto interamente la tesi di Latour, in queste pagine per altro ridotta quasi oltre
misura. L'importante era almeno far emergere la rilevanza, l'originalità e i corollari di
quest'opera, in grado di offrire strumenti non banali per la spiegazione dei problemi della
tecnoscienza, la democrazia e la partecipazione pubblica.
6 Vedi [Bloor, 1999] e il confronto tra i due studiosi presente nello stesso numero di “Studies in History and Philosophy of Science”.
6

Riferimenti bibliografici
[Bloor, 1999] – Bloor D., Anti-Latour, in “Studies in the History and Philosophy of Science”, 30, 1, pp. 81-112.
[Bucchi, 2002] – Bucchi M., Scienza e società. Introduzione alla sociologia della scienza, Bologna, il Mulino.
[Bucchi, 2006] – Bucchi M., Scegliere il mondo che vogliamo. Cittadini, politica, tecnoscienza, Bologna, il Mulino.
[Latour, 1987] – Latour B., Science in Action, Cambridge, Mass., Harvard University Press; trad. it. La scienza in azione, Torino, Comunità, 1988.
[Latour, 1991] – Latour B., Nous n'avons jamais été modernes, Paris, La Découverte; trad. it. Non siamo mai stati moderni. Saggio di antropologia simmetrica, Milano, Elèuthera, 1995.
[Latour, 1999] – Latour B., Politiques de la nature, Paris, La Découverte; trad. it. Politiche della natura, Milano, Cortina, 2000.
[Latour & Woolgar, 1979] – Latour B. e Woolgar S., Laboratory Life. The Social Construction of Scientific Facts, Princeton, Princeton University Press.
[Shapin & Schaffer, 1985] – Shapin S. e Schaffer S., Leviathan and the Air Pump: Hobbes, Boyle and the Experimental Life, Princeton, N.J., Princeton University Press; trad. it. Il Leviatano e la pompa ad aria: Hobbes, Boyle e la cultura dell'esperimento, Firenze, La Nuova Italia, 1994.
7