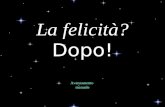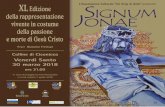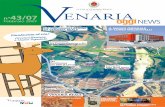info · brate e sostenibili. Anche su questo fronte si è convinti di aver intrapreso la strada...
Transcript of info · brate e sostenibili. Anche su questo fronte si è convinti di aver intrapreso la strada...

www.asiticino.ch
Cronaca regionale:Infermiere scolastico, quando finalmente anche in Ticino?
Approfondimenti:Comunicazione strutturata con le 7 P,meno fattori di disturbo, più sicurezza
Visibilità:Terapie non farmacologiche con i pazienti anziani
Calendario attività ASI-SBK Febbraio - Aprile 2018
La figura del custode
sociale di paese
Sezione TicinoDicembre 2017 - n. 4
Periodico d’informazione sulle attività dell’associazione svizzera infermiere/iAllegato alla rivista “Cure infermieristiche” N. 12/17
info

SOMMARIOinfoDicembre 2017 - n. 4
Periodico d’informazione sulle attività dell’associazione svizzera infermiere/iAllegato alla rivista “Cure infermieristiche” 12/17
Segretariato ASIVia Simen 8CH-6830 ChiassoTel. 091 682.29.31Fax 091 682.29.32E-mail:[email protected] internet:www.asiticino.ch
RedazioneMariano CavoloRoberto GuggiariPia BagnaschiVeronique Dayan
SupervisionePia Bagnaschi
Grafica e stampaArti grafiche Veladini, Luganowww.veladini.ch
Accogliamo con piacere, articoli,progetti da pubblicare, non esitate acontattarci all’indirizzo: [email protected]. Le indicazioni in merito alla formadel testo sono pubblicate sul sitodella sezione e possono essere sca-ricate direttamente:www.asiticino.ch/index.php?id=96
Qui accanto un gruppo di ospiti della casa anzianiPedemonte di Bellinzona,intenti a lavorare sulla copertina natalizia del presente numero di info-asi.
3 EditorialeCronaca regionale
4 La figura del custode sociale di paese (Roberto Mora) 6 Infermiere scolastico, quando finalmente anche in Ticino? (Mariano Cavolo)Approfondimenti 8 Comunicazione strutturata con le 7 P Meno fattori di disturbo, più sicurezza (Christina Gregor)Visibilità12 Terapie non farmacologiche con i pazienti anziani Due esempi proposti dalla Fondazione TusculumInvito alla lettura15 Milioni di farfalle (Véronique Dayan)Informazioni15 Vacanze di Natale ASI Agenda16 Calendario corsi

3allegato alla rivista “Cure infermieristiche” n.12/17
“Complementarietà”Ipnosi al posto dell’anestesia e altre terapie non farmacologicheLa comunicazione ipnotica è una tecnica che induce nella persona uno statomentale naturale e diverso dagli stati di veglia e di sonno, offrendogli l'oppor-tunità di sviluppare e incrementare le capacità di autoapprendimento e autode-terminazione. Lo stato mentale d’ipnosi è quindi uno stato fisiologico e dinami-co, che sviluppa una particolare partecipazione mente-corpo, utile a: rassicu-rare e tranquillizzare il paziente in difficoltà, facilitare la collaborazione e lacura, ridurre l’ansia e la percezione del dolore. Alcuni studi hanno permesso di osservare come l’effetto antidolorifico o antino-cicettivo dell’ipnosi è tale da ridurre il dolore almeno del 50%. Utilizzare lacomunicazione ipnotica nelle procedure invasive permette agli infermieri diportare l’individuo a vivere l’esperienza di cura in modo originale e appropria-to, alla ricerca di un maggior benessere psicofisico per il paziente.In alcuni ospedali l’ipnosi è utilizzata da tempo, con l'obiettivo di ridurre l'in-tensità dell'ansia e del dolore percepito durante le procedure invasive. Nel2007 è stato condotto uno studio pilota con l'obiettivo di valutare l’efficaciadell’ipnosi in questo contesto: 49 donne che avevano subito un intervento chi-rurgico al seno e che dovevano essere sottoposte a mammografia sono stateaddestrate da un'infermiera esperta all'uso dell’autoipnosi durante l’esame, altermine del quale c’è stata una valutazione dell'intensità del dolore e delle emo-zioni sperimentate durante la procedura, confrontata con la valutazione delleesperienze precedenti. Il dolore percepito utilizzando l’autoipnosi si è ridottopiù del 50% rispetto alle esperienze precedenti e l'ansia e le emozioni ad essacorrelate si sono ridotte mediamente del 70%, confermando quanto riportal’evidenza scientifica. Maryse Davadant, infermiera di cure intense, è pioniera dell’ipnosi all’ospedaleCHUV di Losanna e ha portato avanti la sperimentazione della “Ipno-analgesia”in pazienti ustionati, con notevoli risultati. L’ipnosi quindi, una parola che nonlascia indifferente nessuno, che suscita sempre reazioni contrastanti e controver-se, dalla curiosità, a volte al sorriso, specialmente quando si sente dire che è uti-lizzata nel servizio di rianimazione di un ospedale universitario. Di altre terapie non farmacologiche si sente sempre più spesso parlare, nontanto per demonizzare la farmacoterapia, bensì per perorarne gli effetti positivisui pazienti a cui vengono somministrate. In Ticino sono operativi alcuni esempimolto concreti alla Fondazione Tusculum di Arogno. La trenoterapia e la came-ra multisensoriale, a cui è dedicato un articolo in questo numero di dicembre.Le terapie non farmacologiche aiutano a migliorare la qualità della vita delpaziente. Specialmente nelle demenze dove, accanto ai sintomi cognitivi, si svi-luppano disturbi del comportamento di vario genere che contribuiscono inmodo significativo a rendere complessa la gestione della persona affetta dalmorbo di Alzheimer e la vita quotidiana del suo nucleo familiare. Queste tera-pie nello specifico consistono nell’impiego di tecniche utili a rallentare il declinocognitivo e funzionale, controllare i disturbi del comportamento e compensarele disabilità causate dalla malattia.Complementarietà quindi, non intesa in senso sostitutivo, bensì implementataallo scopo di completare un novero di offerte sanitarie sempre più vaste.
Insieme agli auguri di buona lettura, vi giungano anche gli auguri di serenefestività da tutto il gruppo redazionale di questo periodico.
Mariano CavoloDocente di cure infermieristiche al CPSI
editoriale

info4 periodico d'informazione sulle attività dell'associazione svizzera infermiere/i
Cronaca regionale
Quale é lo scopo del custode socialedi paese?
Con la figura del custode sociale di quartiereo di paese si desidera differenziare, rendereeffettive e accrescere le possibilità di presa acarico delle persone anziane o invalide, inse-rendosi nell’attuale polarizzazione delle solu-zioni: a casa senza aiuti adeguati e la neces-saria sicurezza oppure in casa per anziani,anche quando lo stato di dipendenza non èancora tale da giustificarne l’entrata.La differenziazione delle risposte ai bisogni inbase alla reale situazione, l’attivazione e lacombinazione delle risorse e dei servizi giàpresenti (per es. pasti a domicilio, mezzi ausi-liari, centri diurni, volontari, …), rappresenta-no l’impegno e la sfida quotidiani per gli ope-ratori del settore.Attraverso un approccio dal basso, il custodesociale funge da attivatore di risorse formali einformali, si caratterizza quale operatore di ri-ferimento per l'utente e la sua famiglia.La sua presenza quotidiana sul territorio ha loscopo di: • assicurare la presenza regolare di una per-
sona con qualifiche socio-sanitarie,che possa intervenire anche con un brevepreavviso;
• garantire un punto di riferimento costante,per accrescere il sentimento di sicurezza;
La figura del custode sociale di paese
• assicurare sostegno agli anziani o allepersone invalide e ai loro famigliari;
• prevenire e ridurre l’isolamento so-ciale: a casa sì, ma non soli e abbandonati;
• contribuire alla (ri)costituzione o almantenimento di relazioni sociali;
• promuovere e organizzare attività di so-cializzazione e animazione;
• sostenere e sgravare i famigliari curanti; • fornire informazioni e attivare le ri-
sorse della rete che facilitano e miglioranola permanenza a domicilio;
• sostenere, fino a quando è possibile e ra-gionevole, il comprensibile desiderio dellepersone anziane o invalide di rimanere acasa propria;
• ridurre o evitare ricoveri impropri,aumentando se del caso, in modo tempora-neo gli interventi del SACD;
• evitare che gli anziani perdano i propripunti di riferimento e le relazioni socialicostruiti negli anni nel proprio Comune;
È come se le mura di case per anziani o deinosocomi svanissero e le prestazioni, di cui èpossibile beneficiare in queste strutture, venis-sero garantite a domicilio.
In cosa rappresenta una novità Ci sono almeno quattro elementi, in parte giàevocati in precedenza, che si possono anno-
di Roberto Mora
Il custode socialefunge da attivatore
di risorse formali e informali,
partecipandoviattivamente
Arc
hivi
o in
fo-A
SI

5allegato alla rivista “Cure infermieristiche” n.12/17
Cronaca regionale
verare come novità, anche se ad essere since-ri, si possono considerare come l’uovo di Co-lombo: • la presenza regolare del custode sociale in
una determinata area (quartiere o paese) glipermette di intervenire anche in caso di bi-sogno non programmabile (possibilità dirispondere in tempi brevi a richiestenon pianificabili);
• sentimento di maggior sicurezza perutenti e famigliari (infonde maggiortranquillità attraverso la sua presenza);
• supporto e sostegno concreti alle per-sone bisognose di assistenza e ai famigliaricuranti (si è meno soli nella presa a carico adomicilio);
• la proposta e la promozione di atti-vità di animazione e socializzazioneper evitare gli effetti negativi dell’isolamentosociale e della solitudine.
Dove svolge la sua attività?La sua attività si svolge a casa degli utenti, inparticolare nel momento in cui si erogano leprestazioni di cura della persona o della casae nel locale per attività in comune ubicatopresso Residenza InContro a Cadenazzo, do-ve promuove o realizza attività di socializza-zione, proposte preferibilmente dagli utentistessi. Si vuole uscire infatti dal modello secon-do cui gli anziani o le persone invalide adultevengono considerate fruitori di attività pensateper e non con loro, favorendo e realizzandocosì le loro iniziative e valorizzando la loroesperienza di vita e le loro risorse.
A quali bisogni risponde?Siamo convinti che attraverso le attività del cu-stode sociale si possa rispondere a diversi bi-sogni:• maggior sicurezza a casa propria per
utenti e famigliari;• sostegno concreto ai famigliari curanti; • Sentimento di far ancora parte di unacomunità;
• possibilità di rimanere nel contesto so-ciale in cui si ha vissuto per anni;
• possibilità di applicare il diritto di autode-terminazione,
• solidarietà con utenti e famigliari e condi-visione della responsabilità della pre-sa a carico.
Quale profilo di competenze ènecessario per assolvere la funzio-ne di custode sociale?
Sono necessarie le competenze professionalidi base per l’erogazione di prestazioni di curee assistenza che sono da una parte utili permeglio conoscere la situazione bio-psico-socia-le dell’utente e nel contempo risultano esserefondamentali per conquistare la sua fiducia einvitarlo a partecipare alle altre attività di so-
cializzazione. Oltre a questi requisiti di base énecessaro e anzi indispensabile possedere leseguenti caratteristiche: grande motivazione eentusiasmo; buone conoscenze della rete, spic-cate capacità relazionali, flessibilità, creativi-tà, autonomia, spirito di iniziativa, positività,propositività, … in altre parole l’operatore de-ve sentire suo il progetto.
Che formazione è necessaria?È auspicabile una formazione come OSA, OSSo infermiere, preferibilmente con specializzazio-ne come infermiere di famiglia. È necessario in-fatti avere una visione olistica dei bisogni e unabuona conoscenza delle risorse presenti nel ter-ritorio. Sono richieste conoscenze e esperienzenella conduzione e animazione di gruppi.
Cosa fa l’ABAD in questo senso?Al momento si avanza passo dopo passo e sista accumulando esperienza in un progetto ri-tenuto prioritario ed estremamente avvincente.C’è una forte motivazione nel voler individua-re nuove soluzioni per rispondere ai bisognidegli utenti e per proporre nuove forme di pre-sa a carico che siano finanziariamente equili-brate e sostenibili. Anche su questo fronte si èconvinti di aver intrapreso la strada giusta.
Quali sviluppi futuri?Come detto, è un progetto in cui crediamomolto in quanto siamo persuasi che possacambiare, diversificare e migliorare le possi-bilità di presa a carico in base alle diverse si-tuazioni degli utenti. Se raggiungeremo i risul-tati sperati, faremo in modo di estendere ilprogetto ad altri Comuni e quartieri, adope-randoci affinché non rimanga il progetto diABAD, ma che le diverse figure professionalidella rete, le autorità politiche e la popolazio-ne di riferimento lo facciano proprio, così co-me sta avvenendo a Cadenazzo.
Chi fosse interessato a chi deverivolgersi?
Visto che seguo personalmente il progetto ci sipuò rivolgere direttamene a me oppure allacustode sociale, signora Marta Marchese,(076.615.48.49 –[email protected]) all’assistentesociale del Comune, signora Silvia Pestoni(091.850.29.10) o alla Capo dicastero Sani-tà e Socialità, signora Natascia Caccia. Ulte-riori informazioni sono pure ottenibili utiliz-zando il seguente link: (http://www.cadenaz-zo.ch/index.php?node=444&lng=1&vis=2&rif=1b7d9dd55d) �
* Roberto Mora, Direttore ABAD Bellinzona
È auspicabile unaformazione comeOSA, OSS oinfermiere,preferibilmente con specializzazionein infermiere di famiglia

info6 periodico d'informazione sulle attività dell'associazione svizzera infermiere/i
Cronaca regionale
Le richieste di intervento sono
più numerosequanto più è
giovane l’allievo,fatto facilmentespiegabile con
un suo generalemaggior bisogno
di accudimento daparte di un adulto
Infermiere scolastico, quando finalmente anche in Ticino?
Gli insegnanti sono costretti a trasfor-marsi in infermieri? La risposta è sì,almeno stando alle nuove misure va-
rate dall’amministrazione del Canton Ticinoche prevede per tutti i docenti una serie dinuove competenze mediche da mettere incampo in classe.In particolar modo, il DSS e il DECS, hanno in-trodotto una direttiva sull’adozione di provve-dimenti sanitari da parte dei collaboratori diogni ordine e grado scolastico. Le regole, giàsperimentate tra il 2013 ed il 2017, sono di-ventate effettive nel settembre scorso e si rivol-gono a tutti gli alunni con bisogni speciali.Ai docenti spetta dunque imparare a sommini-strare farmaci, a misurare i parametri vitali, maanche a saper intervenire in caso di crisi croni-che d’asma, epilessia o allergie, eccetera.Grazie al «Progetto di accoglienza individua-lizzato» (PAI), destinato agli allievi e alle fami-glie, i docenti potranno quindi essere messi incondizione di operare in classe nel rispettodelle norme sulla sicurezza e nell’ottica di fa-vorire benefici agli alunni.Un allievo con un’allergia accertata al velenodelle api? Un allievo che soffre di epilessia?
Un allievo con mal di testa in classe? Dei ge-nitori che vi chiedono di somministrare un far-maco per abbassare la febbre? Queste sonosolo alcune delle situazioni che capitano conuna certa regolarità nelle scuole e per le qualiviene sovente chiesto l’intervento del docente.Le richieste di intervento sono più numerosequanto più è giovane l’allievo, fatto facilmentespiegabile con un suo generale maggior biso-gno di accudimento da parte di un adulto.Con il passare degli anni l’allievo diverràvieppiù indipendente e in grado di farsi cari-co in autonomia di quasi tutti gli aspetti legatialla propria salute. Sarà un cammino che eglipotrà compiere potendo contare su adulti chelo sostengano con positività, che lo accompa-gnino dandogli fiducia, sostituendosi a lui so-lo quando davvero necessario.Nella scuola di ogni ordine e grado di normanon è prevista l’esecuzione di prestazioni di ti-po sanitario (es. somministrazione di farmaci,modifiche di dieta). Vi sono però alcune ecce-zioni in cui è assolutamente necessario adotta-re provvedimenti sanitari a scuola. Vi sono, in-fatti, allievi che a causa di una malattia croni-ca (es. allergia, asma, diabete, epilessia) han-
di Mariano Cavolo
Arc
hivi
o in
fo-A
SI

7allegato alla rivista “Cure infermieristiche” n.12/17
Cronaca regionale
no bisogno di ricevere cure anche durantel’orario scolastico. Un allievo con una malat-tia cronica deve essere accolto in modo che lasua situazione di salute non comprometta unascolarizzazione serena e con le stesse oppor-tunità di tutti.E fino a qui tutti d’accordo. Ma la domandaè: perché in Ticino deve occuparsene l’inse-gnante?Forse non tutti sanno che nel Canton Vaud la fi-gura dell’infermiera scolastica è già una realtàrodata da tempo e con buona pace di tutti.Queste figure professionali, chiamate per l’ap-punto “Infermières de santé communautaireen milieu scolaire”, hanno come campo di at-tività la salute globale dei bambini e degliadolescenti a scuola. Esercitano delle attivitàdi promozione della salute e di prevenzione,dispongono di locali appositamente predispo-sti e sono integrate negli Istituti scolastici. So-no a disposizione come detto dei bambini,degli adolescenti per un sostegno, un accom-pagnamento ed un orientamento verso conte-sti più specialistici, laddove fosse il caso1.Un altro esempio emblematico è quello spa-gnolo, in cui da quest’anno la Commissione
del Parlamento Spagnolo ha approvato laproposta di legge che istituisce la figura del-l’Infermiere scolastico. Una vera conquista separagonata a realtà molto vicine alle nostre. L’infermiere scolastico è quindi essenziale, sesi vuole affrontare il mondo giovanile in ma-niera globale. Con gli infermieri a suola sipossono portare avanti progetti globali di sa-lute, dal monitoraggio dei bambini, alle cam-pagne di prevenzione e sensibilizzazione al-le sane abitudini. Senza dimenticare la pre-venzione dei comportamenti a rischio negliadolescenti, che spesso attanagliano questaparticolare fascia di età (abuso di sostanze,cattive abitudini alimentari, social network,bullismo, etc.).Non sappiamo a tutt’oggi, come sia stato ac-colto questo ulteriore onere da parte degli in-segnanti ticinesi. Tuttavia possiamo immagina-re non benissimo, vista la già imponente moledi lavoro con la quale sono confrontati. Per-tanto perché non pensare anche per il Ticinoall’introduzione di questa figura professiona-le, visto che è già una realtà in diversi paesi,ma soprattutto è già operativa in altri cantonidella Confederazione? �
Perché nonpensare anche per il Ticinoall’introduzione di questa figuraprofessionale
1 https://www.vd.ch/themes/formation/sante-a-lecole/equipes-psps/infirmieres-scolaires/
Arc
hivi
o in
fo-A
SI

info8 periodico d'informazione sulle attività dell'associazione svizzera infermiere/i
Approfondimenti
Il signor H. ha subito l’asportazione dellaprostata a causa di un tumore. E`contentodi avere alle spalle la prima notte di ospe-
dale. Dopo l’anestesia ha dovuto lottare con-tro la nausea e ci è voluto un po’ prima chegli antidolorifici calmassero i dolori postope-ratori. Essendo abituato a dormire sul fianco,ha fatto fatica a dormire a causa dell’incon-sueta posizione supina. Per questo, la matti-na successiva, è contento quando l’infermie-ra entra in camera. Si presenta come suapersona di riferimento e gli chiede come hadormito. Il signor H. le spiega i vari problemidella notte appena trascorsa. L’infermieraascolta attentamente e intanto gli misura lapressione, fa un prelievo di sangue e glisomministra diversi farmaci. Lo informa chenel corso della mattina, sarà aiutato ad al-zarsi per la prima volta dal letto e nell’igienepersonale e che seguirà la visita medica. Lespiega che ora dovrà andare dagli altri pa-zienti per i quali è responsabile. Dopo il rap-porto tornerà. Nel frattempo può fare tran-quillamente colazione e se ha bisogno puòsuonare. Il signor H. è sollevato al pensieroche sarà aiutato e per essere stato informatosul programma del mattino e saluta fiduciosol’infermiera. Poi gli viene servita la colazio-ne, che farà eccezionalmente seduto a letto.Dopo la colazione, nonostante l’antidolorifi-co, ha ancora dolori alla schiena. Vorrebbealzarsi o almeno sedersi al bordo del letto.Prima della visita medica vorrebbe rinfre-scarsi un po’ e si chiede se deve suonare.Poi pensa che sarà aiutato e decide di aspet-tare ancora un po’. Dopo tutto non è l’unicodi cui l’infermiera si deve occupare e nonvuole disturbarla mentre sta facendo il cam-bio di turno. Gli ha assicurato che sarebbetornata. Verso le 9.00 non sa più che posi-zione assumere. Non può più resistere e suo-na comunque. Arriva subito una OSS e glichiede come lo può aiutare. “Vorrei alzarmi,stendere la schiena e rinfrescarmi”, dice il si-gnor H. La OSS gli assicura che lo riferirà al-l’infermiera responsabile poiché non può fa-re da sola la prima mobilizzazione. Però de-ve aspettare ancora un attimo perché l’infer-miera sta cambiando la medicazione a un
altro paziente. Dopo venti minuti, che al si-gnor H. sembrano un’eternità, l’infermiera el’OSS arrivano, si scusano e lo accompagna-no in bagno per l’igiene. Appena inizianobussano alla porta e arriva il medico per lavisita. Chiede al signor H. di sospenderel’igiene e di mettersi a letto per poter auscul-tare la sua pancia.
Organizzazione proattivaEcco come si svolge una normale mattina inospedale. Interruzioni, ritardi e tempi di at-tesa riguardano tutti: curanti, pazienti e me-dici. Questi fattori di disturbo sono logorantie si ripercuotono sulla concentrazione e pos-sono portare a commettere degli errori ecompromettono la qualità delle cure e la si-curezza dei pazienti (Baethge & Rigotti,2010). Ci si chiede quindi come si può mi-gliorare la pianificazione della giornata e ilcoordinamento dei processi. Un’organizza-zione focalizzata sul paziente dovrebbeconsiderarne la situazione e i bisogni.L’equipe curante deve valutare in modo pro-fessionale i rischi cui è esposto un paziente(decubitus, cadute, trombosi, polmonite,ecc.) e i dolori provocati dalla malattia e/odalla terapia. Inoltre si devono stabilire inmodo individuale con l’interessato quali so-no i suoi bisogni. Questi ultimi devono esse-re rilevati preferibilmente prima che il pa-ziente li esprima o chiami aiuto. Infatti, ap-pena il campanello suona, si deve interrom-pere ciò che si sta facendo. Si tratta quindidi “fornire” ai pazienti le cure di cui neces-sitano prima che siano richieste. Nell’esem-pio presentato sopra, l’infermiera si è occu-pata del signor H., lo ha informato e gli haofferto il sostegno necessario. Tuttavia nongli è stato spiegato come stabilire le prioritàe dare una struttura alla sua situazione.
Comunicare in modo strutturatoPer mettere in pratica il Lean Management nelnostro reparto utilizziamo lo standard delle“7P”. Questo strumento permette di strutturarela comunicazione con il paziente, serve a evi-tare eventi indesiderati e promuove la sicurez-za dei pazienti. Grazie alle 7P si trasmettono
Comunicazione strutturata con le 7 PMeno fattori di disturbo, più sicurezza
L’equipe curantedeve valutare in
modo professionalei rischi cui è esposto
un paziente(decubitus, cadute,
trombosi,polmonite, ecc.)
e i dolori provocatidalla malattia e/o
dalla terapia
di Christina Gregor *
La quotidianità ospedaliera è caratterizzata dalle interruzioni. La pianificazione e l’organizza-zione delle cure diventano così una sfida costante. Grazie alla comunicazione strutturata conlo standard delle “7P” i bisogni dei pazienti possono essere rilevati con maggiore precisionee le interruzioni notevolmente ridotte.

9allegato alla rivista “Cure infermieristiche” n.12/17
Approfondimenti
informazioni importanti e si rilevano i bisogniche portano con maggiore frequenza il de-gente a suonare il campanello o ad avere ri-percussioni negative. Lo standard è ripetutoogni ora permettendo così di ottenere i miglio-ri risultati per quanto riguarda la sicurezza, laqualità e la riduzione dello stress. SecondoMeade, Bursell & Ketelson (2006) controllan-do ogni ora si possono ridurre del 50% le ca-dute, del 14% i decubiti e del 38% le chiama-te dei pazienti.L’impiego dello standard inizia alla mattina,con il primo contatto con il paziente e com-prende tutte le 7P. Le prime tre p servono a ini-ziare la giornata, nei controlli successivi si ag-giungono le altre quattro P (vedi tabella).Secondo Walker1 lo scopo di una standardiz-zazione è ottenere un unico metodo di lavoro,che infonde sicurezza e fiducia al paziente eai curanti e garantisce la sicurezza delle cure:la giusta prestazione al momento giusto, svol-ta dalla persona giusta. Inoltre gli standardservono a orientare il personale curante, met-tendo in evidenza l’approccio corretto da as-sumere anche nell’affrontare imprevisti.
Esperienze con le 7PDurante l’implementazione dello strumento ab-biamo costatato che il personale infermieristi-co è piuttosto critico nei confronti delle stan-dardizzazioni nella comunicazione. Associa-
no questo tipo di comunicazione a un metododi lavoro tecnico e inumano, che contrastacon il rispetto dell’individualità del paziente.Queste perplessità devono essere prese in se-ria considerazione.In effetti è piuttosto inusuale presentarsi allamattina al paziente e spiegargli il piano dellagiornata. Tuttavia, l’esperienza dimostra chele informazioni fornite rispondono ad alcunedomande del paziente e lo aiutano a orien-tarsi. Nella terza fase si chiede al pazientequali sono le sue priorità per la giornata e glisi dà la possibilità di formulare le sue richie-ste. Ciò permette di stabilire la comunicazio-ne e di focalizzarla sulle richieste, i problemie le priorità del paziente e di porgli domandemirate. Ma se la giornata inizia con una do-manda aperta, il paziente descrive tutti i suoibisogni, richieste e insicurezze in una solavolta. Le priorità saranno strutturate e stabilitein un secondo tempo. In periodi di intenso la-voro e a seconda della situazione del pazien-te ciò può rivelarsi estremamente dispendiosoe complesso.Con le prime tre P l’infermiera può ovviare aquesto problema, intervenendo sin dal mattinonella pianificazione della giornata. Se riescea rilevare in modo professionale le richiestedel paziente, l’infermiera crea le basi per unacollaborazione basata sulla fiducia e infondesicurezza, rendendo più rilassata tutta la gior-
L’impiego dellostandard inizia alla mattina, con il primo contattocon il paziente e comprende tuttele 7P
1 Lean Hospital Management, 2015, p. 71-73/
Persona presentarsi come persona di riferimento e informare sul modellodi visite a scadenza oraria
Piano informare su appuntamenti per radiografie, visite ecc., chiarire gliatti infermieristici previsti durante la giornata e discuterli con il pa-ziente
Priorità chiedere e discutere con il paziente su ciò che per lui è importan-te e vorrebbe fosse fatto oggi
Igiene Personale il paziente ha bisogno di essere aiutato per l’igiene? Deve anda-re in bagno?
Pain valutazione del dolore con la scala da 1-10 e osservazione delpaziente per rilevare segnali che rivelano la presenza di dolori
Posizione posizione del paziente, accessibilità degli oggetti come bicchie-re, telefono, luce, ecc.
Presenza chiedere al paziente se ha ancora bisogno e informarlo che si tor-na al più tardi fra un’ora
Le 7 P

info10 periodico d'informazione sulle attività dell'associazione svizzera infermiere/i
Approfondimenti
Alcune infermieredubitano di riuscirea rispettare i loro
impegni vincolanti.Ma questo metodo
permette loro dipianificare e agirepreventivamente
nata. Le successive quattro P, che vengono uti-lizzate ogni ora, aiutano ad evitare diversi ri-schi potenziali. In tal senso domande su “igiene personale” e“posizione” servono a prevenire le cadute. Ipazienti cadono ad esempio perché vanno dasoli alla toilette oppure non hanno gli occhialia portata di mano e si alzano per andare aprenderli. Gli stessi pazienti affermano spessodi non suonare il campanello per non distur-bare i curanti. Per questo ogni ora chiediamose il paziente deve andare in bagno e se hatutto quello che gli occorre nelle vicinanze. Chiedere ogni ora al paziente se ha dolori(“pain”) migliora la qualità della relativa tera-pia. Grazie al riconoscimento precoce e allasomministrazione di farmaci di riserva si ridu-ce al minimo il ricorso a iniezioni antidolorifi-che. Siccome i curanti vedono il paziente ascadenza regolare, possono notare cambia-menti del suo stato e reagire prontamente. Intal modo si possono rilevare e prevenire situa-zioni problematiche più gravi.La “presenza” viene segnata ogni ora primadi uscire dalla camera chiedendo al pazientese gli serve altro e informandolo che l’infer-miera tornerà al più tardi entro un’ora. In que-sto modo il paziente suonerà il campanello so-lo se ha un’urgenza. Ciò permette di ridurre leinterruzioni e le situazioni in cui si deve inter-venire subito.Alcune infermiere dubitano di riuscire a rispet-tare i loro impegni vincolanti. Ma questo me-todo permette loro di pianificare e agire pre-ventivamente. Se invece uscendo dalla came-ra dicono: “Suoni se ha bisogno”, l’interruzio-ne è quasi programmata.
Le 7 P usate in un esempio concretoIeri il signor H. ha subito l’asportazione dellaprostata a causa di un tumore. E`contento diavere alle spalle la prima notte perché dopol’anestesia ha dovuto lottare contro la nauseae ci è voluto un po’ prima che gli antidolorificicalmassero i dolori postoperatori. Essendoabituato a dormire sul fianco, ha fatto fatica adormire a causa dell’inconsueta posizione su-pina. Per questo, si sente sollevato quando al-le 7.30 l’infermiera entra in camera presen-tandosi e dicendogli che sarà lei la curante diriferimento. Gli spiega che il suo turno dura fi-no alle 16 e che passerà ogni ora. Poi passaalla pianificazione della giornata. Il signor H.potrà aggiungere ciò che ritiene importante.Lo informa che prima della colazione verrà ef-fettuato un prelievo di sangue. Il medico pas-
serà alle 9. Per oggi non è previsto altro. As-sieme stabiliscono gli obiettivi terapeutici: al-zarsi due volte, lavarsi al lavandino con l’aiu-to di qualcuno e passeggiare in corridoio ac-compagnato. La colazione sarà servita fra 20minuti, il pranzo arriverà verso le 11.30. Perdomani può consultare il menu che gli porte-ranno nel pomeriggio. Poi l’infermiera chiedeal signor H. che cosa è importante per oggi. Ilpaziente le parla della lunga notte nella posi-zione supina. Per questo verso mezzogiornovorrebbe dormire ancora un po’. Al momentoha mal di schiena e vorrebbe potersi alzaresubito. Inoltre, prima che passi il medico, vor-rebbe rinfrescarsi. Queste sarebbero le cosepiù importanti. L’infermiera chiede ragguagli sull’intensità deidolori, che il paziente descrive con un 4 sullarelativa scala. Gli propone di aiutarlo a seder-si sul bordo del letto, ma dopo aver eseguitoil prelievo e controllato i segni vitali. Potrà co-sì fare colazione seduto e far riposare laschiena. Dopo la colazione, circa verso le8.20 passerà con una OSS e lo accompagne-ranno al lavandino. La OSS lo aiuterà a lavar-si. Poi lo riaccompagneranno a letto, dove po-trà riposarsi prima della visita medica. Dopola visita vorrebbe discutere con lui quando eper quanto tempo vuole riposare e quandoeventualmente avrebbe delle visite, per poterpianificare il resto della giornata.Dopo il prelievo e le varie misurazioni, lo fasedere sul bordo del letto, gli mette sul tavoloi medicamenti del mattino, compresi gli anti-dolorifici, e gli chiede se vuole avere altro aportata di mano, mentre controlla che abbiavicino a sé gli occhiali, il bicchiere con l’ac-qua e il telefono. Il signor H. vorrebbe avere
Arc
hivi
o in
fo-A
SI

11allegato alla rivista “Cure infermieristiche” n.12/17
Approfondimenti
A seconda del paziente e della situazionequesta procedurarichiede qualcheminuto in più
il suo libro sul comodino, per il resto ha tutto.Gli chiede se può fare altro per lui, ma diceche per il momento, così seduto, si sente mol-to meglio. L’infermiera ripone i suoi strumentie riassume brevemente che fra circa mez-z’ora tornerà con la OSS per vedere comevanno i dolori e per accompagnarlo in ba-gno. Mentre sta uscendo dalla camera, arri-va la colazione.
ConclusioneA seconda del paziente e della situazionequesta procedura richiede qualche minuto inpiù. L’insicurezza e l’acutizzarsi dei dolori delsignor H. non incidono. L’OSS non deve inter-rompere il suo lavoro, non deve cercare un’in-fermiera e farle a sua volta interrompere ciòche sta facendo. Il tempo è così facilmente re-cuperato. Per i curanti è difficile essere attendibili neiconfronti del paziente a causa degli innumere-voli imprevisti e della dipendenza con altrigruppi professionali. Questo ostacolo non può
essere completamente superato. Tuttavia, conuna pianificazione preventiva, che compren-de le attività previste e una certa flessibilitànell’agire, si può influenzare positivamente losvolgimento della giornata. L’attendibilità nonè solo una sfida, essa crea pure sicurezza,orientamento e struttura. Affinché la sicurezzadel paziente e la qualità delle cure siano inprimo piano, i processi devono orientarsi inbase ai bisogni dei pazienti. La disponibilitàdi mettere in discussione e far progredire séstessi e il proprio lavoro, standardizzandolo eorientandolo in modo coerente verso i bisognidel paziente è un viaggio interessante e stimo-lante. Ma vale la pena cambiare il propriomodo di pensare e adeguare il modo di lavo-rare, affinché si possa pianificare preventiva-mente e non si debba reagire in continuazio-ne. Nel nostro reparto abbiamo fatto buoneesperienze con le 7P e ogni volta che un pa-ziente suona il campanello ci chiediamo se sisarebbe potuto evitare. �
Letteratura:
Baethge A. & Rigotti T. Arbeitsunterbre-chungen und Multitasking Projekt F 2220,Bundes-anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin,Dortmund/Berlin/Dresden, 2010.
Walker D.(Hg.). Lean Hospital: DasKranken-haus der Zukunft. MWV, Berlin, 2015.
Meade C., Bursell A., Ketelsen L.Effects of nursing rounds: on patients’ call light use, satisfaction, and safety. American Journal ofNursing, 2006, 106. Jg., Nr. 9, S. 58–70.
* Christina Gregor è caporeparto di chirurgiapresso l’ospedale universitario di Basilea. Il re-parto lavora da 21/2 anni con il modello [email protected]
Arc
hivi
o in
fo-A
SI

info12 periodico d'informazione sulle attività dell'associazione svizzera infermiere/i
Visibilità
Terapie non farmacologiche con i pazienti anzianiDue esempi proposti dalla Fondazione Tusculum
Terapia del viaggio e/o trenoterapia
All'interno della Fondazione Tusculum diArogno la Specialista in attivazione Giu-seppina Iona in collaborazione con l’au-
tore della Terapia del viaggio, dottor Cilesi, nel2012, ha implementato questa terapia. La Te-rapia del Viaggio rientra negli interventi deno-minati Terapie non farmacologiche. Queste siprefiggono il benessere degli anziani stimolan-do ricordi, attenuando disturbi del comporta-mento, dando al contempo sensazioni piacevo-li e gratificanti. Il progetto nasce dalla riflessio-ne che per il malato d’Alzheimer l’ambientechiuso viene percepito come uno spazio conte-nitivo che potenzia il distacco dalla realtà, rin-forzando il desiderio di fuga. È importante, di-rei fondamentale, l’organizzazione dell’am-biente collegato ad una precisa metodologia.Ci sono disturbi comportamentali difficilmentegestibili all’interno di uno spazio. E spesso èproprio lo spazio chiuso e contenitivo che faci-lita il rinforzo dei BPSD (disturbi comportamen-tali). Questo accade quando si accentua il de-
cadimento delle funzioni cognitive, il tutto colle-gato a difficoltà di riconoscimento della realtàvissuta. Con questa premessa si può compren-dere quanto può essere importante creare unasituazione strutturata ma virtuale che vada arinforzare l’idea del viaggio. L’intervento tera-peutico non farmacologico interviene positiva-mente sul comportamento, favorendo il rilassa-mento ed il benessere a lungo termine dell’an-ziano. La persona affetta da demenza ha all’at-tivo i canali affettivi ed emozionali e con questipuò ovviare attraverso l’uso di questa terapiaalle problematiche legate ai disturbi dati dallamalattia. Risultati attesi ed ottenuti:attenuare/contenere disturbi del comportamen-to; creare un setting adeguato per favorire larelazione; offrire una terapia alternativa a quel-la farmacologica all'interno della CpA; stimola-re i soggetti con apatia; aiuto assistenziale peri caregiver diminuendo lo stress. In questo per-corso virtuale è fondamentale considerare e va-lidare la realtà che sta vivendo la persona, espesso la sua realtà non corrisponde alla no-stra. In questi percorsi di cura bisogna accom-pagnare la persona, e in questo caso accom-pagnare significa condividere, ascoltare, esser-
Spesso è proprio lo spazio chiuso e contenitivo chefacilita il rinforzodei BPSD (disturbicomportamentali)
Giuseppina Iona
Foto
Fon
dazi
one
Tusc
ulum

13allegato alla rivista “Cure infermieristiche” n.12/17
Visibilità
ci. In uno spazio dedicato all’interno degli spa-zi della quotidianità, si posiziona un finto scom-partimento con a lato un monitor che assume ilruolo di finestra virtuale. Dopo attenta valuta-zione in equipe delle problematiche comporta-mentali delle persone inseribili nel percorso vir-tuale; si effettua l’inserimento, ad orari stabilitiin relazione ai tempi di insorgenza dei disturbi.
Gli obiettivi prefissati sono la diminuzione deglistati di agitazione; diminuzione dei momenti diaggressività; diminuzione di disturbi comporta-mentali (es. wandering ); facilitare i processiemozionali; stimolare l'attenzione; stimolare ildialogo e la capacità relazionale; e non ultimofacilitare il rilassamento.
La camera multisensoriale
La Fondazione Tusculum di Arogno, nelcorso del 2018 amplia la struttura apren-do dei nuovi reparti specialistici: demenza
e psichiatria, chiudendo invece la gestionedella Luigi Rossi di Capolago.Oltre alle novità in termine di “struttura”, inquesti anni la Fondazione ha cambiato la vi-sione della presa a carico delle persone resi-denti nella casa, offrendo accompagnamentialle varie patologie con innovative cure nonfarmacologiche.Le demenze, ad esempio, nei nostri tempi so-no sempre più in aumento. La malattia dege-nerativa che distrugge lentamente e progressi-vamente le cellule del cervello è causa anchedi insorgenza di problematiche comportamen-
tali del deterioramento della personalità e del-la vita di relazione, che divengono causa distress per la famiglia ed il caregiver. Nella presa a carico di queste patologie, ac-canto alle terapie farmacologiche, si affianca-no le terapie non farmacologiche. 5 anni fa il Tusculum di Arogno implementa laterapia del viaggio (vedi p.12).Nel 2016, alla Luigi Rossi di Capolago, vieneimplementata, dalla specialista in attivazioneCaterina Mele, come suo lavoro di diploma,un’altra terapia non farmacologica: la came-ra sensoriale.La camera sensoriale è atta a stimolare isensi all’interno di un ambiente protetto, conl’utilizzo di suoni, profumi, immagini, cuori,oggetti, al fine di creare un contatto con ilmondo interno dell’individuo, favorendo il
Caterina Mele
La Fondazione hacambiato la visionedella presa a caricodelle personeresidenti nella casa,offrendoaccompagnamentialle varie patologiecon innovative curenon farmacologiche
Foto
Fon
dazi
one
Tusc
ulum

info14 periodico d'informazione sulle attività dell'associazione svizzera infermiere/i
Visibilità
rilassamento e quindi il benessere della per-sona.La camera sensoriale nasce in Olanda neglianni ’60 detta Snoezelen (“Snufelen” che si-gnifica esplorare e “doezelen” che significarilassarsi) come intervento per i disabili. Ne-gli anni ’70 viene utilizzata come interventomirato a diminuire gli effetti della deprivazio-ne sensoriale. Negli anni ’90 viene introdot-ta come intervento per le persone affette dademenza.La tecnica fu elaborata da due olandesi: JanHulsegge e Ad Verheul.È un’attività che stimola i sensi in manieradiretta, gli stimoli non sono obbligatoria-mente sequenziali, ma possono essere speri-mentati momento per momento, senza doverricorrere alla memoria a breve termine,quindi non richiede abilità cognitive e intel-lettuali nei pazienti.L’individuo all’interno della camera senso-riale non viene stressato, è libero di sceglie-re e le sue necessità sono messe in primopiano. L’accompagnamento dell’operatore èsicuramente ematico. La stimolazione multisensoriale induce unamigliore interazione tra residenti, famiglia ecaregiver.
All’interno della camera sensoriale l’indivi-duo si rilassa, esplora, grazie alla musica eagli oggetti che possono essere anche per-sonali, ricorda il proprio vissuto. In questostato di relax riduce e previene i comporta-menti oppositivi e aggressivi. A Capolago nella camera sensoriale sonostati inseriti un letto vibroacustico, tubo abolle, fibre ottiche e luci colorate; negli ulti-mi mesi la sperimentazione si è rivolta an-che a pazienti con patologie psichiatriche.Per oggetti e stimoli personalizzati sulla per-sona la specialista in attivazione struttura eprepara l’intervento attingendo alla storia divita del residente. �
Impegnarsi nell’Associazione permette di aggiornarsi e di contribuire attivamente all’evoluzione della pro-fessione, implicandosi nella politica socio – sanitaria a livello cantonale e nazionale.Quindi chi fosse interessato a seguire più da vicino l'attività dell'ASI-SBK Sezione Ticino, quale membro dicomitato, delegato, supplente delegato o membro di un gruppo di lavoro non esiti ad annunciarsi al segre-tariato. Le proposte di candidatura dei membri devono essere inoltrate al segretariato all'attenzione del comitatoalmeno 8 settimane prima dell'assemblea generale che avrà luogo il 22.03.2018
ASI-SBK Sezione TicinoPartecipate attivamente!
L’individuoall’interno della
camera sensorialenon viene stressato,è libero di scegliere
e le sue necessitàsono messe in
primo piano

15allegato alla rivista “Cure infermieristiche” n.12/17
Invito alla lettura
Informazioni
“Milioni di farfalle” è la storia vissuta e narra-ta dal Dottor Eben Alexander, medico diplo-mato ad Harvard e professore alla MedicalSchool della stessa università, uomo di scien-za, con una lunga esperienza come neurochi-rurgo e che ha vissuto in prima personaun’esperienza ai confini della vita. Prima diquesto avvenimento era in grado di spiegaretutti i meandri della funzionalità cerebralebasandosi sulla verità scientifica. Non ha maicreduto alla vita dopo la morte. Eppure è toc-cato proprio a lui esserne il testimone.Nel 2008, dopo aver contratto una raraforma di infezione causata dal batterioEscherichia Coli che gli provoca una graveforma di meningite batterica, nel giro dipoche ore entra in coma. La prognosi, cosìcome nella maggioranza di casi simili, è letalee anche in caso di un’ipotetica ripresa, vieneesclusa la possibilità di un pieno recuperodelle funzionalità neurologiche. Eben Alexander ha così trascorso 7 giorni incoma, monitorato continuamente con le tecno-logie più avanzate in campo neurochirurgico.Tuttavia, con l’avanzare dei giorni, non vieneregistrata più alcuna attività cerebrale. È durante questo periodo che il Dott.Alexander ha sperimentato un’esperienza aiconfini della morte, una “pre-morte” (NDE -Near-Death Experience). Oggi queste espe-
rienze, vissute da molte persone, vengonoampiamente studiate per poter dare prove espiegazioni scientifiche.“Mi trovavo in un mondo di nuvole. Grandinuvole gonfie, bianche e rosa, che si staglia-vano nette contro il cielo di un blu profondo”accompagnato da una fanciulla sulle ali diuna farfalla “in realtà, eravamo circondati damilioni di farfalle” “come un fiume di vita ecolori che si muoveva nell’aria”. Queste sonoalcune parole usate da Eben Alexander perdescrivere il suo viaggio nell’Infinito spiritualedell’Esistenza e che gli cambierà la vita.“L’amore incondizionato e lo spirito di accet-tazione che ho conosciuto durante il mio viag-gio sono la scoperta più straordinaria che ioabbia mai fatto”.Al suo risveglio il dottor Alexander è un uomodiverso, costretto a rivedere le sue posizioniprofondamente razionali sulla vita e sullamorte: esiste una vita oltre la vita, esiste ilParadiso ed è un luogo d’amore e meraviglia.“Milioni di farfalle” è la testimonianza di que-sta incredibile esperienza.È un libro che porta alla riflessione, in gradodi mettere in discussione anche il più scetticodei lettori. Caldamente consigliato a tutti icuranti che quotidianamente si confrontanocon avvenimenti che riguardano i confini dellavita terrena. �
Milioni di farfalledi Véronique Dayan
VACANZE DI NATALE
L’ufficio è chiuso dal 22.12.2017al 07.01.2018
Apertura 08.01.2018 © K
ati M
olin
- Fo
tolia

Calendario attività ASI_SBK sezione Ticino
DATA CORSO TERMINE ANIMATORE PARTECIPANTI LUOGO ISCRIZIONE
19 FEBBRAIO 2018 MANGIARE E BERE IN CURE PALLIATIVE 17.01.2018 VERONICA ALOISIO infermieri Manno CARLOTTA STANGLINI SILVIA WALTHER VERI
20 FEBBRAIO 2018 RIFLESSOLOGIA DEL PIEDE: RIPASSO 17.01.2018 ANTONIO MAGLIO operatori ramo sanitario con Bellinzona formazione base in riflessologia che hanno partecipato al corso “Riflessologia del piede”
22 – 23 FEBBRAIO 2018 DISAGIO E DEPRESSIONE DELL’ETÀ AVANZATA 22.01.2018 VINCENZO SANTORO operatori ramo socio-sanitario Novazzano
26 FEBBRAIO 2018 NUOVE CRONICITÀ 24.01.2018 MAURO REALINI infermieri Chiasso assistenti geriatrici operatori sociosanitari
27 – 28 FEBBRAIO 2018 RUOLO E IMPLICAZIONI DELLA DIMENSIONE INCONSCIA 24.01.2018 MARIANO CAVOLO aperto a tutti Lugano NELLE ORGANIZZAZIONI SOCIOSANITARIE
5 MARZO 2018 ESSERE VICINI ED ACCOMPAGNARE LA PERSONA DURANTE 05.02.2018 MICHELA TOMASONI ORTELLI personale ausiliario Bellinzona IL FINIRE DELLA VITA
7 MARZO 2018 PIEDE DIABETICO: COME E QUANDO TRATTARLO 05.02.2018 ELISABETTA MAGGINI infermieri Bellinzona
8 – 9 MARZO 2018 LA COMUNICAZIONE NELLE RELAZIONI DI CURA 05.02.2018 BARBARA SANGIOVANNI operatori ramo sanitario Chiasso
12 MARZO 2018 APPROCCIO AL PAZIENTE AFFETTO DA ALZHEIMER 12.02.2018 LAURA CANDUCI infermieri Manno
14 MARZO 2018 CORSO BASE DI ELETTROCARDIOGRAFIA 12.02.2018 SERGIO CALZARI infermieri Manno operatori sociosanitari
16 MARZO 2018 UNO SGUARDO SUL FENOMENO CHIAMATO RESILIENZA, 14.02.2018 ALFREDO BODEO operatori ramo socio-sanitario Savosa OVVERO LA FORZA D’ANIMO CHE CI PUÒ PERMETTERE DI AFFRONTARE LE AVVERSITÀ DELLA VITA
22 – 23 MARZO 2018 INTELLIGENZA EMOTIVA: LA RAZIONALITÀ AL COSPETTO 19.02.2018 VINCENZO SANTORO operatori ramo socio-sanitario Mendrisio DELL’EMOZIONE. SCONTRO O SFIDA FRA RAGIONAMENTO LOGICO E GESTIONE DELLE PULSIONI EMOTIVE
26 MARZO 2018 IGIENE ORALE NELLE CURE – SECONDO LIVELLO 26.02.2018 MILENA SCARONI operatori ramo sanitario che Chiasso hanno seguito il primo livello
27 MARZO 2018 COSA FA BENE ALLA SALUTE: ALIMENTAZIONE 26.02.2018 BARBARA RICHLI aperto a tutti Manno NELLA SECONDA METÀ DELLA VITA
9 – 10 APRILE 2018 SCENE DI LEADERSHIP – COME IL CINEMA AIUTA 07.03.2018 MARIANO CAVOLO aperto a tutti Savosa AD ESSERE LEADER
11 APRILE 2018 LA FARMACOTERAPIA NEL PAZIENTE ANZIANO 07.03.2018 MARCO BISSIG infermieri Manno
12 – 13 APRILE 2018 IL MASSAGGIO ZONALE RIFLESSO DEL PIEDE 12.03.2018 ANTONIO MAGLIO operatori ramo sanitario con Bellinzona E LA CIRCOLAZIONE LINFATICA formazione base in riflessologia
13 APRILE 2018 CURA ENTERO – UROSTOMIE 12.03.2018 GIOVANNA ELIA infermieri Lugano assistenti geriatrici
16 APRILE 2018 LA CURA DEI CURANTI 14.03.2018 ANDREA BORDONI operatori ramo socio-sanitario Manno LORENZO DORICI
18 APRILE 2018 QUANDO L’ALIMENTAZIONE DIVENTA DECISIVA 14.03.2018 BARBARA RICHLI operatori ramo sanitario Bellinzona
19 – 26 APRILE 2018 FITOTERAPIA E ALTRE TECNICHE COMPLEMENTARI ALLE CURE 15.03.2018 LILIA NODARI CEREDA operatori ramo sanitario Nerocco3 MAGGIO 2018
20 APRILE 2018 COME GESTIRE ED ELABORARE LE PERDITE CHE LA VITA 20.03.2018 ALFREDO BODEO operatori ramo socio-sanitario Lugano SPESSO CI IMPONE: SEPARAZIONI, INCIDENTI, MALATTIE...
24 APRILE 2018 BLS-DAE® SRC DEFIBRILLAZIONE AUTOMATICA ESTERNA 21.03.2018 formatori BLS DAE infermieri Lugano
APRILE 2018 GESTIRE LA RABBIA: CAPIRE E TRATTARE UN’EMOZIONE 26.03.2018 VINCENZO SANTORO operatori ramo socio-sanitario Novazzano VIOLENTA E TRAVOLGENTE
30 APRILE 2018 MALTRATTAMENTO, COERCIZIONE E BIENTRAITANCE 28.03.2018 MAURO REALINI infermiere/i Chiasso operatori sociosanitari aiuto infermieri operanti in case anziani, istituzioni sociosanitarie, servizi aiuto domiciliare
CORSI – CONFERENZE – ATELIER – ASSEMBLEE FEBBRAIO - APRILE 2018
SCEF 034
ISCRIZIONI www.asiticino.ch/formazione/iscrizione-ai-corsi-asi/INFORMAZIONI Segretariato ASI-SBK Sezione Ticino via Simen 8 – 6830 Chiasso
TEL. 091/682 29 31 Fax 091/682 29 32 [email protected]
DETTAGLIO DEI CORSI www.asiticino.ch/formazione/programma-corsi/