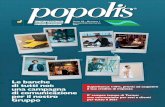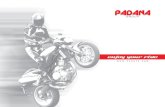GIUSEPPE DE MITA INCONTRA AD ISCHIA AZIENDE E OPERATORI DEL TURISMO
Bimestrale edito dalla Libera Compagnia Padana Anno VI - N. 27 - … · 2017-11-10 · pitare al...
Transcript of Bimestrale edito dalla Libera Compagnia Padana Anno VI - N. 27 - … · 2017-11-10 · pitare al...

27Pensioni in Padania
I confini meridionali della Padania
L’essenza del meridionalismo
Il vero significatodi “fascismo”
Carlo Porta poeta antirisorgimentale
L’inferno popolare di Bastia
27Bimestrale edito dalla Libera Compagnia Padana
Anno VI - N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000

La Libera
Compagnia
Padana
I «Quaderni Padani» raccolgono interventi di aderenti alla “Li-bera Compagnia Padana” ma sono aperti anche a contributidi studiosi ed appassionati di cultura padanista. Le proposte vanno indirizzate a: La Libera Compagnia Padana.
L’italianizzazione dell’Italia - Brenno 1Pensioni in Padania - Fiorangela Bianchini Dossena 3I confini meridionali della Padania- Gilberto Oneto 8La confederazione dei Liguri Friniati - Alina Mestriner Benassi 15L’essenza del meridionalismo - Cristian Merlo 191799-1999: A Alessandro Volta, comasco, in occasione del bicentenario dell’invenzione della pila - Giulia Caminada Lattuada 26Appunti e considerazioni a proposito del Palazzo Reale di Pavia - Mario Gatto 29L’inferno popolare di Bastia - Massimo Centini 32La pietra di Barnaba - Giorgio Fumagalli 42Carlo Porta poeta antirisorgimentale - Andrea Rognoni 44Il vero significato di “fascismo” - Eugenio Fracassetti 46Biblioteca Padana 50
Periodico Bimestrale Anno VI - N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000
Quaderni PadaniCasella Postale 55 - Largo Costituen-te, 4 - 28100 NovaraDirettore Responsabile:Alberto E. CantùDirettore Editoriale:Gilberto OnetoRedazione:Alfredo CrociCorrado GalimbertiFlavio GrisoliaElena PercivaldiAndrea RognoniGianni SartoriCarlo StagnaroAlessandro StortiGrafica:Laura GuardinceriCollaboratoriGiuseppe Aloè, Camillo Arquati, Fabri-zio Bartaletti, Alina Benassi Mestriner,Claudio Beretta, Daniele Bertaggia, Dio-nisio Diego Bertilorenzi, Diego Binelli,Roberto Biza, Giorgio Bogoni, GiovanniBonometti, Romano Bracalini, NandoBranca, Ugo Busso, Giulia CaminadaLattuada, Claudio Caroli, Marcello Ca-roti, Giorgio Cavitelli, Sergio Cecotti,Massimo Centini, Enrico Cernuschi,Gualtiero Ciola, Carlo Corti, MicheleCorti, Mario Costa Cardol, Giulio Cre-spi, PierLuigi Crola, Mauro Dall’AmicoPanozzo, Roberto De Anna, AlexandreDel Valle, Corrado Della Torre, Alessan-dro D’Osualdo, Marco Dotti, LeonardoFacco, Rosanna Ferrazza Marini, DavideFiorini, Alberto Fossati, Sergio France-schi, Carlo Frison, Giorgio Fumagalli,Pascal Garnier, Mario Gatto, OttoneGerboli, Michele Ghislieri, GiacomoGiovannini, Michela Grosso, JosephHenriet, Thierry Jigourel, Matteo Incer-ti, Eva Klotz, Alberto Lembo, Pierre Lie-ta, Gian Luigi Lombardi Cerri, CarloLottieri, Pierluigi Lovo, Silvio Lupo, Be-rardo Maggi, Andrea Mascetti, Pierleo-ne Massaioli, Ambrogio Meini, EttoreMicol, Alberto Mingardi, Renzo Miotti,Aldo Moltifiori, Maurizio Montagna,Giorgio Mussa, Andrea Olivelli, Gian-carlo Pagliarini, Alessia Parma, Giò Bat-ta Perasso, Mariella Pintus, Daniela Pio-lini, Francesco Predieri, Ausilio Priuli,Leonardo Puelli, Laura Rangoni, IginoRebeschini-Fikinnar, Giuliano Ros, Ser-gio Salvi, Lamberto Sarto, Gianluca Sa-voini, Massimo Scaglione, Laura Scotti,Marco Signori, Silvano Straneo, Giaco-mo Stucchi, Candida Terracciano, Mau-ro Tosco, Nando Uggeri, Fredo Valla,Giorgio Veronesi, Antonio Verna, Ales-sio Vezzani, Eduardo Zarelli, AntonioZòffili.Spedizione in abbonamento postale:Art. 2, comma 34, legge 549/95Stampa: Ala, via V. Veneto 21, 28041Arona NORegistrazione: Tribunale di Verbania:n. 277

Che lo stato italiano sia diventato sempre piùmediterraneo e levantino è una evidente ov-vietà. Può essere interessante andare a vede-
re come questo processo di italionizzazione siaavvenuto e con quali tempi. Non disponiamo del-le statistiche storiche sulla provenienza etnica deiburocrati e dei funzionari che forse sarebbero ildato più significativo. Disponiamo però (non èancora stato oscurato dalla censura che si na-sconde dietro alla cosiddetta“legge sulla privacy”) dei datirelativi a tutti i ministri chehanno fatto parte dei governipostunitari e già dal loro esa-me saltano fuori delle inte-ressanti informazioni.
Fino al 1943, alla cadutadel Fascismo, c’erano stati 57governi. Dopo di allora ce nesono stati 60, di cui 6 prima della proclamazionedella Repubblica. Ci sono stati nella prima parte27 Presidenti del Consiglio dei Ministri e 27 nellaseconda. Questo equilibrio numerico consente unparagone molto efficace: fra i primi, 17 erano natiin Padania, e cioè il 63% del totale (che sale al70% se si considerano i due Savoiani, non certoitaliani), contro gli 8 italiani etnici. Dal 1943 ilrapporto si inverte: 12 (il 44%) sono nati in Pada-nia e 15 (il 56% in Italia). Lo squilibrio aumenta
se si considera che due dei nati in Padania sonofigli di immigrati italiani e si scende a un 37% dipadani. Ancora più interessante sarebbe il parago-ne fra i Premier del Regno e quelli della Repub-blica: padano era il 76% dei designati dai re e soloil 26% di quelli repubblicani. Una inversione sec-ca di influenza. Il Grafico n.1 schematizza la du-rata nel tempo di ministeri presieduti da Padani(in alto), da Italiani etnici (in basso) e da Italiani
nati in Padania (in mezzo). Risultano evidenti: a)la preponderanza di presidenze padane (e in par-ticolare, ma non poteva essere diversamente, pie-montesi, con 7 presidenti più due savoiani) finoall’ultimo decennio dell’Ottocento, b) il periodo“siciliano” fino alla fine del secolo, c) quello “gio-littiano” subito dopo, d) la grande macchia pada-na del fascismo, e infine, e) a partire dal 1955, ilcontrollo pressocchè ininterrotto del governo daparte di meridionali o di figli di meridionali.
Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000 Quaderni Padani - 1
L’italianizzazione dell’Italia
Grafico 1
Grafico 2

L’indagine presenta un interesse ancora mag-giore se si vanno a esaminare tutti i ministri chehanno fatto parte dei Governi dall’unità a oggi.
Il Grafico n.2 schematizza l’andamento dellepresenze complessive: sulle ascisse sono posti glianni e sulle ordinate il valore percentuale da 0 a100: in alto stanno gli Italiani e in basso i Padani.Il grafico risulta ancora più interessante se lo siconfronta con quello del rapporto della popola-zione complessiva (linea tratteggiata). Risulta aun primo esame che fino al 1943 i Padani sonostati percentualmente più presenti rispetto all’in-cidenza della loro gente sul totale della popola-zione, e che il rapporto si è ribaltato nel secondodopoguerra fino a sbilanciarsi del tutto negli ulti-mi 15 anni a favore degli Italiani etnici.
Possono essere fatte alcune considerazioni spe-cifiche.
Il primo brevissimo Governo Cavour era perfet-tamente bilanciato al 50% delle due etnie: si trat-tava probabilmente di una scelta deliberata.
Gli Italiani diventano stabile (e forte) maggio-ranza con i Governi Crispi e Rudinì (fino al 70%di ministri non padani).
Gli Italiani sono molto significativamente largamaggioranza negli anni che hanno preceduto ilprimo conflitto mondiale e al momento dell’en-trata in guerra (Governo Salandra II, con il 33%di Padani). Nel corso della guerra è stato ritenutopiù prudente coinvolgere un maggior numero diPadani. Gli Italiani tornano in massa nel disordi-ne del primo dopoguerra e al momento della pre-sa del potere da parte di Mussolini (Governo Fac-ta II, con solo il 31% di Padani). Dopo i primi
convulsi assestamenti, i go-verni fascisti hanno sempreavuto un altissimo numerodi Padani: il 78% fra il 35-36(periodo di massimo con-senso al regime), e il 73%fra il 1935 e il 1939. Nel go-verno che ha gestito l’entra-ta nella seconda guerra i Pa-dani erano crollati al 50%.Sarà un caso, ma entrambele guerre mondiali (e leguerre coloniali “crispine”)sono cominciate con gover-ni molto italiani.Il massimo livello di medi-terraneità si è avuto con igoverni di Bari (e non pote-va essere diversamente…): ilterzo Governo Badoglio
(1944) aveva solo il 24% di padani. Il successivoeffetto del Vento del Nord è durato pochissimo(nel breve Governo Parri, dal giugno al novembredel 1945, i Padani costituivano un 68% mai piùraggiunto). Da quel momento (salvo rare, limita-te e brevissime eccezioni) i Padani sono semprestati meno della metà dei ministri, con periodi diparticolare scarsità per quasi tutti gli anni ‘60(44-46%), nei primi anni ‘70 (32-36%), per preci-pitare al 27% del Governo De Mita (1988-89). Aquel punto compare la Lega la cui presenza (o lacui paura) ha l’effetto di fare aumentare i mini-stri padani fino al 42% del Governo Berlusconi (icui esponenti non leghisti erano per il 74% Ita-liani etnici), e al 48% dei successivi Governi Dinie Prodi, e per riprecipitare al 37% con il GovernoD’alema, e con l’apparente “scampato pericolo”leghista. Il dettaglio dell’andamento degli ultimi30 anni è evidenziato dal Grafico n.3 sul quale so-no anche riportate le percentuali dei ministri natiin Padania da genitori italiani (una occorrenzapraticamente sconosciuta fino agli anni ‘70), cosache rende ancora meglio l’idea del processo diitalianizzazione. A fronte di una popolazione pa-dana del 47% e di un Pil che viaggia attorno al75%, la Padania è molto evidentemente sottorap-presentata nella gestione politica dei vari Ministe-ri. Negli ultimi 10 anni la media dei Ministri ita-liani è stata di circa il 61%, quella degli “oriundi”di circa il 4% e dei Padani del restante misero35%. Sempre che personaggi come Berlusconi,Turco e Prodi possano essere chiamati padani.Una situazione colonialista.
Brenno
2 - Quaderni Padani Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000
Grafico 3

I lavoratori del Nord, dopo avere trascorso lapropria esistenza lavorando per creare benes-sere per le proprie famiglie e per la comunità,
si attendono il giusto riconoscimento di una se-rena vecchiaia, che per essere tale non può pre-scindere da un dignitoso vitalizio. Ma il delizio-so quadretto iconografico che raffigura una cop-pia di anziani sorridenti, attorniati da figli e ni-poti - che tutti abbiamo visto più d’una voltanelle pubblicazioni promozionali degli operatoriprevidenziali, dall’INPS alle assicurazioni priva-te - è ben lontano dalla norma. E giunti alla so-glia della vecchiaia molti lavoratori si vedonoelargire con sorpresa (perché fino all’ultimo nonè dato di sapere nulla) vitalizi assai inferiori aquelli sperati, talora addirittura irrisori. Il puntoè che nessun lavoratore può costituire “diretta-mente” il proprio pacchetto pensionistico, e nonè comunque in grado di conoscerne l’entitàesatta, a meno che non sia un esperto di leggi,leggine, paragrafi, circolari che regolano il siste-ma pensionistico italiano. Il lavoratore versa ilproprio contributo e spera. Ma oggi le pensionisono a rischio, a causa del grande passivo del-l’INPS. E allora diamo un’occhiata a questo pas-sivo pensionistico italiano. Poi formuleremouna nostra proposta che dovrebbe valere nelmomento in cui la Padania diviene una realtà.La proposta potrà sembrare magari provocatoriao inattuabile: è una falsa impressione. Perchénoi partiamo da un punto di vista privilegiato,ossia da una realtà, prossima e speriamo moltovicina, vergine per cui possiamo ribaltare tutto,pur adattando l’esistente se necessario.
Diamo un’occhiata alla situazione attualein Italia
Il sistema pensionistico italiano poggia su al-cuni gravi squilibri di fondo. Intanto l’Ente ero-gatore della previdenza è chiamato ad erogareanche l’assistenza (o meglio l’assistenzialismo),ma anche gli ammortizzatori sociali, la CIG sal-va aziende, le pensioni ai mafiosi (se ne ha unaconoscenza parziale, poiché gli elenchi dell’IN-PS richiesti dall’Antimafia sono stati rifiutatiper motivi di privacy). Un discorso a parte meri-
tano le false invalidità. In totale le invalidità,erogate per il 75% al Sud, ammontano a 7 mi-lioni, a fronte delle 700.000 della Germania, cheha un maggiore numero di abitanti. E’ interes-sante notare che il record percentuale delle in-validità appartiene ai dipendenti pubblici (nelsolo 1997, il 35% dei lavoratori pubblici chehanno cessato l’attività lo hanno fatto per “so-praggiunta invalidità”). Occorre anche ricorda-re che l’Ente erogatore sovvenziona i, talora fal-si, braccianti meridionali (che presentano docu-mentazioni, spesso fasulle, attestanti almeno 51giorni lavorati – e certo nessuno si preoccuperàmai di lavorarne anche uno solo in più - otte-nendo così sussidi per maternità, malattia, di-soccupazione per il resto dell’anno, periodo nelquale costoro lavorano in nero, non versandoquindi contributi, ma incassando due volte).L’INPS, poi, passa 250 miliardi ogni anno a slo-veni e croati, persone che all’inizio della secon-da guerra mondiale erano residenti nei territoriceduti dall’Italia alla ex-Jugoslavia dopo il trat-tato di pace, persone che con l’Italia non hannopiù nulla a che fare da allora. E da allora lasomma erogata è di 3.000 miliardi. Si tratta dierogazioni illecite e indebitamente percepite,grazie a una singolare interpretazione dellanormativa da parte dell’INPS.
Il reale esborso relativo alle sole pensioni cor-risponde al 48% della spesa previdenziale, il re-sto del totale è pura assistenza. Ricordiamo chela spesa previdenziale nella sua interezza (altroche le pensioni!) grava sul debito pubblico, e chequesto si incrementa anche per altre forme assi-stenziali: come i Rom, che ricevono 39.000 lirepro-capite al giorno; come chiunque richiedaasilo politico, che riceve subito, salvo controllosuccessivo, circa 1.200.000 al mese; e come tut-te le spese per documenti, asilo, mantenimento,rimpatrio dei numerosissimi profughi che rag-giungono il territorio italiano senza soluzione dicontinuità. Vogliamo aggiungere i lavori social-mente utili e le facilitazioni contributive elargi-te al Sud? Vogliamo ricordare i seimila forestalidella Sicilia e i quindicimila della Calabria (con-tro i settecento della Lombardia)?
Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000 Quaderni Padani - 3
Pensioni in Padaniadi Fiorangela Bianchini Dossena

Ma torniamo pure alle pensioni. Oltre all’INPSvi sono “fondi speciali” che gestiscono scandalo-si privilegi, spesso in perdita (ad esempio, l’INP-DAP è il fondo del pubblico impiego che, fino al1997, consentiva di percepire la pensione con 23anni di contributi, e ancora oggi l’anzianità nonè equiparata a quella del settore privato, e conuna rata mensile doppia rispetto alle pensioniprivate).
Ci sono poi i magistrati, i dipendenti dei setto-ri volo, telefonici, elettrici, esattoriali, ex-tra-sporti, gas, quelli di Bankitalia, e degli organi divigilanza: costoro possono lasciare l’attività la-
vorativa con molto me-no dei 35 anni di con-tribuzione e con retri-buzioni pensionistichemolto alte. Ma c’è di più: i lavora-tori privati (che risie-dono per l’80% alNord) vanno in pensio-ne con il 66% dell’ulti-ma retribuzione, quellipubblici con percen-tuali fino al 90%.Vo-gliamo ribadire conforza che, a fronte dimolte pensioni da fame(anche di gente che halavorato per molti an-ni), esistono le pensio-ni d’oro dei cosiddettifunzionari di Stato(due o più pensioni cu-mulabili, com’è cumu-labile il lavoro, a diffe-renza di quanto avvie-ne per i comuni citta-dini). E ricordiamo an-che i parlamentari e gliextracomunitari chedopo cinque anni dicontribuzione possonorichiedere la restituzio-ne dei versamenti (gliextracomunitari anchedei contributi versatidal datore di lavoro,più gli interessi matu-rati nel frattempo).Il sistema pensionisticoitaliano è a ripartizio-ne, è un sistema che
poggia su un patto generazionale. Le pensionisono pagate con i contributi versati dai lavorato-ri attivi, non con quelli a suo tempo versati daipensionati di oggi. Occorre bloccare il sistemaperverso dell’unico calderone, dove solo alcuniversano ma: 1) a beneficio di tutto il territorio;2) finanziando non solo la previdenza (perfetta-mente controllabile, se si escludono certe pen-sioni di invalidità), ma anche un’assistenza vora-ce e – questa sì – incontrollabile; 3) con unesborso, da parte delle generazioni attive, “a fon-do perduto”, nella prospettiva (più che realisti-ca) di non potere contare sullo stesso “favore”.
4 - Quaderni Padani Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000
La previdenza per regione(Dati espressi in milioni di lire)
Fonte: La Padania, 20 Agosto 1999
Regione Entrate Uscite Tasso diContributive Prestazioni Copertura1997 (A) 1997 (B) (A/Bx100)
Piemonte 17.695.000 21.815.000 81,1
Valle d’Aosta 412.000 614.000 67,1
Lombardia 43.613.000 45.212.000 96,5
Trentino A.A. 3.665.000 3.698.000 99,1
Veneto 17.721.000 18.204.000 97,3
Friuli V.G. 4.267.000 6.044.000 70,6
Liguria 4.810.000 8.549.000 58,3
Emilia Romagna 16.645.000 19.581.000 85,0
Toscana 11.542.000 15.759.000 73,2
Umbria 2.093.000 3.616.000 57,9
Marche 4.394.000 5.872.000 74,8
Lazio 17.263.000 18.430.000 93,7
Abruzzo 2.433.000 4.376.000 55,6
Molise 448.000 1.095.000 40,9
Campania 7.024.000 15.167.000 46,3
Puglia 4.926.000 12.119.000 40,6
Basilicata 755.000 1.941.000 38,9
Calabria 1.788.000 6.134.000 29,1
Sicilia 5.399.000 14.484.000 37,3
Sardegna 2.493.000 4.851.000 51,4
ITALIA 169.386.000 227.561.000 74,4

Il bilancio pensionistico padano è attivo: una previdenza da regionalizzare
I motivi fin qui elencati spiegano benissimo ilperché dell’attuale disastrosa situazione dellaprevidenza italiana. E tuttavia le regioni padanepotrebbero ancora tranquillamente provvedere,malgrado il rapporto 1:1 (un lavoratore/un pen-sionato) si stia alterando, al pagamento dellepensioni, riuscendo anche a elevare le quote diquelle più basse. Facciamo alcune riflessioni. Sele pensioni di anzianità (quelle cioè con unamedia di 36,5 anni di lavoro e quindi di contri-buzione) sono pagateper il 75% al Nord(dove si inizia prestoa lavorare), quelle diinvalidità sono pagateper il 75% al Sud,con una percentualerispetto agli occupatifra 40 – 50%, che alNord diventa 5 – 7%.Inoltre al Sud è pe-sante il sommerso(2,5 milioni di lavora-tori evasori dei con-tributi INPS, pari a 1lavoratore su 3), congrave danno all’INPSper mancati contri-buti. Non solo, chi la-vora in nero e nonversa contributi è uf-ficialmente disoccu-pato, quindi percepi-sce anche il sussidio,con doppio danno perla comunità. A questoproposito, va ricorda-to che le irregolarità(ad esempio i falsibraccianti agricoli dicui sopra) e l’evasio-ne contributiva alSud erano nel 1998pari a 35,5 miliardi,con una percentualepari al 91,5. A frontedi ciò, nel 1996 Prodiprorogava al 1999 lafiscalizzazione deglioneri sociali agricolial Sud.
Più recentemente,
D’Alema, per non essere da meno, con l’ultimafinanziaria ha concesso un’ulteriore prorogasenza interessi per le contribuzioni evase inpassato. Noi sappiamo bene che questi sono re-gali alla malavita organizzata, che ne beneficiaattraverso dei prestanome, e se ne avvale percoltivare un consenso clientelare, ovviamenteanche a fini elettorali.
Per capirci meglio, diamo un’occhiata ai datidella Tabella 1., nella quale è indicato il bilan-cio previdenziale regione per regione. Ognunopotrà fare le proprie considerazioni, ma ciò che
La previdenza - Saldi regionaliValori espressi in milioni di lire (dati 1980-1997)
Fonte: La Padania, 12 Agosto 1999
Regione Saldo Saldo in moneta ‘97 Saldo con1980-1997 Rivalutato interessi
Con l’inflazione
Piemonte - 1.969.933 + 9.149.179 + 30.381.551
Valle d’Aosta - 1.130.531 - 1.475.255 - 2.151.651
Lombardia + 110.694.668 + 196.157.646 + 362.440.332
Trentino A.A. + 4.259.430 + 6.763.654 + 11.560.075
Veneto + 24.709.566 + 41.575.777 + 75.596.449
Friuli V.G. - 8.183.510 - 9.129.961 - 10.742.948
Liguria - 23.850.393 - 28.907.818 - 38.307.527
Emilia Romagna - 4.741.540 + 933.704 + 12.149.271
Toscana - 16.194.813 - 15.003.520 - 12.268.622
Umbria - 10.278.536 - 13.444.676 - 19.557.060
Marche - 8.678.045 - 10.430.639 - 13.738.144
Lazio + 40.036.620 + 65.979.485 + 115.346.696
Abruzzo - 13.652.195 - 17.945.522 - 26.164.254
Molise - 5.676.341 - 7.840.909 - 12.002.604
Campania - 54.858.444 - 68.550.151 - 94.420.305
Puglia - 59.190.619 - 77.872.000 - 113.638.230
Basilicata - 11.424.816 - 15.988.973 - 24.797.699
Calabria - 40.868.983 - 56.609.519 - 87.013.694
Sicilia - 74.974.462 - 101.227.170 - 151.770.913
Sardegna - 18.477.970 - 24.889.222 - 37.230.225
Non ripartite - 6.871.733 - 8.926.428 - 12.885.192
ITALIA - 181.322.580 - 137.237.317 - 48.614.693
Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000 Quaderni Padani - 5

subito salta all’occhio è - tanto per fare unesempio - il diverso tasso di copertura fra Lom-bardia (96,5%), Trentino Alto Adige (99,1%), Ve-neto (97,3%) da una parte e fra Basilicata(38,9%), Calabria (29,1%), Sicilia (37,3%) dal-l’altra.
Ma ancora più interessante è la Tabella 2. Quiviene riportato il saldo previdenziale effettivonel periodo 1980-1997 (prima colonna), la riva-lutazione di tale saldo in moneta 1997 (secondacolonna) e quindi il saldo con gli interessi qua-lora fosse stato investito dalle regioni in titoli distato (terza colonna). Il dato più eclatante ri-guarda la Lombardia che, se avesse potuto inve-stire il proprio saldo attivo, avrebbe oggi un atti-vo di più di 360mila miliardi.
Invece, a fronte di questi dati che, se la previ-denza fosse regionalizzata assicurerebbero unatranquilla vecchiaia a coloro che hanno lavoratonelle regioni del Nord, va evidenziato il ridottoadeguamento del reddito previdenziale all’infla-zione reale (e quindi il diminuito potere d’acqui-sto delle pensioni), a causa dei conti in rosso delsistema previdenziale italiano (Tabella 3).
Proposta per un “Sistema pensionisticopadano”
Nessuno di noi può prevedere il futuro: stor-ture come quelle denunciate sono sempre pos-sibili in presenza di un sistema come l’attuale.Occorre cambiare radicalmente. Diciamo subitoche noi vediamo due fasi: la prima transitoria(per la gestione del sistema ereditato) e la se-conda caratterizzata dal nuovo regime. Per lanostra trattazione, risulta più semplice parlareprima del nuovo regime pensionistico, così co-me noi lo vediamo, per passare poi alla fasetransitoria.
I punti essenziali della nostra proposta sono iseguenti, e partono dal presupposto di una inte-grazione fra pubblico e privato: 1. Obbligo di iscrizione a un Fondo finanziatocon un sistema di investimento in azioni e ob-bligazioni: sarà questo investimento in primoluogo ad assicurare la pensione.2. La pensione mensile sarà data dal Fondosuddetto, ovvero in parte dal Fondo e in partedal proseguimento della contribuzione (si vedail punto 7 del paragrafo successivo).3. Minimo della rata di pensione fissato perlegge (ad esempio: 2 milioni); massimo libero. 4. Scelta da parte dell’interessato dell’ente acui affidare il proprio Fondo pensionistico. Danotare che questi enti dovranno corrispondere
a precise direttive, volte ad assicurare la pienaefficace gestione dei fondi pensionistici. Le di-sposizioni in materia devono essere severissimee l’ente che non le soddisfa a pieno non potràessere accreditato.5. Età pensionabile: a discrezione del singolo,fermo restando il minimo di rata fissato per leg-ge. Più alta è l’entità delle somme investite, mi-nore sarà il numero degli anni necessari per as-sicurare una rata di pensione adeguata.6. Il giorno di decorrenza della pensione, ilpensionato riceverà un avviso a casa. Il versa-mento sarà diretto e immediato.7. Sarà previsto un Fondo statale per disabili ecasi particolari. 8. Nell’investimento è compreso il rischio (co-perto da assicurazione) di non potere più versa-re, ad un certo momento, la somma da investi-re. Questo per consentire comunque la riscos-sione di un vitalizio adeguato.9. Facoltà di cumulo fra pensione e lavoro,senza penalizzazioni.10.L’importo della pensione non dovrà esseretassato.
6 - Quaderni Padani Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000
Ridotto adeguamento del reddito previdenziale all’inflazione reale
Perdita del valore delle pensioni intermini reali (periodo 1992-1997)
Fonte: La Padania, 25 Agosto 1999
Importo mensile Perdita totale
948.000 7.164.314
1.256.000 10.195.000
1.874.000 15.826.000
Redditi più alti 22.300.000
Le perdite reali nel 1999
Importo mensile Perdita totale
948.000 1.086.000
1.256.000 1.563.000
1.874.000 2.470.000
2.478.200 3.572.000

Fase transitoriaLa fase di passaggio dall’attuale sistema a
quello che noi proponiamo, prevede una serie diadempimenti, che miglioreranno da subito la si-tuazione previdenziale per le regioni della Pada-nia:1. Previdenza Regionale, separata dall’assisten-za, che dovrà costituire un capitolo di spesa aparte, finanziato dallo Stato, quindi non a caricodall’Ente previdenziale.2. Un solo Ente pubblico dovrà amministrare iconti pensionistici. 3. Sprechi, squilibri, privilegi devono essere su-bito eliminati: le norme saranno uguali per tutti.4. Eliminazione del sistema a ripartizione e im-mediato passaggio al pro-rata, con investimentodei contributi (i contributi a carico del lavorato-re passano gradualmente dall’attuale 33% al20%). Tale regime di capitalizzazione resterà invigore per un periodo di cinque anni. Poi en-trerà in vigore l’obbligo di sottoscrivere il Fondopensionistico. Ma, per chi lo volesse, sarà possi-bile mantenere il pro-rata con investimento deicontributi versati dal lavoratore (la percentualedovrebbe ulteriormente abbassarsi fino al 15%).In questo modo, su richiesta del lavoratore,l’Ente integra la pensione già assicurata dalFondo.5. Pratica personale: la pratica segue la perso-na, anche da regione a regione.6. Per ogni lavoratore, calcolo della pensionematurata fino al momento dell’entrata in vigoredel nuovo regime pensionistico. La pensione giàmaturata verrà “accreditata” nella cartella per-sonale del lavoratore e congelata, a meno cheegli non decida di continuare a versare i contri-buti, nel qual caso la pensione contributiva con-tinua a maturare. Al momento di andare in pen-sione, la rata del credito “congelato” verrà riva-lutata in base al mutato potere d’acquisto, ri-spetto al momento della registrazione nella car-tella personale. La rivalutazione non si effettua
nel caso in cui il lavoratore scelga di mantenereil contributivo. Gli importi verranno corrispostidall’Ente alla decorrenza della pensione, con ra-ta mensile.7. L’importo minimo obbligatorio della pensio-ne (punto 3 del paragrafo precedente) sarà datodal Fondo azionario-obbligazionario, ovvero dalFondo più il credito congelato, ovvero dal Fondodella pensione.8. I contributi che l’azienda attualmente versaper i lavoratori, concorreranno in un primotempo, assieme alla tassazione comune, al paga-mento delle pensioni ancora in essere secondo ilvecchio regime a ripartizione. Anche qui, si do-vrà prevedere una riduzione graduale dell’ali-quota in relazione alla diminuzione delle pen-sioni “a ripartizione”. Con l’esaurirsi delle pen-sioni legate al vecchio regime, il corrispettivo ditale aliquota sarà versata dall’azienda ad integra-zione del salario del lavoratore..9. Facoltà di cumulo fra pensione e lavoro, sen-za alcuna penalizzazione10.Invalidità, CIG e ogni forma di ammortizza-tori sociali e di assistenza saranno erogati diret-tamente dallo Stato, attingendo dalla tassazione.
Questa è la nostra proposta, senz’altro imper-fetta e quindi suscettibile di integrazioni e modi-fiche, ma che ha comunque l’ambizione di assi-curare pensioni adeguate e sicure ai lavoratoripadani. Però dobbiamo fare presto! Le regionidella Padania possono ancora coprire l’esborsopensionistico con i contributi dei lavoratori attivie porsi quindi di fronte alla sfida di un nuovo re-gime pensionistico. E’ pur vero che alcune regio-ni del Nord hanno qualche problema a causa del-la presenza di grandi aggregazioni di vecchie in-dustrie statali e per l’effetto devastante delle cas-se integrazioni. Solo la responsabilizzazione a li-vello regionale potrà portare al risanamento delsettore previdenziale. Ma la strada è molto lungae la situazione si aggrava ad ogni momento chepassa. Ecco perché occorre iniziare subito.
Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000 Quaderni Padani - 7

I l movimento pada-nista è ancora oggiaccusato dai suoi
avversari di poca chia-rezza e di pressappo-chismo nella definizio-ne stessa della esten-sione della Padania.Questo nasce anche dauna serie di ambiguitàche non sono mai statechiarite all’interno delpiù importante movi-mento indipendentistapadano, soprattutto aproposito del Brenneroe dei confini meridio-nali. La Lega infatticontinua a elencare frale nazioni padane anche il Sud Tirolo (che trop-po spesso continua addirittura a chiamare AltoAdige), la Toscana, l’Umbria e le Marche e lo fasulla base di considerazioni che sono essenzial-mente di ordine socio-economico reclamandoper queste regioni (e non senza una fetta di ra-gionevolezza) una forte somiglianza con le re-gioni padane in termini di produttività, civismo,attaccamento storico all’autonomia, e resistenzaalle propensioni assistenzialiste e criminali dellostato centralista italiano. Qualche segno di mag-giore sensibilità padanista era apparso con l’ele-zione del Parlamento della Padania (nel quale letre regioni centrali erano presenti solo con “os-servatori”) e con la bozza di Costituzione “pro-vincialista” presentata a Chignolo (1), ma tutto èriprecipitato (in coerenza con l’abbandono delletematiche indipendentiste) nelle solite banaliz-zazioni con la Dieta di Acqui Terme del 3 e 4 set-tembre 1999, nonostante le speranze di chiarez-za adombrate da alcuni esponenti della Lega. (2)
A chi invece, come La Libera Compagnia, hasempre creduto che gli elementi di coesione e diesistenza della Padania debbano essere ricercati
principalmente in oggettività di tipo etno-lin-guistico, storico, culturale e identitario, questoeccessivo e nebuloso allargamento dei confinipadani sembra significare l’azzeramento deiprincipi stessi che sottendono al nostro progettopadanista. Noi abbiamo sempre affermato cheall’interno degli attuali confini della Repubblicaitaliana siano imprigionate cinque nazioni prin-cipali: il Sud Tirolo (quale parte del Tirolo), laPadania, la Toscana, la Sardegna e l’Italia pro-
8 - Quaderni Padani Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000
I confini meridionali della Padania
di Gilberto Oneto
Fig.1 - Aree padane al di fuori degli attuali limiti regionali di Liguria,Emilia e Romagna
(1) Il testo, che è stato pubblicato sui Quaderni Padani n.25-26, era stato ispirato anche nelle sue implicazioni territorialida Ettore Albertoni, che ha dimostrato una coerenza cultu-rale sconosciuta a gran parte della dirigenza leghista.(2) In una intervista al quotidiano La Padania (26 agosto1999), Roberto Maroni annunciava che “per la Padania esi-ste la necessità di definire quali regioni, quali aree ne fac-ciano parte. Sarà uno dei punti che la Lega affronterà nelladue giorni piemontese”. Nella Proposta di Legge Costituzio-nale elaborata ad Acqui si trova invece riaffermata l’ambi-guità delle “(..) regioni Piemonte, Valle D’Aosta, Lombardia,Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche, che costituiscono laPadania (..)”.

priamente detta (o etni-ca, come qualcuno pre-ferisce definirla). (3) Esi-stono poi altre porzioniminori di nazioni ester-ne (Occitani, Arpitani,Sloveni, Catalani, ecce-tera) la cui eventuale ri-definizione istituzionaleè però legata all’esisten-za di “madripatrie” indi-pendenti, oltre che, na-turalmente, al loro libe-ro esercizio di opzionein quel senso. Oggi inPadania, solo i Tirolesi egli Sloveni si trovanonella condizione di po-tersene liberamente an-dare con i loro fratelliche vivono in strutturestatuali libere e rispetto-se delle minoranze.
In particolare, il SudTirolo non è Padania e isudtirolesi dovrebberodecidere del tutto libera-mente il loro destino,compresa l’eventualitàdi restare uniti in qual-che forma confederalealla Padania. Uguale li-bertà devono poteresprimere Trentini e Ladini che sono storica-mente legati alla patria tirolese. In qualche mo-do anche la Toscana potrebbe trovare una formadi aggregazione esterna. Essa ha una sua fortespecificità etno-linguistica e storica, e una anti-chissima tradizione di autonomia. In comunecon la Padania ha lunghi periodi di lotte per lalibertà, di autonomia comunale, di creativitàculturale, di civiltà e di appartenenza all’Europavera, ma non è Padania. Non lo è per anticheorigini (che non possono essere sminuite nep-pure dalla comune fratellanza longobarda), nonlo è per lingua (romanza meridionale e non cel-to-romanza) ma non lo è soprattutto per unaforte propensione identitaria alla toscanità. Conla Padania c’è anche una antica tradizione di al-leanze contro nemici comuni (i Romani, i Sara-ceni, il Barbarossa, i Giacobini e ora il centrali-smo romano): ma non è Padania.
Chi proprio non c’entra ma che viene di conti-nuo “messo in mezzo” sono l’Umbria e le Mar-
che. Pensare a un abitante di Terni o di Ascoli Pi-ceno come a un padano è sinceramente ridicoloe non bastano certo comuni disgrazie o similitu-dini socio-economiche a farcelo diventare. Nonpuò avere grande significato neppure la lungasudditanza allo Stato della Chiesa che le acco-muna alle Romagne. Del resto la presenza inqueste zone di elettorato autonomista è pratica-mente nulla e questo costituisce un sintomaticosegnale del grado di propensione identitaria.
Anche per tutte queste ragioni, si pone conuna certa urgenza la necessità di definire congrande chiarezza quali siano i veri limiti meri-dionali della Padania. Mentre tutti gli altri suoiconfini coincidono con frontiere sancite da trat-tati internazionali, quelli meridionali sono sia il
Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000 Quaderni Padani - 9
Fig.2 - I confini nelle Province di Massa-Carrara e di Lucca
(3) In realtà anche la Sicilia dispone di tutti i presupposti percostituire una identità a sé stante: si tratta però di una sceltache solo i Siciliani possono effettuare

vero oggetto di contenzioso con l’Italia, che unforte elemento di caratterizzazione politica. Sta-bilire dove veramente cominci o finisca la Pada-nia significa infatti definire le basi ideologiche sucui si basano tutta la nostra lotta autonomista ela visione della Padania che vogliamo costruire.
La nostra battaglia si deve basare su due pila-stri: il riconoscimento delle specificità organi-che e la espressione della volontà popolare. Perspecificità organiche si intendono il rapportocon il territorio, le comunanze etno-linguisti-che, l’esperienza storica e l’identità culturale.Anche le comunanze socio-economiche sonoevidentemente importantissime perché sono ilprimo elemento scatenante della ricerca delleradici organiche e perché sono proprio la piùpuntuale verifica e dimostrazione delle stesse:salvo trascurabili eccezioni infatti, identici ca-ratteri socio-economici caratterizzano aree cul-turalmente omogenee.
La libera espressione di volontà è il necessariosuggello delle differenze: non basta essere diver-si ma occorre decidere di esserlo. Per la corret-tezza di questo processo è però fondamentale ri-conoscere scientificamente le specificità oggetti-ve, stimolarle economicamente e legittimarlecon l’espressione della volontà di singoli e di co-munità. Per queste ragioni potrà essere cittadi-no della libera Padania anche chi proviene da al-
tre realtà ma che – stando qui – ha liberamentedeciso di condividere la nostra lotta e di assume-re le nostre identità. La stessa cosa non è possi-bile per altre comunità geografiche (anche seconfinanti con la Padania, e anche se manifesta-no una scelta del genere) perché manca il pre-supposto identitario e soprattutto perché nonesiste l’imprescindibile legame con il territorio.Così si possono definire quali siano, in terminiscientificamente oggettivi, le aree e le comunitàche possono far parte della libera Padania: sitratta della descrizione dei “limiti massimi” al-l’interno dei quali si potrà liberamente manife-stare la volontà di fare parte della comunità pa-dana. In altre parole ci sono limiti geografici cheseparano chi, essendo organicamente padano,può scegliere di esserlo anche istituzionalmenteda chi, invece, non essendolo organicamentenon può neppure inventarsi di esserlo medianteuna libera scelta.
Vediamo quali sono i limiti meridionali del ter-ritorio della Comunità delle Comunità padane, diquesta somma di heimat che chiamiamo Pada-nia, patria (o meglio matria) di tutti i padani.
I criteri di definizione che vengono utilizzatisono ragruppabili in tre tipi basilari: geografico,etno-linguistico, e storico-amministrativo.
Il problema dei confini della Padania è statoaffrontato in termini generali sul numero 3 dei
10 - Quaderni Padani Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000
Fig.3 - I confini nelle Province di Pistoia, Prato e Firenze

Quaderni Padani. In quella occasione erano sta-te definite le parti di territorio esterne agli at-tuali confini delle regioni Liguria ed Emilia-Ro-magna che potrebbero farne parte e, quindi, es-sere parte della Comunità padana. (4) Sembrapiuttosto opportuno ritornare oggi, a tre anni daquella pubblicazione, sullo stesso tema perchénel frattempo non è diminuita la grande confu-sione sull’argomento. L’occasione risulta oppor-tuna anche per cercare maggiore definizione deidettagli. Nella descrizione si parte dagli attualiconfini delle cosiddette regioni settentrionaliche costituiscono essi stessi un riferimento sto-rico-amministrativo, anche se si sa piuttosto be-ne che si tratta di divisioni che spesso hannoscarso costrutto storico e che sono in moltipunti frutto di scelte amministrative recenti epiuttosto arbitrarie.
Il confine padano corre grosso modo sullospartiacque appenninico, sulla frontiera lingui-stica (la cosiddetta linea Massa-Senigallia) chedivide le lingue celtoromanze (o romanze occi-dentali) da quelle romanze meridionali (o ro-manze orientali): questa coincide con un anticoe consolidato limes storico, la cosiddetta LineaGotica che ha confermato la sua persistenza an-
che in tempi recenti. E’ l’antico limite meridio-nale dell’espansione delle popolazioni celtiche eliguri. (5)
In termini geografici vale la pena di ricordareche l’Appennino tosco-emiliano (che è localmen-te chiamato Alp) ha sempre costituito un ostaco-lo difficilmente valicabile e perciò un forte confi-ne fra climi, culture e paesaggi diversi, e – in de-finitiva – una potente barriera psicologica.
Nella Tabella A vengono elencate 18 porzionidi territorio esterne (o a cavallo) degli attuali
Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000 Quaderni Padani - 11
Fig.4 - I confini nelle Province di Pesaro-Urbino, Ancona, Arezzo e Perugia
(4) Erano state allora individuate 7 aree principali: 1 - la Lunigiana e Carrara per motivi linguistici, storici egeografici,2 - l’alta Garfagnana per motivi storici (e in parte linguistici),3 - la frazione di Gombitelli per ragioni linguistiche,4 - le porzioni della provincia di Pistoia a nord dello spar-tiacque appenninico,5 - i comuni della provincia di Firenze a nord dello spartiac-que, anche per ragioni linguistiche,6 - il Montefeltro per ragioni linguistiche e geografiche,7 - i comuni di Sestino e di Badia Tebalda (AR), per ragionilinguistiche.(5) Il confine è stato riconosciuto a lungo anche dagli stessiRomani: per molto tempo è stato il limite settentrionale d’I-talia, poi la separazione fra Italia Annonaria e Italia Suburbi-caria.

confini amministrativi delle regioni settentrio-nali che potrebbero fare organicamente partedella Padania. (6)
Ciascheduna necessita di una succinta descri-zione.1 - Lunigiana e Carrara. E’ il cuore della terradei gloriosi Liguri Apuani che tanto filo da tor-cere hanno dato ai Romani. Linguisticamenteappartiene all’area celto-romanza: vi si parla undialetto emiliano, detto “lunigiano”. Negli ulti-mi secoli l’area ha conosciuto un’alternanza diperiodi di indipendenza e di collegamento conl’Emilia (soprattutto con il Ducato di Modena, e
poi con la Repubblica Cisalpina) e con Lucca. Illimite meridionale dell’area è solitamente fattocoincidere con il fiume Frigido o con il torrenteBrugiano. Qualcuno indica anche come confine
12 - Quaderni Padani Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000
Tabella A
# Provincia Comuni e (porzioni di Comuni)
1 Massa-Carrara Aulla-Aùla, Bagnone-Bagnòn, Carrara-Caràra, Comano-Comàn, Filattiera-Faltéra, Fivizzano-Fivzàn, Fosdinovo, Licciana Nardi-Liciàna, Mulazzo-Mulàzz, Podenzana, Pontremoli-Puntrémal, Tresana, Villafranca in Lunigia-na-Vilafrànca, Zeri
2 Massa-Carrara Casola in Lunigiana-Càsula, (Massa)
3 Lucca (Camporgiano), (Villa Collemandina), Giuncugnano, Mi-nucciano, Piazza al Serchio, San Romano in Garfagnana,Sillano, Vagli Sotto
4 Lucca Frazione di Gombitelli (Comune di Camaiore)
5 Pistoia Abetone-Abetòn
6 Pistoia (Pistoia), Sambuca Pistoiese-La Sambùca, (San Marcello Pistoiese)
7 Prato (Cantagallo), (Vernio)
8 Firenze Firenzuola-Firenzòla, Marradi-Marä, Palazzuolo sul Se-nio-Palazò, (San Godenzo)
9 Firenze (Firenzuola-Firenzòla)
10 Forlì-Furlè (Verghereto)
11 Arezzo Badia Tebalda, Sestino
12 Pesaro-Urbino Tutti i Comuni tranne Cantiano, Frontone, Pergola e Pésre-Urbìn Serra Sant’Abbondio.
13 Pesaro-Urbino (Cagli-Cày), (Frontone), (Pergola)
14 Ancona (Castel Colonna), (Corinaldo), Monterado, (Senigallia)
15 Perugia (Città di Castello), (Pietralunga)
16 Livorno Capraia-Cavràya
17 Cagliari Carloforte-Carlofurte
18 Cagliari Calasetta-Cadäsedda
(6) Nella prima colonna è riportato il numero che fa riferi-mento alle cartine.Nella seconda la provincia interessata.Nella terza colonna sono elencati i Comuni i cui territori sonocompresi nell’area di interesse. Fra parentesi sono indicati inomi dei Comuni che rientrano solo parzialmente nelle aree,con frazioni ed abitati, o con porzioni di territorio anche scar-samente popolate ma di entità superficiale consistente.

il Cinquale (che è l’attualeconfine provinciale) maquesto significherebbe ri-comprendere anche i centridi Massa e di Montignosoche sono linguisticamentetoscani.2 - Storicamente del tuttosimile alla precedente macon caratteri linguistici me-no definiti.3 - Simile alla precedenteper caratteri storici e lingui-stici, ma appartenente allaProvincia di Lucca. Solo aSillano la parlata è decisa-mente emiliana.4 - La piccola frazione diGombitelli, in Comune diCamaiore, dove si parla un dialetto emiliano, co-stituisce una enclave padana in terra toscana.5 - Fine vallata geograficamente e linguistica-mente emiliana.6 - Area geograficamente padana. Il Comune diSambuca è anche linguisticamente emiliano.7 - Scampoli della Provincia di Prato che si tro-vano a settentrione dellospartiacque.8 - Area geograficamentepadana e linguisticamenteromagnola, per secoli ap-partenuta al Granducato diToscana.9 - Il centro abitato di Fi-renzuola è stato in passatopopolato con gente prove-niente dalla Toscana, che haconservato i propri caratterilinguistici, costituendo unavera e propria enclave to-scana a nord dello spartiac-que.10 - Porzione del comuneromagnolo di Verghereto si-tuata a sud dello spartiac-que.11 - Comuni storicamentetoscani ma geograficamentee linguisticamente monte-feltrini.12 - Il Montefeltro ha con-diviso con la Romagna econ le Marche la lunga ap-partenenza allo Stato della
Chiesa, pur conservando per lunghi periodi unapropria specificità come Ducato di Urbino. Essoè però molto decisamente padano per lingua: visi parla infatti una forma di romagnolo (dettaanche “marchigiano settentrionale”), un dialettocelto-romanzo che deriva dalla forza di resisten-za culturale dell’antichissimo insediamento di
Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000 Quaderni Padani - 13
Fig.5 - L’isola di Capraia
Fig.6 - Gli insediamenti tabarchini

Galli Senoni. Faceva infatti par-te dell’antico Ager Gallicus, dicui solo la parte meridionale(l’attuale Provincia di Ancona) èstata italianizzata. Il Montefel-tro coincide quasi del tutto conla provincia di Pesaro-Urbino,eccezion fatta per i Comuni (oparti dei Comuni) di Cantiano,Frontone, Pergola e SerraSant’Abbondio. 13 - Fascia di territorio dai ca-ratteri linguistici meno definiti.14 - Piccola lingua di territoriodella Provincia di Ancona lin-guisticamente romagnola. Ilvecchio confine linguistico del-l’Esino si è lentamente spostatofino quasi a ridosso del fiumeCesano.15 - Piccole porzioni di territo-rio umbro, prive di insediamen-ti di rilievo, geograficamentegravitanti sul Montefeltro.16 - L’isola di Capraia è apparte-nuta per molti secoli alla Re-pubblica di Genova, di cui ha as-similato i caratteri linguistici.17 - Nella seconda metà delXVIII secolo, le comunità liguriscacciate dall’isola tunisina diTabarca si sono insediate nell’isola di San Pietro,fondando il centro di Carloforte che ha conser-vato i caratteri linguistici gallo-italici.18 - Gli stessi Tabarchini hanno anche occupatola metà occidentale dell’isola di Sant’Antioco,che ha anch’essa conservato caratteri linguisticiliguri.
Altre isole linguistiche gallo-italiche (di origi-ne tardo-medievale) si trovano in Italia meridio-nale, completamente circondate (e, di fatto, assi-milate) dal mondo culturale e linguistico italia-no. Risulta oggi piuttosto difficile rivendicareuna loro sia pur lontana padanità. (7)
Tutte le zone descritte possono vantare uno opiù elementi di padanità organica e possono per-ciò fare parte della comunità padana, in terminiidentitari oggi, in termini politico-amministrati-vi quando esisterà una statualità padana. Comepiù volte affermato, questa situazione di pada-nità oggettiva costituisce solo la prima dellecondizioni indispensabili (ma da sole insuffi-cienti) a generare una compiuta appartenenzaalla Padania. La seconda condizione sarà verifi-
cata solo con la libera espressione di intenzioniespressa dagli abitanti di queste aree, la cui vo-lontà è il solo vero suggello della loro accetta-zione di trasformare una appartenenza identita-ria in un rapporto di comunità.
Sulla base dei principi più sopra descritti edelle considerazioni effettuate, è perciò possibiledare una definizione piuttosto precisa dei confi-ni meridionali della Padania, o – meglio – dellaestensione massima verso Sud dello spazio fisicoentro il quale può essere liberamente espressauna adesione di appartenenza alla Comunitàdelle Comunità padane.
14 - Quaderni Padani Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000
Fig.7 - Antichi insediamenti gallo-italici e franco-provenzaliin Italia
(7) - Di origine valdese (franco-provenzale) sono le isole lin-guistiche di Faeto (FG), Celle San Vito (FG) e Guardia Pie-montese (CS), risalenti al XIV e XV secolo. Le colonie gallo-italiche di Sicilia sono invece: Novara di Sicilia (ME), Fonda-chelli-Fantina (ME), Sanfratello (ME), Montalbano-Elicona(ME), San Pietro Patti (ME), Roccella Valdemone (ME), Ran-dazzo (CT), Maletto (CT), Bronte (CT), Mirabella Imbaccari(CT), San Michele in Ganzaria (CT), Caltagirone (CT), Val-guarnera (EN), Sperlinga (EN), Nicosia (EN), Aidone (EN),Piazza Armerina (EN), Ferla (SR).

Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000 Quaderni Padani - 15
Le vaste terre degli AmbroniAl loro apparire nella storia, Gli Ambroni
(´Αµβρωνες)(2), così i Liguri chiamavano sestessi nella propria lingua, almeno secondoquanto ci tramanda Erodoto, furono uno dei po-poli più importanti, non solo della Padania pri-mitiva, ma anche di una buona parte dell’Euro-pa occidentale, che controllavano fino alla Spa-gna settentrionale e forse meridionale: i toponi-mi possono essere determinanti per stabilirel’effettiva estensione degli stanziamenti di que-ste antiche genti(3), così nella penisola, come aldi là delle Alpi. Antichi dotti hanno assimilato ilnome della Loira, Liger(4) (Λιγυρος), o dei Llo-grys, Locyers, Locgwys, che abitavano la Britan-nia a nord del Tamigi, a quello dei Liguri, altrihanno notato come il nome Albion, dato antica-mente all’Inghilterra, potesse riferirsi alla stessaradice dei nomi Albium, Album, Alba, comuni adiverse città notoriamente fondate dai Liguri(5).
Vivevano lungo le coste del golfo di Genova gliIntimilii, gli Ingauni, i Genuates e gli Apuani;l’Appennino ligure e le Alpi occidentali, con lamaggior parte della regione alpina e piemontesefino al Ticino, erano occupati principalmentedagli Statielli, i Bagienni, i Taurini e i Salassi ela loro influenza toccava anche la Toscana e l’E-milia, fino al territorio dei Friniati, celebri perla fierissima resistenza alle legioni romane.
Con l’avvento, nella Cispadana, prima degliEtruschi e poi dei Celti, la nazione ligure si con-centrò soprattutto in Appennino, da Arezzo a Pi-sa sino a Piacenza e, a est, sulla catena dei mon-ti fra Genova e Tortona, fino a che, in epoca im-periale, si trovò a controllare soltanto il territo-rio compreso tra il Varo e le Alpi Marittime, laMagra a sud - est e il Po a nord.
La fama dei LiguriStrabone menziona i Liguri insieme agli Sciti
e agli Etiopi, descrivendoli come un popolo so-brio e fiero che si batteva in modo estremo perla propria libertà: “..le donne erano forti comegli uomini e gli uomini come le fiere..”; essinon avevano cavalleria, ma i loro opliti e la lorofanteria leggera, che faceva uso di un lungo scu-do del tipo celtico, si difendevano validamente.Tito Livio li chiama “antiqua gens” e anche Ca-tone attribuisce loro una lontanissima origine.Sempre Strabone(6) racconta, in particolare, levicende dei Liguri Friniati, stanziati presso ilfiume Scoltenna, che attraversa l’Alto Frignanoda Fiumalbo a Pievepelago, per poi congiungersicon il Leo e diventare, più a valle, il Panaro.
Il modo di vita dei Liguri era considerato simi-le a quello dei Celti delle regioni alpine: vivevanoall’interno di “pagi” (o distretti) fino a un certopunto autonomi(7). La loro costituzione era
La confederazione dei Liguri Friniati Il popolo dalle cui gesta e sangue
derivò il suo nome il “Frignano” modenese(1)di Alina Mestiner Benassi
(1) Sull’origine del nome Frignano, scrive F. Schneider, inDie Entstehung von Burgund Landgemeinde in Italien.Berlin 1921, a pag. 48: “Questo territorio detto Ferronia-num evidentemente dal toponimo coniato secondo il latinodotto, vede in seguito il suo nome volgarizzato; la regione sichiama, nel Medio evo, Fregnanum”. E’ utile tuttavia ricordare come sia avvenuta anzitutto la ca-duta della desinenza ligure -tes a vantaggio della latina-um.(2) E’ accertato che i Liguri tenevano anticamente i principa-li mercati dell’ambra presso il delta del Po.(3) D’Arbois de Iubainvalle, Les premiers habitant d’Europe,II. Rifacendosi al Flechia, che è stato il fondatore dell’antica
scienza toponomastica in Italia, D’Arbois dimostra che inLiguria, Piemonte, Lombardia e Toscana, in tutti i paesicioè dove gli storici dell’antichità hanno collocato stanzia-menti liguri, ricorrono con una certa frequenza toponimi in-asco, -usco, -osco, suffissi caratteristici che documenti in-contestabili riferiscono alla lingua dei Liguri.(4) Artemidoro e Eustazio(5) Ricordiamo: Album Ingaunum, Albenga; Album Inteme-lium, Ventimiglia; Alba Docilia; Alba Longa; Albula, il nomepiù antico del Tevere; ecc.(6) Strabone, V, 218.(7) Strabone, Geografia V, 2 “Liguri dissipati per pagos vi-vunt”. Tito Livio, Hist., 39, 1.

16 - Quaderni Padani Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000
schiettamente federale, tipica di ogni stato pre-romano dell’attuale Padania e Toscana: non cit-tadina, ma cantonale, in cui la prima cellula sitrovava a essere il “vicus”. Dalla confederazionedi più vici, emergeva una unità maggiore detta“pagus” e tanti pagi assieme formavano il “con-ciliabulum”(8), pur mantenendo ciascuno granparte della propria autonomia.
Il “vicus”, che non va immaginato come unagglomerato di case o capanne come la “villa”romana, priva peraltro di qualsivoglia organiz-zazione, era soprattutto una assemblea di capo-famiglia del luogo, che deliberava sugli affaridella collettività, occupandosi, prima di tutto,del godimento delle terre comuni, vale a diredei “fundi” compresi nel distretto del “vicus”9.Il “pagus”, analogamente, si esprimeva in unaben più ampia assemblea, ricordata in numero-se iscrizioni, le cui delibere, “pagi scitum” o“pagi sententia”, si occupavano di terre e pasco-li comuni a tutti i “possessores pagi” di questodistretto territoriale. Il “conciliabulum” rappre-
sentava infine una sor-ta di lega federale su-periore. Gli storici moderni(10)che si sono occupatidelle aree d’influenzaligure, ci informanoche queste unità terri-toriali non si confon-deranno, in seguito,nella deprecabile divi-sione del “solum itali-cum” tra i vari “muni-cipia” di romana me-moria, ma conserve-ranno altresì, in massi-
ma parte, le loro funzioni. Questo soprattuttonelle zone alpine e appenniniche(11).
Quando, dopo il IV secolo, i “pagi” e i “conci-liabula”, veri e propri organismi politici dellostato preromano, persero parte della primitivaautonomia, che passò alle magistrature stabilidei “municipia”, mantennero tuttavia, quasiinalterata, fisionomia e funzionalità, derivandoessi spontaneamente dalle esigenze della vita so-ciale di quel popolo. I “pagi”(12) furono però de-stinati, dallo stato romano, a funzioni di secon-do piano, come la manutenzione delle vie e deisentieri, l’annona militare e i culti locali, fermarestando la primitiva funzione relativa al godi-mento dei boschi e dei pascoli della comunità ealla nomina di “magistri pagi” o “curatores” li-guri. Questi ufficiali, sempre eletti dal popolo,detenevano un potere di coercizione, nei con-fronti dei “possessores pagi”, in relazione allacosiddetta “munitio viarum”, e, con ogni proba-bilità, esercitavano sul territorio funzioni di po-lizia, pur non essendo gli scherani di Roma.
Il territorio dei LiguriFriniati1 - “Pagus Feronianum” 2 - “Pagus Verabulum”3 - “Pagus Montebellum”A tratteggio, l’area dellaSelva Feronia
(8) Voce “Conciliabulum” in Paulj-Wissowa, IV, 799-801(9) cfr. Tavola Velleiate, (10) A. Mazzi, Studi Bergomensi. Bergamo 1888.(11) A. Schulten, Die Landgemeinden im romischen Reich,Philologus LIII. 1891(12) Il pagus, come soggetto di diritti e di oneri patrimoniali,
è organo fiscale, toccato dall’imposta nella sua integrità (A.Schulten, op. cit.. Flaccus, De cond. Agror., 165, 4) e, dalpunto di vista amministrativo, viene posto da Roma a basedelle registrazioni catastali (Dig. L. 15, 4). Nerva riconobbeal pagus il diritto di ricevere legati (Gaius, D. 30 De legatis,73; Cod. 2, 58, 2, 5).

Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000 Quaderni Padani - 17
Sui Liguri FriniatiQuella parte dell’Appennino che si trova tra
Modena e Lucca e tra Modena e Pistoia, primadelle due guerre ligustine (II sec. a.C.), era terri-torio stanziale dei Liguri Friniati(13). Al di là diquesto dato, peraltro essenziale, pochissimo sia-mo in grado di trarre dalla storiografia romana eper avere altri dati bisogna, per forza, adattarsi al-la più tarda testimonianza bizantina. Pur tuttaviaimportanti reperti dell’archeologia, nella vicinavalle della Polcevera, suppliscono alle mancanzedella storia. Mi riferisco alla tavola bronzea, dettaappunto “Tavola della Polcevera” (117 a. C.) e allacosiddetta “Tavola Velleiate” o “Tavola alimentaredi Traiano (più o meno della stessa epoca)(14), es-senziali per la conoscenza dell’organizzazioneterritoriale dei Liguri. Grazie a queste tavole, al-l’inizio del secolo, Gaetano Poggi(15), CornelioDesimoni(16) e Gian Piero Bognetti(17) hanno di-mostrato la sopravvivenza dell’antico organismogiuridico del “pagus” ligure nelle circoscrizioniromane, rendendo, in questo modo, perfettamen-te utilizzabili le poche notizie inerenti la fram-mentazione del territorio nelle altre regioni, pri-ma dell’intrusione romana(18). Con analogo pro-cedimento, estendiamo queste risultanze al popo-lo friniate, venendo così a una possibile identifi-cazione dei “pagi” appenninici dei Liguri Friniati.
Il “pagus Feronianum”, il “Montebellum” e il “Verabulum”
Copiose testimonianze, risalenti anche all’altoMedio Evo(19), contribuiscono a determinare conesattezza l’ubicazione del “pagus Feronianum”,per quanto riguarda il tempo che intercorre dallaseconda metà dell’VIII sino all’XI secolo.
Occorre anche tenere presente che, per il ca-tasto di Augusto, la dislocazione di ogni“fundus” veniva stabilita sul tracciato di un “pa-gus”(20) e tale denominazione catastale è usatanel Frignano ancora dopo il Mille, così come
compare in numerosi atti di vendita(21). Il “Feronianum” comprendeva tutta la vallata
dello Scoltenna-Panaro, dalla base collinare alle“Alpes”, così si chiamava allora l’appenninicospartiacque tosco-emiliano. Una testimonianzaancora più antica, il bizantino “Liber Pontifica-lis”(22., ci attesta, con l’esistenza del “Feronia-num”, la presenza di altri due “castra” liguri, adifesa dell’Esarcato di Ravenna: il “Montebel-lum” (Monteveglio, tutta la valle del Samoggia)e il “Verabulum” (Verabolo, tutta la valle delSecchia), sulle montagne modenesi e bolognesi.
Possiamo, a questo punto verosimilmente, trar-re la conclusione che questi distretti corrisponde-vano agli antichissimi, preromani, “pagi” dei Li-guri Friniati: soprattutto il Feronianum e il Vera-bulum si possono tranquillamente identificarecon il territorio dell’attuale Frignano(23), che dalprimo ha ereditato anche il nome(24). Con ogniprobabilità questi aggregati, pur godendo di unelevato grado di coesione interna, dovuta all’unitàetnico-linguistica, non hanno avuto, almeno sinoall’arrivo dei Romani, una vera e propria capitaledella confederazione, ce lo prova l’assoluto silen-zio delle fonti storiche e, soprattutto, di Livio.Emerge così, in modo clamoroso, la mancanzatotale di qualsiasi tendenza alla centralizzazione,che tanto piacque a quelli che vennero dopo.Fondamentale tuttavia era il possesso collettivodi terreni, suddivisi in pubblici e compascui(25),che rappresentavano la effettiva base patrimonia-le del “pagus” e, al tempo stesso, dell’organizza-zione civile di questo grande popolo e della suaassemblea (conciliabulum(26)).
Il Conciliabulum Questa assemblea, che aveva anche giurisdizio-
ne sul culto, quando era organo religioso, si riu-niva nel “compitum”, il luogo sacro, dove si cele-bravano le feste per la semina, la mietitura o laposa dei confini dei campi.(27) Questa era la lega
(13) Livio, Hist., 39, 51; 41, 12 e ss. (14) Tavola della Polcevera, C.I.L., V, 7749; Tavola Velleiate,C.I.L., XI, 1147(15) G. Poggi, Genoati e Veiturii, in “Atti Soc. Lig. St. Patr.,XXX. 1900.(16) C. Desimoni, Sulla tavola di bronzo della Polcevera,ibid., III, fasc. II, p. 531.(17) G. P. Bognetti, Sulla origine dei comuni rurali nel MedioEvo. Pavia 1927.(18) G. Mengozzi, Il comune rurale nel territorio lombardo-tosco. In: La città italiana nell’Alto medio evo. Firenze 1931.(19) A. Sorbelli, G. Tiraboschi e la questione del “castrum Fero-nianum”, in “Atti dell’Accademia delle Scienze”, Modena 1933.
(20) G. Poggi, op. cit.(21) Drei G. Carte Arch. Parmensi, Parma 1928. Cod. Dipl.Mod., III, 48(22) Liber Pontificalis. Vita Gregorii II (vol. I), edition Duche-sne, Paris 1886.(23) Livio, 39, I.(24) Altri “pagi” friniati, presumiamo, analogamente, che sipossano identificare con il “pagus Monsbellum” e con il “pa-gus Persicetum” nella pianura sottostante (Lib. Pont. I e Cat.Prov. 188)(25) Tavola Velleiate, cit.(26) Festo, 38:”locus ubi in concilium convenitur”.(27) G. Mengozzi. Op. cit.

18 - Quaderni Padani Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000
di tutte le tribù dello stesso nome e, in perfettaanalogia con il “pagus”, deteneva terre e boschicomuni che si trovavano, generalmente, “in tri-finia et quadrifinia”(28) e che erano consideratisacri perché in essi si venerava la divinità dellaconfederazione. Giova, a questo punto, ricordarecome, presso le antiche genti, il centro religiosovenisse presto a coincidere con il centro civile ecome questi luoghi fossero anche sede di merca-ti (radice: fer > porto). Così, mentre le tribù la-tine si davano appuntamento nel bosco Ferenti-no, i Liguri Friniati amavano far festa o com-merciare nella Selva Feronia.
La Selva FeroniaLa Selva Feronia, chiamata in epoca più recen-
te “Romanesca”, comprendeva ancora, dopo ilMille, buona parte dell’alta valle del Secchia edello Scoltenna-Panaro ed era sicuramente losplendido santuario (nemus) della confederazio-ne, centro spirituale e politico dei Liguri Frinia-ti. Questo territorio, delineato a sud dallo spar-tiacque delle “Alpes”, tra il monte Cimone e ilCusna, costituiva un distretto naturale che tro-vava la sua ragion d’essere nella stessa configura-zione fisica della regione: le carte geografichedell’Alto Medioevo continueranno a rappresenta-re i medesimi confini, strettamente determinatida elementi oroidrografici di notevole rilievo e,per questo, ineliminabili. (Non si trattava certa-mente di una nazione costruita sulla carta, comel’Italietta, che di questo materiale può far propriala fragilità e la provvisorietà). Pur tuttavia, anchese questo ampio territorio costituiva la sede piùcerta della confederazione dei Liguri Friniati,non possiamo escludere categoricamente altrefonti(29), che, pur non consentendoci conclusionisicure, ci lasciano intuire l’esistenza di un anti-
chissimo territorio confederato di dimensionimolto più ampie dell’attuale Frignano.
La Selva Feronia segnava anche il confine coni Liguri Briniati dell’altro versante dell’Appenni-no(30) con cui tuttavia i nostri mantenevano di-ritti di pascolo e di legnatico in comune: questofatto spiegherebbe molto bene la sostanzialeunità toponomastica delle due vallate.
Dopo l’invasione romana, questa forma di or-ganizzazione, relativa a tutte le zone boschiveappartenenti alla nazione ligure, si conservònella Gallia Cisalpina almeno fino al 59 a. C.(31),e la Selva, anche se incamerata dal fisco deglioppressori, venne lasciata alla confederazione,naturalmente dietro pagamento di untributo.(32) Si formò così il maggior centro civilee commerciale del Frignano nei pressi di Pavul-lo: l’“oppidum Gallianum” (Gaiato) di cui ci par-la anche Plinio(33).
ConclusioneIl territorio della confederazione, mutilato e
spogliato peraltro di ogni attribuzione politicadall’invasore romano, ridotto a un semplice or-ganismo amministrativo, passava tuttavia, conuna fortissima identità, nei secoli seguenti, re-cando in sé il germe di un futuro sviluppo degnodi un passato di libertà e di indipendenza.
(28) Frontino. De contrversis agrorum. Lachmann.(29) Desjardins. Atlas Geographique de l’Italie ancienne. Pa-ris 1852. Lo studioso pone con sicurezza i Friniati tra il cor-so superiore dello Scoltenna e la Selva Litana.(30) Frontino. Op. cit.(31) Lex de Gallia Cisalpina. C. I.., 205. XI, 1116.(32) Ricordiamo la sopravvivenza di confederzioni abbastanzasimili nelle valli alpine, Schulten, l. c.(33) Regio VIII.

Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000 Quaderni Padani - 19
Se “nessuno è più schiavo di colui che si ri-tiene libero senza esserlo”(1), la Padania,suo malgrado, è una terra popolata da un
grande numero di individui che, nella loro insa-na quanto autodistruttiva illusione, travisanomisere garanzie e residuali concessioni sprez-zantemente elemosinate dall’alto, come fosseroaurei e fulgidi galloni, lealmente conquistati sulcampo di battaglia o ancora i benefici effetti as-sicurati da un sistema tutto sommato incardi-nato su principi legalistici e democratici. Ma iproblemi non si risolvono certo facendosi beffedi quelle catene che ostinatamente si vuol nega-re esistano: magari a qualche padano sarà an-che capitato di aver meritatamente vinto unconcorso per l’assegnazione di un pubblico im-piego; o forse sarà stato anche il fortunato asse-gnatario di una casa popolare; alle poste, nellestazioni, negli ospedali sarà stato persino gen-tilmente trattato da individui che non si senti-vano in dovere di credersi i depositari di unacultura diversa e superiore; e che dire dellescuole o delle università: a qualcuno sarà pursuccesso di prendere parte a una lezione, addi-rittura di storia, in cui il vernacolo utilizzatoper l’esposizione non fosse spiccatamente le-vantino o che l’esposizione stessa non conte-nesse i germi di una visione filosofica romanofi-la e romanocentrica, impregnata del mito della“Roma caput mundi”; e ancora, a qualche pada-no sarà anche sicuramente successo di aver var-cato l’aula di un tribunale ed essere stato ivigiudicato da un magistrato che riuscisse a com-prendere le sue ansie, i suoi dubbi, la sua men-talità, la sua “tavola di valori”, e ancor prima,naturalmente, la sua stessa lingua!
Tutto ciò, ribadisco, sarà avvenuto di sicuro e,col beneficio del dubbio, potrà anche non trat-tarsi delle classiche eccezioni che confermanola regola. Quello che importa è ben altro dato,sconfortante in tutta la sua lapalissiana concre-tezza: infatti, gli esempi addotti - che peraltrosono solo una piccola parte di tutta una conge-rie di situazioni che potrebbero essere richia-mate - sono al contempo epifenomeno patologi-
co di un processo disgregatore e pretesto dineghittosa inazione. Cioè a dire, la presenza ditale miriade di fattispecie delinea senza mezzitermini il perverso assetto materiale “istituzio-nalizzato” nel tessuto economico-sociale-cultu-rale della Padania, nonché subliminalmenteformalizzato come buono e giusto dai suoi inte-ressati sostenitori. La sua operatività, difatti, siè retta e si regge tuttora su assurde ideologie-nel senso più deteriore del termine -, su artifi-ciosi quanto surrettizi principi, su premessetanto errate quanto passivamente condivise: edè solo grazie alla straordinaria opera di analisi,di critica, di studio, - oltre alle innumerevolibattaglie combattute - del movimento e dell’o-pinione pubblica padanista che si sta ingene-rando un positivo effetto “torpedine”, grazie alquale si dovranno via via ridestare le coscienzeancora assopite dal cloroformio romano-meri-dionalista.
Il pernicioso procedimento è stato costruitoad arte e ha garantito (e tuttora, purtruppo,continua a garantire) ai suoi artefici un elevatorapporto benefici-costi: e ciò sostanzialmente,bisogna dirlo, grazie a una serie di fattori predi-cati al “modus operandi” dei padani durante nu-merosi decenni: acquiescenza, timore, interessepersonale, opportunismo, miopia, disillusione,rassegnazione, frustrazione…E , come dice ilproverbio, “chi è causa del proprio mal piangase stesso”!
Quel che è fuor di dubbio è che la scaturiginedi tale circolo vizioso è da ricondursi al cosid-detto “problema del free-rider”, che un illustreeconomista ha recentemente illustrato in un il-luminante saggio(2).
Il “free-rider” (o “battitore libero”) è “uno chesi assicura i profitti del bene o del servizio diconsumo collettivo senza partecipare affatto al-la condivisione dei costi”. “…ognuno avrà moti-
L’essenza del meridionalismodi Cristian Merlo
(1) J.W. Goethe, Massime e riflessioni,II, 5(2) J.Buchanan, I limiti della libertà (Milano: Rusconi,1998),pp. 92-95

20 - Quaderni Padani Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000
vo per astenersi dall’assumere iniziative di pro-pria volontà nella misura in cui nutra l’aspetta-tiva che il suo comportamento sia indipendenteda quello degli altri partecipanti nell’ambitodella possibile interazione sociale”. Ebbene, nelBelpaese, il meccanismo di cui sopra si avvale dimigliaia, milioni di “battitori liberi”: essi sonogli esponenti del più vampiresco, subdolo e op-pressivo meridionalismo, una miscela esplosivadi sfruttamento economico blandito col fatali-smo più ipocrita e astenico, di dileggio politicocelato sotto il più truffaldino e bieco solidari-smo, e di devastazione culturale perpetrata conil più irriverente cinismo.
Il mastice del sistema è costituito dagli ele-menti più disparati ma, allo stesso tempo, inte-grati fra loro:a) una visione levantina e totalmente manicheadell’esistenza, per la quale il mondo si divide infurbi (=meridionali) e fessi (=padani), in “coltie figli di una cultura millenaria”, a cui per dirit-to naturale e per la stessa ineluttabilità del fatospetterebbe di essere mantenuti e “ignorantieredi di generazioni di paesani gozzuti e pella-grosi, buoni solo per sgobbare”(3), a cui per do-vere spetta tale mantenimento;b) una casta politica espressiva di tale settariafilosofia e sordida esecutrice di inganni, media-zioni, compromissioni di ogni genere; di più,essa, operando con un vero e proprio vincolo dimandato nei confronti dei propri elettori-credi-tori(4), può garantirsi innumerevoli guadagnipersonali, sterminato potere, stima e sicura ri-conoscenza spendibile anche in futuro - da par-te dei beneficiari materiali di tale politica: i fa-migerati “free-riders”;c) il soccombismo più totale da parte dei padaniche a tale immorale “stangata” non si sono maiopposti; hanno tollerato ogni tipo di vessazione,sopportato angherie e taglieggiamenti, soprusiumilianti, accise inconcepibili, condizioni iugu-latorie.
I motivi di tale indisponente “oblomovismoautoctono”, come già rimarcato in precedenza,sono molteplici, ma sostanzialmente riconduci-bili a un unico fondamento: il sempre più mar-ginale benessere materiale di cui si continua agodere!
Ci tassano in maniera spropositata, ma pos-siamo pur sempre permetterci due automobili;ci offrono servizi ospedalieri da terzo mondo,ma ci si può concedere il “lusso” di una visitaprivata; le strade sono paralizzate dal traffico,piene di buche e incroci pericolosi, ma alla do-
menica lo stadio è pur sempre raggiungibile; iltenore di vita nella città va peggiorando di annoin anno?: non importa, tanto si può sempre ap-profittare del fine settimana libero per una gitafuori porta; e se le condizioni di integrazionesociale vanno deteriorandosi ineluttabilmente,nessuno ci impedisce di barricarci in casa a gu-starci un bel programmino alla tv!
Tale modo di ragionare sembra però viziatoab origine, essendone le promesse integralmen-te falsate: il benessere materiale non può mai,in ogni caso, surrogare, l’autonomia decisionalee normativa, la possibilità di scelte libere e re-sponsabili, in una parola la propria incoercibile,incomprimibile libertà!
Non è ammissibile alcun baratto, alcuna per-muta artatamente ammantata di giustizia redi-stributiva ed equità allocativa, giacché si rivele-rebbe a ogni qual modo un ignobile e speciosopatto leonino, proditoriamente architettato perestorcere rappresentatività politica e potere eco-nomico in cambio di residuali benefici “conces-si”…a chi quei benefici se li crea già di per sé.Un vero e proprio paradosso: i padani si lascia-no irridere, prostrare, avvilire in cambio di unpiatto di lenticchie…peraltro da se stessi cuci-nato; e non è tutto, in quanto acconsentirebbe-ro a tutto questo per avere una garanzia, unagrande garanzia: la sicurezza di gustarsi quelpiatto in santa pace, senza che l’aguzzino inter-venga di nuovo!
Del resto, la pletora di professori, l’esercitosterminato di impiegati pubblici, giudici e ma-gistrati sempre e solo provenienti da una certaparte dello Stivale, sono un fenomeno talmenteradicato che si comprende rapportandolo allasua devastante funzionalità.
L’indecente contratto capestro stipulato daidue interessati contraenti - classe politica me-diatrice romana da una parte e i tanti, troppiesponenti beneficiari del meridionalismo assi-stito dall’altra - realizza quello che l’analisi eco-nomica definisce come esternalità: ossia, il per-
(3) Gilberto Oneto, “Privazione culturale”, su La Padania,03-01-99, p. 19(4) Tale accordo si regge indubbiamente con la classica pro-cedura del voto di scambio, grazie alla quale l’ideologia me-ridionalista è effettivamente in grado di alimentarsi e impor-si attraverso i canali più svariati: stanziamenti a fondo per-duto, benefici particolari, assistenze “a pioggia”, aiuti ecce-zionali, concessioni agevolate …E questo sempre con la soli-ta, pelosa giustificazione: “favorire lo sviluppo economicodelle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso,oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione”.

Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000 Quaderni Padani - 21
seguimento delle rispettive (mal)intenzioni (5),imponendo delle mortifere conseguenze sui con-ti economici e sull’assetto sociale di terzi sogget-ti, la gran parte dei quali del tutto estranei e cer-tamente non consenzienti alla costituzione diquel turpe vincolo. Esso, irrefutabilmente, intro-duce scompensi, squilibri, discrasie nell’ambitodel globale tessuto comunitario padano, materia-lizzandosi in special modo:a)Nella destabilizzazione del nostro caratteristico
bagaglio di valori ingenerando una letale e pro-gressiva sfiducia nell’efficacia propositiva diquegli elementi ideali, culturali, di quei princi-pi orientativi che hanno sempre fondato e chetuttora fondano il nostro progresso, il nostrosviluppo materiale e civile. Ma la ricchezza, l’e-voluzione, l’incremento non possono mai di-scendere dall’alto per grazia divina o dipendereesclusivamente da fattori esterni, fisici, indi-pendenti dalla volontà dell’individuo; i nostriprogenitori non hanno spianato le montagne,arginato l’impeto irriducibile dei fiumi, costrui-to villaggi, borghi, città prosperi e floridi cosìper caso o per l’intervento di qualche deus exmachina. No, la nostra realtà è il frutto natura-le delle fatiche, dell’impegno, del lavoro e delsudore di milioni di uomini e donne, sorretti dauno straordinario e religioso culto per certi pa-radigmatici presupposti: la libertà di pensiero edi intrapresa, la sovranità nell’autogoverno,l’autonomia organizzativa, la progettualitàcreatrice, il “diritto-dovere al lavoro vissuto co-me atto di dignità esistenziale e contributo allasviluppo armonico della società”(6), nonché lalealtà, la tolleranza, la capacità mediatrice deldialogo, il rispetto dell’individuo e dell’unità fa-miliare. A un’attenta analisi, dunque, emergeche la realizzabilità di taluni obiettivi è vincola-ta alla operatività di molteplici fattori, che sipongono come antecedenti logico-ontologicidell’intero disegno d’insieme. Il contrabbanda-re da parte degli assertori del meridionalismopiù peloso - la latitanza di quei fattori nell’am-bito della loro specifica dimensione mentale,culturale, spirituale, per una irrevocabile e in-colpevole condanna alla cronica deficienza difrutti tangibili (che dovrebbero promanare daifattori menzionati), significa solamente intor-bidare le acque, scambiando le cause con gli ef-fetti. A questo punto, mi chiedo: fino a quandoci dovranno essere addebitate le esiziali riper-cussioni originate da un’interpretazione dellavita e dei suoi risvolti del tutto diversa (se nonaddirittura opposta) dalla nostra, caratteristica
di contesti a noi del tutto estranei e indifferen-ti?; fino a quando dovremo sobbarcarci l’oneredi riparare alla più totale assenza di criteri eti-co-sociali comparabili e compatibili coi nostri, iquali rappresentano l’ossatura, l’impalcaturaimprescindibile di un certo modello di ri-pro-duzione della società? Nostro malgrado, l’im-mane pioggia di concessioni e benefici non po-trà mai costruire quel substrato mancante,quel terreno ubertoso dal quale dovrebberotrarre linfa vitale, iniziative, progetti, idealità dicrescita e sviluppo: la voglia di lavorare né sicompra al supermercato, né può essere espor-tata(7)!
b)nella indefessa spoliazione e nella improvvidadepredazione, perpetrate con ignobile ed em-pia rapacità levantina, alle quali vengono sot-toposte tutte le risorse umane, materiali, spiri-tuali - prodotte in Padania o in un certo sensoespressive di modalità autoctone di vivere, agi-re e operare. Non basterebbero pagine e pagineper enumerare la pletora di torti e ingiustizieche quotidianamente dobbiamo tollerare(8):siano essi tasse assurde, accise medievali, bal-zelli illogici, canoni spropositati per serviziinesistenti, regole manifestamente infondate, oprovvedimenti emessi per far fronte a chissàquale nuova evenienza. La verità si staglia intutta la sua disarmante chiarezza e nella suasfrontata molestia contro i cittadini padani:
(5) Tali intenzioni, giova ripeterlo, consistono, per i mediatoripolitici romano-meridionalisti, nella massimizzazione sottoogni profilo economico/reddittuale, propagandistico/elettoralein primis - della loro speciale rendita “di posizione”; per i be-neficiari di tale politica, i free- riders, nell’approfittarsi dellecopiose opportunità derivanti da una situazione che, se nonvolutamente costituita , è però perlomeno mantenuta tale neisuoi aspetti strutturali: quelli di una società povera, perma-nentemente bisognosa di provvisioni, inguaribilmente affettada…sindrome di trasferimenti “a basso costo”. Del resto, unvoto di scambio può ben valere un contributo di assistenza!(6) Roberto De Anna, “In Padania, cultura in prima linea”, suLa Padania, 18-04-99, p. 22(7) Il grande economista padano Bresciani Turroni sostenevache “la sorgente del reddito nazionale è data dalla quantitàdei fattori della produzione: lavoro, risorse naturali, stru-menti della produzione creati dall’uomo. Ma non basta, ilreddito è determinato anche dall’efficacia di questi fattori, ilquale dipende dallo stato della tecnica, dall’organizzazionerazionale delle imprese, e anche da fattori psicologici, qualela volontà di lavorare”. Quanto allo spirito d’iniziativa, è es-so “che trasforma i risparmi monetari in nuove fabbriche, instrade ferrate, in navi che solcano gli oceani”. (8) Cfr. in proposito, ad esempio, Gilberto Oneto, “La tassadel tricolore”, su La Padania, 20-12-98, p. 19, nonché Gil-berto Oneto, “L’opera pia chiamata Italia” , su La Padania,27-12-98, p. 19

22 - Quaderni Padani Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000
non solo sistematica negazione-esclusione dalgodimento dei benefici fisiologicamente e giu-ridicamente connessi con la detenzione dellepiù elementari situazioni soggettive attive - di-ritti, potestà, aspettative, interessi legittimi,status - ma soprattutto - quel che è più grave -quotidiana erosione dei pur labili spazi operati-vi tendenti a garantire le più che legittime ri-vendicazioni degli “incisi-discriminati”(9) di “ri-manere all’interno di un nucleo di ragionevoliaspettative di rinegoziazione” (J.Buchanan). Equesto affinché si possa ri-definire i logici e ov-vi equilibri distributivi delle suddette situazionisoggettive attive, lesi da decenni di ignobilesfruttamento coloniale. In soldoni questo signi-fica che i cittadini padani, oltre a non poter di-sporre di diritti sacrosanti che sarebbero tutela-ti in qualsiasi parte del mondo civile(10), si tro-vano immersi, loro malgrado, nelle paludi delpretestuoso e parassitario immobilismo roma-no, che trae vitalità e prosperità proprio dallasoppressione di qualsiasi istanza riguardante la
necessità di impostare scelte nuove per ri-trat-tare, ogniqualvolta sia opportuno, le proprieposizioni e i propri ruoli sociali sulla base di pa-rametri del tutto divergenti da quelli vigenti,oltreché per selezionare gli strumenti appro-priati per attuare le risultanze di quelle trattati-ve. La bontà di tali propositi si riscontra espres-samente e si rinvigorisce nell’idea di un proces-so di una specifica autoregolamentazione loca-le, intesa come espressione di una dimensionepsicologica e spirituale “egoisticamente”(11)orientata alla realizzazione concreta di obiettivie finalità, avvalendosi di mezzi e modalità pre-suntivamente impliciti in quei canoni di eticapubblica e moralità individuale che da sempreinformano il nostro modo di essere, pensare,produrre. Secondo tale prospettiva, infatti, ledistinte esigenze, le personali necessità e i pro-positi soggettivi dovranno essere sempre asse-condati, fintanto che ciò non comporti degliscompensi irriducibili all’interno del corpo so-ciale, pregiudicando, da ultimo, la stessa con-
(9) Con tale espressione si ribadisce, se ce ne fosse bisogno,che l’inesausta e arbitraria estensione di benefici a favore ditalune categorie - a detrimento di altre - è tendenzialmenteconcretata attraverso il prelievo forzoso di ricchezza appar-tenente a quegli stessi individui che sono poi anche immuta-bilmente esclusi dall’ estensione. Va da sé, per converso, chei privilegiati godano oltremodo di dispense ed esenzioni perquanto concerne gli atti di compartecipazione obbligatoriaalla formazione dei cosiddetti beni prestazione, costituitidalle disponibilità economico-finanziarie necessarie per ilconseguimento di utilità future, sussumibili nella sfera deicompiti e delle funzioni che un moderno stato di diritto ha ildovere di conseguire. In tali casi, il vincolo impositivo chegrava sui soggetti in questione o si esplicita sotto forma diprelievi per lo meno sproporzionati rispetto alle provvidenzeassegnate (detrazioni, detassazioni), o sotto forma di inter-venti di mera facciata, di interlocutori “pro forma” (esenzio-ni a vario titolo, aliquote agevolate…), o addirittura attra-verso una vera e propria complicità nell’incentivare la messain atto di comportamenti omissivi (la evidente avversionenel sanzionare gli innumerevoli casi di comprovata evasionefiscale). (10) Proprio perché questi diritti e queste aspettative sono ilportato diretto e immediato di autoevidenti regole di giusti-zia e di principi etico-sociali universalmente riconosciuti,che, checché se ne dica, sono manifesti e palesi anche nellaCostituzione vigente: la possibilità di poter concorrere a usu-fruire di talune opportunità, in virtù del possesso di idoneirequisiti senza essere regolarmente discriminati, è uno scon-tato corollario del principio di imparzialità (combinato dispo-sto articolo 51 e articolo 97); così come quella di poter bene-ficiare, in maniera equa, di utilità e vantaggi cui si è parteci-pato alla costituzione, in ragione della propria capacità con-tributiva, è una evidente conseguenza del principio di ugua-glianza (combinato disposto articolo 3 e articolo 53); ancora,il diritto di poter accedere - ceteris paribus - a ricoprire cari-
che, funzioni, mansioni per via di qualificanti parametri lega-ti al fatto di vivere e conoscere la realtà di una determinataarea o quello di vedersi destinare una congrua quota del get-tito fiscale prodotto sul proprio territorio per la risoluzionedegli specifici problemi locali costituiscono un’intuitivaesplicitazione del principio fondamentale dell’autonomia de-gli Enti Locali (art. 5 Costituzione) e di quello della sussidia-rietà, tante volte proclamato e sancito da norme comunitarie(cfr. art. 3B, secondo comma del Trattato di Maastricht).Tant’è che se se “l’esercizio delle responsabilità pubbliche de-ve, in linea di massima, incombere di preferenza sulle auto-rità più vicine ai cittadini” (art. 4.3, Parte I della “Carta Eu-ropea”), “le collettività locali hanno diritto, nell’ambito dellapolitica economica nazionale, a risorse proprie sufficienti, dicui possano disporre liberamente nell’esercizio delle lorocompetenze” (art. 9.1 della suddetta Carta). Ma per l’ordina-mento italiota sono semplicemente parole al vento, da rece-pire formalmente in disposizioni interne affinché restino persempre…LETTERA MORTA! Quando, invece, se corretta-mente inteso e applicato, il suddetto principio di sussidiarietàcondurrebbe alla eliminazione di quelle “competenze garan-tite” illiberali e liberticide, espressione di un apparato centra-lista e centripeto, apportando, se non altro, una effettiva “de-strutturazione complessiva delle competenze con una con-correnza Comunità (locale, n.d.a.)-Stato-Regioni retta da unprincipio di utilità comunitaria”. (Chiti)(11) L’accezione di “egoismo” va qui intesa in senso lato, im-plicando delle connotazioni e della valenze tutt’altro che ne-gative: essa, infatti, è assimilabile a quella condizione defini-ta da uno studioso contemporaneo come “individualismosano e rettamente inteso”…”interessato ad obiettivi a lungascadenza , [che] cerca di trarre benefici per sé e per le perso-ne care su basi sempre più razionali…Tale individualismo ri-getta ogni forma di delirante degenerazione pseudo-indivi-dualista: il narcisismo, l’ingordigia, l’edonismo…” Tibor Ma-chan, su La Padania, 12-12-98

Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000 Quaderni Padani - 23
cretizzazione egoistica degli obiettivi. Le idee,le aspirazioni, i sogni, le illusioni di ogni singo-la persona possono tingersi coi colori della pro-gettuale realizzabilità e del pragmatico reali-smo solo se avranno potuto trovare armonicacomposizione nell’ambito della vita d’insieme;tuttavia, l’insopprimibile punto di partenza el’indefettibile fondamento positivo dovrà essereriscontrato, senza eccezioni, nell’individuo, inqualità di momento di sintesi dei nuclei essen-ziali dei singoli diritti, doveri e libertà, nonchédi referente soggettivo ultimo della loro tutela. Però, sino a ora, qualsiasi tentativo diretto arender palese e manifesto tale stato di cose, ascandagliarne le cause più remote, rimarcarnei sintomi, denunciarne gli effetti più squalifi-canti, viene metodicamente, a seconda dei casi,blandito, misconosciuto, mistificato o oppor-tunisticamente travisato; così come ogni pro-posta e ogni serio progetto di riforma, suscetti-bili di apportare modifiche sostanziali e fecon-de prospettive di rinnovamento, vengono, divolta in volta, stigmatizzati, vituperati, tacciatidi velleitarismo, populismo, disfattismo, sfasci-smo, razzismo… insomma tutto e il contrariodi tutto! E questo solo ed esclusivamente affin-ché, gattopardescamente, la sostanza delle co-se possa continuare a conservarsi così com’è:specie in quella struttura socio-politica orren-damente polarizzata e cristallizzata, dagliagenti teratogeni statalisti, in forme vieppiùibride e mostruose. Il regime cerca, con ognisquallido artifizio e con ogni sorta di machia-vellico inganno, di sedare, frenare, edulcorare -dove non sia possibile far altro - tutte quellespinte innovatrici che promanano direttamen-te dai gangli di quei corpi sociali padani chehanno finalmente compreso la sesquipedalemolestia della imposizione coatta dell’impe-rante “minimalismo esistenziale”. Trattasi cioèdi tutti coloro che rigettano e aborrono la ras-segnata accettazione, se non addirittura la sto-lida condivisione, di una concezione raccapric-ciante, deviata, che fa del masochismo autodi-sprezzante una bandiera. Essa conduce, diret-tamente o indirettamente, a una uniformazio-ne di giudizio sui vari sistemi di fini oggettivirappresentabili, a una capziosa standardizza-zione delle scelte comportamentali che sono amonte del perseguimento di quei fini, in ag-giunta a una farisaica stereotipia della gerar-chia oggettiva di valori puri implicata in quellescelte; tutto ciò non fa che ridondare a vantag-gio del bieco programma di manipolazione
delle menti dei colonizzati padani, che devonoconvincersi di adoperarsi per le legittime causeegualitariste del…colonizzatore meridionali-sta. In altre parole, si tende a far dimenticareche la salvaguardia dei propri legittimi inte-ressi (siano essi economici o di altra natura)coincide con l’implicita salvaguardia delle pre-ferenze e delle decisioni che li hanno determi-nati e prodotti, alle quali sono sottese diffe-renti opzioni, ideali e culturali. Tutelare unproprio legittimo interesse vuol quindi anchedire tutelare quei canoni identitari che con-traddistinguono un certo di modo di rappre-sentare quell’interesse specifico; così come ri-nunciare, senza giustificato e valido motivo,alla sua tutela significa accondiscendere allaperdita della propria identità, alla vocazionecomportamentale che informa il rapporto conlo stesso interesse. Per un padano, ad esempio,difendere il proprio legittimo diritto al lavoroimpone la difesa di quei meccanismi compor-tamentali e socio-culturali che definiscono larelazione con quel diritto: lavoro inteso comeattività socialmente e legalmente regolamenta-ta per la realizzazione di precise utilità econo-miche, lavoro inteso come mezzo eletto per lapromozione del proprio equilibrio e della pro-pria armonia “antropologica”, o ancora comepresupposto ontologico in vista della pienarealizzazione di obiettivi ulteriori. Al contra-rio, rinunciare senza un valido perché al dirit-to di gestire le proprie risorse, anziché di frui-re di servizi efficienti (in relazione alla propriapartecipazione contributiva), implica l’abdica-zione a particolari scelte di razionalismo effi-cientista e di trasparenza meritocratica. L’iden-tità padana, come già rimarcato(12), si avvale diun patrimonio di valori ben delineato(13), ilquale necessariamente influisce sulle determi-nazioni afferenti , in ispecial modo:- definizione/delimitazione della portata de-
gli interessi sottesi a una determinata posi-zione giuridica;
- prospettazione delle differenti modalità di
(12) Non si tratta certamente di un asserto prescrittivo, vali-do in se e per se e in assoluto; trattasi, più semplicemente, diun affresco empirico-descrittivo di linee tendenziali alquan-to diffuse, espressive dei caratteri di determinate realtà so-ciali. (13) Se si potesse condensare in pochi tratti caratteristici lavarietà di tale patrimonio valoriale, si potrebbe forse tentaredi riassumerla nella seguente triade di principi regolativi:autonomia decisionale, responsabilità delle proprie scelte,meritocrazia legata agli effetti di tali scelte.

24 - Quaderni Padani Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000
esercizio di determinati interessi giuridica-mente tutelati;
- prospettazione dei procedimenti di salva-guardia delle suaccennate modalità di eser-cizio;
- regolamentazione degli effetti e delle leciteutilità connessi a certe modalità di esercizio;
Ma v’è di più: per poter attribuire la patente dilegittimità agli interessi che stanno a valle, biso-gna far sì che le decisioni e le rappresentazionidegli stessi, che stanno a monte, siano conformial cosiddetto concetto proprio o “giuridico” dellagiustizia. Ogni deliberazione in proposito nonpuò fare a meno di confrontarsi con l’idea dellagiustizia, in quanto essa procede direttamentedall’intima natura della coscienza e il suo rico-noscimento “inserisce l’uomo in una coordina-zione intersubiettiva, nella quale il lecito è de-terminato per ciascuno dei soggetti dal rapportocon gli altri”. I suoi irrinunciabili elementi fon-dativi sono essenzialmente: 1) l’alterità/bilateralità di ogni determinazionegiuridica, per la quale ogni soggetto deve esserevisto, nella contestualità del caso, l’uno in fun-zione dell’altro;2) la parità iniziale tra i soggetti, implicante lapostulazione dell’ulteriore nozione del contrac-cambio: un soggetto non ha la facoltà di operarein un modo distinto rispetto agli altri, “senzarendere con ciò legittima o <<giusta>>, nellemedesime circostanze, un’eguale operazione de-gli altri in confronto suo”(14);
3) la reciprocità, alla quale può essere imputata“la valutazione di ogni atto nel suo significatoobiettivo, cioè in quanto esso costituisce unmezzo di comunicazione o d’interferenza trasoggetto e soggetto, e quindi anche la base perun trattamento corrispondente”;
Se dunque la giustizia “non tocca che il campodelle esigibilità reciproche tra soggetti”, si impo-ne come apodittico corollario l’esigenza che“ogni soggetto sia riconosciuto (dagli altri) perciò che vale, che a ognuno sia attribuito (daglialtri) ciò che gli spetta”(15).
Orbene, stando così le cose, si può certamenteaffermare, senza tema di smentite, che i nostriprincipi normativi, nell’ottica in cui li abbiamodefiniti, integrano tendenzialmente l’ipotesi diconformità al paradigma di giustizia cui accen-navamo: nessuna analisi empirica o documenta-zione storica potrà mai affermare il contrario! Equesto proprio in base allo specifico retroterraculturale e al peculiare habitus mentale padano,che ha sempre permesso di affrontare delle scel-te ancorandole, pragmaticamente, all’ethos digiustizia connaturato nella stabile libertà deirapporti interindividuali, funzionale al singoloper divenire il demiurgo del proprio orizzonteoperativo e l’artefice di un appagante processodi aspettative inesplorate o di impensabili nuovevie all’autoregolamentazione dei propri interes-si(16). È solo nella libertà che la giustizia si vivi-fica e l’individuo ottimizza il proprio benessere!
Per converso, non può dirsi lo stesso per coloro
(14)Tale concetto è anche esprimibile come “una virtuale au-torizzazione a un atto analogo tra gli stessi soggetti, che peripotesi abbiano invertito le loro parti”.(15) Le notazioni citate sono state tratte da Enciclopedia Filo-sofica Sansoni, vol. 3 (Firenze: Sansoni, 1968), pp. 254-255 (16) Per descrivere l’entusiasmante tensione ideale, l’inesaustapropensione alla libera progettualità e alla costruttiva e fattivalaboriosità che da sempre animano i nostri popoli, si possonoaddurre a esempio le straordinarie parole di quello straordina-rio lombardo che fu Carlo Cattaneo, nel tratteggiare mirabil-mente le caratteristiche distintive riscontrabili nella realtàstorico - sociale della sua amata terra : “S’intraprese il censodi tutti i beni dietro un principio che poche nazioni finorahanno compreso. Si estimò in una moneta ideale, chiamatascudo, il valor comparativo d’ogni proprietà.Gli ulteriori au-menti di valore che l’industria del proprietario venisse ope-rando, non dovevano più considerarsi nell’imposta; la qualeera sempre a ripartirsi sulla cifra invariabile dello scudato.Ora, la famiglia che duplica il frutto dè suoi beni, pagandotuttavia la stessa proporzione d’imposte, alleggerisce di unametà il peso, in paragone alla famiglia inoperosa, che paga lostesso carico, e ricava tuttora il minor frutto.Questo premiouniversale e perpetuo, concesso all’industria, stimolò le fami-glie a continui miglioramenti. Tornò più lucroso raddoppiare
colle fatiche e coi risparmi l’ubertà d’un campo, che possederdue campi, e coltivarli debolmente. Quindi il continuo inte-resse ad aumentare il pregio dei beni fece sì che col corso deltempo e coll’assidua cura il piccolo podere pareggiò in fruttoil più grande;... Dalla metà del secolo in poi si attivò un’im-mensa divisione e suddivisione di beni; il numero dei possi-denti e degli agiati crebbe nella proporzione stessa in cuicrebbero i frutti. Si cominciò a sciogliere i fedecommessi, cheunivano nelle famiglie la noncurante opulenza dei primogeni-ti con la povertà, l’umiliazione, la forzata carriera dei cadetti edelle figlie. Si abolirono le mani morte; si rimisero nella liberacontrattazione i loro sterminati beni; si alienarono i pascolicommunali; si riordinarono le amministrazioni dè municipi;si rivocò l’educazione publica a mani docili e animate dallospirito del secolo e del governo; si abolirono i vincoli del com-mercio, la schiavitù dei grani, quasi tutte le mete dei comme-stibili, e i regolamenti che inceppavano le arti....Si apersero lestrade; si soppressero barriere e pedaggi;...Si abolirono le pre-ture feudali, in cui per conto di privati si mercava la giusti-zia...Regnò la tolleranza di tutti i culti; e si aperse ospite sog-giorno agli stranieri che apportavano esempi di capacità ed’intraprendenza....Il povero riceve una più generosa parte disoccorsi che altrove”. C. Cattaneo, Lombardia antica e mo-derna (Firenze: Sansoni, 1991), pp. 85-86-98

Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000 Quaderni Padani - 25
che sin dall’inizio abbiamo definito come “free-ri-ders”: proprio perché essi non confidano nellabontà operativa della stabile libertà delle relazionisociali, e si abbandonano alla convinzione che“chi detiene un potere (o dei mezzi economici)non li ha in forza dell’applicazione di regole isti-tuzionali, da tutti conosciute e riconosciute - e ingenere per una unità di tempo determinata - main virtù di attitudini personali, di relazioni privi-legiate, o per l’efficacia di una tradizione invete-rata ed immutabile”(17). Inevitabilmente ne con-segue, da un punto di vista logico, il totale disco-noscimento dei rapporti personali basati sul mu-tuo riconoscimento delle proprie posizioni reci-proche e paritarie: in quest’ottica svanisce laconcezione di individuo libero rapportato a unaltro individuo libero, il cui interagire è dimen-sionato su riferimenti che, per forza di cose, con-templano l’equa e legittima esigibilità delle ri-spettive azioni. Ad essa si sostituisce la visione diun mondo incentrata su ben altre premesse, incui i legami intersubiettivi si connotano per deirequisiti affatto differenti: i nessi che avvinconoil liberto al suo patrono, il cliente al suo protet-tore, lo schiavo al suo padrone. “È da questi na-turali <<protettori>> che il singolo attende favo-ri, altrimenti dovuti (secondo le leggi vigenti), oelargizioni graziose, apprestandosi a ricambiarela grazia ricevuta con il comportamento di un<<fedele>> cliente (comportamento dal conte-nuto molto indeterminato). Chiunque voglia in-traprendere qualcosa nel Sud, deve tener contosempre di questo diffuso reticolo di omertà, e deirapporti personali di clientela che lo generano,fino ai limiti del delitto”(18). Va da sé, a questopunto, che le determinazioni, inerenti alla condi-zione e alla funzione individuale di tali elementinella sfera della vita associata, saranno viziate aborigine, inficiando così di netto l’essenza del loro
contenuto; in quanto, come abbiamo visto, essepresupporranno delle vere e proprie clausole ves-satorie nei confronti degli estranei al loro vinco-lo personale, di quanti, proprio per il fatto di es-sere estranei, possono potenziare al massimo leprerogative che discendono dall’aver inquadratola propria dinamica di relazione su un piano dilibera parità. Potenzialmente limitante e limita-to, il vincolo “cliente-protettore” si rivela inveceassai proficuo se è in grado di accaparrare le ri-sorse necessarie a preservare i suoi meccanismidi riproduzione, dallo sfruttamento indebito deiliberi (=estranei al vincolo) consenzienti(19). Equando i consenzienti, per un motivo o per l’al-tro sono la maggioranza…c’è poco da meravi-gliarsi della catastrofica situazione in cui nostromalgrado ci ritroviamo!
E’ sicuramente necessario intervenire per met-tere tutti coloro che lo desiderino nella condizio-ne di accedere, su basi paritarie, a relazioni socia-li stabilmente libere, nel rispetto delle peculiarimodalità di partecipazione di ognuno; ma è al-trettanto necessario opporsi a qualsiasi mira dicompressione-ablazione delle nostre rispettiveposizioni.
È però doveroso comprendere quanto sia eco-nomicamente controproducente, oltre che mo-ralmente disdicevole, rinunciare a dei diritti sa-crosanti, che riposano su delle modalità d’eserci-zio rispettose dei dettami di giustizia, per i qualisi è cooperato (spesso sul proprio territorio) allarealizzazione di condizioni favorevoli per unosviluppo efficiente delle utilità lecitamente trai-bili dagli stessi diritti, al fine di consentire ad al-tri, che si sono volontariamente sottratti e co-stantemente si sottraggono a quel contesto dicooperazione, il loro esercizio arbitrario e discre-zionale, secondo principi regolativi di certo nonconformi al paradigma di giustizia.
(17) G.Miglio, L’asino di Buridano, (Vicenza:Neri Pozza, 1999),pp. 37-38 (18) Ibidem, p.38(19) Pertinente, ancora una volta, risulta il riferimento a dueesplicativi “bozzetti” storici, esemplarmente evocativi dei de-plorevoli effetti ingenerati dal rapporto clientelare: “In segui-to all’esodo massiccio dalle campagne, nel Sud si era costitui-to un nuovo blocco sociale, non più fondato sulla proprietàfondiaria, ma urbano, e legato al controllo degli ingenti flussidi spesa pubblica, erogati dalla Cassa del Mezzogiorno, e vin-colati alla crescente espansione del settore terziario. Questonuovo blocco sociale, fondato su ceti medi urbani, improdut-tivi e parassitari, e legati al controllo politico della ripartizio-ne delle risorse distribuite dallo mano pubblica, realizza unnuovo sistema di potere: da una parte c’è una classe politicache ripartisce risorse finanziarie, e dall’altra c’è un elettorato
di massa, che ricompensa con il voto e la lealtà partitica i be-nefici ricevuti.” Ibidem, p.59“La pubblica amministrazione fu così invasa da legioni di lau-reati e diplomati e semplici studenti meridionali, che una vol-ta entrati nella cittadella aprirono le porte come uscieri, fatto-rini, archivisti, segretari e così via, a un esercito di parenti eamici, meridionalizzando irreversibilmente la burocrazia.Che da allora è diventata sinonimo di macchinosità, lentez-za, ritardi, complicazione, ossequio ai potenti e arroganzaverso i deboli, caratteristiche tipiche della maggior parte deipubblici impiegati, in quanto retaggio mediterraneo. Al taci-turno pragmatismo dei piemontesi si sostituì la ciarliera ne-ghittosità dei campani e dei romani, assidui pianificatori del-la <<pausa>>, elemento distintivo della mentalità meridio-nale.” Fabrizio di Ferdinando, “Burocrazia italiana 100 annidi inettitudine”, su La Padania del 07-10-99, p.11

26 - Quaderni Padani Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000
Alessandro Volta, settimo figlio del patriziocomense Filippo e di donna Maria Maddale-na dei Conti Inzaghi, nasce a Como nella
contrada di Porta Nuova, ora Via Volta 62, il 18febbraio 1745 e trascorre la prima infanzia aBrunate, nella casa dell’artigiano costruttore dibarometri Ludovico Monti, al numero 5 dell’at-tuale via Volta. La leggenda vuole che proprio aBrunate - sull’ameno colle che sovrasta comeun balcone fiorito la città di Como e il lago -Alessandro Volta accendesse le riflessioni per lescoperte future. Si suole narrare che il piccoloVolta amasse recarsi nella piazza del paese, lun-go le strade del borgo diBrunate, con baracca eburattini, un vero e pro-prio teatrino che amavaanimare per il diverti-mento suo e dei suoiamici, illuminandolo ecreando giochi d’ombracon la luce di una cande-la. Ma ecco che un gior-no, un violento tempora-le si abbatte, improvviso,su Brunate e sulla suapiazza, sulla baracca e suiburattini… La fiammadella candela sfugge alcontrollo del piccoloAlessandro e ahimè…, inbreve tempo poco restadel teatrino tanto amato.E se è vero, com’è vero,che tutta la vita è risolve-re problemi, ci piacciaconsiderare questo sem-plice aneddoto, fra leg-genda e realtà, un ele-mento che ci fa intrave-
dere la curiosità e lo spirito creativo che ani-mando la mente del giovane comasco, tanto lu-stro hanno dato alla città di Como e alla suaProvincia.
Le scienze naturali, come pure le scienze so-ciali, partono da problemi, da ciò che in qual-che modo suscita meraviglia. Le situazioni pro-blematiche, vale a dire l’emergere di un proble-ma in una determinata situazione del nostro sa-pere di sfondo, generano il metodo che il comu-ne buon senso utilizza: per successivi tentatividi soluzione del problema, si eliminano le solu-zioni false come erronee. In riferimento alle più
accreditate teorie scienti-fiche degli ultimi anni, ilprogresso scientifico nonè qualcosa di garantito apriori, ma qualcosa cherichiede l’atteggiamentoconsapevolmente criticonei confronti dei tentati-vi di soluzione e la parte-cipazione attiva alla falsi-ficazione delle congettu-re che sono state propo-ste, in una continua di-mostrazione della supe-riorità della teoria vinci-trice, ma non della suaverità. E, benché, ai tem-pi di Volta la comunitàscientifica fosse più “dog-matica” da un punto divista scientifico, e proba-bilmente fosse più tesa asalvare una teoria dallafalsificazione, Alessandroè sin da piccolo un inge-gno vivace e curioso.Rimasto precocemente
1799-1999: A Alessandro Volta,comasco, in occasione del bicentenario
dell’invenzione della piladi Giulia Caminada Lattuada
Il modellino della pila di Volta

Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000 Quaderni Padani - 27
orfano di padre, e in gravidifficoltà economiche, il gio-vane Volta è accolto con lamadre e tre sorelle dallo ziocanonico Alessandro, cheprovvede al loro manteni-mento e all’educazione delbimbo. A diciassette anniAlessandro Volta possiedeuna solida cultura umanisti-ca ma coltiva anche, da auto-didatta, gli studi scientifico-naturalistici, soprattuttoquelli che riguardano i feno-meni elettrici, con gran de-lusione dello zio che lo vor-rebbe avviato alla carrieraecclesiastica.
Nonostante i fermenti del-la rivoluzione scientifica delSeicento, la viva attenzionedegli studiosi e la curiositàche gli spettacoli degli “elet-trizzanti” destano nei salottie nelle fiere, nella secondametà del Settecento l’elettri-cità è considerata poco più diun gioco. Benché venganocostruiti apparecchi capaci diaccumulare grandi quantitàdi cariche elettriche, questistrumenti permettono effettidi brevissima durata. E Ales-sandro s’impone all’attenzio-ne degli studiosi nel 1769,quando invia al Beccaria unamemoria con la quale attaccala sua ipotesi di un’elettricità“recuperata” e sostiene chel’equilibrio elettrico è determinato dalla satura-zione delle forze attrattive. È l’inizio delle futuree straordinarie applicazioni. Nel 1774, il gover-natore Firmian, rappresentante lombardo delgoverno di Maria Teresa d’Austria, nomina Ales-sandro Volta soprintendente reggente alle RegieScuole di Como e nel 1775, Alessandro Volta co-struisce una semplicissima macchina elettrosta-tica, che egli chiama elettroforo perpetuo per-ché, per influenza, una volta elettrizzata nonperde più la carica e permette di produrre cari-che elettriche senza strofinio continuo. L’inven-zione ha grande risonanza nel mondo scientificoe il Conte Firmian premia Alessandro Volta “perla superba e utilissima scoperta” nominandolo,
senza concorso e senza laurea, professore stabiledi fisica sperimentale al Regio Ginnasio di Co-mo. Nel 1777 costruisce la pistola elettrico-ae-rea-infiammabile, lampade perpetue, moschettie archibugi per la caccia, un ingegnoso accendi-lume elettrico e nel 1779, come trasformazionedella sua pistola, l’eudiometro, un apparecchiodi grande precisione ancora oggi usato per l’ana-lisi dei gas infiammabili e della purezza dell’aria.
Le utili applicazioni cercate dal suo spiritopratico, non sfuggono all’attenzione del ConteFirmian che nel 1778 nomina il Volta professoredi fisica sperimentale all’Università di Pavia, pre-miando la sua attività autorizzando, con un ge-neroso sussidio, viaggi a scopo scientifico attra-
L’opuscolo informativo edito dall’APT del Comasco in occasionedell’anno voltiano

verso la Svizzera, l’Alsazia, la Savoia, la Germa-nia, il Belgio, l’Olanda, la Francia, l’Inghilterra,l’Austria, la Cecoslovacchia. Nel frattempo, Vol-ta continua le sue ricerche e l’insegnamentopresso l’Università. Nel 1780 studia il fenomenodella condensazione elettrica, realizzando ilcondensatore, un dispositivo atto a registrareanche quelle tracce minime di elettricità chesfuggono ai comuni elettroscopi e con una ca-pacità elettrica assai maggiore di un normaleconduttore. Nel 1785 Alessandro Volta, elettoRettore Magnifico dagli studenti pavesi, accre-sce il prestigio e la fama dell’Università chia-mando all’insegnamento valenti docenti, am-pliando le aule e acquistando nuovi preziosistrumenti scientifici. Le sue ricerche si esten-dono anche al campo della metrologia e dellameteorologia elettrica.
Nel 1789 i venti di rivolta che la severa vigi-lanza austriaca non può impedire di far circola-re, raccontano in Lombardia che a Parigi il po-polo ha preso la Bastiglia e che l’Assemblea Na-zionale ha abolito i diritti feudali. Sono in attocambiamenti politico-economici, tecnico-scien-tifici e sociali rivoluzionari che, più o meno si-lenziosamente, cambieranno il mondo. Neglianni compresi tra il 1786 e il 1791, il medicobolognese Luigi Galvani, professore di anatomiaall’Università di Bologna, effettua esperimentidi conduzione elettrica su rane morte e scorti-cate. Alessandro Volta, che è uno dei suoi primisostenitori, ripete gli esperimenti che aprirannola famosa disputa che divide il mondo scientifi-co in galvaniani e voltiani e che vedranno l’ini-zio di una lunga serie di esperimenti che dimo-streranno con i fatti l’esattezza delle teorie vol-tiane. In Francia gli avvenimenti precipitano enel maggio del 1796 i Francesi entrano in Co-mo dopo aver sconfitto gli Austriaci a Lodi e do-ve - a parte una breve parentesi di tredici mesitra il 1799 e il 1800 - vi resteranno fino alla di-sfatta napoleonica del 1814, con il successivo ri-torno degli Austriaci e la successiva proclama-zione del Regno Lombardo-Veneto, aggregatoall’Impero austro-ungarico. Alessandro Volta eGiambattista Giovio, in qualità di Decurionicomponenti il Consiglio Generale di Como, so-no incaricati, nel 1796, di recarsi a Milano, inrappresentanza della città, per rendere omaggioal generale Bonaparte che ha occupato la Lom-bardia e da cui ora dipende la riapertura dell’U-niversità e il futuro della popolazione. Le nuoveidee libertarie circolano già da qualche tempopromosse, soprattutto, dall’ambiente universi-
tario pavese, che molti giovani comaschi aveva-no frequentato e con il quale erano in contatto.La minoranza giacobina sperava in un rinnova-mento che portasse alla costituzione di uno sta-to unitario, ma il popolo era di un altro parere,soprattutto dopo aver visto gli scempi operatidall’esercito francese. Il Bonaparte riapre l’Uni-versità e trasforma le repubbliche Cispadana eTranspadana, liberamente costituite dai giacobi-ni italiani, in uno stato satellite della Francia, laRepubblica Cisalpina, a scapito dell’individua-lità amministrativa del territorio comasco, cheè ora suddiviso secondo nuovi schemi.
Nonostante le difficoltà economiche, legatealle continue guerre e all’aumento della fami-glia per la nascita del terzo figlio, Volta conti-nua gli esperimenti sui cui risultati si fonderàla moderna civiltà tecnologica e che in una gri-gia giornata di dicembre, nel 1799, lo porteran-no alla scoperta della pila, “l’organo elettricoartificiale”, come la chiama l’inventore. La noti-zia suscita entusiasmo e ammirazione in tuttoil mondo scientifico del tempo poiché, la pila,oltre a generare un flusso continuo e regolaredi corrente elettrica, apre orizzonti di ricerca dienorme importanza nel campo della fisica. Na-poleone, che nel giugno del 1800 ha rioccupatola Lombardia e ripristinato la Repubblica Cisal-pina - trasformata nel 1805, dopo la sua nominaad imperatore, in Regno Italico -, colma il fisicocomasco di onori, così come Francesco I, chedopo la caduta di Napoleone riprende possessodella Lombardia.
Dopo l’invenzione della pila, Alessandro Voltacontinua la sua vita operosa di scienziato e dicittadino esemplare. Nel novembre del 1801,Alessandro Volta trovandosi a Parigi dove ricevel’omaggio di lode di Napoleone, così scrive allamoglie: <<In mezzo a tante cose che devonocerto farmi piacere, e che sono fin troppo lusin-ghiere, io non m’invanisco a segno di credermidi più di quel che sono, ed alla vita agitata dauna vana gloria preferisco la tranquillità e dol-cezza della vita domestica>>. Di lui si ricorda-no la modestia, l’intensa vita religiosa, la gran-de disponibilità e l’alto senso civico e morale.Tra i suoi meriti è da ricordare anche l’introdu-zione e la diffusione in Lombardia della colturadella patata. Come ha detto Einstein, giunto nelsettembre del 1933 in visita al Tempio Voltiano,<<La pila è la base fondamentale di tutte le in-venzioni>>. In onore di Alessandro Volta, co-masco, l’unità di forza elettromotrice è statachiamata Volt.
28 - Quaderni Padani Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000

“Dopo la caduta dell’impero romano, Ticinum,come Verona fu scelta dagli Ostrogoti come se-conda capitale dopo Ravenna. L’importanza diTicinum si accrebbe durante la guerra gotica.Dopo la caduta di Ravenna (540), la città ospitòil comando dell’esercito, una zecca, e qui ven-nero eletti i re(1).”
Perché Pavia capitale di regnoDalla seconda metà del V secolo, distrutte Mila-
no e Aquileia dagli Unni di Attila, rimanevano so-lo Verona e Pavia come unici centri urbani dotatidi difese credibili. Queste due città furono fondatedai Romani in età repubblicana nelle immediatevicinanze di precedenti insediamenti celtici e sitrovano situate nei punti nevralgici della regionecisalpina, in prossimità di grandi fiumi navigabili,di arterie stradali e in zone di confine di più po-polazioni locali: nel caso di Pavia a nord c’erano
gli Insubri, ad est i Cenomani, ad ovest i Liguri, asud i Boi. L’importanza di questi due centri naticome capisaldi e avamposti di natura sia militareche commerciale rimarrà inalterata nei secoli.Pavia si trova in riva al Ticino e a poca distanzadalla confluenza di questo fiume con il grandePo, nella direzione opposta, verso nord, la città diMilano non dista più di 40 km.
Le contenute dimensioni della città la rendeva-no facilmente difendibile e forse per questo mo-tivo fu scelta come caposaldo militare da parte dipopoli e di eserciti limitati nel numero. Risultavaquindi preferibile rispetto a grandi centri comeMilano dove la lunghezza delle mura rendeva dif-ficile una efficace difesa e dove la massiccia pre-senza della popolazione autoctona poteva creareseri problemi in caso di insurrezione, come èsuccesso nel 538 quando i Milanesi, aizzati dalloro vescovo Dazio, si ribellarono e scacciarono iGoti (l’anno seguente, per vendicare tale insurre-zione, un esercito capeggiato dal goto Uraia di-strusse la città).
Con Teodorico, Pavia venne trasformata in unodei cardini amministrativo militari del suo re-gno, insieme a Ravenna e a Verona. Il re dei Gotiripristina mura e acquedotti e fa costruire un pa-latium, come del resto farà nelle altre due città.In effetti, con il trasferimento della capitale im-periale da Milano a Ravenna nel 401, Pavia rima-ne l’unico valido caposaldo posto trans-padum.Tra l’altro, dopo la morte di Teodorico vi fu elettol’ultimo re dei Goti.
L’importanza strategica di Pavia venne confer-mata anche in seguito. Durante l’invasione dei
Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000 Quaderni Padani - 29
Appunti e considerazionia proposito del Palazzo Reale di Pavia,prima sede stabile - in tutta l’Europa -
di un potere di stampo occidentaledi Mario Gatto
(1) P. Hudson, Archeologia urbana e programmazione dellaricerca: l’esempio di Pavia. 1981, pag. 23

Longobardi è l’unica città che offre una qualcheresistenza ad Alboino, arrendendosi - ci informaPaolo Diacono (sicuramente esagerando) - solodopo tre anni di assedio.
Con i Longobardi Pavia diventa la prima sedestabile di un regno occidentale: assurgerà a que-sto ruolo dopo la morte del re longobardo Agi-lulfo (dal 616) diventando l’unica capitale di re-gno con Ariowaldo nel 626. A facilitare questascelta è stata la presenza del palatium costruitoda Teodorico e che al tempo di Ariowaldo avevapiù d’un secolo di vita.Pavia rimase capitale am-ministrativa della regione padana per diversi se-coli anche dopo la caduta del regno longobardosotto le successive dominazioni dei Franchi, deiSassoni e degli Svevi, senza peraltro perdere ilproprio carattere culturale lombardo acquisitonel corso del VII e VIII secolo.
Stanchi delle angherie cui erano sottoposti daparte degli imperatori tedeschi, i Pavesi (nel1024) distruggono completamente il palazzo di-venuto simbolo non più del cuore di un regnoautonomo ma della oppressione amministrativae fiscale di poteri stranieri.
È da ritenere che con la distruzione del Palaz-zo Reale di Pavia si sia intrapreso uno dei primiimportanti passi verso la stagione delle libertàcomunali e possiamo paragonare quel processoa una benefica metastasi: lentamente ma ineso-rabilmente nelle lande padane stava crescendola volontà di autogovernarsi.
Nei secoli seguenti, nelle città di tutta la Pada-nia, iniziano a sorgere i palazzi della Ragione odei Signori, all’interno dei quali i cittadini, riuni-ti in consigli, amministravano la cosa pubblica.
Dove si trovava il Palazzo Reale?“In questi giorni il re Perctarit costruì nella
città di Ticino la bellissima porta vicina al pa-lazzo, che è chiamata Palazzese(2).”
Da questa e da altre testimonianze storichesappiamo che il palazzo era situato in prossimitàdella Porta Palacense, nella parte orientale dellacittà, purtroppo però non sappiamo con preci-sione il luogo esatto e gli stessi studiosi che sisono dedicati all’individuazione del sito hannoopinioni divergenti in proposito. Qualcuno lo ri-tiene ubicato a sud di Corso Mazzini tra le vieMorazzone e Porta(3). Qualcun altro invece loposiziona nell’area compresa tra il Liceo UgoFoscolo e l’attuale Municipio(4).
Personalmente io propendo per la secondaipotesi, e ne spiego il motivo. Nel corso delle ri-cerche si è notato che in certe città (fortificatetra V e VI secolo) di notevole importanza strate-gica durante tutto l’altomedioevo il complessopalaziale era ubicato in prossimità della portaorientale e a destra della porta stessa, rispetto achi entra.
Delle precise esigenze, di ordine più militareche amministrativo, devono aver motivato que-ste scelte. Troviamo questa dislocazione, oltre
30 - Quaderni Padani Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000
(2) Paolo Diacono, Storia dei Longobardi, a cura di Lidia Ca-po, Milano 1995, V, 36-38, pag. 285(3) “...in corrispondenza dell’isolato compreso tra le attualivie Morazzone e Porta.” in A. Arecchi, Attila e Teodorico, Pa-via 1997, pag. 61 e piantine a pag. 34(4) “..., e che il palazzo fosse situato nel quartiere nord-orientale, presso l’attuale Municipio.” in P. Hudson, Archeo-logia urbana e programmazione della ricerca: l’esempio diPavia, Firenze 1981, pag. 24

che in Pavia, a Verona, a Cividale, e molto pro-babilmente a Treviso. Queste sono, in definitiva,le più importanti città del dispositivo difensivocreato per fermare le frequenti invasioni prove-nienti da est: i facili valichi del basso Isonzo rap-presentavano la via più comoda e diretta perraggiungere le regioni padane.
Dalla posizione dei palazzi sia rispetto allacittà che rispetto alla porta orientale si evinceche la preoccupazione maggiore di chi li ha co-struiti era rivolta all’organizzazione della difesadel centro abitato stesso. Quindi erano in prossi-mità delle mura per effettuare una difesa imme-diata a ridosso della porta e da una posizione divantaggio strategico nel caso si fosse resa neces-saria un’azione di contenimento.
Nel caso di Pavia (e di tutte le altre città sovra-menzionate) va rilevata la posizione più elevatain cui era posto il palazzo rispetto alla porta, persfruttare, in caso d’attacco, il vantaggio offertodal leggero pendio.
Una prospettiva possibileL’individuazione, e la relativa valorizzazione,
dei resti archeologici del Palazzo Reale può sicu-ramente contribuire a un rilancio culturale diPavia.
Naturalmente non si può pensare di ricostrui-re il palazzo ov’era com’era, ma si potrebbe se-guire l’esempio di quanto è stato fatto a Pader-born. Nella città vestfalica, una volta scoperte eposte in luce le fondamenta del palazzo, hannopensato di preservarle e nello stesso tempo direnderle visibili al pubblico costruendovi sopraun museo. Così al piano terra si possono visita-re i resti archeologici dell’antico edificio men-tre al piano superiore ne viene illustrata la sto-ria attraverso l’esposizione di modelli ricostrut-tivi e dei reperti archeologici ritrovati durantegli scavi.
Per realizzare un progetto di tal genere moltodipende dalla volontà delle amministrazionipubbliche e degli stessi cittadini di Pavia. I fondinon mancano, la Lombardia invia una caterva disoldi a Roma e gli abitanti dei sette colli (e din-torni) sanno benissimo come utilizzare i nostrisoldi, difatti il centro storico romano è da sem-pre tutto un cantiere: scavi archeologici, restau-ri, consolidamenti e abbellimenti sono in corsoda anni. È davvero impossibile trattenere in locouna parte di quella valanga di soldi e utilizzarliper valorizzare le nostre città?
Durante l’altomedioevo il Palazzo di Pavia harappresentato fisicamente il benessere e la pro-sperità della città, è stato poi distrutto quandoesso era oramai diventato il simbolo della op-pressione fiscale esercitata dagli imperatori ger-manici.
Oggi, andrebbe senz’altro riscoperto per far ri-nascere la città dal punto di vista culturale eidentitario.
Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000 Quaderni Padani - 31

Adagiata tra le colline di Mondovì (CN), lachiesa di San Fiorenzo a Bastia è deposita-ria di una tradizione artistica che resiste
agli assalti del tempo, offrendoci un’immaginedi grande valore storico. Il tesoro pittorico diBastia, circa 326 mq di affresco, può essere col-locato in quel segmento dell’arte cosiddetta “mi-nore”: una realtà povera forse, ma autentica ericca di vissuto (1).
In questa nota ci soffermeremo solo su unaparte del ciclo pittorico di San Fiorenzo, nonperché l’intero complesso sia privo di interesse,ma per il fatto che la rappresentazione dell’aldilà
(in particolare l’Inferno) ci permette di mettere afuoco alcune prerogative culturali tipiche dellareligiosità popolare tardo medievale.
L’humus sul quale si consolidò il “messaggio”pittorico di Bastia, ebbe origine prevalentementenella simbiosi di esperienze culturali diverse, incui confluirono tendenze orientate verso la for-mazione di un linguaggio artistico sostanzial-mente didascalico.
La cultura ecclesiastica, con la sua funzionecatechistica rivolta in special modo al popolo, lacultura Scolastica accessibile ai dotti, la culturacavalleresca con le sue prerogative laiche orien-tate nella maggioranza dei casi al totale disimpe-gno intellettuale, spesso convivono a stretto con-tatto nella dimensione pittorica della chiesetta diBastia. Nella mescolanza di queste tendenze, ilRaineri scorge appunto la struttura portantedella cultura in cui fiorì il corpus pittorico diSan Fiorenzo, aderente quindi a modi e stili tipi-ci dell’arte rintracciabile sui due versanti alpini.
Le maniere e i modelli iconografici di quest’ar-te “subirono l’influenza grandissima della diffu-sione che ebbe proprio nel sec.XIV l’arte dellaminiatura, dell’arazzo e l’internazionalità dellamoda francese, specialmente provenzale, stretta-mente legata alla cultura dei troubadours.
L’evoluzione dei temi e delle forme nelle no-stre terre è legata a quella della lingua d’Oc, e fasì che l’uso dei volgari affinati da esperienze tec-niche e dall’ambiente clericale, diventi uno stru-
32 - Quaderni Padani Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000
L’inferno popolare di Bastiadi Massimo Centini
(1) Sull’argomento, oltre alla monografia di A. Griseri - G.Raineri, San Fiorenzo in Bastia Mondovì, Bastia 1975, è utilela consultazione di altri studi apparsi su riviste locali: L. Ber-ra, “L’inferno pittorico di S. Fiorenzo di Bastia”, in Cuneoprovincia granda, n.3, 1956; L. Berra, S. Fiorenzo di Bastia,Mondovì 1914; L. Berra, “S. Fiorenzo di Bastia”, in BollettinoS.S.S.A.A. della provincia di Cuneo, n.11, 1934; C. G. Chicco,La chiesa di S. Fiorenzo di Bastia, Cuneo 1887; G. Raineri,“Antichi affreschi del Monregalese”, in Boll. S.S.S.A.A. dellaprovincia di Cuneo, n.53, 1965; G. Raineri, Affreschi del XVsecolo nel Monregalese in “Boll.S.S.S.A.A. della provincia diCuneo”, n.54, 1966; G. Raineri, “Gli affreschi di S. Fiorenzodi Bastia e la pittura rurale gotica nel Monregalese”, in Boll.S.S.S.A.A. della provincia di Cuneo, n.65, 1971.
Incisioni tratte dal Iudicio de la fine del mon-do

mento idoneo all’espressione di un’arte maturaed elevata” (2).
L’autore degli affreschi di San Fiorenzo ebbequindi modo di cogliere questa tendenza cultura-le “europea”, rifacendosi alla pittura gotica fran-cese, senza peraltro perdere il vigore della suaspontaneità poetica e una certa rozzezza dialetticacaratteristica del suo mondo naif. Dalla maggio-ranza degli storici che si sono avvicinati a Bastia,l’autore degli affreschi è riconosciuto in GiovanniMazzucco, un artista certamente non straordina-rio, ma ricco di una notevole inventiva e di unabuona capacità costruttiva sul piano pittorico, cheoperò nel Monregalese nella seconda metà del XVsecolo. Giovanni Mazzucco, dopo attenti raffronti,è risultato un pittore “locale” con una sua “botte-ga, non di scuola, in Mondovì nella seconda metàdel secolo XV, dipingendo a braccio nell’ampiadizione politica e amministrativa monregalese enella periferia, che mantenevano da un paio di se-coli assidui rapporti economici e culturali con laProvenza e col Delfinato. Per queste relazioni pe-netrò fra noi l’Arte francese lungo le strade dei va-lichi alpini, come penetrò nel Saluzzese e nel Pi-nerolese, che con la Francia ebbero anche rappor-ti politici più a lungo di Mondovì” (3).
Lo stile del Mazzucco è popolare; in esso è evi-dente quella “infantile” esaltazione contenutisticadelle prime istanze laiche, che si affianca ad unasempre nitida funzione didascalico-moralistica,
tipica di una ricostruzione pittorica di matriceeccelsiastica diretta al popolo (4).
In Bastia troviamo quindi una base iconograficache affonda le proprie radici espressive in unacontinua ricerca di uno o più elementi, in gradodi suscitare l’attenzione del fruitore. Quasi comein un grande exultet, o come nelle cartelle di uncantastorie, il ciclo pittorico di San Francescosvolgeva una funzione prevalentemente illustrati-va, quindi non risentiva di quelle istanze esteticheche invece erano il fulcro principale di una certaarte “colta” del periodo. Entrando in San France-sco, si ha la sensazione di trovarsi al centro di unascenografia medievale; il testo pittorico, come ac-cadeva per il testo teatrale, si espande senza solu-zione di continuità: il presbiterio, le pareti e gliarchi erano simili a tante mansiones poste intor-no ai fedeli-pubblico. Le parole del sacerdote, co-me i gesti dell’attore, si fondevano nello spazioreale-immaginario delle varie cartelle dell’affre-sco, evidenziando i punti principali e accentuandoil proprio potere didascalico nella forza rappre-sentativa dell’icona. Si veniva così a creare una di-mensione scenica che come nelle rappresentazio-ni teatrali non risentiva di imposizioni e di limita-zioni vincolate alla narrazione, ma si concretizza-va negli spazi mentali dei fruitori, che si allinea-vano alle condizioni imposte dal testo (5).
In quest’ottica, gli affreschi di Bastia non van-no letti come una cellula isolata, ma come parte
Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000 Quaderni Padani - 33
(2) G. Raineri, “Arte cristiana medievale sui diversi versantidelle Alpi”, in Boll. S.S.S.A.A. della provincia di Cuneo, n. 87,1982, pag. 49.(3) L. Berra, Op. Cit., 1956, pag.31; l’autore nel corso delle suericerche sulla figura del Muzzucco e dei suoi “emuli coevi” haavuto modo di constatare che la pittura di questi artisti fu es-senzialmente popolare, “nettamente distinta dalla pittura au-lica di scuola, l’una adornava tabernacoli ed oratori campestri,qualche volta cappellette di castelli e chiese di confraternite,mirando sopra tutto ad uno scopo educativo e morale, a com-muovere e persuadere; l’altra rideva sulle tavole e sulle teledelle chiese ricche, sugli altari patronali dei nobili, nelle aulecapitolari, nelle sale rabescate dei signori, morendo prima dievolversi; la seconda deve invece avere seguito il processo evo-lutivo dell’Arte e nella libera e fiorente Mondovì deve aver re-cato assai più degli echi della pittura italiana” (Op. Cit., 1956,pag.31-32). Una definizione sintetica ma particolarmente niti-da, che offre una chiara testimonianza della cultura in cui gliartisti minori operavano, all’interno di piccole comunità agro-pastorali. Il loro apporto culturale fu quindi fondamentale, inparticolare nei casi (come per il Mazzucco) in cui il pittore ri-sultava condizionato da tradizioni e da mode d’oltralpe. LaGriseri non scarta neppure l’ipotesi che a Bastia avessero ope-rato i fratelli Tommaso e Matteo Biazaci (Biasacci) attivi nelCuneese e in Liguria. Nella chiesa di San Bernardino nei pres-si di Albenga, nel 1483, affrescarono un giudizio universaleche potrebbe anche essere correlato a quello di Bastia, visti al-
cuni dei suoi aspetti iconografici. L’invezione pittorica ha neltema dell’inferno e delle pene una particolare espressività dia-lettica, in cui ritornano ostentatamente alcuni motivi dram-matici caratteristici delle raffigurazioni infernali, in cui i pec-catori sono travolti dai tormenti più terribili.(4) Per una valutazione dei rapporti “locali” tra gli affreschi diSan Fiorenzo e l’arte coeva: G. Raineri, Op. Cit., 1971.(5) Nel teatro medievale, quando lo spazio non era sufficientea garantire una lineare ricostruzione scenica, lo spettatore do-veva sapersi adattare alle mutazioni rappresentative, sintetiz-zando le carenze della narrazione. “Vigeva poi la convenzioneper cui, nel corso di una rappresentazione, gli spettatori dove-vano dimenticare tutte le altre mansions eccetto quella cui siriferiva l’azione presentata in quel momento: se la mansionera troppo angusta per poter accogliere effettivamente tuttigli attori che prendevano parte alla scena, e quindi alcuni do-vevano prender posto per terra davanti alla mansion, allora ilpubblico doveva immaginare che questa zona di terreno fosseuna parte della mansion stessa (...) d’altro canto, se un attoredoveva compiere un viaggio immaginario da una mansion al-l’altra, il terreno su cui poggiava i piedi si immaginava cherappresentasse, in scala ridotta, lo spazio tra due luoghi im-maginari lontanissimi. Così, ad esempio, nell’Adam, i diavoliche sbucano dall’Inferno corrono in giro per plates (cioè sullapiazza) prima di avvicinarsi al Paradiso per tentare Eva. Laplatea era, in altre parole dovunque”, A. Nicoll, Lo spazio sce-nico. Storia dell’arte teatrale, Roma 1966, pag.63.

di un organismo vivente, che trovava la propriaarea vitale nella carica emotiva contenuta nellospazio semantico della ricostruzione scenica (6).
Questo organismo si estendeva in una stratifi-cazione culturale tipicamente popolare, e avevala funzione di oggettivare la fede di un “pubbli-co” che richiedeva una continua verifica del mes-saggio cristiano. Il tutto estrinsecabile attraversoun linguaggio provvisto di una segnica di fortevalenza dialettica, alimentata dal patrimonio cul-turale dei narratori.
Nel testo pittorico di San Fiorenzo è quindi in-negabile un legame con la matrice teatrale, lega-me che è già stato brillantemente evidenziato daAndreina Griseri: “come nel teatro medievale enelle sacre rappresentazioni, il racconto procedea Bastia per azioni, gestite da personaggi nume-rosi: il santo protagonista, nella Storie di SanFiorenzo, o il Cristo in quelle della Passione, so-mo collocati al centro di gruppi con senso conti-nuo e legamenti d’uso nei retabili gotici, dove sierano scelte pittura e scultura; qui si impiegal’affresco, meno costoso e di tanto più facile re-dazione” (7).
L’intento del pittore, probabilmente in accor-do con la committenza, fu quello di creare unasintesi descrittiva in grado di suscitare stuporee, attraverso una sorta di propaganda spirituale,avvicinare le genti ad un mondo oltre il mondo:un universo ancora relegato alle interpretazioniverbali e letterarie. L’intento moralistico si èservito di una pittura semplice, che ha la stessaentità della preghiera, già nota nei laudari me-dievali.
Continuamente tormentato dalle carestie edalle malattie, il popolo trovava nella chiesal’occasione per tonificare lo spirito e per imma-ginare, su un piano antropologicamente defini-bile, il premio e la punizione finali. La pitturarievoca modelli escatologici popolari, trasfor-mandosi in discorso con la collettività che siserve senza riserve di archetipi comuni, rinvi-goriti dalla multisignificanza di una segnica ca-pace di andare a stimolare la radice delle ance-strali paure del gruppo.
Il testo di Bastia propone una dimensione doveil pittore e gli stessi fruitori si trovano inseriti inuna sola realtà, in cui le specifiche regole seman-tiche dell’iconografia sono sollecitate attraversototalità fortemente didascaliche: supporto lingui-sticamente attivo, che si ripete, si esaspera nelquasi fragoroso rincorrersi delle figure.
In genere, il complesso pittorico di Bastia, inparticolare la raffigurazione dell’aldilà, può esse-
re collocato nel filone della pittura contadina,fortemente moraleggiante, in cui prevale unastruttura pedagogica atta a narrare, senza mezzitoni figurativi, alcuni aspetti catechistici in tuttala loro essenza dialettica, pur nella crudezza dellinguaggio.
Fin dal principio, la critica non ha assegnatoagli affreschi di Bastia una collocazione aulica,riconoscendo in essi una tradizione artistica mi-nore, il che però, secondo il nostro punto di vi-sta, non dovrebbe condizionarne la valenza cul-turale: “affreschi rappresentanti il Paradiso sottocui sono raffigurate le opere di carità e l’infernosotto cui è raffigurata la cavalcata dei vizi; storiedella vita di Cristo, di S.Fiorenzo e di S. AntonioAbate. La data del 1472, inscritta sotto le storiedi S.Antonio, può riferirsi anche agli altri affre-schi, che sono opera della stessa mano, di fattu-ra scadente, ma d’iconografia interessante. Peraltri esempi della raffigurazione delle opere dicarità e della cavalcata dei vizi cfr. anche gli af-freschi di Giaglione, Liverogne, Melezet, Sala-bertrand, Villafranca Sabauda” (8).
Più recentemente, il Raineri ha studiato conattenzione il complesso pittorico di Bastia, po-nendolo in una dimensione culturale certamen-te meno anonima, in cui svolgeva un compitodialettico di grande importanza: “i primi chehanno osservato queste pitture, a mio avviso, lehanno contrapposte al grande patrimonio delgotico italiano, fiorito nel trecento e perciò, an-che per il ritardo di quasi un secolo, le hannoconsiderate rozze e povere, e in ritardo dovuto auna forma di arretratezza. Già il Cavallari Mu-rat aveva levato una voce contro questa valuta-zione e pertanto questo sfasamento di quasicento anni, va inteso, non come deficienza dicultura, ma come un rifiuto o almeno una certareticenza ad accettare le maniere rinascimenta-li, già rigogliose nel 1400 in altre regioni. Que-sto attaccamento a modi e maniere più confa-centi coi principi e i sentimenti delle nostregenti, si è protratto oltre il sec. XV, ed ha quasiassorbito in un tardo gotico i pochi documentirinascimentali “ (9).
Come detto, nel corpus pittorico di Bastia è si-
34 - Quaderni Padani Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000
(6) Cfr. L. Birolli, “Il formarsi di un dialetto pittorico nellaregione ligure-piemontese”, in Boll. Soc.Piem. di Arch. eBelle Arti, Torino 1966.(7) A. Griseri - G.Raineri, Op. Cit., pag.14.(8) A. M. Brizio, La pittura in Piemonte dall’Età Romanicaal Cinquecento, Torino 1942, pag.45.(9) G. Raineri, Op. Cit., 1971, pag.34.

curamente la raffigurazione dell’Inferno ad of-frire allo studioso e al visitatore l’opportunitàper meglio definire il rapporto tra i fedeli e l’i-dea delle pene dell’oltretomba, così come si eraaffermata nella cultura rurale del XV secolo.
Nell’affresco della chiesa di San Francesco èevidente una ricostruzione piana dell’Inferno,quasi scandita scenograficamente, che recuperala tradizioni iconografiche e le esperienze folk-loriche medievali (10).
La pene rappresentate sembrano però quasiun preludio ai tormenti, forse scanditi gerarchi-camente, posti oltre le insaziabili fauci, peren-nemente spalancate, del mostro. Rettile che quisvolge il ruolo di accesso alla cavità degli inferi,secondo un modello simbolico tipico della sacrarappresentazione (11).
Analoghi riferimenti sono rintracciabili nel-l’arte medievale, dalla miniatura alla scultura,in cui sostanzialmente il drago-inghiottitoreera interpretato come accesso all’inferno, svol-gendo quindi un favorevole ruolo di sintesi dia-lettica.
Un’importante indicazione di quanto sia con-
dizionate una certa iconografia diabolica, cigiunge dal de Lancre, che nel suo Tableau desmauvais anges (1613), riportando le afferma-zioni di una tredicenne accusato di stregoneria,Marie d’Aguerre, propone una dimensione delsabba certamente influenzata dalla tradizionepittorica medievale: “depose che nelle suddetteassemblee vi era una grande bocca in mezzo alsabba dove esce il diavolo, in forma di capro e,uscendo, diviene di grandezza spaventoso e, fi-nito il sabba, rientra nella bocca”.
La raffigurazione dell’Inferno è un crescendodi terribili ricostruzioni, in cui i riferimenti aiMystères (12) francesi e ad una certa iconografiaraccolta in modesti libretti che circolavano confrequenza durante il XV secolo, sono un ele-mento di verifica che non può assolutamenteessere ignorato. Ne è testimonianza anche ilLucifero trifronte posto al centro dell’affresco;tutto intorno, una moltitudine di diavoli impe-gnati a sottoporre i condannati a tremende tor-ture.
Il Berra, soffermandosi sul Lucifero di SanFiorenzo, osserva che “risale a quella stessa fon-
Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000 Quaderni Padani - 35
(10) Cfr. J. Le Goff, La nascita del Purgatorio, Torino 1982;Aspetti eruditi e popolari dei viaggi nell’aldilà nel medioevo,in L’immaginario medievale, Bari 1988; C. Kappler, Demoni,mostri e meraviglie alla fine del medioevo, Firenze 1983. Laconvinzione che l’aldilà fosse diviso in più dimore sopravvis-se nella trattatistica cristiana fino alla sistemazione del con-cetto di Purgatorio (fine XIII secolo). Il versetto di Giovanni“nella casa di mio padre vi sono molte dimore” (14,2), cheebbe un ruolo fondamentale nelle rappresentazioni topogra-fiche dell’aldilà “aveva già ispirato il IV Libro di Ezra (messoinsieme, raccogliendo diversi frammenti, nel 120 d.C.): quisi parla di una plurarità di dimore (habitationes o habitacu-la) nelle quali sono ospitate le anime dei giusti, divise a lorovolta in sette ordini (ordines). La partizione è ripresa da Am-brogio (che pure considera Ezra un filosofo pagano) e persua via penetra di forza nella letteratura più propriamentecristiana: egli identifica infatti gli habitacula con le mansio-nes del Vangelo”, V. Dornetti, Il diavolo in pulpito. Spettri edemoni nelle prediche medievali, Milano 1991, pag. 135. Laconcezione dell’inferno abitato dai diavoli, manipolatori delfuoco e tormentatori, sembrerebbe essere penetrata nellatradizione religiosa europea attraverso le visioni e le narra-zioni dei monaci irlandesi: ebbero un ruolo fortemente con-dizionante opere come la Navigatio Sancti Brandani, la Visode Tungdal, il Purgatorio di San Patrizio.Ma già nel IV secolo era diffuso in oriente l’apocrifo La Visio-ne di San Paolo, tradotto in latino nell’ VIII secolo e lenta-mente diffusosi anche in occidente.(11) Il drago si propone come una raffigurazione concreta delcaos inconscio atavicamente deposto nella nostra psiche, at-traverso un apparato multisimbolico. Che sia l’eterno casti-gatore dell’Apocalisse o il grande rettile un po’ naif capace disputare fiamme dalle fauci, è la rappresentazione della be-stialità priva di ogni legame con l’umano: il male primitivo,
che ha conservato nella propria struttura antidiluviana, l’e-nergia in cui sono contenuti i quattro elementi principalidella vita: acqua, terra, aria e fuoco.Va aggiunto che nella tradizione artistica medievale, l’in-gresso dell’inferno era frequentemente raffigurato da unabocca spalancata di drago. Segno che l’orrenda creatura mo-struosa non aveva ancora perduto la sua quasi biologica con-nessione con il mondo dell’ombra e dei demoni. Il Leviatàn,serpente fuggente, il Leviatàn serpente tortuoso (Is, 27,1), oRahab (Sl 87,4) era un mostro che aveva il proprio archetiponella tradizione mitologica canaanita (Gb 3,8). Tra i più anti-chi riferimenti al drago vanno segnalati quelli provenientidagli scritti hittiti (2000-1600 a.C.), a cui si connettono lenumerose tradizioni della Mesopotamia. Dalla biblioteca ba-bilonese di Ashurbanipal, proviene la leggenda della dea Tia-mat, creatrice di draghi terribili che terrorizzavano le gentidel Vicino Oriente.L’essere mostruoso è quindi concreta conferma dell’immor-talità del male primigenio, da sempre in lotta con il rappre-sentante del bene. Mentre sul piano mitico, il difensore delbene è identificato nell’eroe, su quello cristiano il compitorisulta assolto dall’angelo liberatore o dal santo, ad esempiodal ben noto San Giorgio. Nella tradizione popolare, il com-battimento con il drago è il momento culminante, il dia-framma che l’eroe positivo deve infrangere e superare per fa-re in modo che il bene sia trionfante.(12) Con Mystères generalmente si intendono le rappresenta-zioni teatrali medievali che rimanevano tendenzialmenteancora legati ai temi biblici, se pur “la loro gamma era estre-mamente più ampia e il dialogo avveniva ora nei dialetti co-muni di ciascun luogo. Nacquero così le raccolte informi didrammi conosciuti col nome comune di miracles o mystèreso sacre rappresentazioni e descritti oggi come misteri cicli-ci”, A. Nicoll, Op. Cit., pag. 58.

te, alla quale si ispirò il silografo che illustròcon poverissime vignette il Mistero sacro de Lojudicio de la fine del mondo. O dovremo inveceritenere che questi attingesse al Mazzucco? IlLucifero del Mazzucco è infatti assai vicino alLucifero delle silografie. Per vari rispetti tutta-via la derivazione del Mazzucco dalle xilografiee viceversa si potrebbe negare. Lucifero di SanFiorenzo differenzia dagli altri Luciferi più noti,se partecipa, e come!, della scena infernale, nonla domina e neppure la condizoona: egli è unministro di pene e di supplizi come i demoni,che operano intorno a lui, il primus inter pa-res” (13).
Va però anche specificato che l’impianto nar-rativo dell’Inferno, rifacendosi ancora a schemiteatrali, pone sull’identico piano l’interno del-l’oltretomba destinata ai peccatori e il suo ac-cesso esterno, effettuando quella sintesi sceno-grafica che come sappiamo fu una prerogativadell’arte scenica della sacra rappresentazione.
Nella parte bassa dell’affresco sono rappresen-tati i vizi capitali, orientati in direzione dellabocca spalancata del mostro.
L’aspetto dei diavoli è diversificato e condizio-nato da tutta una serie di riferimenti al micro-mondo del folklore. Quasi seguendo una pro-pria gerarchia con gradi e compiti di varia natu-ra, i torturatori dei dannati hanno piedi palmatio zampe simili a quelle di enormi uccelli preda-tori, corpi pelosi o squamosi con colori scuri echiari o addirittura maculati, occhi terribili,
barbe ispide, corna, zanne, code e unghie. Tutti,dalle loro naturali aperture, sprigionano fiam-me inarrestabili (14).
La forte ibridazione dei demoni suggerisce unevidente legame con i miti delle mascherate,entrate a far parte del folklore già nel medioevoe perseguite dalla demonizzazione ecclesiastica.
Le cause che condussero all’abbinamento ma-schera-demone sono numerose, profonde e do-vute sostanzialmente alla paura insita nell’uo-mo per quanto si nasconde dietro un’immaginestereotipata, che occulta l’aspetto primitivo del-l’essere. La demonizzazione del travestimentoandò accentuandosi già in seno al cristianesimodelle origini, quando la maschera fu collegata aldiavolo e alla sua capacità di mutarsi continua-mente nel corso dei suoi tentativi di traviare gliuomini.
La maschera penetrando nel folklore, diventa“segno” del rinvigorirsi del paganesimo, in senoalle tradizioni popolari che, nell’ottica dellaChiesa medievale, erano un autentico ricettaco-lo del demonio. Emblematica in questo senso latestimonianza di Cesario di Arles (VI secolo): “quando arriva la festa delle calende di gennaio,vi rallegrate stupidamente, diventate ubriaconi,vi scatenate in giochi osceni (...) Se non voletepartecipare al loro peccato collettivo (quello dichi era direttamente coinvolto nei festeggia-menti, n.d.a.) non permettete che vengano incorteo davanti a casa vostra, mascherati da cer-vi, da streghe, da una qualunque bestia; rifiuta-
36 - Quaderni Padani Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000
(13) L. Berra, Op. Cit., 1956, pag. 36. Va ancora aggiunto, chenella pittura popolare la tricefalia del diavolo ritorna conuna certa frequenza; non è improbabile che “accenni adun’intonazione negativa dell’immagine trinitaria, a sua voltarappresentata con tre teste nel mondo slavo e greco-ortodos-so”, A. di Nola, Il diavolo, Roma 1987, pag. 322. Un ulterioreriferimento può essere rintracciato anche nella tradizioneapocrifa: in particolare il Vangelo di Nicodemo in I Vangeliapocrifi, a cura di M. Craveri, Torino 1969.(14) I diavoli di Bastia non sono esclusivo prodotto della crea-tività del Mazzucco, ma si sovrappongono effettivamente aquei modelli rappresentativi della cultura popolare, che hanel diavolo un tema spesso astratto, riconducibile a figura-zioni di diversa origine.Nella coscienza popolare, il diavolo da sempre assume con-notazioni sincretistiche caricandosi di attributi mostruosi,originati da influenze esterne ma anche da archetipi comu-ni. In genere è dotato di intonazioni grottesche, fino ad esse-re una sorta di figura malvagia ma impotente, che l’uomoriesce sempre a vincere con l’astuzia e con la fede. Una fortecondizionante è data anche dalle reminiscenze religiose pa-gane, demonizzate dalla Chiesa, che nel suo impegno evan-gelizzante ne poneva in evidenza tutte le sfaccettature de-moniache. Nei canoni dei concilii, nelle omelie dei primi ve-
scovi e in numerose altre fonti, la Chiesa prese spesso le di-stanze da tutte quelle tradizioni popolari che, cercando diabbattere i poteri negativi del diavolo, in effetti finirono perripercorrere la sua stessa strada, ricorrendo a pratiche apo-tropaiche di chiara origine pagana.Nell’immaginario popolare, il diavolo diventa parte di unmeccanismo di riconoscimento, che ricerca nel quotidiano isegni di una creatura destinata comunque a porre in eviden-za la sua alterità, di conseguenza la sua temibilità.La figura demonica è utilizzata con notevoli slanci pedagogi-co-moralistici, che le leggende hanno assorbito sotto formadi segnali mitici ad uso propriamente didascalico. Da qui l’af-fermarsi di cautele metodologiche, a cui attenersi rigorosa-mente secondo uno schema semplificato e ricorrente.Il diavolo, nella tradizione popolare, molto spesso non è piùquella figura definita e relegata ad un ambito preciso dellatradizione cristiana, ma come una maschera carnevalescapenetra nei contesti diversi, si fa guardiano di tesori impos-sibili, terrificante abitante di antri senza fondo, di oscure fo-reste e montagne difficili da ascendere (J. B. Russell, Il dia-volo e l’inferno tra il primo e il quinto secolo, Milano 1986;A. A. Barb, “La sopravvivenza delle arti magiche”, in Conflit-to tra paganesimo e cristianesimo nel secolo IV, a cura di A.Momigliano, Torino 1975).

te di dar loro la strenna, biasimateli, correggete-li e, se potete, impedite loro di agire così”.
Ognuna delle creature di Bastia meriterebbeuna descrizione singola, poiché ognuna è diver-sa dall’altra; spesso si tratta di piccole differenzestilistiche, condizionate da un repertorio cultu-rale di vastissima origine, giunto attraverso ca-nali non sempre ufficiali e mediato dal vernaco-lo simbolico.
L’immagine del diavolo abbruttito dalle ibrida-zioni, reso mostruoso dal riemergere di manipo-lazioni formali di divinità pagane e con la com-plicità di una certa tradizione apocalittica, si èprofondamente radicata nella cultura cristianaoccidentale con la sua eco di terrore. Sul pianoiconografico, la figura non ha però confini e ri-sulta contrassegnata da una sorta di standariz-zazione formale presente in tutte le religioni. Inogni caso il diavolo è brutto, scuro e sporco,mentre l’angelo è bello, luminoso e limpido. C’ècomunque una motivazione di ordine psicologi-co alla base dell’invenzione del volto del diavolo,un innesco di origine quasi atavica, elaboratolentamente, fino a trovare l’apoteosi nelle rico-struzioni infernali della pittura medievale.
L’arte del medioevo è stata certamente il mag-
giore amplificatore del diavolo in tutte le suepeggiori manifestazioni: tentatore, adulatore,torturatore, carnefice, lascivo amante travestitoda fiore di purezza, caprone infamante, amatoresenza freno, ingordo promotore di banchetti ebevute colossali.
Corna, zampe caprine, occhi di brace e falli si-mili ad armi, dominano nei cicli di affreschi,mentre l’antico tentatore gioca le sue carte con ideboli illusi o sfoga la sua impotenza su quantihanno creduto alle bugie spacciate come unapossibile certezza. L’arte ha fatto del diavolo unprotagonista, nella stessa misura in cui l’uomocomune ne ha fatto un primoattore, ne ha og-gettivato la presenza, ne ha convogliato le con-notazioni più violente recuperandole anche dal-la mitologia e dalle rivisitazioni che la culturapopolare ha voluto proporre su questo immorta-le essere, sempre pronto a dilaniare i progettivotati al signore della luce. A Bastia le mille ibri-dazioni del diavolo sono ben evidenti, in unsusseguirsi di figurazioni e di rimandi allegoricisempre di grande effetto. Ad esempio, la cavalca-ta dei vizi è introdotta dalla superbia, rappresen-tata da un uomo con una spada sul dorso di unleone; l’avarizia è una donna vestita di stracci
Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000 Quaderni Padani - 37

con la borsa del denaro stretta al petto e sedutasul dorso di un cane; la lussuria è una donna suun caprone, nella mano sinistra stringe unospecchio e con la destra solleva la gonna; l’invi-dia è una donna che nasconde il volto cavalcan-do un felino maculato; la gola è un uomo chebeve e stringe nella mano uno spiedo cavalcandouna volpe; l’ira è un uomo che si trafigge la golacavalcando un lupo; l’accida è raffigurata da unuomo adagiato su un asino. Chiude il corteo undiavolo con la frusta.
Vicino alla terribile bocca troviamo invece undemone con un aspetto diverso; il suo compitonon è quello di torturare i dannati, bensì quellodi travolgerli spiritualmente nel gorgo dellapaura: infatti il diavolo suona uno strano stru-mento a fiato e stringe tra le mani anche untamburo. Vicino, secondo un nodello fumetti-stico, la scritta: “O infelices peccatores, venitead choreas. Taratantara” (15).
Comunque, qualunque siano il loro compito eil loro aspetto, i diavoli di Bastia sono tutti attoridi una rappresentazione di cui sono parte inte-grante e primaria; infatti i dannati svolgono unafunzione secondaria, la loro è una partecipazionestatica in cui la posizione delle vittime impotentiè evidenziata dall’atteggiamento di palese rasse-gnazione. I peccatori, oltre le pene inflitte dagliaguzzini degli inferi, sono tormentati da terribiliserpenti che entrano loro dalle orecchie ed esco-no dalla bocca. Si insinuano nei loro corpi come,prima, si insinuò il peccato. Ovunque sofferenzee dolore, paura ed eterna agonia in un susseguir-si di moti che non conoscono pace.
Osservando in generale l’affresco di Bastia, sicoglie evidente il mutato ruolo della chiesa, chesi trasforma quasi in luogo teatrale: ma la fin-zione non raggiunge mai livelli troppo elevati diartificio, poiché il dramma quotidiano comuneera un ottimo catalizzatore dialettico nel pro-getto didascalico ecclesiastico.
Certamente il contenuto “apocalittico” in cui
la gente era costretta a vivere favorì il rapportocon una certa forma di simulazione pittorica, incui la semplice escatologia popolare trovava ilmodo per oggettivare le proprie angosce.
L’apparato figurativo si impostava con una sor-ta di dialetto pittorico, che pur utilizzando modie sistemi linguistici propri del contesto popolare,non alterava mai l’integrità del messaggio cate-chistico moraleggiante. Certe soluzioni pittori-che risultano in netta contrapposizione all’artecavalleresca e ai riti ludici giocati sull’estetismo;nelle opere come quelle di Bastia c’è tutto ilpathos della sofferenza interiore, c’è la paura nonfugata di una punizione finale che pare rileggerein modo proprio le tradizioni apocalittiche vete-rotestamentarie, certamente condizionate da in-fluenze demonologiche vicino-orientali. Una ti-pica biblia pauperum rivista e corretta attraversoi modi di sentire e di rappresentare di una reli-giosità popolare continuamente alla ricerca disimboli, ma assolutamente non sterile di imma-ginazione. A rendere ulteriormente interessanteil progetto didascalico dell’Inferno di Bastia con-tribuisce il legame con il testo di una sacra rap-presentazione coeva, illustrato da una serie di xi-lografie tipologicamente non molto diverse dal-l’apparato pittorico di San Fiorenzo.
Nel 1515 a Mondovì, Vincenzo Berruerio stam-pa un volumetto in quarto, di 44 carte, in carat-teri gotici; si tratta del Judicio de la fine delmondo, una sacra rappresentazione di evidentematrice popolare. Il testo si inserisce perfetta-mente in una tradizione che esemplificava tema-tiche sacre complesse, ricche di riferimenti nonsolo canonici ma anche agli apocrifi, con l’ausiliodi un ampio apparato iconografico. Nel caso inquestione si tratta di ben 84 xilografie, che dun-que si impongono sulla parte scritta: una bibliapauperum parallela alle contemporanee rappre-sentazioni pittoriche con didascalie della stessaarea culturale, “un libro per vedere” che affiancail “ciclo pittorico per leggere”(16).
38 - Quaderni Padani Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000
(15) Ci risulta difficile risalire al significato del termine “tara-tantara”: lasciamo però all’erudita penna del Berra il compi-to di suggerire una sintetica ma puntuale precisazione filo-logica. “In un’opera di Prisciano, grammatico del V secolo, silegge: At turba terribili sonitu taratantara dixit. Taratantara.Secondo l’etimologia di Ugoccione di Pisa sarebbe un arneseda mulino, una specie di buratto, ed anche l’instrumentumquo farina colatur, cioè il setaccio. E dal rumore che tale ar-nese fa sarebbe venuto al rumore stesso il nome taratantara,talché il Du Cange commenta: Vocem usurparunt veterespro tubae clangore. Benzone, vescovo di Alba, libellista fa-moso della lotta delle investiture, parlando dei Normanni,
dice che vennero in Italia senza brache, ed aggiunge: hodiecoram elevato simulacro (Alessandro II) resonantibus tubisperstrepunt taratantare. E qui taratantara è preso come gri-do di tumultuosa folla d’armati”, Op. Cit., 1956, pag. 40. E’inoltre interessante rilevare che in Sicilia le processioni ri-tuali di maggio sono dette, nel dialetto locale, “taratatà”.(16) G. L. Beccaria, Il judicio de la fine del mondo, Torino,1978, pag. 4. L’autore insiste sul valore didattico di quest’o-pera, in cui l’immagine “non ha la funzione di ornare e diimpreziosire, ma, col dare il la allo scritto, visualizza e rendeesplicito il racconto, quasi per guida ad un inesperto letto-re”, A. Griseri, Op. Cit., pag. 23.

Già da queste prime indicazioniappare evidente come il Judiciosia il prodotto di una cultura an-cora tutta medievale, nonostantevenga stampato agli inizi del XVIsecolo.
Tuttavia bisogna considerareche la frontiera del Medio Evo va-ria cronologicamente da regionea regione. In particolare l’area delMonregalese in cui è prodotto ilJudicio, risulta piuttosto arcaicanelle sue forme espressive, sia te-stuali che pittoriche.
Nello stesso periodo in cui, inaree confinanti, abbiamo i note-voli esempi pittorici del castellodella Manta o di Macrino d’Alba,le silografie che ornano le cinque-centine o la Passione di Revello,nel Monregalese troviamo ancoraopere di esecuzione popolare cheprivilegiano la formulazione piùaccessibile, in cui la variazione èlimitata ad un ambito già noto eprevedibile (17). Ma questa culturaal confine tra Piemonte e Ligurianon presenta affatto, nella sua ap-parente semplicità, linearità o ba-nalità di intenti e di contenuti; alcontrario è il risultato di un com-plesso intersecarsi di influenzeprovenienti sia dall’area umbro-toscana sia d’oltralpe. Il modelloletterario è tipicamente italiano:come numerosi studiosi hanno dimostrato (18),in questa sacra rappresentazione sono presenti lelinee guida dei canovacci umbri di fine duecento.
Il tema del giudizio non è affatto inconsueto;anche Mondovì risentiva, verso la fine del Quat-trocento, di un generale clima di crisi dei tempibui che portava ad un proliferare di libretti popo-
lari, poemetti, drammi, testi teologici e scientifi-ci, nonché rappresentazioni pittoriche, sui temiapocalittici. Sicuramente dunque la produzionedi questo dramma sacro non è una casuale com-mistione di temi popolari, ma in esso si avvertonomolteplici fonti. D’altra parte bisogna considerareche sul Judicio non sappiamo molto: con buona
Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000 Quaderni Padani - 39
(17) G. L. Beccaria, “Convenzionalità linguistica e alteritàideologica nella letteratura degli ultimi: la canzone popolarenarrativa”, in Sigma, XI, 1978. Per quanto riguarda i ciclipittorici in cui si ripetono temi e immagini, A. Griseri, Ja-querio e il realismo gotico in Piemonte, Torino 1965. (18) La bibliografia legata al teatro italiano delle origini e allasacra rappresentazione in particolare è piuttosto ampia. Ci-tiamo solo alcuni riferimenti: A. D’Ancona, Origini del tea-tro italiano, Torino 1891; E. Faccioli, a cura, Il teatro italia-no, vol.I, Dalle Origini al Quattrocento, Torino 1975; P. To-schi, a cura, L’antico dramma sacro italiano, Firenze 1926;V. De Bartholomaeis, a cura), Laude drammatiche e rappre-
sentazioni sacre, Firenze 1943; M. Bonfantini, a cura, La sa-cre rappresentazioni italiane, Milano 1942. Più specifici i ri-ferimenti con i testi umbri in G. Galli, a cura, Laudi ineditedei disciplinati umbri scelte di su i codici più antichi, Berga-mo 1910 e E. Monaci, “Uffizi drammatici dei disciplinati del-l’Umbria”, in Rivista di Filologia Romanza, I, 1872. Perquanto riguarda il Piemonte: G. L. Beccaria, Op. Cit., Torino1978; F. Neri, “Il dramma sacro del medioevo in Piemonte”,in Fabrilia. Ricerche di storia letteraria, Torino 1930; R. Re-nier, “Reliquie popolari del dramma sacro in Piemonte”, in IlGelindo. Dramma sacro piemontese della Natività di Cristo,Torino 1965.

probabilità si può però supporre che la data del1510 non sia affatto quella della sua ideazione,ma solo il momento della codificazione formaledi un testo elaborato nel tempo e soggetto allemodifiche caratteristiche delle composizioni po-polari, in particolare se legate alla recitazione eall’improvvisazione (19).
Nel Judicio quindi si inseriscono i temi piùconsueti della predicazione che invita ad una ra-dicale revisione dei costumi in vista del GiudizioFinale e illustra insieme i falsi allettamenti del-l’Anticristo e le punizioni infernali.
Seguiamo in breve lo svolgersi della vicenda. Nel prologo vengono presentati alcune cita-
zioni e riferimenti delle “auctoritate de li sacridoctori de lo advento de Christo benedecto al fi-nale iudicio com el preambulo horibili e malitiade questo pesumo sedutore homo de Antechri-sto”(20).
Seguono quindi i diversi peccatori, suddivisinelle sette categorie canoniche: anche se l’ordinein cui vengono citati è diverso, data l’importanzache assume nel Judicio questa presentazione,viene spontaneo il riferimento alla Cavalcata deivizi dell’affresco di Bastia. Dopo un cenno alledannazioni eterne e alla solennità del giudizio,l’introduzione si conclude con le formule con-suete del dramma popolare: “Or stati doncha be-ne atenti e senza favelare, / e con bonna devotio-ne me voliate ascoltare” (vv.84-85).
Il profeta Enoc (21), dopo un ennesimo richia-mo ai peccatori, annuncia la venuta dell’”inimi-go de Christo, lo qualle se domanda Antechristo”(vv:114-115) che alletterà con ricchezze e ban-chetti i suoi adepti; ma egli in realtà “è uno dra-
chone”(v.138) (22) di cui l’agnello di Dio farà giu-stizia.
Segue un lungo intervento del profeta Elia (23),in cui i “paccatori maledecti” vengono terroriz-zati per ciò che li aspetta: non potranno scampa-re ai meritati castighi divini e non avranno nes-suno in grado di difenderli (“non gli averay iudi-ci, advocati nì procuratori, / madre né padre,moglier né figlioli né parenti / che davanti a Dioosserano dir niente” vv.171-173) (24).
I tormenti infernali saranno terribili, tanto che“più tosto voreve tu esser morto / che vederequello terrore” (vv.177-178); anche la natura nesarà spaventata:”che la terra, chi non ha senti-mento, / trema tuta quanta de gran pagura / An-chora quarda quella rocha dura / e queste che so-no a l’avirone: / se derocharono tute quante degran pagura, / l’una cum l’altra se derocharano”(vv.186-191) (25).
Compaiono poi alcuni importanti personaggi:l’Anticristo, che minaccia coloro che non crede-ranno in lui, il Papa, che gli si oppone chiaman-dolo “homo felone” e “diavolone” (vv.244-245), el’Imperatore, pronto a profetizzargli che “a lo in-ferno saray proffondato” (v.270).
Tutti i presenti mettono alla prova l’Anticristodicendogli:
“se tu sey quello che tu te fay appelare / fa’ limorti resuscitare e li arbori fiorire prestamente./ E se cossì poray fare, / crederemo che tu seyChristo. (vv. 286-289)
Ma quando l’Anticristo dice che salirà in cieloper dimostrare che è il vero Messia, gli si parainnanzi l’arcangelo Michele che con la sua spa-da lo respinge (26). È il momento in cui tutti si
40 - Quaderni Padani Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000
(19) G. L. Beccaria, Op.Cit., pag. 7 e D. De Robertis, Problemidi metodo nell’edizione dei cantari, in A.A.V.V., Studi e pro-blemi di critica testuale, Bologna 1961. (20) Lc 21; Mt 24; Dn 12; Is 63. Per il testo seguiamo la tra-scrizione interpretativa di G. L. Beccaria, Op.Cit., Torino1978, che utilizza la tesi di laurea di R. Ferrero in Storia del-la Lingua Italiana, Facoltà di Lettere, Università di Torino,a.a.1971-72 a cui si è attenuta anche l’edizione del LionsClub Mondovì del 1978. (21) La visione escatologica ebbe in Enoc (III sec. a.C.) unpreciso punto di riferimento che si contrapponeva pessimi-sticamente alle prospettive dei profeti, Apocrifi dell’AnticoTestamento, a cura di P. Sacchi, Torino 1981.(22) Cfr. nota 11.(23) Sicuramente l’utilizzo di questo personaggio veterote-stamentario permette una maggiore valenza “scenografica”;inoltre è il profeta che ha conquistato una salda posizione inseno al cristianesimo e pertanto guardato con sospetto dallatradizione talmudica.(24) Sulla presenza di “advocati” e di “procuratori” notiamo
che evidentemente godevano in zona di pessima fama. Infat-ti nel teso sono anche citati nell’elenco di peccatori che fa inseguito Satana (“iudici eh advocati con li sui cativi procura-tori”, v.738) e Lucifero afferma che, se altri saranno lasciatiscappare, vuole almeno prendere qualcuno di loro (“apporta-time alcuno da quelli advochati, / più cari me sono che millede li altri”, vv.980-981). Nell’affresco di Bastia non solo sonoperfettamente riconoscibili con il loro berretto rosso e bian-co, ma il pittore, per accentuarne la presenza e forse il mo-nito nei loro confronti, ha anche apposto la scritta Procura-tores e Avocatores.(25) Le pietre che “se derocharano” si riconnettono all’aper-tura del sesto sigillo (Ap 6,12); ma si ritrovano anche in uncodice del 1476 della Biblioteca Reale di Torino e sono “lepietre che l’una l’altra (...) se bateranno” della Passione diRevello (G. L. Beccaria, Op. Cit., 1978 pag.13).(26) In Ap 12, 7-9, si presenta la guerra tra Michele con i suoiangeli e il dragone, “il serpente antico, quello che è chiama-to diavolo e satana”, che con i suoi adepti viene precipitatosulla terra.

accorgono dell’inganno e lodano la venuta delvero agnello di Dio. Gesù rievoca tutte le vicen-de della sua passione, i tormenti e i tradimenti,e invita al giudizio finale “in la valle de Io-saphat” (27).
Secondo moduli narrativi consueti, interven-gono prima gli evangelisti, poi la Vergine e ilBattista che cercano di intercedere presso Cristo,invocando misericordia per i peccatori. Ma Gesù,secondo il compito che gli ha dato il Padre, deveessere giudice e davanti a lui ogni autorità e po-tere terreno sarà annullato in una totale egua-glianza dei viventi. Egli farà “pagare ciaschadunosecundo che ello averà facto” (28).
Compare poi “Sattanas Diavolo”, impaziente dientrare in azione, che si lamenta per la perdita ditempo: “zamay non visti parlamento / che fussicossì longo né cossì grando a comensare. (vv.680-681) Il demone si descrive: ha “piote grande helonge” (...) “in le piede he in le mane”, con unacorona imperiale in testa (vv.700-704). Nonostan-te gli inviti di S.Michele a pazientare, Satana èsempre più agitato ed inizia ad enumerare con vi-vacità le varie categorie di peccatori, tra cui pre-valgono ecclesiastici e borghesi agiati (29).
Entrano in scena la Bona Anima e l’Anima Ca-tiva, ambedue timorose del giudizio. Attorno a lo-ro si affollano i demoni, tra cui Lucifero, che invi-ta gli altri diavoli ad affrettarsi a catturare i pec-catori per sottoporli ai tormenti, e Gramatel (30),che prepara “caldere grande” in cui buttare idannati.
Satana e Belzebù vogliono immediatamete ipeccatori: tanto si sa già “che tuti quelli da lamane drita / sarano tuti quanti salvi / e tuti quel-li da la parte sinistra / sarano tuti dampnati/(vv.969-972) (31). Lucifero in particolare insiste:
vuole un avvocato, per occuparsene personal-mente. E nell’affresco di Bastia è proprio un av-vocato ad essere dilaniato da Lucifero, mostruosafigura centrale della composizione.
Alla presenza degli Evangelisti e della Vergine,inizia il Giudizio Finale: i peccatori sono separatidai beati e la loro distinzione avviene in base alleopere di misericordia (32).
Mentre la Cativa Anima non ha riconosciutoCristo nei bisognosi, e quindi verrà punita, la Bo-na Anima è stata misericordiosa, anche se rim-piange di non aver agito meglio: “O Signore mio,non te hò veduto / né anchora cognosuto, / per-ché se io te avesse cognosuto / anchora meglo teaveria facto” (vv.1203-1205).
Il testo si conclude, secondo una tipologia pre-stabilita, con moralistici e didascalici inviti a se-guire i comandamenti per evitare i tormenti cheinevitabilmente colpiranno chi si presenterà alGiudizio Finale nel peccato.
Come si è visto, il dramma procede dunquecon uno svolgimento piuttosto semplice, tipicodi tale genere letterario. Non si colgono moltispunti originali, che escano dalla prevedibilitàdel modello. Il testo del Judicio è rispondente,come l’affresco, alle necessità della cultura tipicadi una comunità contadina.
E anche il linguaggio si adegua. Pur non es-sendovi ancora studi approfonditi sulla lingua diquesto documento (33), possiamo scorgere in es-sa il compenetrarsi di diverse convenzioni lin-guistiche: il latino medievale, il toscano tre-quat-trocentesco, la tradizione dialettale alto italiana.
Tranne alcuni fenomeni grafici e fonetici gene-ricamente settentrionali, il testo non presentaspiccati particolarismi dialettali, nonostante lavistosità dell’uso di alcuni vocaboli.
Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000 Quaderni Padani - 41
(27) In Gl 4,2 la Valle di Giòsafat significa la “Valle di Dio-Giudice” e al versetto 14 è richiamata con “Valle della deci-sione”, in quanto luogo in cui Dio eseguirà quanto stabilitodal giudizio. E’ un nome simbolico che non può essere loca-lizzato. Emblematico il riferimento alla Valle di Giòsofat nelLibro di Enoc (etiopico): “un profondo burrone la cui boccaera aperta” (53,1).(28) Ap 20, 12: “I morti, grandi e piccoli, stavano davanti altrono mentre venivano aperti dei libri; e un altro libro fuaperto, quello cioè della vita. I morti venivano giudicati inbase a quanto stava scritto nei libri, secondo, cioè, le loroopere.”(29) Vengono citati nell’ordine papa, duchi, principi, eccle-siastici di vari ordini, mercanti, borghesi e cavalieri, lavora-tori e contadini, giudici, avvocati, dottori in teologia, medi-ci e speziari, artigiani esperti in diverse arti, studenti e don-ne imbellettate. A questo proposito viene spontaneo il ri-mando alle invettive dantesche (Paradiso, XV), esempio di
questo topos letterario.(30) La presenza di Gramatel, l’addetto alle “caldere”, intro-duce una variante nelle consuete presenze di diavoli. Questoantroponimo, da riconnettersi con il dialettale “gram”, mal-vagio, è presente anche nella Passione di Revello (G. L. Bec-caria, Op. Cit., pag.14).(31) Nelle civiltà mediterranee antiche la sinistra rappresentala direzione della morte.(32) Dar da mangiare agli affamati; offrire la carità; dar da be-re agli assetati; vestire gli ignudi; visitare i malati; seppellirei morti; ospitare i pellegrini.(33) Oltre allo studio di L. Berra, Op. Cit., 1946, il primo ten-tativo completo di analisi linguistica è stato attuato nella te-si di laurea di R. Ferrero (Op. Cit.). Possono risultare inte-ressanti il testo a cura di A. Cornagliotti sulla Passione diRevello, Torino 1976, e le annotazioni di A. Sobrero, “Alcuneconsiderazioni sul piemontese antico”, in Boll.Stor.Bibl.Su-balpino LXX, 1972.

Nei tempi andati, la contrada di porta Vigenti-na, a Milano, un giorno l’anno si vestiva a fe-sta, in un tripudio di verde e di fiori, di suoni
e canti spensierati. Era la festa del “Tredesin deMarz”, con cui i Milanesi solevano salutare la finedell’inverno e il ritorno della primavera.
In origine la fiera del tredesin si celebrava suibastioni di Porta Orientale, presso la chiesa diS. Dionigi, che la tradizione voleva fondata sulluogo medesimo dove S. Barnaba aveva piantatola sua rozza croce a simboleggiare l’evangeliz-zazione della città.
Barnaba era un eminente personaggio; Luca,
autore degli Atti degli Apostoli, ce lo presentain termini formali: “Barnaba, levita di Cipro,aveva un podere, lo vendette e preso un prezzolo depose ai piedi degli Apostoli”. Sennonché,poche pagine dopo, lo dipinge con una vivacepennellata: Paolo e Barnaba, che in Licaoniapredicavano e operavano miracoli, furono rite-nuti divinità scese dall’Olimpo, il primo fu cre-duto Mercurio e l’altro fu scambiato per Giove,
tanta era la sua personalità e il suo carisma. Quando si separarono, Paolo, grande oratore,
si rivolse alle genti d’oriente e Barnaba, uomod’azione, si occupò dell’occidente.
Non era facile portare il messaggio della cro-ce in un mondo che vedeva in essa solo il sim-bolo di un supplizio infamante e i due agironoin maniera diversa, secondo il modo a ciascunopiù congeniale.
Paolo scrisse una bellissima lettera, chiamataanche “Vangelo della croce”, ma prudentementela indirizzò ai Galati, pagani d’origine celtica,tra i quali l’emblema della croce era diffuso già
prima del cristianesi-mo e quindi erano fa-vorevolmente predi-sposti. Barnaba portòdi persona il vessillodella croce a Milano,ma non ci risulta chesia entrato nella città,dove già operava Ana-talone consacrato ve-scovo l’anno prece-dente; si fermò invecein un sobborgo orien-tale, dove probabil-mente le tradizioniceltiche erano ancoravive, anche se formal-
mente abrogate da Augusto, cinquanta anni pri-ma.
Secondo la tradizione: il 13 di marzo dell’an-no 52, S. Barnaba Apostolo, che predicava al po-polo milanese il Vangelo di Cristo, presso lemura di Via Marina a Porta Orientale, eressel’insegna della croce, sopra una pietra rotonda.
Per i Celti, la pietra era un simbolo dellamassima importanza, era posta alla base delle
42 - Quaderni Padani Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000
Nell’anno 52, l’incontro tra la tradizione celtica e il Vangelo di Cristo
La pietra di BarnabaIl 13 marzo, i Milanesi ricordavano l’arrivo di Barnaba
di Giorgio Fumagalli
DIE XIII MARTII ANNO DOMINI LII
S. BARNABAS APOSTOLUS EVANGELIUM CRISTI
POPULO MEDIOLANENSI PRAEDICANDO IN LOCO
PROPE MOENIS VIAE MARINAE PORTAE ORIENTALIS
IN HOC LAPIDE ROTUNDO VEXILLUM CRUCIS EREXIT
Testo della lapide, che si trova presso la pietra celtica, nella navata cen-trale della chiesa di S. Maria del Paradiso, a Milano, così traducibile:Il 13 marzo del 52° anno del Signore / S. Barnaba Apostolo / nel mentre predicavaai Milanesi il Vangelo di Cristo / non lungi dalle mura di Via Marina, a Porta Orien-tale / in questa pietra rotonda piantò il vessillo della Croce

costruzioni più importanti e dei troni dove ve-nivano incoronati i re. Barnaba, uomo di gran-de intelligenza e sensibilità, non distrusse lapietra, non la ignorò; anzi, la valorizzò, ponen-dola a fondamento del nuovo corso della storia.Nello stesso tempo, diede la massima efficaciaal messaggio evangelico che stava proponendo.
Gli storici hanno cercato di approfondire il si-gnificato del suo gesto, che certamente avevacreato una profonda impressione; è comunqueevidente che ponendo la croce sopra una pietraceltica d’antica venerazione, Barnaba volevapresentare il messaggio del Vangelo per sosti-tuirlo al vecchio culto, senza necessariamentecreare una frattura col passato.
Tuttavia non dobbiamo pensare ad un miraco-lo del tipo “la croce nella roccia”, perché inrealtà la pietra celtica si prestava benissimo allabisogna, in quanto aveva la forma di una ruota,con tredici raggi ed un foro nel centro.
La ruota - sappiamo - è stata una delle piùgrandi invenzioni della storia, fondamentale per
i Celti, un popolo nomade un tempo e di agri-coltori più tardi: essi furono i primi ad applica-re legnetti tra asse e ruota, in modo da realizza-re primitivi, ma efficaci cuscinetti a rotolamen-to; giunsero persino a collocare ruote d’egregiafattura, nelle tombe di illustri personaggi. Nes-suna meraviglia, quindi, per l’importanza dataad una ruota di pietra.
Il Cristianesimo vietò il culto delle pietre, maqualche eccezione fu tollerata e la pietra di Bar-naba fu conservata a lungo nella chiesa di S.Dionigi, presso la quale era stata eretta ancheuna colonna con una gran croce, detta appunto“Croce di S. Dionigi” citata anche dal Manzoni:è lì che Renzo trovò i pani della Provvidenza.
La chiesa fu demolita nel 1783, per far luogoai giardini della villa reale e i Padri Serviti, chefino allora vi avevano officiato, dovettero migra-re in una chiesa di porta Vigentina, dedicata aS. Maria del Paradiso. E così pure la pietra celti-ca, che ancor oggi vi è conservata, accanto aduna lapide che ricorda il mirabile evento.
Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000 Quaderni Padani - 43

A quasi duecentoventicinque anni dalla nasci-ta sembra emergere una nuova interpreta-zione della poesia di uno dei più grandi poe-
ti in lingua lombarda di tutti i tempi, interpreta-zione lontana finalmente dalle ubriacaturemarxistiche degli anni settanta ma anche dalleforzature nazionalistiche che hanno attraversatola critica letteraria del Novecento.
Ho detto lingua lombarda perché il terminetradizionale “dialetto” non è più accettabile allaluce di una filosofia della storia e della geografiache non stabilisce più stolte classificazioni lessi-cali coniando termini come “nazione” ad agglo-merati spaziali ove sono state imposte delle lin-gue ufficiali a svantaggio di altre che sono statelimitate, svilite e talvolta addirittura tagliate.
Dietro le citate cattive letture ermeneutichec’era comunque un monolito filosofico che pertanto tempo ha dominato la scena in Europa,tingendosi volta per volta di coloriture prospetti-che di destra o di sinistra, lostoricismo, che ha finito persposare alla fine l’unica ideolo-gia mercenaria rimasta libera,il cattolicesimo progressista.Questi orizzonti epistemologiciavevano la pretesa di azzeccareinfallibilmente il vero corsodella storia umana, inquadran-do qualsiasi personaggio o au-tore in una determinata epoca(illuminismo, romanticismo,ecc.)che sembra da una parteincasellare qualsiasi realtà sot-to un’idea ferrea e dall’altrapartecipare al cammino deitempi preparando epoche suc-cessive che porterebbero ineso-rabilmente verso la felicità fi-nale di quegli stessi automi, in-gabbiati volta per volta, insempre nuovi marchingegnicollettivi.
Una delle vittime di questiequilibrismi intellettuali è sta-
to proprio Carlo Porta, visto prima come illumi-nista, poi come romantico, poi ancora come an-ticlericale senza mezzi termini.
Val la pena allora di dare un’occhiata alla suabiografia, per cercare di liberarlo definitivamenteda ogni falsa etichetta. Carlett, o come lo chia-merà Stendhal, suo ammiratore, Carline, eracresciuto nell’ultimo quarto di secolo del Sette-cento in una famiglia - come scrive il Bezzola,suo principale biografo - piena di preti e frati, edorientata, sul piano professionale, verso il mondodella finanza e dell’amministrazione. La forma-zione del Carlett fu collegiale e liceale e il giova-ne fu indirizzato presto alla professione del con-tabile, prima sotto l’Austria e poi sotto i napoleo-nici; ma la sua attenzione si rivolgeva precoce-mente al mondo popolare milanese e lombardo(non senza riferimenti a Venezia ove passò partedella sua prima gioventù) e alla sua traduzionenel linguaggio vernacolare, che solo sentiva suo
ed immediato, rispetto ad unitaliano vissuto come artificio-so e ad un francese o a un te-desco che sapevano di imposi-zioni ed angherie. Si pensi cheil suo primo personaggio poe-tico fu un lavapiatti, sintomodi un interesse per gli ambien-te sottoproletari ed umili chea torto è stato interpretato so-lo come volontà di rivolgi-mento demoradicale.Il suo cuore parlava comun-que di istanze filoaustriachenell’ossequio ad una organiz-zazione che avrebbe salva-guardato anche le classi popo-lari proprio perché non avreb-be mai proposto il tedesco co-me sostitutivo del meneghino,come invece fecero più tardiproprio le classi alte che parla-vano italiano e ostentavano di-sprezzo per il popolo.È vero che negli ultimi anni
44 - Quaderni Padani Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000
Carlo Porta poeta antirisorgimentaledi Andrea Rognoni
Ritratto di Carlo Porta di FeodorBruni

del secolo il Porta partecipò al Teatro Patriottico,fucina di intellettuali ed artisti di impostazioneprerisorgimentale, ma in quel contesto il suoruolo fu quello di attore e non di autore o politi-co. Se inoltre Carlett entra in contatto con la let-teratura italiana lo fa per tradurre la sua operapiù famosa, l’Inferno di Dante, in un linguaggiocommestibile ai veri meneghini, adattando perfi-no la mentalità del toscano a quella più padana.Va spiegato però che la scelta del cosiddetto dia-letto non fu solo la conseguenza di uno sponta-neo attaccamento alle radici popolari ma dellaconoscenza e della coltivazione della tradizioneletteraria milanese di un Maggi, secentesco, e diun Balestrieri settecentesco, con particolare rife-rimento all’Accademia dei Trasformati all’internodella quale lo stesso Parini, pur avendo scritto inlingua italiana, aveva rivestito un ruolo decisivo.Tutti autori che avevano vissuto sì il preillumini-smo e l’illuminismo ma si erano atteggiati neiconfronti del mutamento dei tempi con unprofondo monito morale, intravedendo da unaparte la decadenza del clero e dell’aristocrazia,penalizzate paradossalmente dai lumi perchémesse non più nelle condizioni di esprimere laloro specifica funzione, con conseguente ripiega-mento e corruzione, e dall’altra la pletora di con-troindicazioni causate dalla cura razionalistica eprotomondialistica del Nuovo Regime, come l’in-quinamento delle strade e dell’aria, l’affarismo fi-ne a se stesso, la contaminazione delle tradizionipopolari lombarde.
È su questa linea che si pone il Porta, arrivan-do a far parlare i meno abbienti per portare, cer-to anche a suon di parolacce e brutte maniere, laprotesta estrema verso una società e un gustodestinati a cambiare troppo maldestramente. Ec-co, la volgarità del Porta non era tanto il sintomodi una volontà rivoluzionaria ma la parodia bef-farda del livello a cui sarebbero arrivate le classialte se avessero continuato sulla strada dell’im-barbarimento. La stessa Ninetta del Verzee, eser-citandosi nelle varie arti della prostituzione, vuolporsi a modello di virtù rispetto a forme di pro-stituzione morale attuate da chi doveva porsi an-cora come guida delle anime. Così la satira neiconfronti dei preti e dei frati non vuole essere unatto di condanna di un mondo corrotto in sub-stantia, da eliminare o sconfiggere, ma un con-tributo alla presa di coscienza dell’abiezione acui può giungere una classe sociale quando ven-gono meno i principi dell’onestà e del rispettodelle Scritture: si veda ad esempio l’opera “Onfunerall”, ove chiede direttamente a Dio di far
qualcosa per restaurare ordine e serietà all’inter-no del mondo ecclesiastico.
Se non venne mai meno la stima di un Manzo-ni o di un Grossi per il Porta, oltre ai comple-menti transalpini di Berchet e Stendhal, vuol di-re che anche i cosiddetti moderati avevano capi-to che dietro alle sue saghe popolaresche e allesue battute al pepe di Cayenna c’era una rifles-sione di base, di valida egida morale.
Il Manzoni aveva preso una via diversa pur te-nendo d’occhio i valori dei ceti emergenti, unavia che unendo nazionalismo, cattolicesimo e so-lidarismo avrebbe portato, complici critici edesegeti senza scrupoli, al principale modello let-terario dell’Italia buonista. E forse sentiva incuor suo di aver fatto un’operazione un po’ pira-tesca, prendendo spunti e materiali dalle poesiedel Porta, per sublimarle con i panni fiorentini eproiettarle a modello di vita cristiana nei “Pro-messi Sposi” (vedi ad esempio la descrizione delcorpo di Lucia a modello della morosa del Mar-chionn). Sentiva soprattutto, nei momenti buidella sua vita, che l’operazione della lingua to-scana costituiva sostanzialmente un artificio, an-che se un magnifico artificio, rispetto alla spon-taneità del meneghino portiano. Ha ragione per-tanto lo studioso Isella quando scrive che mentrenel Manzoni la realtà contemporanea è momen-to d’avvio di una meditazione che ne forza i ter-mini immediati muovendo verso una soluzionemetastorica, la meditazione portiana è calata in-teramente nella realtà stessa, nella persuasioneche in ogni momento essa ha, per gli uomini chela vivono un valore assoluto, che impone scelteassolute. La scelta assoluta dell’inizio dell’Otto-cento era quella della lingua locale come unicomezzo di conservazione degli antichi valori, per-ché qualsiasi altra soluzione avrebbe portato allacancellazione delle vere identità.
Così Franco Loi, uno dei massimi poeti dialet-tali dell’Italia e della Padania attuali, può coglie-re il fatto che colla sola (si fa per dire) forza deldialetto milanese, il Porta riesce ad anticipare igrandi temi della letteratura russa dostojevskia-na (cosa non riuscita al pretolstoiano Manzoni)con la denuncia del demonismo a cui può porta-re nelle classi popolari una fede mal vissuta e unaffievolirsi dei modelli virtuosi provenienti dal-l’alto. Il Carlett è costretto in qualche modo a ca-larsi nei suoi personaggi, nei suoi dannati, perfar comprendere l’abominio del male, per farprovare a noi, che saremmo venuti dopo, il rac-capriccio totale che solo può far tornare sullaretta via dell’ordine e dell’onestà.
Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000 Quaderni Padani - 45

G iuseppe Garibaldi il 30 Giugno 1862, arrin-gando la folla palermitana dal balcone delMunicipio di Palermo, diceva: “Il muratti-
smo - l’ipotesi di gestione francese nel Regnodelle due Sicilie se si fosse realizzato l’accordodi Plombiéres tra Cavour e Napoleone III° delluglio del ’58 - condurrebbe a scissura inevitabi-le le forze nazionali, scioglierebbe quel fascioromano che noi vogliamo ad ogni costo com-porre...”(Massei Carlo: L’Italia e la politica di Na-poleone III°; Livorno 1863; Vol. I°; Cap. XXIV°).
Alla sera dello stesso 30 Giugno, Garibaldi, ateatro, alla fine del primo atto dell’opera,ringrazia il pubblico che lo acclama con questeparole: “Il programma che ci rese vittoriosifin’oggi, io ve ne assicuro, ci renderà vittoriosiin appresso. Esso è Italia e Vittorio Emanuele.Coloro che vogliono sostituirvi un diverso pro-gramma, cercano la discussione, suscitano legare municipali, vi conducono al dispotismo. Ilfascio romano che noi abbiamo formato, è ilsimbolo per cui sorsero le legioni romane chepasseggiarono per il mondo vittoriose...”(c.s.).
Il giorno dopo ad un gruppo di cento universi-tari al Municipio di Palermo, così Garibaldi siesprimeva: “Ci dicono che siamo ventidue mi-lioni di uomini; non è vero, siamo venticinquemilioni di uomini, come noi uniti, compatti,uniti in un fascio, che non temono tutti i nemi-ci. I fratelli di Roma e Venezia sono con noi,combatteranno con noi...” (c.s.).
Relativamente al “fascio”, a cui faceva riferi-mento Garibaldi, va ricordato che nell’anticaRoma questa insegna di origine etrusca era ilsimbolo del potere dei Magistrati. Composto daun mazzo di verghe di olmo e betulla e da unascure, era legato da cinghie rosse ed era portatonelle cerimonie dai Littori (ufficiali di scorta)davanti ai magistrati romani a simboleggiare ilpotere coercitivo, e quindi l’autorità dello Stato.
Quando Garibaldi nel primo discorso del30/6/1862 dice che il murattismo condurrebbe a“scissura” le forze nazionali, e che questa “scis-sura” porterebbe a “sciogliere” “quel fascio ro-mano che noi vogliamo ad ogni costo com-
porre”, significa che lui - d’accordo con VittorioEmanuele II° - voleva mettere insieme, comeverghe di betulla, l’uno accanto all’altro, tutti gliStati italiani e legarli tra di loro - simbolica-mente - ad una scure quale simbolo del poterecoercitivo. E questo è stato fatto!.
È del tutto evidente allora che il “fascio”, nelpensiero di Garibaldi - ma anche in quello diVittorio Emanuele II° (primo Re d’Italia) - avevail significato di mettere insieme strettamente -come fuscelli - tutti i popoli e le etnie abitantinon solo nella penisola italica ma anche in quel-la parte continentale comprendente la valle delPo che confina con le Alpi e che noi chiamiamoPadania. Questo fascio littorio non era, nel pen-siero che Garibaldi voleva imporre, e che ha im-posto, solo simbolo di stretta, quasi asfissianteunione tra i popoli italici, ma doveva essere an-che, seguendo le sue stesse parole, un richiamoalla romanità antica che permise alle sue legionidi “passeggiare per il mondo vittoriose”. È statoquesto un ben preciso richiamo non tanto aduna pace ricercata quanto ad un futuro proposi-to militarista di una possibile espansione colo-niale oltre confine. Nella terza esternazione ri-portata, quella in cui il Generale parla ai giovaniuniversitari, egli prefigura quel “fascio”, a cuitende il suo pensiero, non tanto e non solocome un insieme di Stati ed etnie italiche, quan-to costituito dall’insieme di venticinque milionidi “fuscelli” - uniti molto stretti - ognuno deiquali rappresenta un uomo che in questa unionenon teme “di tutti i nemici”.
Ebbene, unione di antichi Stati, unione di an-tiche culture, unione di antiche etnie, unione diuomini... ed in mezzo a loro la scure, rappresen-tante il potere coercitivo nel segno dell’anticaRoma dei Cesari!... Ma domandiamoci: in questastretta, indissolubile unità tra gli uomini e tra lediverse etnie, doveva e poteva rimanere lo spaziovitale per lavorare, per produrre, per poter vi-vere secondo le precedenti secolari tradizioni,secondo le precedenti nobili culture? I fenomenisuccedutisi, di estrema povertà generalizzata, dibiblici flussi migratori - quasi una pulizia etni-
46 - Quaderni Padani Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000
Il vero significato di “fascismo”di Eugenio Fracassetti

ca! - dimostrerebbero tutto il contrario. Il Risorgimento, quale movimento insur-
rezionale di liberazione dei popoli, va ricordato,non era di matrice puramente italiana, ma ap-parteneva ad un afflato filosofico e culturale direspiro europeo. Il risorgimento si richiamavaalla cultura dei “lumi”, e cioè alla cultura della“ragione” e della “obiettività scientifica” volta acontrastare tutto quel potere sedimentato siasui biblici teoremi teologici di impossibile di-mostrazione sul piano razionale, sia su uominiil cui valore risiedeva tutto nel modo, nellagrazia e nella forma di articolare i discorsi. L’esi-genza di far riferimento alla nuova oggettivitàscientifica, sui “lumi”, che illuminavano la ra-gione umana, su uomini, che dimostrassero illoro valore con le loro opere, era partita dallacorrente filosofica del Giusnaturalismo inglesedel diciassettesimo secolo (Thomas Hobbes) peraffermarsi e perfezionarsi in Francia - attraversol’opera dei suoi filosofi (Montesquieu, Rousseau,Voltaire e Diderot) con l’Illuminismo del di-ciottesimo e per concretizzarsi poi, sul pianopolitico-istituzionale, nella affermazione dellanuova rivoluzionaria classe borghese di fine se-colo.
La filosofia dell’illuminismo fondava le sueidee politiche sul culto delle nuove libertàborghesi, in contrapposizione al precedente op-primente e fallimentare assolutismo regio ap-poggiato dal clero, e queste libertà riguardavanoi campi dell’intrapresa e del lavoro umano nel-l’ambito del libero commercio non più penaliz-zato dalle precedenti barriere doganali.
Sul piano istituzionale la rivoluzione - ameri-cana prima e francese poi - ha distribuito apiene mani le libertà civili e religiose, ed ha datoil “suffragio universale” ai popoli perché eleg-gano liberamente i loro rappresentanti nelle as-semblee parlamentari. Con questi principii ipopoli europei del diciannovesimo secolo, soste-nuti da un potente afflato romantico, si sonoproposti, con le guerre risorgimentali, di ac-quisire:1) L’affermazione e l’applicazione del Principio edel Diritto di Nazionalità per ogni popolo.2) La libertà di intrapresa economica sul pianoindividuale.3) La libertà religiosa.4) Il suffragio universale.
Era del tutto evidente però - fin d’allora - cheper poter felicemente coniugare l’affermazionedel diritto di nazionalità di ogni popolo con lalibertà di intrapresa economica individuale e la
caduta delle barriere doganali, era necessario in-staurare una sorta di accordo politico tra gliStati che desse spazio di vivibilità all’una e all’al-tra cosa, e quest’accordo - nel richiamarsi all’or-dinamento degli antichi popoli etruschi - nonpoteva essere che quella forma sempre attuale diconvivenza civile chiamata Federalismo. Nullaosta infatti che ogni Stato ed ogni culturanazionale autoctona liberamente si “federi” conaltri Stati e con altre culture, concordando dirit-ti e doveri reciproci, lo spostamento dei confinidoganali e la costituzione di una “Dieta” qualesuperiore organo parlamentare deliberante, cosìcome avvenuto nella Svizzera dei ventisei Can-toni, nell’America dei cinquanta Stati e nellaGermania delle tante case regnanti.
Non uno, dei quattro punti succitati, la nuovastruttura monarchica italiana ha riconosciutoed attuato nel 1861 quale portato della nuovaciviltà risorgimentale per la quale tanto sanguehanno sparso anche i popoli padani nelle guerreartatamente denominate “per l’Indipendenza”,imponendo viceversa: A) un assolutismo antis-torico; riunendo: B) un Parlamento la cui baseelettorale era costituita da meno dell’1 per centodella popolazione (l’1.9 % della popolazione era-no gli aventi diritto di voto in ragione del cen-so); abolendo: C) ogni dirito di applicazione delPrincipio di nazionalità; imponendo: D) unapseudo cultura unitaria derivante dalla savoiar-da Costituzione Albertina estesa a tutto il Paese;permettendo: E) il dominante integralismo cat-tolico della religione di Stato; imponendo: F)tassazioni esorbitanti ma mai sufficienti a sa-nare gli enormi e progressivi deficit dello Stato,che costrinsero masse enormi di popolazione aperdere ogni orgoglio etnico, a perdere ogni lo-ro identità storica e a darsi alla fuga all’estero incerca di pane e lavoro.
In realtà nel corso degli eventi il vantaggioeconomico - in sintonia col privilegio della Casaregnante, del Corpo parlamentare e della buro-crazia centralista di estrazione meridionale - eratutto a favore dei latifondisti e dei grossi indu-striali omologati al sistema. Di certo, quindi, legrandi idealità insite nelle lotte risorgimentali,al contrario degli altri Paesi europei, non sonostate applicate nell’Italia post-risorgimentale! Equesto, di per se stesso, è un fatto storico moltograve.
Ma, al di là delle qualità socio-politiche delnuovo regime monarchico italiano, bisogna fareancor oggi una seria riflessione sul precedenteconcetto di “fascio romano” emerso dalle ester-
Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000 Quaderni Padani - 47

nazioni di Garibaldi. In realtà il problema di fon-do è che questo “fascio” è stato davvero realizza-to nel secolo scorso, ed è tuttora in vigore, an-che se il simbolo è stato graziosamente elimina-to dopo il 1943 con la caduta del regime mus-soliniano. La “nuova” Costituzione “blindata”del 1948 l’ha infatti nuovamente ribadito rele-gando al margine il tema delle autonomie edelle libertà locali. Credo allora, a questo punto,che possa essere evidente a tutti quale sia stato equale sia tuttora il vero significato della parolafascismo, da dove derivi - da fascio - e quando inrealtà sia stato cronologicamente applicato -non tanto come simbolo quanto come struttutapolitico-sociale derivante da quel simbolo - perla gestione dell’insieme del popolo. Il richiamoalle “legioni romane che passeggiarono per ilmondo vittoriose” quale paradigma della futuralibertà del popolo italiano non è stato del restosolo prerogativa del Generale Garibaldi negli an-ni della fondazione dello Stato unitario italiano.Nicomede Bianchi (Reggio Emilia 1818 - Torino1886), per lunghi anni archivista ufficiale diCasa Savoia e storico-testimone degli avveni-menti risorgimentali, così commentava l’impre-sa garibaldina del 1860: “Se il Generale Garibal-di a capo degli eroici suoi compagni allora davaal mondo splendidissima testimonianza chel’antico valore ripullulava rigogliosamente nel-la razza latina, il Conte di Cavour alla sua voltasporgeva splendido documento che il vetustosenno italico non aveva abbandonato i tardinepoti dei gloriosi avi romani”(N. Bianchi: IlConte Camillo Cavour - Documenti editi edinediti; Torino 1863; pag. 84/85).
Sembra chiaro a questo punto come il richi-amo all’antico impero romano - e quindi al fa-scio littorio - al contrario di quanto ha volutoimporre la moderna storiografia sul piano dellapubblica opinione, non sia databile al 1922 incoincidenza con la supposta nascita ufficiale delregime fascista, quanto viceversa proprio alleorigini della formazione dell’unità nazionaleitaliana, al punto tale che questa forzata unità sipuò identificare completamente - ancor oggi -con questo simbolo.
Questo, di fatto, è un concetto di grande va-lore storico perchè fa coincidere nella realtà sto-riografica nazionale la forzata unificazione degliStati, dei popoli, degli uomini più eterogeneidella penisola italica e della valle del Po, avvenu-to nel 1861, alla riesumazione dell’antico simbo-lo di Roma imperiale: il fascio.
Il fascio ha rappresento quindi, fin dall’origine
- e continua perciò a rappresentarlo perchè daallora nulla è cambiato - l’unità nazionale ita-liana.
Non importa poi se questa simbologia di ro-manità sia stata di derivazione etrusca. Nell’am-bito della civiltà etrusca il fascio aveva infattiben altro significato, perchè proprio gli Etruschiavevano per primi unificato l’Italia fondando il“governo della prosperità, della libertà, il gover-no federativo” (Antonio Monti). Altra cosa, vice-versa, è stata la “dittatura dei Cesari” che haschiacciato ed annientato ogni riferimento allacultura etrusca attraverso l’omologazione a Ro-ma. Tale e quale all’oggi!.
L’importanza attuale di questo concetto credodebba essere sottolineato per questo fondamen-tale motivo: dell’Italia moderna, nata senza unaCarta Costituzionale nel 1861, i Savoia fecero -come suol dirsi - di tutta l’erba un fascio, adot-tando per l’appunto il fascio romano a simbolodi questa unità tra i popoli. Ribadiamo dunqueche non è vero che il fascismo propriamentedetto, e cioè l’assolutismo fascista del fascio lit-torio, sia nato - così come si legge nei nostri li-bri di storia - nel 1922 con la Marcia su Roma, esia finito nel 1943 con la caduta del regimemussoliniano. No! Non è vero che il fascismo siaidentificabile semplicemente con la dittatura diMussolini. No! Lo Stato del fascio, in realtà, ètuttora vivo perchè nessuno, dal 1861 ad oggi,malgrado le immani tragedie che si sono abbat-tute su questo Paese ed in Europa nel XX° seco-lo, promosse proprio dalla abnorme struttura is-tituzionale italiana esportata nel ’33 in Germa-nia e nel ’35 in Spagna, è mai più riuscito asciogliere quel nodo politico antidemocraticoche lega da allora strettamente le genti mediter-ranee della penisola italica con le genti conti-nentali della valle del Po. L’immagine dellacaduta del fascio romano in coincidenza con lacaduta di Mussolini, e la nascita della Repubbli-ca è una scena di comodo, è un’affabulazione, èun artificio storico per dimostrare che tutto ècambiato perchè siamo entrati in una nuova erademocratica. Non è vero! La struttura istituzio-nale originaria è rimasta! Il fascio littorio non siè mai sfasciato! Il fascio littorio - come dicevagiustamente Giuseppe Garibaldi - era, ed è tut-tora - sinonimo della stretta unità di uomini,popoli, etnie di questa Italia istituzionalmentepre-illuminista. Il Diritto di Nazionalità di ognipopolo, principio fondamentale su cui poggiaval’Illuminismo ottocentesco e l’idealità e le spe-ranze del Risorgimento italiano, mai è stato at-
48 - Quaderni Padani Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000

tuato, nei fatti, in Italia dall’epopea risorgimen-tale all’oggi. È talmente, stretta questa unità,che mai i cordoni del decentramento politico sisono allentati nel corso della storia unitaria diquesto paese, anzi, col tempo si sono vieppiùstretti, come dimostra la recente fondazione del-la Tesoreria Unica a Roma (Governo Goria) incui confluiscono tutte le risorse dei Comuniitaliani, e perchè il decentramento regionale at-tuato nel 1970 è di puro valore formale e di-mostrativo dato che non ha portato - malgradoil costosissimo apparato - a nessun vero poteredecentrato da Roma. Anche questo nostro tor-mentone dell’entrata in Europa - come ai tempidi Cavour - non è che un fatto d’immagine pernascondere le “rughe” della vecchiezza isti-tuzionale, per perseguire un business che politi-camente non meritiamo, per “omologare” un“regime” lontano secoli dal vero liberalismo edalla vera cultura liberale europea. In realtàquesto “fascio” è sempre stretto come all’origine
perchè mai a questi popoli è stato riconosciutoil diritto di essere padroni del loro destino e delloro futuro... perchè ancora una volta in questicentotrentotto anni tutto è tragicamente e trau-maticamente cambiato perché tutto rimangacom’era... com’era nel 1861.
Per finire vorrei ancora una volta sottolineare- da veneto quale sono - ciò che a tutti i veri li-bertari non può sfuggire: la lotta per un Venetolibero, pur integrato nell’ambito di una federa-zione padana, è identificabile nella lotta controil fascismo. Ci sono armi civili, politiche, cultu-rali ed economiche che si possono legittima-mente usare per vincere finalmente questa bat-taglia, e il naturale esodo, la “soap” di migliaiadi industriali veneti - per esempio - verso la Ro-mania in questi ultimi anni è un esempio; e puòessere questa un’arma, disperata ma alternativa,da usare contro il vassallagggio romano che confatica ancor oggi dobbiamo sopportare. L’Europadeve capire!
Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000 Quaderni Padani - 49

Pierangelo ManueleIL PIEMONTE SUL MARE(La Marina Sabauda dal Medioevo all’Unità d’Italia)Cuneo: Edizioni L’Arciere,1997, L. 65.000
Solimano il Magnifico attaccòRodi nel 1522. I Cavalieri di Ge-rusalemme opposero strenuaresistenza per sei mesi, atten-dendo invano aiuto dall’Europacristiana che, divisa in numero-se lotte intestine, inviò scarsisoccorsi.I Gerosolimitani capitolarono il24 Dicembre dello stesso anno,perdendo così il possesso dell’i-sola durato 212 anni. Dopo la capitolazione le navidell’Ordine si rifugiarono in unprimo tempo a Messina ed inseguito a Nizza. Le unità navalivennero accolte con molto favo-re da Carlo II di Savoia che videin questo modo la possibilità dicontare su una vera e propriamarina. I Cavalieri Gerosolimi-tani ottennero il 23 Marzo 1530la sovranità sull’isola di Malta. Ilprimo Gran Maestro eletto areggere l’isola, fu un piemonte-se: Fra’ Pietro Dal Ponte appar-tenente ad un’antica famigliache si era trasferita dal Monfer-rato in Asti, alla seconda metàdel Trecento. Dall’8 Maggio all’8Settembre del 1565, i Musulma-ni tornarono però all’attacco: in40.000 si scagliarono contro500 cavalieri e 1800 soldati del-la Croce Bianca, a cui si eranoaggiunti 700 volontari prove-nienti da tutta Europa. Nella di-fesa di Malta, ecco accorrerenumerosi Piemontesi fra i quali
i Provana di Leynì, il cui mag-gior esponente era il Conte An-drea, confidente di EmanueleFiliberto detto Testa di Ferro;ma l’avventura della Marineriasabauda era cominciata moltoprima, come ci dice PierangeloManuele nel suo minuzioso la-voro: “Il Piemonte sul mare”,facendoci risalire agli inizi delladinastia dei Savoia e precisa-mente a Umberto Biancamano,Signore borgognone e Ducad’Aosta. Questi, per aver aiutatol’Imperatore Corrado II a scon-figgere il ribelle Oddone diSciampagna, nel 1034, presso illago Lemano, ottenne in cam-bio un territorio di grande im-portanza strategica che com-prendeva tre importantissimivalichi alpini: il Moncenisio, ilPiccolo San Bernardo e il GranSan Bernardo. Manuele ci ricor-da che i successori di UmbertoBiancamano si trovarono, in se-guito, padroni della Savoia, del-la Svizzera Romancia e dellaValle d’Aosta, una regione cheancor oggi costituisceun’isolaetnico-linguistica dove si parlala lingua franco-provenzale, alcentro della quale si trova il la-go Lemano. Questo lago fu appunto il moti-vo principale che spinse i Savoiaad armare una flottiglia di navida guerra per difendersi dai di-versi feudatari sempre in lottafra loro, che lì si affacciavanocon i loro castelli. Le prime anavigare furono le “barbotte”pacifiche imbarcazioni da sorve-glianza o da pesca, ben prestoseguite da navi più potenti, si-mili alle galere che solcavano ilMediterraneo. “Queste elegan-tissime navi”, ci dice ancora lostudioso, “dominarono il mareper secoli”. Esse operarono peròanche nel Mar Baltico e in alcu-ni grandi laghi: il lago di Gardae naturalmente il già citato lago
di Ginevra. In un primo tempo,la realizzazione delle imbarca-zioni fu affidata ai fratelli Pon-teys di Villeneuve, luogo vicinoal castello di Chillon e sede delporto sabaudo. Più avanti ilConte Amedeo V si rivolse aimaestri d’ascia e carpentieri ge-novesi, veri professionisti conuna lunga esperienza. Essi sitrasferirono sul lago dove co-struirono grandi navi marittimeben diverse dalle tranquille bar-botte. Molte battaglie navali sisvolsero sul lago di Ginevra apartire appunto dalla secondametà del Duecento sino al 1355quando il Conte Verde ebbe ra-gione del Castellano di Her-mance che resistette per quat-tro mesi prima di arrendersi.Nel 1388 ecco la svolta per lamarineria sabauda: l’agognatoaccesso al mare, grazie allaspontanea offerta di se stessa,della Contea di Nizza. Il piccolopossedimento comprendeva ol-tre Nizza, il porto naturale diVillafranca, oggi Villefranche-sur-Mer. Molto garbatamenteManuele ci ricorda la storia-leg-genda di Aleramo, il povero scu-diero che dopo aver sposato dinascosto, Adelasia, figlia del-l’Imperatore Ottone I di Sasso-nia, si rifugiò in Liguria; dopoaver ottenuto il perdono dalsuocero e il dono di un territo-rio che comprendeva il Piemon-te meridionale e la Liguria diPonente, chiamò il villaggio incui si era rifugiato con Adelasia:Adelaxium, l’odierna Alassio. Idiscendenti di Aleramo diviseropoi, questo territorio e la parteprincipale spettò ai Marchesi diMonferrato che furono i primiSignori della Regione Piemontea intraprendere lunghi viaggiper mare, con lo scopo di parte-cipare alle Crociate. (Rammen-tiamo per inciso che anche ilgrande ammiraglio Cristoforo
50 - Quaderni Padani Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000
BibliotecaPadana

Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000 Quaderni Padani - 51
Colombo era un piemontese,nativo di Cuccaro nell’Astigia-no). I primi provvedimenti, su-bito dopo aver ottenuto il sospi-rato sbocco sul mare, furonopresi dal Conte Rosso e indiriz-zati al potenziamento delle for-tificazioni per contenere l’assal-to dei Mori, piuttosto che a veree proprie iniziative navali. Il pri-mo ad abbozzare una politicamarinara, fu il figlio del ConteRosso, Amedeo VIII che nel1431 fece costruire due galere,in assoluto le prime navi daguerra, di Casa Savoia, dopoquelle costruite a Villeneuve,sul lago di Ginevra; in quel mo-mento, infatti, “Saraceni erantcum multis fustibus, in mari,pro offendendo”. Citiamo comel’autore, le cronache del tempo.Purtroppo dal 1504 al 1553, co-minciò un tragico destino di de-cadenza per lo Stato Sabaudo(si innesta in questo periodo l’o-spi talità concessa ai Gerosoli-mitani che come abbiamo visto,erano stati cacciati da Rodi). ICavalieri di Gerusalemme ar-marono due galere: la San Gia-como e la San Filippo, e lagrande caracca Sant’Anna. Que-sto fatto non impedì che la si-tuazione precaria del Ducato,fosse ulteriormente aggravata
dall’assedio che, nel 1543, Fran-cesi e Turchi alleati, per motividi convenienza, posero a Nizza;la città, dopo una lunga resi-stenza, fu costretta a capitolaree subì un feroce saccheggio daparte dei Turchi del famoso Kai-reddin detto Barbarossa (un no-me questo, dal significato parti-colare, per la storia della Pada-nia). La sorte della Sabaudiasembrava ormai segnata, quan-do apparve sulla scena un giova-ne duca: Emanuele Filibertoche con la sua abilità di politicoe di condottiero cambiò il desti-no del Piemonte.Il 1557, vede infatti la vittoriadel Duca, alleato e comandantedelle armate di Filippo II, suiFrancesi, a San Quintino.Proprio questa vittoria pose lebasi della rinascita della Casatae della Nazione, da molto tempocampo di battaglia e di conqui-sta per gli eserciti francese espagnolo. (informiamo che aTorino, svolge la sua attività,l’Associazione Culturale “Com-pagnia di San Quintino, cheogni anno rievoca l’ingresso inTorino, nuova capitale, di Ema-nuele Filiberto).Il 3 Novembre 1559, il Ducagiunse a Nizza, accolto dal go-vernatore Andrea Provana, con-
te di Leynì, suo amico e mini-stro che gli era stato accantoanche nella guerra di Fiandra.In quel momento era impegna-to a fortificare la piazza-forte diVillafranca nonché a costituireuna Marina da guerra, degna ditale nome seppur piccola. Leprime operazioni furono indi-rizzate alla caccia dei pirati bar-bareschi ed in seguito, come ab-biamo visto, alla difesa di Malta.Dopo molte peripezie, le armatecristiane, il 6 Settembre del1565, ebbero la meglio sui Tur-chi ormai stremati.Negli anni successivi, le navinon ebbero più occasione dimettersi in evidenza sino al1570 allorchè il Sultano SelimII, intimò a Venezia di abbando-nare Cipro; naturalmente i Ve-neziani si rifiutarono e il Sulta-no per tutta risposta posel’assedio a Famagosta che pur-troppo cadde il 18 Agosto. Il va-lorossimo comandante Marcan-tonio Bragadin vi trovò unamorte orribile con molti deisuoi Questi fatti indussero l’Ar-
Veduta del porto di Villafranca con in primo piano una galera. Dipinto di Dominique Trachel,conservato presso il Musée d’Art et Histoire di Nizza.
BibliotecaPadana

mata Cristiana, ferma alla rada,a uscire dal porto di Messina; sitrattava di una flotta formidabi-le costituita da 207 galere, 6 ga-leazze e 30 navi minori, per untotale di 1815 cannoni e 84.400uomini. La mattina di domeni-ca 7 Ottobre 1571, le avanguar-die cristiane, nei pressi di Capo-Scrofa, al dissolversi della neb-bia, si trovarono di fronte aduno spettacolo terribile: l’im-boccatura del golfo di Patrassopullulava di navi turche, che la-sciata Lepanto, si dirigevanoverso lo schieramento degli Eu-ropei, in numero di 230 galere euna trentina di navi minori; im-mediatamente le due armate sischierarono secondo lo schemavisibile a pag. 54 del Volume. Loscontro fu terribile, con perditedi uomini e navi per entrambele flotte; alla fine i Cristiani eb-bero la meglio: i Turchi persero107 navi affondate o bruciate,140 catturate con oltre 40.000fra morti e prigionieri.In ricordo di tale vittoria, a To-rino, nella chiesa di San Dome-nico, è conservato il “drapò”che secondo la tradizione,Provana aveva innalzato sul piùalto pennone della sua nave “LaCapitana”, anche se studi recen-ti hanno dimostrato essere fal-so; soltanto il tondo centraleche rappresenta il Santo Suda-rio, simbolo dei Savoia, potreb-be essere autentico.Molti quadri, in Piemonte, rap-presentano la Battaglia di Le-panto: notevole una grande pit-tura a olio su tela che si tro-va aBra, nella sacrestia della chiesadi Sant’Andrea, opera di JoanClaret, un pittore delle Fiandre
che operò in tutto il Cuneese,intorno alla metà del Seicento.Questi quadri si trovano gene-ralmente, nelle cappelle dedica-te alla Madonna del Rosario,perché alla sua intercessione, èstata attribuita la grande vitto-ria della Cristianità. Naturalmente l’epopea dellaMarina Sabauda, proseguì benoltre i fatti fin qui ricordati, in-fatti sono numerosi i casi diguerra che la videro in prima fi-la: dalla Rivoluzione francese al-le guerre napoleoniche, dallaprima guerra di indipendenzaalla seconda con la campagnanavale in Adriatico. Ai comandidella flotta si alternarono varipersonaggi appartenenti il piùdelle volte alla nobiltà piemon-tese. La Storia marinara del Pie-monte è chiaramente narrata daPierangelo Manuele con stilescorrevole e precisione di fatti,cifre e personaggi. L’unico ap-punto che possiamo fare all’au-tore riguarda la mancanza (anostro parere) di emozioni per-sonali e la poco approfonditaanalisi sui capitoli che riguarda-no la lotta al banditismo sardoda parte della Marina. Manuelenon si è chiesto se veramente dibanditi si trattasse o non piutto-sto di patrioti che mal sopporta-vano il giogo sabaudo.
Mariella Pintus
Claudio PaglieriI Liguri: Quelli che MugunanoTorino: Edizioni Sonda, 1996,pagg. 98, L. 10.000
Anche i padanisti hanno biso-gno di relax: e, visto che l’au-toironia pare sia una delle ca-ratteristiche salienti dei Liguri,questo sembrerebbe proprio illibro adatto per farsi quattro ri-sate. Si tratta infatti di unaspietata e dissacrante guida“per turisti inesperti” ai mi-
gliori difetti e ai peggiori pregidi cui gli abitanti di questa re-gione possono vantarsi - o, ascelta, dovrebbero pentirsi.L’autore non trascura proprionessun aspetto della vita socia-le di ogni Ligure che si rispetti:va così a pescare ogni luogo co-mune, ogni reazione tipica,ogni atteggiamento per met-terlo in luce.Si parte così da un dato macro-scopico che forse potrà stupirema che, in fondo, è perfetta-mente comprensibile: in nes-sun “dialetto” da Ventimiglia aSarzana esiste il corrispettivodella parola “Liguria”: a sottoli-neare l’esasperato campanili-smo e le mille rivalità esistentitra le diverse cittadine riviera-sche e dell’entroterra. Non po-teva mancare un cenno allabassissima natalità della regio-ne, che Paglieri spiega almenoparzialmente con la scarsa fi-ducia nel futuro che nutronogli eredi della Superba (“perchémettere al mondo un infeli-ce?”).Divertentissima - e, a onor delvero, anche piuttosto fedele al-la realtà - è la sezione dedicataal carattere. Il primo tratto damettere in evidenza, così, è lapropensione al mugugno: “il li-gure è una persona che si alzadal letto e dice “Che freidu!”,va in bagno e dice “vedrai chesi ghiacceranno i tubi”, si fa ilcaffè e dice “certo che l’acquadel bronzino (il rubinetto) nonè più quella di una volta, va allafermata e l’autobus “non arrivamai”, entra in ufficio e il riscal-damento è troppo alto, va inmensa e la pasta è scotta e cosìvia. Insomma, vede il bicchierequasi sempre mezzo vuoto, equando è mezzo pieno il vinofa schifo”. Non manca un ten-tativo di interpretazione “psi-cologica”: “d’altra parte il mu-
52 - Quaderni Padani Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000
BibliotecaPadana

gugno, così fastidioso per i fo-restieri, è la molla che dà al Li-gure la forza di tirare avanti:sentendosi sempre in lotta conil destino, come un eroe dellamitologia classica, trova risorseinaspettate e riesce a superarequalsiasi ostacolo”.Paglieri prosegue con capito-letti dedicati al senso dell’ospi-talità (“un “devi assolutamentevenire a cena a casa mia” pro-nunciato da un Ligure equivalea uno “stiamo preparando ilprogramma da sottoporre aglielettori” pronunciato da un po-litico”), la tirchieria (“il fatto èche il denaro, come i senti-menti, non va sprecato se nonsi è sicuri che ne valga la pena(…) La tirchieria tipica consi-ste nell’andare a piedi per ri-sparmiare le mille lire del bus,per poi spendere senza battereciglio decine di milioni per ca-se, mobili, gioielli (gli investi-menti sicuri)”, e via via con lapermalosità, la riservatezza, ipettegolezzi e, in un brevissi-mo paragrafo (grrr…), le virtù.Terminata la rassegna dei po-poli tradizionalmente “amici” e“nemici” dei Liguri, l’autore silancia in una disamina di quel-le che definisce le “ossessioni”(i regali, il rischio, la casa, lareligione) e delle attività concui riempiono il tempo libero.Proprio qui viene enunciatauna santa verità: “i Liguri sisentono a disagio quando nonhanno niente da fare: non per-ché rischino di annoiarsi, maperché il tempo è denaro e, selo si spreca, si sprecano palan-che”. Al di là dell’impostazionegoliardica del lavoro, è pur ve-ro che vi è in Liguria un’eleva-zione del “darsi da fare” a si-stema di vita, come hannomesso in evidenza anche stu-diosi seri di questa terra e delsuo popolo.
Particolarmente interessante èil capitolo dedicato al “sensodell’umorismo”. I Liguri, infat-ti, al di là del luogo comuneche li vuole (non del tutto atorto…) musoni, quando vo-gliono sanno sfoderare uno hu-mour che nasce proprio dalleloro caratteristiche succitate:le battute ciniche e dissacranti(vagamente “inglesi”) sono laloro specialità, il riso amaro il
loro scopo. Non è un caso, allo-ra, che il personaggio di Fan-tozzi sia nato a Genova, né cheun comico “violento” e spregiu-dicato come Beppe Grillo siaoriginario della stessa città; sa-vonese è Fabio Fazio, albenga-nese Antonio Ricci col suo Ga-bibbo (parola ligure che, pro-priamente, significa “terrone”)e spezzino Gino Patroni. Non èun caso neppure che “una re-gione dove ti aspetteresti vendi-te record di Kierkegaard eSchopenhauer” sia patria di al-cuni dei più grandi fumettistipadani: Antonio Rubino, Lucia-
no Bottaro e Aurelio Galleppini(il creatore grafico di Tex), tan-to per citarne qualcuno.Divertente è poi la parte del li-bro in cui viene messo alla ber-lina il curioso atteggiamentonei confronti dei turisti: da unlato ricercati perché fonte diricchezza e dall’altro visti allastregua di invasori che “rubanoi parcheggi”, criticati perchéspendono troppo poco e con-temporaneamente disprezzatiperché buttano via i soldi a de-stra e a manca. La guida termi-na con la rassegna dei “grandipersonaggi” (da cui espunge-remmo volentieri i nomi triste-mente famosi di Garibaldi e deAmicis e dalla quale già manca- per fortuna, per caso, o peresplicita e gradita volontà del-l’autore - Mazzini) e con unaserie di aneddoti di vita quoti-diana genovese. Tanto per ci-tarne uno, si dice che una voltaStendhal, affascinato da un af-fresco che aveva intravisto at-traverso le finestre di una casa,bussò alla porta e chiese di sa-lirle per ammirarli più da vici-no; il padrone di casa, avendo-gli chiesto chi fosse, replicò:“Stendhal chi?” e gli sciolse icani alle calcagna: “e fu cosìche venne colpito dalla famosasindrome”.Il libro è, insomma, una letturapiacevole e rilassante che, trauno scherzo e l’altro, riesce adare un buon ritratto di quelloche sono i Liguri. E non costaneanche tanto, soprattutto achi, come il sottoscritto, riu-scirà a trovarlo in un mercati-no dell’usato.
Giò Batta Perasso
BibliotecaPadana
Anno VI, N. 27 - Gennaio-Febbraio 2000 Quaderni Padani - 53