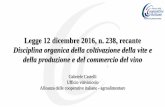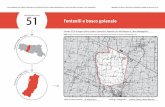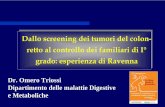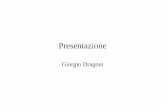atti del convegno - culturali e...
Transcript of atti del convegno - culturali e...

Istituto per i beni artistici culturali e naturali della
Regione Emilia-Romagna
IBC


atti del convegnoBologna, 28 maggio 2004
a cura di
ValeriaCicala
Maria PiaGuermandi

regioni e ragioninel nuovo codice dei beni culturalie del paesaggio
Atti del convegnoBologna, 28 maggio 2004
coordinamento scientifico ed editoriale:Valeria Cicala, Maria Pia Guermandiredazione:Valeria Cicala, Maria Pia Guermandi, Maria Elena Tosisegreteria del convegno:Maria Elena Barbieri
stampa:Stamperia della Regione Emilia-Romagnaeditore:Istituto per i beni artistici culturali e naturalidella Regione Emilia-Romagna - IBCversione elettronica:www.ibc.regione.emilia-romagna.it/regioni-ragioni/
© 2005, Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna

Indice - 5
indicePresentazione ..................................................................................7
Programma del convegno ............................................................9
Introduzione al convegnoGian Mario Anselmi......................................................................11
Alla ricerca di un accordoMarco Barbieri ..............................................................................13
Ministero e regioni: cronaca di un’intesa impossibileAlessandro Zucchini .....................................................................17
Centro e regioni: la necessità di un sistemaMaria Pia Guermandi ..................................................................25
Codice di comunicazioneValeria Cicala...............................................................................37
i beni culturali
Il Codice tra centro e periferiaMarco Cammelli ..........................................................................43
Dalla parte dello StatoDaniele Carletti ............................................................................59
Regioni e Codice dei beni culturaliMariella Zoppi ...............................................................................67
I principi ed il contestoElio Garzillo ....................................................................................71
Fra tutela e valorizzazioneAlberto Vanelli ..............................................................................77
Il patrimonio culturale italiano tra vincoli e opportunità:la prospettiva economicaMichele Trimarchi .........................................................................83

6 - Indice
La fine del “sistema delle arti”?Andrea Emiliani.............................................................................. 91
La cultura del CodiceBruno Toscano ................................................................................97
il paesaggio
II paesaggio dal Testo Unico del 1999 al Codice del 2004Giovanni Lo Savio........................................................................ 107
Il contributo regionale alla definizione di una nuova politicadel paesaggioGiancarlo Poli............................................................................... 113
Tutela, valor d’uso e pianificazione Edoardo Salzano ........................................................................ 121
Paesaggio, territorio, Codice UrbaniAlberto Clementi ......................................................................... 129
Il paesaggio dei beni culturali nell’esperienza dell’IBCAnna Marina Foschi .................................................................... 141
documenti
Convenzione europea del paesaggioFirenze, 20 ottobre 2000.............................................................. 151
Accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali,la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni delle autonomielocali Emilia-RomagnaRoma, 9 Ottobre 2003 ............................................................... 173
Codice dei beni culturali e del paesaggioDecreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42 ............................. 195
Documento della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delleProvince autonomeRoma, 3 marzo 2005.................................................................... 273

Presentazione - 7
Presentazione
Il presente volume raccoglie gli interventi tenuti nel corso del conve-gno “regioni e ragioni nel nuovo Codice dei beni culturali e del paesag-gio” che l’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna ha or-ganizzato il 28 maggio 2004, in concomitanza con l’entrata in vigore (1°maggio 2004) del decreto legislativo n. 42/2004.
La giornata di studi ha costituito uno dei primi momenti di riflessionesu uno strumento legislativo, il Codice, che ha suscitato, fin dalle primefasi di elaborazione, una discussione animatissima che ha trovato largaeco sulla stampa nazionale.
I testi qui pubblicati restituiscono un quadro assai articolato di que-sto dibattito, evidenziando luci ed ombre, ma soprattutto la complessitàdi uno strumento che, quale che sia il giudizio globale, è destinato amutare il quadro della tutela e della gestione del nostro patrimonio cul-turale.
Poiché il processo di applicazione del codice, che si sta avviando inquesti mesi e non appare esente da incertezze interpretative, attraver-serà una fase “sperimentale” di due anni legata al carattere di legge-delega, non sembra inutile fornire, in questa fase, i materiali di com-mento e analisi elaborati in occasione della manifestazione promossadall’IBC.
Il colloquio si è focalizzato sul rapporto Stato-Regioni e sui nuovicompiti ai quali saranno chiamati gli enti locali nel loro complesso; nellaconvinzione che proprio questo sia uno degli aspetti più importanti delcodice, la verifica del quale è, come detto, in corso e sul quale si col-lauderà la sua reale efficacia come strumento moderno di tutela e valo-rizzazione del nostro patrimonio culturale e paesaggistico.
L’iniziativa si inquadra all’interno del programma di manifestazionicon le quali si è inteso ricordare i 30 anni di attività dell’IBC:un’istituzione unica nel suo genere in Italia che, fin dall’origine, ha af-fiancato il Ministero nella sua opera di salvaguardia e conoscenza deibeni culturali, primo e concreto esempio di quanto lo spirito quotidianodi collaborazione e la sinergia delle risorse possano giovare al perse-guimento ordinato di comuni obiettivi.
In sede di pubblicazione, si è ritenuto opportuno allegare agli atti al-cuni documenti che, proprio perchè fonte primaria di riferimento o di ri-flessione per molti dei relatori, poteva essere utile metter a riscontro.
Così, oltre al Codice, sono riportati la “Convenzione europea delpaesaggio” firmata a Firenze nel 2000, l’“Accordo tra il ministero per i

8 - Presentazione
beni e le attività culturali, la Regione Emilia-Romagna e le Associazionidelle autonomie locali dell’Emilia-Romagna” del 2003 ed è stato inseritoanche, recentissimo, 3 marzo 2005, il “Documento della Conferenzadei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome”.
Le Curatrici
Bologna, marzo 2005

Programma - 9
Regione Emilia-RomagnaIstituto per i beni artistici culturali e naturali - IBC
regioni e ragioninel nuovo codice dei beni culturali e del paesaggioBologna, 28 maggio 2004 - Sala di rappresentanza Unicredit Banca
Programma
Apertura dei lavoriGian Mario Anselmi, Membro del consiglio direttivo dell'Istituto Beni Culturali,Regione Emilia-RomagnaMarco Barbieri, Assessore alla Cultura della Regione Emilia-RomagnaAlessandro Zucchini, Direttore dell'Istituto Beni Culturali
I beni culturaliRelazione introduttiva e coordinamento:Marco Cammelli, Ordinario di Diritto Amministrativo, Università di Bologna -Direttore Rivista AEDON
Interventi:Daniele Carletti, Ministero per i Beni e le Attività CulturaliMariella Zoppi, Assessore alla Cultura della Regione ToscanaElio Garzillo, Soprintendente regionale per i Beni e le Attività Culturali dell’Emilia-RomagnaAlberto Vanelli, Direttore ai Beni Culturali della Regione PiemonteMichele Trimarchi, Straordinario di Scienza delle Finanze, Università di Catanzaro“Magna Graecia”Andrea Emiliani, Accademico dei LinceiBruno Toscano, Ordinario di Storia dell’Arte Moderna, Università di Roma Tre
Il paesaggioCoordinamento:Paolo Conti, Giornalista, Corriere della Sera
Interventi:Giovanni Lo Savio, MagistratoGiancarlo Poli, Responsabile Servizio di valorizzazione e tutela del Paesaggio dellaRegione Emilia-RomagnaEdoardo Salzano, UrbanistaAnna Marina Foschi, Responsabile del Servizio Beni architettonici e ambientali,Istituto Beni Culturali, Regione Emilia-RomagnaAlberto Clementi, Segretario della Società Italiana degli Urbanisti


Gian Mario Anselmi - 11
Introduzione al convegnoGian Mario AnselmiMembro del Consiglio Direttivo dell’Istituto Beni Culturali, Regione Emilia-Romagna
Istituto Beni CulturaliVia Galliera, 2140121 – Bologna
Non è casuale che nel trentesimo della sua fondazione, l’Istituto ab-bia voluto dedicare un convegno di analisi e di critica, attenta riflessio-ne al nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio. La puntualità e laricchezza dei contributi che si sono dispiegati nonché l’accurata prepa-razione che l’Istituto nel suo insieme, a cominciare dal suo Presidente,professore Ezio Raimondi e dal suo Direttore, Alessandro Zucchini, vihanno profuso testimoniano dell’importanza e della gravità del mo-mento. Così come lo testimonia l’oculata partecipazione dell’assessorealla Cultura della Regione Emilia-Romagna, Marco Barbieri.
Dalla nostra Regione deve partire una stagione di riflessione maanche di intensa progettualità: la nuova legislazione, e gli interventi delconvegno lo mostrano bene, porta a dinamiche nuove ma con corredipericolosi per la tutela e la salvaguardia di tutto il patrimonio nazionale.
Né sono affatto evitati i pericoli di conflitti di competenze e di incer-tezze nelle applicazioni normative. Mentre la nostra Regione, e propriotramite l’IBACN, ha saputo sempre coniugare progettualità e tutela, po-litica del giusto vincolo ed energia ordinatrice di progetto.
Ora non è il tempo di arrendersi passivi alle contraddizioni dellanuova legislazione. Occorre mettere al centro delle politiche regionali lacultura e individuare punti eccellenti per il lavoro futuro. Ne indichiamointanto alcuni a titolo esemplificativo:1) parchi archeologici;2) itinerari letterari con valorizzazione delle case dei poeti e degli
scrittori;3) sistemi integrati fra le realtà museali;4) rigoroso impegno sulla memoria storica, specie otto-noventesca,
con investimento sui ricchi depositi documentari che la caratteriz-zano e in accordo naturale con il sistema bibliotecario;
5) laboratori di ricerca sul patrimonio musicale e teatrale, sulla tradi-zione dei dialetti, sulla cultura gastronomica e alimentare;
6) organici interventi sull’identità del paesaggio e dei beni naturalicome fondamento del profilo stesso della nostra Regione.

12 - Introduzione al convegno
Tutte queste sono priorità essenziali per ogni politica regionale chedavvero non accetti di subire passivamente le aporie della legislazionenazionale ma voglia costruttivamente proporre percorsi per una veraprogettualità sul futuro, fuori dalle secche di sterili contrapposizioni fracentri e periferie. E si può immaginare, se scuole e università vi sapes-sero dialogare, se fondazioni e privati vi sapessero cogliere le opportu-nità di tali disegni (il primo riferimento va naturalmente al turismo),quale inedito slancio al tempo stesso formativo e produttivo potrebbeaccompagnare questa nuova stagione dell’Emilia Romagna per la cul-tura.
È con questi auspici e con queste prospettive che il convegno ènato e può costituirsi come punto d’orientamento essenziale per il futu-ro.
Grazie a tutti quelli che vi hanno partecipato, che lo hanno prepa-rato e che vorranno continuare comunque a progettare con noi il pre-zioso futuro dei beni culturali.

Marco Barbieri - 13
Alla ricerca di un accordoMarco BarbieriAssessore alla cultura della Regione Emilia-Romagna
Assessorato alla cultura, Regione Emilia-RomagnaViale A. Moro, 6440127 Bologna
Il 2004 ha rappresentato, nel settore dei beni culturali e più in gene-rale per l'intero comparto cultura, un momento di grande mutamentonon privo di alcune ombre.
L'approvazione della riorganizzazione del Ministero e del nuovo Co-dice di tutela hanno contraddistinto i primi mesi di quell'anno.
Il Ministero, a pochi anni dall'ultima riforma, affronta nuovamente uncomplessivo riassetto che vede in molti punti radicalizzati e talvoltaampiamente reinterpretati gli orientamenti sottesi al precedente prov-vedimento. Ringrazio quindi l'Istituto per i Beni Culturali per avere of-ferto l'opportunità di questo incontro in un momento decisivo per la tu-tela e la politica dei beni culturali nel nostro paese.
Lo scenario legislativo e operativo dei beni culturali è oggi profon-damente diverso da quello col quale, tutti noi, amministratori e operatorieravamo abituati a confrontarci.
A semplice titolo di esempio ricordo che la figura del Soprintendenteregionale, cui originariamente erano prevalentemente affidati compiti dicoordinamento, diviene ora - sulla base delle disposizioni più recenti -un funzionario a tutti gli effetti sovraordinato ai sovrintendenti di settoree dotato di ampi poteri in termini decisionali e di spesa.
La nomina dei nuovi dirigenti ministeriali e dei nuovi Soprintendentiregionali è stata ripresa con grande risalto da tutta la stampa nazionale.Le Regioni stesse hanno appreso delle nuove designazioni dalle pagi-ne dei quotidiani, e non si può non sottolineare con rammarico che, suun tema così importante e delicato per l'azione diretta sul territorio, nonvi sia stato un maggiore coordinamento fra Ministero e Presidenti delleRegioni.
Accanto alla riorganizzazione ministeriale è entrato in vigore dal 1maggio 2004 il nuovo Codice di tutela che è oggetto dell'incontro di og-gi. Si tratta di un testo con più ampie aspirazioni rispetto al Testo Unicodel ‘99, prevalentemente compilativo. Quest’ultimo, senza intaccare lasostanza della vecchia legge del '39, riordinava la materia, in molti casi

14 - Alla ricerca di un accordo
frammentata tra diversi provvedimenti, e ne forniva un compendio piùfacilmente consultabile.
Sul nuovo Codice il dibattito nazionale è stato intenso e il confrontofra Stato e Regioni serrato e non privo di punti di asprezza. Queste ul-time in particolare si aspettavano da un lato di vedere ampiamente edefficacemente messe in pratica le affermazioni contenute nel nuovo ti-tolo V della Costituzione, dall'altro di vedere riconosciuti decenni diconcreto impegno nel campo della conoscenza e della valorizzazionedei beni culturali, nonché della salvaguardia del paesaggio e dei centristorici. Il dibattito sul nuovo testo di legge è intenso e certamente l'in-contro promosso dall'Istituto Beni Culturali rappresenta una preziosaoccasione per confrontare diversi e autorevoli pareri in proposito. Milimito quindi a sottolineare alcuni aspetti.
In primo luogo vorrei richiamare lo sforzo che è stato compiuto perpassare da un testo unico di carattere compilativo ad un riassetto si-stematico complessivo della normativa.
Se dovessi indicare il carattere distintivo del nuovo testo con unafrase o un singolo vocabolo, indicherei la parola "accordo" o "intesa".
Due nozioni che tornano ripetutamente, in ossequio anche alla ri-forma del Titolo V e alla richiesta di concertazione fra i diversi livelliistituzionali.
Certamente le Regioni non hanno ottenuto quel decentramento am-pio che forse si aspettavano, tuttavia sono molte le possibilità che siaprono utilizzando in modo serio ed efficace lo strumento della con-certazione. In questa direzione, peraltro, vanno sia l'accordo di pro-gramma quadro siglato tra Ministero e Regione Emilia-Romagna nel2001, che prevede consistenti interventi di restauro su importanti edificistorici e oggi finalmente in fase di attuazione dopo non pochi e non pic-coli problemi operativi e procedurali, sia l'istituzione della Commissioneregionale per i beni e le attività culturali voluta dal D.Lgs.112 del 1998 eattiva in Emilia-Romagna dal gennaio del 2004.
Ad un forte spirito di collaborazione sono ispirati anche gli articolisulla valorizzazione, dove pure le regioni hanno potestà legislativa con-corrente. Accordi a livello regionale fra Regioni, Enti pubblici territorialie Ministero possono definire modalità, tempi e obiettivi della valorizza-zione. L'accento viene posto sulla "prospettiva di sistema" e apparechiaro l'invito ad affrontare il tema "valorizzazione" in un'ottica ampia,sinergica e integrata.
Tale approccio fa emergere con maggiore chiarezza il tema dellapubblica fruizione. Azioni coordinate di valorizzazione su ampie porzio-ni di territorio potrebbero consentire, non solo una ottimizzazione delle

Marco Barbieri - 15
risorse, ma una razionalizzazione dell'offerta e conseguentemente ren-dere possibili più efficaci e più capillari azioni di comunicazione, promo-zione e informazione culturale.
Uno degli obiettivi, infatti, del governo regionale è consolidare e au-mentare la domanda e fare in modo che la conservazione e la valoriz-zazione dei beni culturali siano percepite come esigenza importante,come servizio necessario e insostituibile.
Occorre in sostanza “far parlare la cultura” e “far parlare di cultura” efavorire sempre più numerosi ed efficaci contatti e approcci ai beni cul-turali e alla cultura in generale da parte di tutti.
Tuttavia non posso nascondere che il nuovo testo di legge destaanche qualche preoccupazione. Si tratta in particolare del dibattuto te-ma delle alienazioni. L'introduzione della verifica di interesse per il de-manio culturale e la successiva possibile dismissione in assenza di di-chiarazione di interesse risulta aggravata dalla disposizione del silen-zio-assenso. Cioè in caso di mancato invio da parte della Soprinten-denza della verifica, questa è da intendersi come negativa e il bene èquindi alienabile. Non è il caso di insistere sulla perversione, a propo-sito della quale anche recentemente si sono levati pesanti attacchi sullastampa nazionale, di questo meccanismo che scarica ogni responsabi-lità sui già esangui uffici periferici.
Ora non rimane che sperimentare nel concreto e quotidianamente inuovi assetti voluti dal legislatore, armonizzarli con le esigenze del ter-ritorio, le dinamiche dei rapporti istituzionali e le necessità del patrimo-nio storico e artistico la cui salvaguardia è un obiettivo fondamentaleper tutta la collettività.
Infatti i beni culturali rappresentano un'autentica eredità collettiva daaffidare ai nostri figli, possibilmente accresciuta di valore.


Alessandro Zucchini - 17
Ministero e regioni: cronaca di un’intesa impossibileAlessandro ZucchiniDirettore dell’Istituto Beni Culturali, Regione Emilia-Romagna
Istituto Beni CulturaliVia Galliera, 2140121 - Bologna
Introduzione*
Questo intervento vuole essere la cronaca di quanto è successoprima del 16 gennaio 2004, data di approvazione definitiva del Codiceda parte del Consiglio dei Ministri. Una sorta di “dietro le quinte” dellefasi di elaborazione del Codice, dalla parte delle regioni.
Il 6 ottobre 2002, con la legge n. 137, il Ministero per i Beni e le Atti-vità culturali ottiene la delega per il riordino delle norme in materia dibeni culturali.
Presso il Ministero viene istituita una commissione di giuristi, pre-sieduta dal professore Trotta, alla quale sono invitati a partecipare duerappresentanti delle Regioni italiane.
In vista della designazione degli esperti regionali e della loro parte-cipazione ai lavori, il Presidente della Conferenza dei Presidenti delleRegioni Italiane, Enzo Ghigo, sulla base del documento approvato, il 28gennaio 2002, dalla Conferenza stessa ed illustrato in un’audizione allaCommissione Cultura del Senato, illustra, nel convegno degli Assessoriitaliani alla Cultura e al Turismo, che si svolge a Firenze a fine febbraio2003, l’orientamento delle Regioni Italiane.
Per le Regioni la delega per la revisione del T.U. 490/99 rappre-senta un’occasione importante per adeguare la legislazione al dettatocostituzionale introdotto dal nuovo titolo V e al quadro culturale, socialee istituzionale radicalmente modificato rispetto a quello nel quale erastata definita la legge 1089/39.
“L’Italia del 1939 - afferma il Presidente Ghigo - era un paese agri-colo, povero, con un livello culturale relativamente limitato in cui esiste-va il problema di salvaguardare il patrimonio culturale dai rischi di ab-bandono, incuria che il patrimonio stesso correva. Dunque era indiscu-tibilmente necessaria un’autorità esterna che dettasse le condizioni di
* Si ringrazia la dottoressa Sonia Amarena delle note fornite, che hanno costituito la trac-cia fondamentale per questo intervento.

18 - Ministero e regioni: cronaca di un’intesa impossibile
conservazione e circolazione dei beni.“Oggi, il quadro è radicalmente mutato e le stesse condizioni cultu-
rali dei singoli e della comunità manifestano, in maniera ampia e co-munque crescente, consapevolezza del patrimonio di cui dispongono eche esso è elemento costitutivo dell’identità di una comunità. Alla lucedi tutto ciò, le Regioni chiedono che la nuova norma preveda, innanzi-tutto, una definizione certa e precisa del concetto di tutela, definisca lemodalità di cooperazione ed intesa tra i compiti dello Stato, quelli delleRegioni e delle altre Autonomie nell’esercizio delle funzioni amministra-tive di tutela; si limiti a specificare i principi fondamentali in materia divalorizzazione.” (dall’intervento del Presidente Ghigo - Convegno degliAssessori alla cultura e al turismo d’ Italia - Firenze, 27 febbraio 2003).
1) La Commissione TrottaLa professoressa Anna Poggi e chi scrive vengono nominati rap-
presentanti regionali in seno alla Commissione Trotta (a loro si aggiun-geranno, per la parte del paesaggio, Umberto Vascelli Vallara, Direttoregenerale del territorio e urbanistica della Regione Lombardia e FrancoFerrero, Direttore generale per la pianificazione e gestione urbanisticadella Regione Piemonte) e presentano, il 6 marzo 2003, un elenco dipunti qualificanti e preliminari, che caratterizzano la posizione regionalesul nuovo Codice:• la definizione di bene culturale deve essere di tipo sintetico e non
analitico. Il Codice deve limitarsi ad indicare il principio di individua-zione, mentre l’attività di elencazione degli stessi beni deve essererinviata ad atti di tipo diverso.
• va distinta un’idea di tutela come obbligo di conservare il patrimo-nio culturale, che ovviamente riguarda tutti i soggetti pubblici e pri-vati proprietari o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali, da unesercizio di funzioni amministrative di tutela quali autorizzazioni, di-vieti, vincoli o altri atti incidenti su un bene culturale al fine di rico-noscerlo, conservarlo e proteggerlo. La tutela in senso giuridico, alfine di un esercizio unitario sul territorio nazionale, deve essere dicompetenza statale, ma vanno comunque previste forme d’intesacon singole Regioni in materia di tutela, secondo quanto previstodalla Costituzione (art. 118, terzo comma).
• vanno confermate ed eventualmente completate le deleghe di tu-tela in materia di beni librari e beni paesaggistici.
• la valorizzazione dei beni culturali va concepita come funzione voltaa garantire e migliorare le condizioni di conoscenza e conservazio-

Alessandro Zucchini - 19
ne dei beni e a garantirne il pubblico godimento, l’utilizzazione e lafruizione.
• i principi in materia di valorizzazione devono essere pochi e di ca-rattere generale.
• la disciplina della gestione dei beni culturali di proprietà pubblicanon statale o di soggetti privati senza fini di lucro, va riconosciutaalla legislazione regionale.
• la gestione dei beni culturali appartenenti al demanio o al patrimo-nio dello Stato in consegna al Ministero va definita in accordi traMinistero e Regione interessata, sentiti gli enti locali.
Le proposte regionali non vengono nemmeno analizzate e discusse,e la Commissione Trotta sembra, piuttosto, orientarsi verso un artico-lato conservatore e centralista, che aggira e non attua il nuovo titolo Vdella Costituzione. Un segnale evidente di questa tendenza è la propo-sta di riportare allo Stato le funzioni amministrative di tutela del patri-monio librario e paesaggistico (già delegate alle Regioni dagli anni ‘70)e la definizione della valorizzazione del patrimonio culturale come “ogniattività diretta a favorirne, anche economicamente, la fruizione”.
Vista la difficoltà di costruire un confronto sereno e costruttivoall’interno della Commissione Trotta i rappresentanti regionali rasse-gnano le dimissioni il 16 aprile 2004.
2) Ministero e Regioni direttamente a confronto: verso una se-conda rottura
Conseguentemente alle dimissioni dei rappresentanti regionali, ilPresidente Ghigo scrive al Ministro Urbani chiedendo di avviare, primache il testo licenziato dalla Commissione Trotta venga trasmesso per ilsuo esame in sede di Conferenza Unificata, un nuovo confronto tra Mi-nistero, Regioni ed Autonomie Locali per pervenire ad un’intesa tra leistituzioni.
L’8 maggio 2003 la Conferenza dei Presidenti approva il documentodal titolo “Più tutela, più valorizzazione”. Un documento programmaticoche segna una svolta decisiva nella politica regionale in materia di beniculturali. Le Regioni elaborano proposte nuove, ispirate dall’obiettivo diun rafforzamento del livello complessivo delle attività di tutela e valoriz-zazione del patrimonio culturale, prevedendo un raccordo tra Stato eRegioni in materia di valorizzazione e l’allargamento, il più possibile, aivari livelli istituzionali del perseguimento delle finalità di tutela.
Il documento, riferendosi nello specifico al nuovo Codice dei beniculturali, chiede che:

20 - Ministero e regioni: cronaca di un’intesa impossibile
1) il nuovo Codice sia una legge di principi sia per quanto at-tiene alla valorizzazione, sia in materia di tutela, delegandoil più possibile agli strumenti pattizi la definizione di stan-dard, indirizzi, linee guida e procedure in materia di valoriz-zazione;
2) il nuovo Codice non rinvii ai regolamenti previsti dal sestocomma dell’art. 117 Cost. che, distinguendo rigidamente leattribuzioni delle potestà regolamentari tra Stato e Regioni,apriva la strada a rischi di contenziosi.
3) il nuovo Codice non comporti in alcun modo arretramentirispetto al sistema di deleghe, già operanti dai DPR del ’72e del ’77 in materia di beni librari e di paesaggio, ma piutto-sto il sistema sia completato organicamente ed eventual-mente esteso.
Il documento dell’8 maggio viene condiviso ed adottato da ANCI edUPI, che si affiancano alle Regioni nel confronto con il Ministero.
Il Ministro Urbani risponde di essere favorevole a riavviare il con-fronto con le Regioni e le Autonomie Locali, ma precisa, appellandosialla legge delega che prevede che non si abbassi il livello attuale di tu-tela e si conservino gli strumenti in vigore, di non poter accogliere laproposta di un Codice agile e snello, che definisca esclusivamente iprincipi.
Per il resto il Ministro manifesta la propria piena disponibilità, dichia-ra di valutare sia la possibilità di ampliare le deleghe già esistenti inmateria di tutela, sia tutti gli emendamenti e modifiche al testo “Trotta”,che le Regioni vogliano avanzare.
In un clima più sereno e costruttivo, anche se la trattativa raggiungetalora punte aspre, si svolgono diversi incontri tra l’Ufficio Legislativodel Ministero e una delegazione delle Regioni in materia di beni cultu-rali, coordinata dal dottor Alberto Vanelli, Direttore ai Beni culturali dellaRegione Piemonte, in quanto regione capofila in materia.
Paradossalmente, anche se con grande fatica, si conviene sui prin-cipi generali e sulla parte attinente la tutela, ma la trattativa si interrom-pe bruscamente, a fine luglio, quando si passa all’analisi del titolo sullavalorizzazione.
Nella definizione ministeriale di valorizzazione, si annidaun’interpretazione della valorizzazione come mera attività di erogazionefinanziaria e servizio promozionale, che confinerebbe le Regioni e glienti pubblici territoriali in una funzione ancillare agli uffici di tutela.
Le Regioni non chiedono che la valorizzazione dei beni dello Statosia soggetta tout court alla competenza legislativa e regolamentare re-

Alessandro Zucchini - 21
gionale, ma propongono piuttosto che le modalità di valorizzazione delpatrimonio culturale siano definite mediante accordi o intese al fine digarantire armonizzazione, integrazione e coordinamento nella gestionedei servizi culturali.
Il Ministero, diffidente, non accoglie i suggerimenti delle Regioni,rompe il negoziato e decide di procedere da solo alla stesura del testodi legge.
3) L’estate non porta consiglio Il 29 settembre 2003 il Ministero propone al Consiglio dei Ministri,
che lo approva in via preliminare, uno schema di Codice in cui nessunodei punti qualificanti richiesti dalle Regioni sembra essere stato recepi-to.
Il quadro che emerge dal testo del 29 settembre è piuttosto allar-mante perché, attraverso la norma, sembrano compiuti passi indietrorispetto al quadro legislativo vigente e messe in difficoltà e sostanzial-mente negate situazioni ampiamente consolidate nella realtà, situazioniche vedono compartecipi, accanto al Ministero, soggetti locali, pubblicie privati, nei processi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonioculturale.
Pertanto, il 23 ottobre 2003, la Conferenza dei Presidenti delle Re-gioni approva un ordine del giorno in cui ribadisce l’orientamento delleRegioni e chiede al Governo di riaprire un confronto serrato sui teminon condivisi. Qualora ciò non sia accettato, le Regioni richiedono cheil Codice si limiti a riordinare la materia della tutela dei beni culturali,escludendo la normazione della valorizzazione, sulla quale si chiede diavviare un confronto secondo le procedure previste dall’art. 1 della leg-ge 131/2003.
Nell’ordine del giorno le Regioni lamentano che lo schema di Codi-ce, nella Parte prima Disposizioni generali, dilati la definizione di tutelaintroducendo finalità di “promozione della coscienza della comunità edel suo territorio” e attività di conoscenza, che troverebbero un più cor-retto inserimento nella valorizzazione; per altro verso, riduce la valoriz-zazione a mera attività di sostegno economico, al miglioramento dellecondizioni di conservazione e all’incremento della fruizione, escludendoin tal modo l’accessibilità, fruibilità ed utilizzazione dei beni culturalidalle competenze di valorizzazione.
L’intero Codice sembra pervaso da norme volte ad affermare che ilMinistero esercita tutte le funzioni; gli altri partners, istituzionali e non,vengono collocati in una posizione subordinata e marginale nell’attivitàdi salvaguardia e promozione del patrimonio culturale, in netto contra-

22 - Ministero e regioni: cronaca di un’intesa impossibile
sto con l’articolo 9 Cost., che affida all’intera Repubblica, e non soltantoallo Stato, il compito di tutelare il patrimonio storico-artistico e di svilup-pare la crescita culturale del nostro paese.
La stessa affermazione, introdotta all’art.1, che il patrimonio cultu-rale costituisce e rappresenta l’identità nazionale appare inserita alloscopo di riportare al governo centrale ogni funzione di tutela e di valo-rizzazione, escludendo le comunità e le istituzioni locali dalla partecipa-zione all’amministrazione del patrimonio.
Nel titolo II, Fruizione e valorizzazione, viene operata un’artificiosaed incostituzionale separazione tra attività di fruizione e quella di valo-rizzazione con il solo scopo di svuotare di organicità l’attività di valoriz-zazione che, come già si è detto, viene ridotta a sponsorizzazione e adiniziative pubblicitarie e promozionali.” (dall’ordine del giorno dellaConferenza dei Presidenti - 23 ottobre 2003).
4) La stretta finaleIl Ministro per gli Affari Regionali, Enrico La Loggia, ricevuto l’ordine
del giorno, convoca urgentemente, il 29 ottobre, una riunione con ilPresidente della Conferenza dei Presidenti, Enzo Ghigo, e il Ministroper i Beni e le Attività culturali, Giuliano Urbani.
In quella sede il Presidente Ghigo illustra ancora una voltal’orientamento comune alle Regioni e agli Enti Locali e sottolinea comeil Ministero, preoccupato che la valorizzazione equivalga a competenzadelle Regioni e non anche dello Stato, ne svuoti, attraverso il Codice, ilsignificato e allarghi le finalità della tutela. Il presidente chiarisce che lavalorizzazione compete a tutti i livelli istituzionali della Repubblica e chela legislazione regionale attua sul proprio territorio, non nei confrontidegli uffici e dei beni del patrimonio dello Stato, ciò che prevede lanorma nazionale. Alla luce di ciò vengono proposti degli emendamentisul Codice approvato in via preliminare e il Ministro Urbani si dichiaradisponibile ad analizzarli.
La riunione si conclude con il mandato agli Uffici Legislativi dei dueMinisteri e a una rappresentanza del coordinamento delle Regioni apervenire ad un’intesa entro il 10 dicembre, quando in sede di Confe-renza Unificata sarà all’ordine del giorno, il Codice.
Dopo un intenso lavorio, con ritmi concitati e talora esasperati, fi-nalmente, in sede tecnica si perviene a un testo condiviso da Ministero,Regioni e Autonomie Locali.
Rimane in sospeso e rimesso alla decisione politica un unico punto:l’articolo 6 (valorizzazione del patrimonio culturale).

Alessandro Zucchini - 23
In sede politica il Ministro Urbani dichiara di comprendere e condivi-dere la finalità di tale punto, ma di riservarsi qualche giorno per formu-lare una proposta che lo recepisca.
Dopo qualche giorno di telefonate ed e-mail assidue e agitate, siconviene sulla seguente formulazione: “la valorizzazione concerne an-che la promozione e il sostegno alla conservazione”.
Finalmente, dunque, il testo di legge risulta condiviso nella sua inte-rezza.
5) Poteva andare tutto bene?Dopo l’approvazione in Conferenza Unificata, il testo viene trasmes-
so e sottoposto all’approvazione delle commissioni cultura della Came-ra e del Senato.
La Commissione cultura del Senato esprime, già a dicembre, parerefavorevole. La Commissione della Camera, invece, convoca, perun’audizione, il 9 gennaio 2004, le Regioni, ANCI ed UPI che, di frontead essa, riconfermano il parere favorevole.
Per le Regioni, congiuntamente ad ANCI ed UPI, risultano elementipositivi del nuovo testo :
• l’essere pervenuti a definizioni precise e condivise di tutela evalorizzazione, che superano le non sufficientemente determi-nate definizioni dell’art. 149 del D. Lgs. 112/98, compiendo unsignificativo passo avanti nell’attuazione del dettato costituzio-nale; in quest’ambito risulta di rilievo l’aver inserito anche lapromozione e il sostegno alle attività e agli interventi di conser-vazione tra le funzioni connesse alla valorizzazione, consen-tendo in tal modo alle Regioni di legiferare in tale campo;
• il Codice non solo conferma le funzioni di tutela già esercitatedalle Regioni, ma le estende, completando le attribuzioni aglialtri beni librari e ai beni audiovisivi ed introduce la possibilità diulteriori attribuzioni di tutela mediante accordi ed intese, anchea geometria variabile;
• il Codice accoglie, all’art. 29, la proposta delle Regioni di defini-re a livello nazionale norme tecniche, linee guida e criteri per laconservazione dei beni culturali, riducendo in tal modo la di-screzionalità degli uffici di tutela;
• il Codice introduce, per la prima volta nella legislazione, graziead una forte iniziativa di Regioni, Province e Comuni il concettodi istituto culturale e luogo della cultura, definendo musei, bi-blioteche, archivi, complessi monumentali, parchi ed aree ar-cheologiche, qualificandoli come servizi pubblici, superando, in

24 - Ministero e regioni: cronaca di un’intesa impossibile
tale modo, una concezione puramente patrimonialistica dei be-ni culturali;
• il Codice prevede la possibilità di costituire congiuntamente traMinistero, Regioni e altri soggetti pubblici e privati, centri di do-cumentazione e centri per il restauro e la formazione dei re-stauratori, precisando, in tale ambito, le modalità per la forma-zione degli stessi;
• il Codice non solo consente, ma afferma l’esigenza del concor-so dei privati all’attività di valorizzazione;
• è confermata la possibilità del Ministero di conferire la gestionedi musei e altri beni culturali a Regioni, Province e Comuni, conprocedure semplificate rispetto a quelle previste dall’ex art. 150del D. Lgs. 112/98;
• il Codice, infine, introduce la procedura negoziale e pattizia perla gestione della fruizione e della valorizzazione dei beni cultu-rali.(dalla relazione dell’Assessore Giampiero Leo, Assessore allaCultura della Regione Piemonte. Commissione cultura dellaCamera, 9 gennaio 2004).
Durante l’audizione, la Commissione Cultura della Camera valutapositivamente il testo di legge approvato dalla Conferenza Unificata,apprezzando il lavoro svolto congiuntamente da Ministero, Regioni edAutonomie Locali e condividendone ampiamente lo spirito.
Nel verbale dell’audizione, però, mentre da una parte la Commis-sione ribadisce la necessità che il Governo accolga il testo formulato inConferenza Unificata, dall’altra pone come condizioni del parere favo-revole due emendamenti agli articoli 4-5, articoli che disciplinano lefunzioni delle Regioni in materia di tutela del patrimonio culturale e co-stituiscono uno dei capisaldi dell’equilibrio istituzionale raggiunto.
Le richieste della VII Commissione della Camera non vengono noti-ficate né alle Regioni né agli Enti Locali che le apprendono casual-mente ed informalmente poche ore prima del Consiglio dei Ministri, chedeve approvare in via definitiva lo schema di Codice. Dopo un susse-guirsi di telefonate concitate e nervose, finalmente pochi minuti primadel Consiglio, il Ministero e le Regioni pervengono a una formulazionedegli articoli 4 e 5, che accoglie i suggerimenti della Commissione e,allo stesso tempo, non modifica sostanzialmente i concetti espressi, ri-spettando e non turbando l’intesa che, dopo un anno di intenso e logo-rante lavoro, le istituzioni avevano raggiunto.
Il nuovo testo viene così approvato dal Consiglio dei Ministri in viadefinitiva il 16 gennaio 2004.

Maria Pia Guermandi - 25
Centro e regioni: la necessità di un sistemaMaria Pia GuermandiIstituto Beni Culturali, Regione Emilia-Romagna
Istituto Beni CulturaliVia Galliera, 2140121 - Bologna
Un patrimonio contesoLa giornata di confronto di cui questi Atti costituiscono testimonianza
si collocava all’interno di un percorso di riflessione e di approfondi-mento sulle tematiche aperte dall’applicazione del Codice intrapresodall’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna fin dalle fasi dielaborazione del Codice stesso (v. relazione Zucchini). Tale percorso sista tuttora svolgendo, in questo primo anno di applicazione della nuovalegislazione, soprattutto attraverso il confronto con le altre regioni im-pegnate nell’apposito gruppo di lavoro costituito all’interno della confe-renza delle regioni. La manifestazione del 28 maggio non a caso erafocalizzata proprio sul nuovo rapporto Stato-Regioni che il Codice inau-gura, nella convinzione che proprio questo sia uno degli snodi più im-portanti, la verifica del quale ci accompagnerà per i mesi futuri e sulquale si collauderà la reale efficacia del Codice come strumento di tu-tela e valorizzazione del nostro patrimonio culturale.
A livello nazionale la discussione, inevitabilmente, si è incentratasoprattutto su alcuni temi “caldi”: il meccanismo del silenzio-assenso, ildiverso ruolo delle soprintendenze all’interno di un mutato modello divincolo, la contrapposizione tutela-valorizzazione che riproducel’antagonismo centro-periferia. Tutti temi che trovano puntuali e appas-sionati echi nel dibattito che si è svolto in sede di convegno.
L’ultimo scorcio del 2004 ha visto il riaccendersi delle polemichesulla tutela del nostro patrimonio culturale e paesaggistico oltre che sulruolo delle regioni in questo ambito. L’annosa querelle, che si inserisce,a pieno titolo, nel più ampio dibattito del rapporto stato-regioni ha vistoil coagularsi di due schieramenti, contrapposti quasi sempre in manieramolto netta, ed è stata rilanciata dall’impugnazione, da parte del gover-no, del nuovo statuto regionale toscano che annoverava la tutela delpatrimonio fra le finalità dell’amministrazione regionale e che ha provo-cato il riaccendersi di un dibattito mai sopito fra fautori del centralismoministeriale e “federalisti culturali”.

26 - Centro e regioni: la necessità di un sistema
Da subito, in fase di redazione del Codice, le regioni, hanno lamen-tato di essere state coinvolte solo in uno stato di elaborazione giàavanzata dello strumento legislativo, quando l’ossatura del testo era giàcostituita, fatto tanto più grave in quanto uno degli obiettivi principali delCodice stesso, anzi il principale, come più volte ribadito dallo stessoMinistro, era l’adeguamento legislativo, anche in questo settore, almutato quadro costituzionale venutosi a creare con la riforma del titoloV della Costituzione.
Subito dopo l’entrata in vigore del Codice, a questa prima fase è su-bentrato un periodo, si può dire, di riflessione giuridica, che ha vistol’avviarsi di una esegesi molto puntuale e dettagliata e che ha portato asottolineare aspetti innovativi e positivi del Codice, pur presenti in ognisua parte, come anche ambiguità sulle quali occorrerà lavorare; da piùparti si è cercato quindi, in quest’ultimo periodo, di esercitare una critica“pragmatica” tesa alla sperimentazione e all’enucleazione di eventualielementi correttivi, tanto più che proprio per il carattere di legge delegache il provvedimento riveste, esiste ancora un margine per aggiusta-menti e parziali ripensamenti.
Fra tutela e valorizzazioneA scopo riassuntivo e senza alcuna pretesa di illustrare una vicenda
così complessa - anche perché non ancora stabile - in tutti i suoi risvoltisi cercherà, in questa nota, di riassumere i temi del dibattito emersinella giornata di studio promossa dall’Istituto, accennando al contempoanche a quanto emerso nelle fasi successive, soprattutto alla luce di unquadro legislativo che nei mesi passati si è venuto a dir poco compli-cando, con ricadute pesanti nell’ambito della tutela del patrimonio cultu-rale.
Sabino Cassese, fra gli estensori del decreto legislativo, ha affer-mato che i principi del Codice possono essere riassunti in due grandigruppi: quelli sui rapporti pubblico-privato e quelli sulla distribuzionedelle funzioni fra Stato e Regioni.
In questo ambito, come noto, il principio cardine cui si sono attenuti ilegislatori è il dualismo funzionale tutela / valorizzazione, attraverso ilquale si è cercato di risolvere il dualismo istituzionale.
Fra gli aspetti sicuramente positivi introdotti dal nuovo Codice, ilprincipale va individuato, indubbiamente, nel tentativo complessivo disuperare un regime emergenziale di esercizio della tutela. Così comeva sicuramente annoverato anche lo sforzo definitorio: il Codice ha la-vorato molto sui concetti, anche se non poche perplessità sono statesollevate per quanto riguarda talune definizioni (ad esempio quella di

Maria Pia Guermandi - 27
museo, per la quale poteva essere compiuto un maggiore sforzo inno-vativo).
In generale, comunque, si deve riconoscere che l’oggetto della tu-tela risulta piuttosto ampliato relativamente, ad esempio, alle categoriedei beni: nell’elenco (art.10) troviamo, per la prima volta, le piazze, lestrade, gli spazi urbani, i siti minerari, le navi, le tipologie di architetturarurale. E sicuramente, rispetto alle ambiguità presenti nella citatissimariforma del titolo V della Costituzione, è chiarita la sovraordinazionedella tutela rispetto alla valorizzazione, anche se la chiarificazione, purnecessaria, fra gli ambiti delle due funzioni non era forse obbligatoria-mente connessa ad un principio di gerarchizzazione. Sorvolandosull’implicito ossimoro insito nella contrapposizione tutela-valorizzazione: la tutela sancisce, in effetto, il così detto “dirittoall’inutilità” del bene culturale, il bene culturale vale in sé, e non qualeoggetto di scambio o godimento, mentre il concetto di valorizzazionerimanda ad un momento di riduzione del bene a valore di scambio.
Il problema della scissione tutela-valorizzazione era sorto ben primadella riforma del titolo V: in pratica la valorizzazione era divenutal’attività non autoritativa esercitata dalle regioni. Come noto, è con ledisposizioni del d.lgs.n. 112/1998 che viene delineato un sistema sudue funzioni amministrative, da un lato la tutela, dall’altro la valorizza-zione: accanto ad esse il medesimo decreto legislativo aveva indivi-duato una terza funzione: la gestione, intesa come “ogni attività diretta,mediante l’organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare lafruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimentodelle finalità di tutela e valorizzazione”.
Nel Codice si ribadisce che la potestà legislativa in materia di tutelaè riservata allo Stato in maniera esclusiva per “garantire l’eserciziounitario delle funzioni”, anche se da più parti si è ribadito che l’unitarietàsarebbe piuttosto assicurata non da un esercizio di funzioni centralisti-co (peraltro sempre più velleitario in quanto ad una maggiore comples-sità delle funzioni stesse non paiono essere intervenuti ampliamenti so-stanziali a livello di formazione o anche solo di numerosità degli addetti:in altre parole le funzioni si complicano e si differenziano e gli organici,le risorse in genere e gli strumenti rimangono al meglio inalterati), oltreche attraverso un sistema generale di garanzie legislative, con una se-rie di linee guida, standards, criteri: in sostanza elaborando, a livellocentrale (e magari in collaborazione con le Regioni ed altre istituzioni,quali, ad esempio, le Università) una unitarietà di regole e metodologie,di procedure e codici di comportamento e di indirizzo scientificamente

28 - Centro e regioni: la necessità di un sistema
mirati che, soli, possono decretare una reale unitarietà di obiettivi e dirisultati.
Come considerazione finale sul nodo tutela / valorizzazione, occorreinfine accennare al fatto che la separazione delle politiche di vincolo daquelle di valorizzazione e di intervento attivo (pur inevitabile alla lucedella divisione introdotta con la riforma costituzionale) rischia di ignora-re del tutto i nuovi rapporti tra conservazione e sviluppo sostenibile, adesempio per quel che riguarda il nodo cruciale delle politiche di preven-zione che riguardano tanta parte del nostro patrimonio storico, o perquel che riguarda gli interventi socioeconomici necessari nei territoridell’abbandono e della marginalizzazione, che coprono ormai una parteimportante del territorio nazionale.
Per quanto riguarda la tutela, quindi, il ruolo delle regioni è per ilmomento limitato ai beni librari ed al paesaggio, andrà però completatoorganicamente, come peraltro già previsto, per quanto riguarda i benilibrari e potrebbe essere eventualmente esteso ad altre categorie dibeni, anche se i termini di questa delega permangono del tutto vaghi.
In effetti, una lettura ‘ottimistica’ - in senso regionalistico - del Codi-ce porta a sottolineare larghi spazi per un decentramento possibile:quasi tutte le funzioni statali possono essere decentrate con accordi alsistema locale. Le forme di cooperazione Stato-Regione prefigurate dalCodice sono amplissime, anche se le modalità di attuazione, rimango-no completamente da definire.
Beni culturali + paesaggioFra i problemi tuttora aperti che il Codice presenta, il primo fra tutti,
a livello generale, può essere individuato nella definizione di patrimonionel suo complesso che dovrebbe essere intesa non come sommatoriacasuale di individualità, ma con una connotazione di complessod’insieme organico. Il persistere del riferimento esclusivo ai “beni” (cul-turali e paesaggistici: art. 2, c.1) rischia invece di ridurre il patrimonio auna pura collezione di oggetti indipendenti, ignorandone sia i sistemi direlazioni che lo strutturano e lo fanno vivere, sia il rapporto ineludibilecon le comunità di appartenenza: ciò rimanda alle vecchie logiche deglielenchi purtroppo invocati anche per tentare di mitigare gli effetti deva-stanti dei condoni e della svendita dei beni pubblici (si vedano, adesempio, le liste dei beni “non alienabili”), in contrasto con concezioniormai saldamente acquisite a livello scientifico e culturale e soprattuttocon la necessità di territorializzare la tutela e la valorizzazione del pa-trimonio, base imprescindibile di ogni autentico e sostenibile sviluppoeconomico, sociale e culturale.

Maria Pia Guermandi - 29
In materia di paesaggio, uno degli obiettivi dichiarati del Codice eraquello di adeguarsi alla Convenzione europea del paesaggio stipulata aFirenze nel 2000 come anche di fronteggiare i limiti della normativa esi-stente, incapace di contrastare il crescente abusivismo. Nel primo casosi può affermare che il Codice, da un lato, inserendo il paesaggioall’interno del sistema patrimonio culturale compie un indubitabile pro-gresso, dall’altro, però, la definizione di paesaggio che propone recepi-sce in modo alquanto superficiale le linee della Convenzione europea.
Sempre per quanto riguarda l’ambito paesaggistico, oltre al fatto,non secondario, che per la prima volta il paesaggio rientra nel patrimo-nio culturale, gli aspetti innovativi del Codice vanno individuati soprat-tutto nell’estensione dell’azione di tutela all’intero territorio enell’impegno a sviluppare il coordinamento e la collaborazione tra i di-versi soggetti istituzionali. Fra gli aspetti positivi complessivi può essereannoverato, inoltre, il passaggio da un vincolo “nudo” o “muto” ad unvincolo “vestito” o meglio ragionato, che oltre a dare più forza in virtùdella motivazione al vincolo stesso, gli toglie quel sapore di atto auto-cratico dal sapore ancora un po’ borbonico che lo aveva reso bersagliodi critiche violente per un uso, a torto o a ragione, ritenuto troppo di-screzionale.
Nel nuovo Codice, quindi, il patrimonio culturale è costituito dai beniculturali e dai beni paesaggistici, anche se, come sottolineato, si trattadi una unificazione alquanto meccanica.
Si è parlato, in questo senso, di giustapposizione fra i due ambiti;essa risulta tanto più evidente per quanto riguarda il modus operandi:mentre per i beni culturali si continua sostanzialmente nell’otticadell’elenco e quindi della tutela “puntiforme”, per quanto riguarda il pae-saggio l’ottica è o vorrebbe essere sistemica…eppure il paesaggio so-no anche i beni culturali che su di esso insistono e per converso i beniculturali sono tali perché - e spesso soprattutto perchè - inseriti in uncontesto territoriale.
È impossibile concepire la tutela di un monumento indipendente-mente dalla salvaguardia del paesaggio che lo accoglie e che, conte-stualmente, concorre a determinarne il valore culturale. La compren-sione di un immobile di pregio così come di un oggetto d’arte non è se-parabile dalla conoscenza dei caratteri storici e naturalistici del territorionel quale si collocano e del quale rappresentano emergenze visibili,capaci di esprimerne il valore culturale.
La divisione tra beni culturali e paesaggistici, pur essendo compren-sibile alla luce delle tradizioni nazionali in materia di conservazione, èdifficilmente sostenibile non solo sul piano strettamente scientifico e

30 - Centro e regioni: la necessità di un sistema
culturale, ma, in taluni casi, anche sul piano applicativo: basti pensareai centri storici, praticamente assenti dal Codice, se non ridotti alla figu-ra di “monumenti complessi”: non rientrano infatti nei beni culturalielencati all’art.10 e sono esplicitamente esclusi dai beni paesaggisticienumerati all’art.142. Anche in questa direzione il ruolo delle regionipotrà risultare decisivo in senso migliorativo e l’Emilia-Romagna, grazieanche al decennale apporto di ricerca dell’IBC, può sfruttare, in questosettore specifico, il vantaggio di un patrimonio di conoscenza e docu-mentazione ampiamente riconosciuto.
In generale, comunque, il Codice sancisce l’abbandono della logicabinaria vincolo/non vincolo a favore di una disciplina estesa all’interoterritorio e valorizza il piano paesaggistico affidato alle regioni, qualestrumento di gestione dinamica del territorio stesso e dei valori culturaliche esso esprime.
Il piano paesaggistico, non limitato alla considerazione dei soli beni“vincolati” per legge, ma esteso appunto all’intero territorio, assumeun’efficacia anche prescrittiva immediatamente prevalente sulla ordina-ria pianificazione territoriale che, per conseguenza, è tenuta ad ade-guarsi ad esso.
In questo senso col Codice si modifica radicalmente l’impianto della“tutela per categorie” di beni ambientali introdotto dalla Galasso chescontava la frammentarietà e l’episodicità delle azioni di tutela.
Si tratta di un passaggio importante e non privo di rischi, laddove sipensi che nel 1985 l’introduzione delle categorie di beni ambientali epaesaggistici tutelati ope legis ha comportato l’estensione del vincolopaesaggistico a oltre il 50% del territorio nazionale, mentre i vincoli ditipo provvedimentale coprirebbero, attualmente, solo circa il 18% delterritorio.
Altra lacuna importante sulla quale le regioni saranno chiamate, au-spicabilmente, ad introdurre elementi correttivi, consiste nell’assenza,nel Codice, di alcuni dei principali temi che la riflessione delle disciplinedel territorio ha invece messo in evidenza negli ultimi anni: la crisi delpaesaggio agrario, lo sradicamento delle popolazioni insediate sul ter-ritorio dove si sono infrante le relazioni d’uso che legavano una comu-nità al suo ambiente, o ancora i diffusi processi di omologazione deipaesaggi, legati a forme di urbanizzazione estensiva che dissolvono ilconfine tra urbano e rurale e che tendono a ridurre sempre più il ruolodel paesaggio come elemento di riconoscimento identitario.
Per conseguenza, nelle definizioni delle categorie che connotano ibeni ambientali prevalgono quasi esclusivamente i criteri ancora larga-

Maria Pia Guermandi - 31
mente improntati sui valori estetici, senza considerare che per il pae-saggio si parla da tempo di biodiversità e naturalità diffusa.
Infine, a livello complessivo, fra gli elementi di perplessità sui qualioccorrerà concentrare l’attenzione futura, è stata anche rilevata, da piùparti, l’inadeguata formulazione del ruolo della pianificazione: pratica-mente assente nella prima parte (anche per il riferimento esclusivo alconcetto di bene, a cui sfugge, come detto, la dimensione territorialecon tutti i suoi articolati rapporti tra istanze ambientali e interessi eco-nomici e sociali) nella quale si parla piuttosto di cooperazione, e conce-pito, nei confronti del patrimonio paesaggistico, in chiave essenzial-mente protezionista, in cui si privilegia l’attenzione agli oggetti piuttostoche ai processi.
Il ruolo delle regioniQuanto fin qui annotato, sottolinea, in sostanza, il carattere com-
plessivo del Codice come un congegno giuridico complesso, nel qualesono percepibili ancora tensioni irrisolte, derivate dal tentativo di me-diazione fra istanze diverse e che, nella versione attuale, suscita nume-rose incertezze interpretative. Talune di queste incertezze possono es-sere lette come conseguenze della modifica costituzionale ancora ogginon del tutto chiarita e consolidata. Talché il sospetto di eccessivafretta svolto nei confronti di un Codice che arriva a pochissimi anni dalriordino comunque operato dal Testo Unico, quasi a voler fissare, intempi rapidissimi, un punto acquisito lungo il percorso di una devolutionancora da compiersi.
Indecisioni e ambiguità sono inevitabili e in qualche misura utili per-ché consentono di dare vita alla legge interpretandola in modo“creativo”: fin d’ora occorre quindi lavorare nella direzione diun’integrazione propositiva rispetto alle lacune già evidenziate e di unadeguamento alle esigenze che emergeranno, in un’ottica di reale sus-sidiarietà e cooperazione fra centro e periferie e richiamandosi ad unimpegno storicamente ancor più appropriato.
Le regioni, come detto, vengono ad essere lo snodo fondamentale,in quanto impegnate sui due versanti: sia nei confronti dello Stato chenei rapporti con gli enti locali: a loro spetterà, innanzi tutto, la disciplinadell’iniziativa degli altri enti pubblici in materia di gestione dei beni cultu-rali e nell’organizzazione del territorio, poiché se, soprattutto in questoambito, il principio dell’autorità viene sempre più sostituito da quelloispirato ad una responsabilità condivisa e partecipativa, questo non de-ve far derogare la pubblica amministrazione, in quanto unica a poter

32 - Centro e regioni: la necessità di un sistema
rappresentare bisogni ed esigenze dell’intera collettività, dall’azione re-golatrice.
Il ruolo delle regioni in materia di costruzione partecipata delle politi-che per il territorio, viene, perciò, ad essere determinante. Per portaresolo qualche elemento esemplificativo, fra i tanti possibili, affinché lapianificazione paesistica possa avere contenuti realmente innovativi,dovrebbe essere possibile con il piano paesistico regionale disciplinare,con gli strumenti della pianificazione ordinaria, gli immobili (suoli ededifici) in nome del paesaggio, anche in assenza di vincolo, in quanto,accanto alla tutela dei paesaggi di valore, occorre promuovere e soste-nere l’attribuzione di qualità paesaggistica alle parti di territorio che nonne hanno. I nostri paesaggi degli ultimi anni sono caratterizzatidall’espandersi esponenziale di contemporanei fenomeni di abbandonoe di sovrautilizzo: vi è necessità di strumenti regionali di indirizzo, di co-ordinamento e di orientamento delle politiche settoriali e di equilibrio fraconservazione e trasformazione. È d’altro canto a livello regionale chediviene possibile promuovere l’integrazione tra politiche di spesa setto-riali (agricoltura, turismo, ecc.) e paesaggio e promuovere adeguati,aggiornabili ed estesi sistemi unitari di conoscenza, di sperimentazionee di formazione.
Non che il quadro regionale si presenti scevro da zone d'ombra eritardi: prescindendo dai dislivelli di tipo organizzativo che caratterizza-no la situazione delle regioni italiane, ad esempio nell’ambito della tu-tela del paesaggio, se pure non si vuole dare credito a chi si lamenta diuno stallo generalizzato, è però oggettivamente riscontrabile comel’azione delle istituzioni regionali sia piuttosto improntata, negli ultimianni, ad una delega del ruolo di alta pianificazione a favore dei livelliprovinciale e comunale. È quindi in questo contesto, un po’ depresso eun po’ compromesso, che viene ad inserirsi il Codice, che quindi andràsupportato da un’azione di rilancio dell’opera di pianificazione territo-riale da parte delle regioni.
Per quanto riguarda nello specifico la Regione Emilia-Romagna, ilcammino, in ambito paesaggistico, è stato già intrapreso ed occorrealmeno citare l’Accordo del 9 ottobre 2003 tra la Regione Emilia-Romagna, il Ministero e l’Associazione delle autonomie locali in materiadi gestione delle tutele paesaggistiche (v. sezione documenti), che, inmaniera antesignana, ha cercato di porsi come strumento di speri-mentazione e confronto e all’interno del quale, prima di tutto, sono fis-sate regole certe, ruoli definiti e strumenti condivisi da utilizzare nellaprogettazione e nella valutazione della compatibilità degli interventi inambiti tutelati.

Maria Pia Guermandi - 33
Al nostro convegno, Marco Cammelli oltre a ricordarci che da ades-so, per tutti (stato - regioni - enti locali - privati) non sarà più possibileoperare senza un sistema, affermava, in ottica positiva, che il Codicepersegue un allargamento complessivo della tutela, sottolineando però,al contempo, come, per estendersi senza allargare le maglie,quest’ultima debba poter contare su risorse rafforzate e reggersi suun’impalcatura “forte”, ovvero sia su strutture in grado di sostenerla.
La riorganizzazione del Ministero ha comportato, tra l’altro, il raffor-zamento dell’istituto della Direzione regionale che assume il compito dicoordinare le Soprintendenze “tecniche” e di costituire l’interlocutoreprincipale, sul territorio regionale, degli enti locali. Per evidenti ragioni diopportunità ed equilibrio istituzionale, da più parti si sta sollecitando lacreazione, da parte delle regioni, o la ristrutturazione, di organismi checostituiscano l’omologo di quello ministeriale e che si pongano, d’altrolato, come coordinamento delle istanze ed esigenze dell’insieme deglienti locali territoriali, come anche di associazioni e privati.
Le regioni per prime sono quindi chiamate a dotarsi di strutture fun-zionalmente adatte ai nuovi bisogni: primo ineludibile passaggio dellaloro volontà e capacità di governo anche in questi territori tanto contesied ambiti, così come sono chiamate a rilanciare (o in alcuni casi a crea-re per la prima volta), per quanto riguarda la pianificazione territoriale,come detto, una nuova stagione di analisi ed elaborazione, riappro-priandosi, del resto, di un ruolo spesso disatteso, soprattutto nelle ulti-me stagioni o perseguito con troppa stanchezza e qualche attarda-mento culturale di troppo.
Non si parte da zero: modalità di collaborazione sono da anni av-viate tra Ministero e molte regioni italiane e il percorso già svolto costi-tuisce una base ottimale per allargare le intese e sperimentare nuovistrumenti.
In questo percorso di adeguamento l’Emilia-Romagna, anche a li-vello di strutture, si colloca in una posizione storicamente privilegiata,grazie alla presenza dell’Istituto per i Beni Culturali: una delle istituzionipiù articolate nel panorama nazionale, se non altro per “anzianità” eche da molti anni persegue in modo sistematico e come elemento fon-dante delle proprie politiche culturali, la collaborazione a tutto campocon le strutture del Ministero, centrali e periferiche. Il nostro Istituto èchiamato ad un ruolo importante da questa legge e anche grazieall’esperienza trentennale può rappresentare, nella sua natura tecnicae scientifica interdisciplinare, una formula efficace, un’authority idealeper la gestione dei temi trattati dal Codice e sicuramente una dellestrutture cardine (in collaborazione con altri settori dell’ente regionale)

34 - Centro e regioni: la necessità di un sistema
attraverso le quali la nostra regione perseguirà quegli obiettivi di miglio-ramento complessivo della tutela del patrimonio, ribaditi, da ultimo, neiprincipi del suo nuovo statuto.
Il contestoPer concludere questo breve quadro di luci ed ombre, non si posso-
no tralasciare alcune considerazioni sul contesto - organizzativo, finan-ziario, legislativo - nel quale il Codice sarà chiamato ad operare.
Il Codice, come richiamato in vari interventi, in più di un passaggio silimita ad auspicare azioni coordinate e programmate per le attività spe-cifiche senza dettagliare oltre a quali strumenti e modalità di program-mazione si possa far riferimento: tali lacune, come anche altri silenzi,sono indice di quanto la reale efficacia operativa del Codice sia condi-zionata da una serie di fattori sottaciuti, primo fra tutti, un reale incre-mento delle risorse organizzative, umane, finanziarie.
Se vogliamo cercare di prevenire o contrastare gli elementi negativiche possono inficiare l’azione di tutela prefigurata nel Codice non pos-siamo non ricordare che a costo zero è impossibile realizzare alcun mi-glioramento sensibile: se l’adozione di questo strumento legislativo nonsarà accompagnata, sia a livello nazionale, che a quello regionale, daun incremento di risorse, è quasi pleonastico pronosticare che non po-trà innescare alcun miglioramento nel quadro complessivo della tutela.Il Codice, nel suo attuale impianto, prevede l’azione concertata di unaserie di strutture alcune delle quali già esistenti ed altre da costituire.Per quanto riguarda la prima e fondamentale di queste strutture, qualeè, ovviamente, il Ministero stesso, i recenti provvedimenti di riorganiz-zazione sono ancora in una fase di assestamento operativo per poteressere compiutamente giudicati, anche se complessivamente, per lenote ragioni di bilancio generale, il potenziamento tanto auspicato, alivello periferico, sembra alquanto disatteso.
Appare a tutt’oggi abbastanza evidente che le scelte organizzativeadottate sembrano negare la visione di un sistema integrato e il peri-colo, in questo caso, è costituito da una omologazione al ribasso: perpuntare ad un miglioramento complessivo della tutela si dovrà, al con-trario, mirare decisamente all’esercizio di una sussidiarietà compiuta,ricordando che accanto al principio della sussidiarietà verticale si parlaanche del principio di sussidiarietà sociale o orizzontale, secondo cuitutte le istituzioni che compongono la Repubblica debbono favorire losvolgimento di attività di interesse generale da parte dei cittadini singolie associati.

Maria Pia Guermandi - 35
Quali ultime considerazioni determinate dall’evolversi accelerato su-bito in questi ultimi mesi dal quadro normativo nazionale, per una piùmeditata interpretazione del Codice oltre all’esegesi giuridica che si sta,come detto, compiendo (cfr. da ultimo il testo curato dal professorCammelli e dal quale è tratto l’intervento a suo nome qui riportato) oc-correrà verificare, quanto più analiticamente possibile, il contesto nelquale il Codice è calato e che, lungi dall’essere stabile e compiuta-mente definito (ma ci si accontenterebbe, in fondo, anche di definirlo‘leggibile’) appare quanto mai fluido e sempre più pericolosamente sbi-lanciato.Tale contesto - legislativo, amministrativo o meglio politico insenso ampio - non è evidentemente neutro e rischia di avere riflessipesanti sull’efficacia di alcune norme cardine sancite dal Codice stesso.Questi ultimi mesi hanno visto il succedersi e sovrapporsi, a volte conscarsa coerenza giuridica, di provvedimenti legislativi di ambito forte-mente interrelato alle tematiche del Codice: per citare in ordine sparso,il condono edilizio nazionale che ha innescato un’analoga e spessoapertamente contrapposta attività legislativa a livello regionale, il prov-vedimento di delega ambientale, la nuova legge urbanistica in discus-sione in sede parlamentare, per non parlare di quegli articoli che, purappartenendo a provvedimenti legislativi di altro ambito, presentano ri-cadute dirette sul nostro tema, quale, da ultimo, la proposta di nuovanormativa della Funzione Pubblica che estenderebbe il meccanismodella Dia (dichiarazione di inizio attività) anche ai beni soggetti a tutela.
Si può certo affermare che il territorio, nel suo complesso, sia statooggetto di un’attenzione molto vivace da parte del nostro Parlamento:gli esiti di questa attività andranno verificati nel dettaglio, ma fin da orauna prima sommaria lettura non induce a ritenere che possano essereletti, nel loro insieme, come un segnale di potenziamento inequivocodella tutela del territorio. Il rischio reale è che con alcuni meccanismiprevisti all’interno dei provvedimenti citati, siano di fatto svuotati o aggi-rati alcuni principi ribaditi nel Codice, con il risultato evidente di com-prometterne l’efficacia operativa.
In questa fase di sperimentazione ed avvio, pur tra le incertezze e leambiguità che i partecipanti al convegno non hanno mancato di sottoli-neare e di fronte ad attacchi così ripetuti e pesanti nei confrontidell’impianto complessivo dei dispositivi della tutela, le pur giuste recri-minazioni che dalla ‘periferia’ sono state rivolte ad un ‘centro’ conside-rato troppo rigido nel ribadire le proprie prerogative e assai poco gene-roso nel delegare, devono ora lasciare il posto all’unica scelta possibile:quella di far fronte comune, evitando i particolarismi e il frazionamento.

36 - Centro e regioni: la necessità di un sistema
La partita da giocare ora è quella di trovare unità d’intenti e ricreare,nell’azione programmata e condivisa, quella Repubblica capace di di-fendere e trasmettere alle generazioni future un patrimonio così fragileed irriproducibile nella sua stratificazione e diffusione nel tempo e nellospazio.

Valeria Cicala - 37
Codice di comunicazioneValeria CicalaIstituto Beni Culturali, Regione Emilia-Romagna
Istituto Beni CulturaliVia Galliera, 2140121 - Bologna
Quando la stampa quotidiana ha iniziato a porre attenzione e a de-dicare spazio alla stesura del nuovo Codice dei beni culturali e del pae-saggio, ben prima che venisse approvato, in molti ci siamo rammaricatidel fatto che a porre le sue scomode considerazioni non ci fosse ancheAntonio Cederna, colui al quale, scriveva Vittorio Emiliani (il Messagge-ro, 28 agosto 1996) all’indomani della sua scomparsa, “dobbiamo laformazione di una opinione pubblica più sensibile e avvertita” sul nostropatrimonio, sull’importanza della salvaguardia e della valorizzazione.Come avrebbe tuonato sul discorso relativo al paesaggio, così come siconfigura nel Codice!
Il tema del nuovo Codice ha goduto, a livello di interventi giornalisticie mediatici tout court, di una rassegna stampa raramente così rigoglio-sa per questo ambito. Di solito è necessario che ci sia una scopertaclamorosa, oppure che un’opera d’arte venga “aggredita”, trafugata o,ancora, che una struttura architettonica crolli miseramente perchè sipossano avere diverse colonne a disposizione.
Bisogna, forse, andare indietro di una dozzina d’anni per ritrovare lostesso continuativo interesse nei confronti delle scelte legislative e ge-stionali del Ministero competente con le ricadute che queste implicava-no sul territorio nazionale.
Correva l’anno 1993 e l’allora ministro Ronchey aveva varato la leg-ge “Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali”. Si parlava diservizi aggiuntivi, di misure di sicurezza, di approcci manageriali, di rin-novamento dell’offerta museale; un insieme di prospettive che poteva-no costituire solo una premessa a quella grande riforma che tutti auspi-cavano. L’argomento, comunque, risultava goloso. Così giornalisti eaddetti ai lavori scrivevano, gli uni si entusiasmavano, gli altri temevanoun ridimensionamento o comunque uno svilimento del loro ruolo di di-rettore. Ma, proprio sfogliando la rassegna stampa di quell’anno e con-frontandola con le voci che hanno animato il dibattito sul Codice, si per-cepisce una notevole differenza di approccio ed un clima assai mutato,per quanto attiene alla politica culturale.

38 - Codice di comunicazione
Se si scorrono, ora, le principali testate giornalistiche relativamenteal nuovo Codice, sia nei mesi precedenti alla sua entrata in vigore, chein quelli successivi, si configura una cesura più netta tra chi scrive suigiornali per professione e l’informazione proposta dall’istituzione.
L’Istituto Beni Culturali tiene sistematicamente la rassegna stampasu tali argomenti, che lo riguardano in quanto organo della RegioneEmilia-Romagna con specifiche competenze sul patrimonio regionalefino dall’anno della sua creazione, nel 1974. Si è ritenuto, dunque, op-portuno, in occasione del convegno, predisporre una raccolta degli arti-coli pubblicati dai maggiori quotidiani e dal Giornale dell’Arte a partiredal 1° luglio del 2003, attestandoci sul 15 maggio 2004, in modo da of-frire ai partecipanti una significativa panoramica degli aspetti legatiall’informazione.
Abbiamo continuato a monitorare il Codice attraverso gli articoli e lospazio che la stampa vi ha dedicato ben oltre la data del nostro eventoe sembra di rilevare come costante il fatto che il dibattito el’informazione relativi all’accoglienza riservata al Codice abbiano avutocome firme, molto frequentemente, i funzionari degli uffici competentidel Ministero per i beni e le attività culturali, i Soprintendenti, studiosispesso impegnati in qualità di esperti o consulenti. Dunque un punto divista qualificato e ben documentato; ma per costoro l’equidistanza daiproblemi suscitati dal Codice è influenzata dall’appartenenza e il lorospirito critico deve, comunque, compenetrarsi con il dettato ministeriale.
Significativi in questa prospettiva appaiono i contributi pubblicati dalSole 24 Ore, in particolare i “Rapporti” dedicati ai beni culturali; si vedaquello della domenica 23 novembre 2003, incentrato sull’introduzionedel principio del silenzio-assenso sull’alienazione patrimoniale: “Gioiellidi Stato, la partita resta aperta”, questo era il titolo di apertura del fasci-colo, nel quale, oltre al sentimento di allarme suscitato da questo prov-vedimento, è forte l’attenzione ai risvolti economici e alle dinamiched’impresa connesse al patrimonio.
Un anno dopo, domenica 21 novembre 2004, un altro Rapportoapre titolando “Il percorso minato del Codice”; nell’occhiello si legge “Iltesto che riorganizza l’universo delle attività culturali è stato accolto daconsensi generali ma ha già dovuto subire ritocchi”. Forse queste righesfumano il contrasto per quanto attiene al ruolo di Regioni ed Enti loca-li, alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, un aspettospesso poco evidenziato dal dibattito giornalistico. La definizioni deiruoli e delle competenze sono ancora in grossa sofferenza. Anche il fa-scicolo dello scorso novembre dedica poi ampio spazio all’apporto e alruolo da assegnare alle aziende e al non facile rapporto tra privato ed

Valeria Cicala - 39
istituzioni, come pure riflette sull’offerta museale in Italia. Tutti argo-menti, questi ultimi, ben sviscerati ed attinenti al taglio della testata, chesicuramente si segnala per la continuità di spazio offerta al sistema be-ni culturali, ma con una sensibilità che oscilla tra l’impresa e lo Stato econ una comprensibile attenzione al valore aggiunto della cultura, chestenta a trovare i suoi profili.
L’impressione, ancora una volta, è che le tematiche economico-gestionali ed un rinnovato centrismo soverchino alcune linee che ven-gono prima e sono metodologicamente più fondanti. Le voci dei giorna-listi, quando ben documentate, sollecitano ed evidenziano discrepanzee contraddizioni. Proprio in questi ultimi mesi, abbiamo letto preoccu-pate riflessioni come quelle di Vittorio Emiliani sulle allarmanti nomineministeriali e gli altrettanto allarmanti trasferimenti (Disastro Urbani.Non c’è più un euro ai Beni Culturali, L’Unità, mercoledì 12 gennaio2005), come pure quelle del professor Salvatore Settis sulla regola delsilenzio-assenso (La tutela? Carta straccia, La Repubblica, 22 febbraio2005).
Sembrano assai lontani i giorni di settembre in cui il professoreesprimeva dalle pagine del Sole 24 Ore apprezzamento perun’intervista rilasciata dal Ministro Urbani sul “Corriere della Sera” aPaolo Conti, il 19 agosto 2004, nella quale questi sembrava prendere ledistanze dal governo sul taglio apportato ai finanziamenti; Bravo Urba-ni, ma ora riforma la tua riforma titolava il Domenicale del 29 agosto2004.
Ma, è complessivamente, anche alla luce degli articoli pubblicatinelle ultime settimane, che si coglie, al di là della competente attenzio-ne di giornalisti come Carminati, Conti, Detheridge, Dall’Orso, De Mar-chi, Emiliani, Erbani, Isman, Vagheggi, - solo per ricordarne alcuni diquelli che con più sistematicità si dedicano a questo settore - come sicontinui ad avvertire una consapevolezza epidermica o troppo stempe-rata all’interno di altre osservazioni per quanto riguarda un nodo por-tante della riforma: quello delle competenze tra Stato e Regioni.
Le decisioni prese in loco sono troppo importanti e le Regioni hannoesperienze ed attribuzioni che non possono appiattirsi o venire al ri-morchio di sempre più faticosi rapporti tra soprintendenze e direzioniregionali.
E concludiamo dedicando ancora qualche battuta di attenzione allaparte terza, del Codice, alla voce Paesaggio, con la considerazione fi-nale tratta da uno degli ultimi articoli scritti da Mario Fazio sulle colonnedella “Stampa”: “da noi c’è il terrore del divieto, pur salutare e indispen-sabile se vogliamo davvero salvare qualcosa”.


i beni culturali


Marco Cammelli - 43
Il Codice tra centro e periferia*
Marco CammelliOrdinario di diritto amministrativo, Università di Bologna
Università di Bologna - Facoltà di GiurisprudenzaVia Zamboni, 2240126 - Bologna
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio non si presta a facili, etroppo frequenti, semplificazioni ma ne va rispettata la complessità:certamente si registrano numerose innovazioni; altrettanto sicuramentevi sono aspetti, generali e specifici, che sollevano dubbi o vere e pro-prie critiche; c’è infine da chiedersi qual’è il sistema verso cui si sta an-dando e quali le azioni che ne possono sorreggere l'evoluzione in sen-so positivo.
Le valutazioni debbono essere articolate su ognuno di questi aspet-ti.- Le innovazioni. Riguardano praticamente molti degli elementi del
settore.Per quanto riguarda i concetti, si è registrata la funzione unificante
del patrimonio culturale, la conferma della sovraordinazione della tutelasulla valorizzazione, con conseguenze anche puntuali (come il prestitodi beni culturali trasferito dalla valorizzazione alla tutela: art. 46),l'estensione oggettiva (v. beni ulteriori) e soggettiva (v. soggetti desti-natari: altre amministrazioni pubbliche e soggetti privati senza fine dilucro) della disciplina di tutela. Resta l'accezione giuridica reale (la co-seità) del bene culturale, che certo non soddisfa le attese più volteemerse in ordine alla immaterialità del bene culturale, ma che rappre-senta il riflesso dei principi di tipicità, pluralità e materialità del bene ge-nerati dai profili relativi alla tutela di altri beni, come la proprietà privata,o altri interessi pubblici (come quello penale o fiscale) che ostacolanoforme più indeterminate di definizione. Sono tra l'altro proprio questeesigenze che portano a ritenere che il rinvio alla «legge» per la even-tuale individuazione di altri beni operato dai commi 2 e 3 dell' art. 2 va-da interpretato come rinvio alla sola legge statale.
Quanto alla tutela, si è già detto dell'adeguamento soggettivo, checomprende tutte le amministrazioni pubbliche, anche quando i relativisoggetti, in virtù dei processi di privatizzazione, mutano natura (per ibeni di cui all'art. 10 comma 2 si veda quanto disposto dall'art. 13comma 2), e i privati senza fine di lucro (a cominciare dalle fondazioni

44 - Il Codice tra centro e periferia
ex bancarie). In termini oggettivi, le innovazioni riguardano l'inserimentodi beni quali piazze, strade, spazi urbani aperti pubblici; siti minerari,navi e galleggianti, tipologie di architettura rurale.
Significativamente modificato è anche il procedimento, con il supe-ramento del sistema degli elenchi (per i soggetti pubblici) e la conse-guente dichiarazione di interesse culturale che comporta singole decla-ratorie per i singoli beni e, soprattutto, la fine della «presunzione diculturalità» di beni pubblici cui, in attesa della richiesta dichiarazione, siprovvede ad estendere in via cautelativa la disciplina di tutela. Proprioper queste ragioni la previsione del silenzio-assenso ex art. 12 ultimocomma risulta incongrua rispetto alla ratio dell'intero art. 12, probabil-mente illegittima rispetto ai principi costituzionali sanciti dall'art. 9 e co-munque limitata alla fase di primo avvio.
Una ulteriore novità procedimentale è infine costituita dal ricorsoamministrativo (di merito e tecnico) previsto avverso la dichiarazione diinteresse (art. 16) ed esteso ai provvedimenti di temporanea immodifi-cabilità per tutela indiretta (art. 46 comma 4) e diniego di circolazione(69). Una soluzione da considerare con favore, sia perchè permette digarantire in concreto l'omogeneità (oggi assai carente) nell'operatodelle soprintendenze, sia perchè pare immune dalle preoccupazioniche in proposito sono state sollevate.
La sospensione degli effetti del provvedimento avverso cui è statopresentato ricorso (art. 16 comma 2), infatti, non sospende affatto lavigenza della disciplina cautelativa disposta dal Codice per i beni in at-tesa della dichiarazione di interesse culturale ma, coerentemente al si-stema adottato, rinvia alla determinazione definitiva la questione del seed in che misura tale interesse sussista e si sia dunque di fronte non adun bene solo cautelativamente garantito dalla disciplina dei beni cultu-rali, ma ad un bene culturale tout court.
Quanto al regime di protezione, il Codice interviene in chiave di in-novazione e semplificazione, come nel caso delle autorizzazioni agliinterventi sui beni culturali (riservate al solo soprintendente con esclu-sione del livello ministeriale), nelle disposizioni in materia di formazioneprofessionale (dunque, competenza regionale) per conservazione e re-stauro (competenza, invece, statale) ove l’art. 29, commi 6-10 risolve laquestione prevedendo l’adozione di un decreto ministeriale di intesacon la Conferenza delle regioni, nel superamento del contratto di depo-sito (a titolo oneroso, e dunque poco praticabile) e nel ricorso al como-dato, previsto prima solo per i beni archivistici e ora esteso a tutte leipotesi (44).

Marco Cammelli - 45
Forti innovazioni si sono avute anche in materia di circolazione deibeni, passata dalla originaria generale inalienabilità ad un sistema a trelivelli: beni assolutamente inalienabili (art. 54, 1 e 2); alienabilità sottostretta sorveglianza (art. 55) previa autorizzazione condizionata agliobblighi di tutela, godimento pubblico, destinazione d’uso compatibile(ma indebolito dalla mancanza delle cautele, come il progetto o la clau-sola risolutiva del precedente regolamento ex dpr 283/2000 oggi abro-gato) semplice autorizzazione, infine, per tutti gli altri (art. 56).
A queste, vanno aggiunte le modifiche nella prelazione, ridisegnatariferendola da esercizio di un diritto ad espressione della potestà auto-ritativa della Pa e in tal modo estesa a regioni e enti locali, nonchél’allineamento dell’espropriazione al recente T.U. 327/2001, assicuran-do in tal modo la coincidenza tra soggetto competente alla realizzazio-ne delle opere pubbliche e chi adotta gli atti del procedimento espro-priativo.
Per quanto riguarda la valorizzazione-fruizione, occorre registrareun notevole divario tra chi ritiene confermato il riparto ex d. lgs.112/1998 e titolo V, confermato dalle recenti pronunce della Corte co-stituzionale (9 e 26/2004), secondo cui la tutela ha per finalità principalequella di impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisicamentre la valorizzazione è diretta soprattutto alla fruizione del bene echi invece1 segnala una forte tensione tra art. 6 (valorizzazione, princi-pi) e art. 111 (attività di valorizzazione), perchè nel primo la fruizione èuna finalità compresa nella valorizzazione (ma anche nell'art. 3, tutela,ove però è circoscritta alle attività di individuazione, protezione e con-servazione del bene) e art. 111 nel quale il fine resta, ma le attività silimitano interamente a compiti di supporto finanziario, organizzativo elogistico, con la conclusione che la fruizione spetterebbe solo allo Statoe il corollario di una potestà legislativa regionale decisamente circo-scritta.
Degli istituti e luoghi di cultura (per i quali peraltro deve rammentarsiche non sussistono le esigenze di tipicità richiamate per i beni culturalie non vi è dunque ostacolo di principio all'intervento della legge regio-nale) si è segnalata la riformulazione delle definizioni di museo, areaarcheologica, parco archeologico e l'aggiunta delle biblioteche, archivie complessi monumentali, mentre si aggiunge l’espressa qualificazionedell'attività svolta, in termini di servizio pubblico, se la titolarità è pubbli-ca, e di servizio privato di utilità sociale se di titolarità privata.
1 L.Casini, Valorizzazione e fruizione dei beni culturali, in “Giornale Dir. Amm.”, 2004,482.

46 - Il Codice tra centro e periferia
Delle forme di gestione e dei problemi posti dal rapporto con la di-sciplina di settore si è lungamente detto in altra sede2, qui basterà ag-giungere una perplessità in ordine all'ipotesi di beni culturali oggetto divalorizzazione di società di capitali a maggioranza pubblica cui sonoconferiti in uso (art. 115 comma 9), dato che la loro computabilità a finidel patrimonio o del capitale sociale si traduce, agli effetti dei creditoridella società medesima, in una sostanziale fideiussione per l'importoequivalente e dunque, date le condizioni della finanza locale, in unaprevedibile e forte pressione per l'alienazione del bene in questione.- Elementi positivi e valutazioni critiche. Un complesso così ampio di
innovazioni, insieme ad aspetti sicuramente apprezzabili, non èevidentemente esente da riserve. Vediamo sinteticamente gli uni ele altre.
a) Elementi positivi. Sul piano della disciplina sostanziale, co-me si è appena detto, molte delle cose viste sono apprezzabilie condivisibili. Quanto al piano istituzionale, è innegabile che ilCodice cerca di passare da un sistema dualistico (centro-autonomie; tutela-altro) ad un sistema integrato. Operano in questo senso la ridefinizione di concetti unitari(patrimonio culturale, tutela, valorizzazione, luoghi e istituti, be-ne culturale, ecc.) e il loro aggiornamento sostanziale, anchese l’estensione pone evidenti problemi di sovraccarico di cui sidovrà tenere debito conto; l’individuazione di principi comuniper le competenze legislative concorrenti; la previsione di deci-sive funzioni regolative centrali (normative, standards, livelli es-senziali, ecc.); la previsione di un ampio decentramento possi-bile (artt. 4-6) e differenziato, il che rende ancor più incompren-sibile la dichiarata ostilità per le ipotesi di autonomia specialepreviste dall'art. 116 comma 3 Cost. vigente, che si inseriscesulla stessa linea aggiungendo la possibilità di modalità organi-che (e non puntiformi) di decentramento di funzioni legislative eamministrative a singole regioni con garanzie procedimentaliassai più appropriate (consultazione degli enti locali, intesaStato-Regione, veste legislativa della approvazione, maggio-ranza qualificata); il ricorso ad una larghissima cooperazione; iltimido, per il momento, affacciarsi delle direzioni regionali delMinistero, funzionali ad un decentramento degli apparati cen-trali, auspicabili interfaccia della regione e degli enti locali e
2 M. Cammelli, Introduzione, in M. Cammelli (a cura di), Il Codice dei beni culturali e delpaesaggio, Bologna, Il Mulino, 2004.

Marco Cammelli - 47
presupposto per il coordinamento delle soprintendenze), anchese altri aspetti suscitano invece, come si dirà, qualche dubbio; ilprincipio generale dell'adeguata autonomia scientifica, organiz-zativa, finanziaria e contabile delle strutture di gestione (115comma 2), che nella auspicabile prospettiva di un vero e pro-prio «statuto di organizzazione» dei soggetti operanti in materiadi beni culturali andrebbe esteso anche ai soggetti privati. Questo in termini generali: ma altrettanto positiva è la valu-tazione da compiere per molti aspetti di dettaglio, dalla previ-sione del ricorso amministrativo, di cui si è detto, al silenzio-assenso per interventi di edilizia (art. 22) o dal (timido) ricono-scimento del concorso delle Università, per realizzazione, pro-mozione e sostegno di studi e attività conoscitive sui beni cultu-rali (art. 118) o per la definizione dei livelli di qualità della valo-rizzazione (art. 114 comma 1), alla possibilità di protocolli diintesa con le fondazioni ex bancarie, per l'equilibrato impiegodelle risorse da queste poste a disposizione, sviluppando in talsenso gli accenni operati dalle sentenze Corte cost. 29 settem-bre 2003, n. 300 e 29 settembre 2003, n. 301 (http://www.cortecostituzionale.it).
b) Valutazioni critiche. Si è già accennato a più di un aspetto sucui è lecito sollevare qualche dubbio o critica. Il problema, ora,non è di riproporne sia pure sinteticamente una rassegna ma diisolare i profili istituzionali generali più significativi che appaio-no, agli occhi di chi scrive, meno persuasivi o comunque ca-renti. Dagli operatori di ciascun settore, naturalmente, vengonoformulate in numero crescente molte considerazioni che non èpossibile qui raccogliere.
Almeno su un aspetto, tuttavia, è giusto soffermarsi. Ci si riferisce allaquestione delle tipologie e delle definizioni di bene culturale e di funzio-ni racchiuse nella parte iniziale del Codice, su cui sembrano lecite leseguenti osservazioni:- intanto, resta non chiara nè scontata la necessità di procedere ad
una ridefinizione delle funzioni rispetto a quelle operate di recentedall'art. 148 del d. lgs. 112/1998 per una questione di metodo,l'inevitabile effetto destabilizzante di intervenire, modificandone si-gnificativamente i caratteri e i contenuti, su tipologie solo di re-cente adottate e riferibili senza troppo sforzo anche alle modificheordinamentali apportate nel 2001 dal titolo V Cost., come la lettura

48 - Il Codice tra centro e periferia
datane dalla Corte costituzionale nelle pronunce del 2003 e del-l'inizio 2004 ha ampiamente dimostrato. Ne deriva, tra l'altro, unadiscontinuità rispetto all'attività di messa a punto posta in esseredagli operatori e dagli interpreti che non è priva di inconvenienti.Inoltre, le prime letture sul tema della tutela e della valorizzazione-fruizione, indicano che il terreno sarà fonte di notevoli incertezze econflitti;
- le medesime osservazioni si possono ripetere in ordine alla ridefi-nizione dei beni, perchè resta aperto il tema della immaterialità eperchè, inevitabilmente, si tratta di delimitazioni per loro naturaesposte ad un grado notevole di opinabilità. Un solo esempio, mi-nore ma significativo: perchè limitare la previsione dell' art. 10comma 4 lettera d) agli spartiti musicali quando lo stesso Ministe-ro, attraverso l'istituto del catalogo unico (Iccu) ha già provvedutoa raccogliere e digitalizzare una varietà assai più ampia, dai200.000 manoscritti musicali, ai codici beneventani e alle partituredi orchestra?
Ma veniamo, appunto, al profilo che più ci è proprio, quello istituzio-nale e amministrativo. Ebbene, dall'esame che si è accennato, emergein modo evidente la fragilità dell'intelaiatura istituzionale su cui poggia-no le disposizioni e le azioni immaginate dal Codice con riflessi, è benesubito sottolineare, non solo giuridico-amministrativi ma, ciò che forseancora più conta, funzionali e sostanziali.
Le scelte strategiche operate dal d. lgs. 42/2004, infatti, non sono davalutarsi solo in sè ma anche in relazione alla tenuta del sistema, ed èchiaro che non basta la bontà intrinseca di una soluzione se poi que-st'ultima resta sprovvista di adeguato supporto organizzativo e ammini-strativo. La decisione di estendere l'arco dei beni culturali, o quelle ri-guardanti la verifica puntuale della presenza dell' interesse culturale peri beni pubblici invece che la loro «presunzione ex lege di culturalità», ladifferenziazione del regime di circolazione del bene culturale e del rela-tivo statuto o la scelta di praticare l'intervento delle soprintendenze pri-ma, al momento della stesura dei piani paesaggistici, invece che dopo,come repressione degli strumenti o dei singoli provvedimenti che se nediscostino, per non citarne che le più significative, possono essere ap-prezzate in sè ma certo andranno valutate in modo positivo o negativoa seconda della «tenuta» del sistema e della concreta capacità di farvifronte in modo adeguato.
Quali siano le ragioni per cui il Codice nasce sprovvisto di una rico-noscibile ed affidabile intelaiatura istituzionale, è questione che in que-sta sede non può esser affrontata: in parte la cosa non era possibile

Marco Cammelli - 49
perchè alcuni elementi di fondo, come ad esempio la conferma inte-grale del riparto di competenze operato dal titolo V Cost. nel 2001 o ilripensamento dello stesso Parlamento e la trasformazione del Senatoin camera della rappresentanza territoriale, erano di là da venire, tantoche vi provvede (o tenta di provvedervi) la nuova riforma costituzionaleche ha iniziato il suo lungo iter con l'approvazione in prima lettura delSenato il 25 marzo 2004, vale a dire due mesi dopo l'entrata in vigoredel Codice.
In parte la cosa è stata sottovalutata sia in termini di merito che dimetodo, dato che nel testo l'organizzazione è separata dalla normazio-ne, ciò che non è consigliabile in questo settore e non è stato fatto inaltre esperienze, come la recente codificazione francese3. Ove il pro-blema, ovviamente, non è l'inserimento materiale della disciplina orga-nizzativa e ministeriale nel Codice, con i temuti appesantimenti e rigi-dità, ma la considerazione congiunta e armonica dei due profili nel por-re mano all'uno e all'altro.
In parte ancora si è privilegiato il dato normativo, quando l'esperien-za di tutto il settore dei beni culturali è lì ad indicare che più che di nor-me si tratta di azioni, mezzi, soluzioni organizzative, e che anzi è pro-prio la difficoltà di ottenere risultati accettabili su questi terreni (uno pertutti: la completa e sistematica catalogazione dei beni culturali esistentie riconosciuti) che porta ad alterare il preesistente tessuto normativoper (cercare di) ovviare in termini di disciplina a quanto risulta deficitarioin termini di pratica amministrativa e gestionale.
Ma questo non sposta i termini del problema: aggiunge soltanto che,almeno per questi profili, il Codice rischia seriamente l'intempestivitàquanto al momento, la parzialità nei contenuti, e l'insufficienza in termi-ni di efficacia.
Dunque, torna il problema di merito, quello dell'intelaiatura istituzio-nale di fondo che non si riduce affatto al solo tema delle competenze edelle «quantità» di potere rispettivamente assegnate allo Stato o alleregioni, perchè certo se a questi aspetti si riducesse meriterebbe dav-vero le critiche di Salvatore Settis nel denunciare gli effetti devastanti,da vero e proprio «fuoco amico»4, di chi cioè spende energie e paroleper tali dispute senza avvedersi dei pericoli incombenti sul lato dellealienazioni di immobili, del rapporto con i privati, del silenzio-assenso,
3 S. Cassese, Postfazione. Tra continuità e innovazione, in Il Codice dei Beni Culturali edel Paesaggio, in “Il Sole-24 Ore”, aprile 2004, 172.4 S. Settis, Non toccate la Costituzione sulla tutela ambientale, in “la Repubblica”, 23gennaio 2004, 15.

50 - Il Codice tra centro e periferia
del Patrimonio spa. Pericoli sui quali l'attenzione, e la preoccupazione,è evidentemente comune.
Ma non è così.Il quadro generale in cui si iscrive il Codice è pesantemente segna-
to, nei seguenti elementi determinanti, da incertezze che lo rendono in-certo e vulnerabile:- un centro, non attrezzato da centro del sistema: tale è la fisiono-
mia del Ministero delineata dal d. lgs. 3/2004, come già dalla pre-cedente riforma del 1998, concepito come singolo ed autonomocomplesso di apparati privo di relazioni centrali con i livelli regio-nali e locali e dunque chiaramente fondato sul presupposto chetali relazioni o non sono necessarie o transitano per altri canali(essenzialmente politici), che le risorse in gioco sono essenzial-mente statali, che il processo decisionale è nei contenuti in sensodiscendente (dal generale al particolare e dall'astratto al concreto)e dunque istituzionalmente a cascata dal centro alle «periferie». Ilche, evidentemente, non solo non corrisponde alla realtà dei fatti(a quello che è, oltre che al dover essere delle prescrizioni norma-tive) ed è concettualmente incompatibile con le molteplici «circola-rità» tipiche di ogni «sistema» proprio perchè tale, ma proietta unalunga serie di dubbi sulle forme di cooperazione su cui il d. lgs.42/2004 opera la scommessa maggiore e di cui nel coevo d. lgs.3/2004, invece, non c'è traccia;
- un decentramento di funzioni dallo Stato al sistema regionale elocale che, affidato alle puntiformi soluzioni di singoli accordi o in-tese tra Ministero (o, più verosimilmente, parti di quest'ultimo) eenti interessati, appare sprovvisto della veste giuridica richiestadagli artt. 118 comma 1 e 118 comma 3 Cost., la copertura legi-slativa, e impropriamente riservato a solitarie determinazioni delMinistero in luogo delle necessarie decisioni collegiali parlamenta-ri, se tramite legge, o del Consiglio dei ministri, sempre che l'isti-tuto della delegazione amministrativa intersoggettiva sopravvivaanche nel nuovo titolo V Cost. Una condizione, insomma, di ob-biettiva incertezza che supera di gran lunga la «versatile combina-zione» di trasferimenti e deleghe con cui la Corte costituzionale,con la sentenza 408/98, aveva salvato la legittimità della leggedelega 59/1997;
- una cooperazione, cioè una virtù che tutti sappiamo rara e diffi-coltosa tra gli individui come tra le istituzioni, di cui mancano, oltreai presupposti strutturali come si è appena visto, le regole specifi-che (contenuti, implicazioni organizzative e finanziarie, effetti giu-

Marco Cammelli - 51
ridici, personale) e ancor più le motivazioni. A meno che non la sipensi semplicemente eventuale ed aggiuntiva, il che di nuovocontraddice il sistema, o maliziosamente discrezionale e, quandovoluta, necessaria: raggiungibile, cioè, con l'effetto combinato dipoteri autoritativi e l'aspettativa di assegnazioni di risorse via Ar-cus, cui è affidata la gestione delle ingenti somme derivanti dalladestinazione, operata dalla finanziaria del 2002, alla tutela e alleattività culturali del 3% delle spese per infrastrutture, stimate neiprossimi dieci anni tra 3,6 miliardi di euro dal ministro Urbani (“IlSole-24 Ore”, 28 marzo 2004) e 4 miliardi dal ministro Lunardi (“IlSole-24 Ore”, 31 dicembre 2003). L’ipotesi di strutture comuni,come quelle immaginate per la formazione dall'art. 29 comma 11,si ferma a questo unico esempio.
- una seria sottovalutazione dei dati organizzativi degli apparati mi-nisteriali, soprattutto tecnici, ed in particolare delle soprintenden-ze, ciò che solleva generalizzate e fondate preoccupazioni supassaggi chiave come i nuovi procedimenti in materia di verificadell'interesse culturale e per tutta la parte (piani e autorizzazioni)dei beni paesaggistici.È proprio la consapevolezza delle difficoltà delle regioni e deglienti locali che rende queste lacune ancora più preoccupanti e an-cora più rilevante il ruolo di un centro capace di ragionare, e dipensarsi, in termini di sistema.Se questo non avviene, tutti gli attori perdono: quelli centrali equelli regionali, quelli territoriali e quelli funzionali, quelli pubblici equelli privati. Ecco perchè la denuncia delle lacune non è «fuocoamico» ma identificazione di snodi cruciali e vulnerabili capaci dimettere in gioco la tenuta del sistema.
- Prospettive possibili. Da quanto si è appena detto, risulta chiaroche a Codice ormai in vigore la cosa più urgente è quella di pro-cedere ad una adeguata attuazione, ai vari livelli nei quali questadovrà avvenire, concentrando l'attenzione sugli aspetti più criticidel sistema, dei quali curare la definizione e la messa a punto.
Naturalmente si tratta di stabilire a quale sistema si fa riferimento.Se si pensa ad un sistema in buona parte imperniato sul centro e sulministero per i Beni e le Attività culturali magari leggendo in questomodo l'art. 9 Cost.5 che invece non allo Stato ma alla Repubblica fa ri-ferimento, da un lato, e sulla preminenza delle sedi politiche su quelle
5 Settis, cit., 15.

52 - Il Codice tra centro e periferia
tecnico-amministrative, come per molti aspetti suggerisce la letturadella triade di interventi istituzionali varata all'inizio del 2004 (organiz-zazione del Ministero, d. lgs. 3/2004; Codice, d. lgs. 42/2004 e Arcus,legge 291/2003 e relativo statuto del gennaio 2004), allora si può con-cludere che le basi sono definite e che, semmai, restano da chiarire al-cune implicazioni e, soprattutto, gli strumenti della sua messa in opera.
La centralità dello Stato, confermata dalla riserva (diretta o indiretta)in mano al medesimo di tutti i più importanti aspetti riguardanti discipli-na, regolazione e finanziamento del settore, tanto che non a caso si èparlato di «recupero del centro»6, è naturalmente suscettibile di «alleg-gerimenti» (decisi di volta in volta dal Ministero e comunque reversibili)in favore di singoli enti regionali e locali, ed è proprio per questo cherisulta comunque indispensabile mettere a fuoco il regime del decen-tramento e della cooperazione.
D'altra parte, la preminenza delle sedi politiche su quelle tecnico-amministrative è la naturale conseguenza delle scelte operate nel porremano alla struttura del Ministero, della non rimediata debolezza orga-nizzativa degli apparati tecnici, peraltro ribadita anche dal regolamentodi attuazione del d. lgs. 3/20047, della riserva a decisioni del Ministrodell'intera gamma delle più importanti nomine (dei titolari delle direzionigenerali, dei direttori regionali, della maggior parte dei componenti delconsiglio di amministrazione di Arcus). Tutto ciò, specie se consideratoalla luce degli effetti di «fidelizzazione» di tali soggetti al Ministro gene-rati dalla legge 145/2002, costituisce infatti una evidente estensione delpeso delle sedi politiche su quelle culturali, professionali e amministra-tive.
Un'estensione, si badi bene, che il decentramento a regioni ed entilocali a sistema invariato finisce per accentuare, più che ridurre, e chepotrebbe portare a leggere in questo senso anche innovazioni, comel'introduzione del ricorso amministrativo avverso alle determinazionidegli organi periferici del Ministero, che pure in sé sembrano, come si èdetto più sopra, condivisibili.
Se invece si ritiene che uno scenario come quello appena delineatosia improponibile per motivi di fondo (il settore, in un sistema politicoavviato alla democrazia maggioritaria, non può essere concentrato inun'unica sede istituzionale senza rischi per il pluralismo da cui è con-notato), costituzionali (il riparto di compiti tra Stato e autonomie regio-nali e locali operato dal titolo V) e funzionali (il sovraccarico, e il conse-
6 Cassese, cit.7 S. Settis, Il manager non salva l’arte, in “la Repubblica”, 22 aprile 2004, 46.

Marco Cammelli - 53
guente grave rischio di disfunzioni, che ne deriva oltre allo scollamentocon le numerose politiche di settore connesse alla materia e dislocate alivello locale), allora la soluzione non può che essere un'altra, quellacioè di un sistema policentrico e a forti autonomie, ancorchè ancoratosu altrettante forti garanzie tecniche e giuridiche assicurate in primoluogo dallo Stato.
Ma, se è così, allora c'è ancora molto da fare: se si considera cheandiamo verso un sistema ormai privo dei solidi ancoraggi tradizional-mente assicurati dall'unicità del legislatore (v. potestà legislativa regio-nale), degli apparati statali (v. amministrazioni regionali e locali), dellagestione pubblica (v. intervento dei privati) e della solidità di uno statutoforte e riconoscibile dei beni pubblici (v. modifiche alla circolazione deibeni), appare allora evidente che si tratta di individuare i nuovi anco-raggi del sistema. Di lavorare, cioè, sui punti di giuntura e sui relais inmodo da assicurare a quest'ultimo le necessarie cerniere tra i diversielementi.
Per farlo si deve agire su più fronti, il che non significa solo chiarire(e, in parte, rivedere) alcune disposizioni del Codice, ma soprattuttoporre mano ad un complesso di atti (legislativi e amministrativi) e azionia livello regionale e locale. Il che offre già una prima indicazione, e cioèche se si condividono le premesse appena illustrate non ci si può limita-re ad una logica di semplice «recepimento» della nuova disciplina po-sta dal Codice.
Ma vediamo su quali elementi dovrebbero poggiare le «cerniere» dicui si è detto.
Un primo gruppo è rappresentato da un complesso di statuti, cioè diveri e propri punti fermi su snodi cruciali senza i quali il sistema rischiaoscillazioni intollerabili: si tratta cioè di individuare e raggruppare, inmodo stabile e riconoscibile, principi atti a definire:- lo statuto del bene culturale il cui regime, nel momento in cui è resa
flessibile e comunque meno determinante la titolarità pubblica, ne-cessita di garanzie più appropriate, quali ad esempio quelle assicu-rate (in termini di progetto e di garanzie: v. rescissione del contrat-to) dalle disposizioni a suo tempo dettate dal regolamento 283/2000;
- lo statuto tecnico-organizzativo dei soggetti, pubblici o privati, cen-trali o locali, cui è affidata la gestione di beni culturali o che comun-que sono abilitati ad intervenirvi. In genere, della cosa ci si è occu-pati solo per profili parziali e limitatamente ai privati (v. i requisiti ri-chiesti alle imprese specializzate nel restauro di beni mobili), ciòche ha favorito ripetute pronunce di illegittimità del TAR Lazio (l'ul-

54 - Il Codice tra centro e periferia
tima, con la sentenza 1 marzo 2004, n. 1844, in «Trib. amm. reg.»,2003, 12, 4426). Si tratta invece di affrontare la cosa in generale, eanche per le amministrazioni pubbliche, e i principi sanciti dall'art.115 comma 2 rappresentano un'ottima base di partenza, certa-mente da integrare e precisare. Fra questi, sembrerebbe opportunoapprofondire, anche con riguardo a ciò che si dirà al punto imme-diatamente successivo, la possibilità di assicurare al personaletecnico-professionale che opera in queste strutture una collocazio-ne strutturale e contrattuale particolare, con elementi di autonomiae di autogoverno, di cui vi è traccia nel progetto di autonomia spe-ciale ex art. 116 comma 3 Cost. elaborato per la regione Toscananel 20038, ovviamente da approfondire e precisare. In ogni caso, non pare dubbio che dal principio generale qui ri-chiamato derivino necessariamente anche implicazioni sulla com-posizione degli organi di amministrazione degli organismi (qualifondazioni o altro) cui sia affidata la gestione di beni culturali, orga-ni che debbono assicurare la prevalenza di membri specificamentecompetenti per il tipo di attività svolte, come giustamente si è os-servato9;
- lo statuto del processo decisionale, basato sulla distinzione delleistruttorie e delle determinazioni tecniche rispetto alle decisioni po-litico-amministrative, con conseguenti e distinte responsabilità, esul principio della necessaria separazione tra sedi o apparati titolaridi interessi pubblici diversi, in modo da favorirne la trasparentedialettica e il reciproco bilanciamento. Ciò comporterebbe, adesempio, il dovere di allocare a livelli istituzionali distinti le compe-tenze in materia di trasformazioni territoriali, da un lato, e le auto-rizzazioni relative ad interventi in materia di beni paesaggistici, conil conseguente dovere per le regioni di rivedere le sub-deleghe ope-rate nel settore a favore delle amministrazioni comunali;
- lo statuto dei rapporti con i privati, in modo da assicurare la pienez-za delle garanzie relative al bene culturale e alla utilizzazione chelegittimamente può esserne fatta e, contemporaneamente, la pos-sibilità di un credibile affidamento del privato realizzabile solo attra-verso una preventiva definizione da parte della autorità pubblica deilimiti e dei vincoli da rispettare. Elementi, come tutti sanno, deter-minanti per praticare una strada che l'esperienza di questi anni mo-
8 v. “Aedon”, 1/2003.9 S.Settis, Se il museo è una merce di scambio, in “la Repubblica”, 16 marzo 2004, 41.

Marco Cammelli - 55
stra ben più complessa e difficoltosa di quanto molti all'inizio pen-savano.
Un secondo gruppo di cerniere riguarda i principi del processo deci-sionale, vera e propria intelaiatura funzionale del sistema. Se si partedal presupposto, innegabile, che la maggior parte del patrimonio cultu-rale ha una collocazione decentrata e sul territorio e che le quote piùconsistenti di regolazione sono invece (necessariamente) accentrate, èdel tutto evidente la circolarità del processo decisionale in termini di ac-quisizione, organizzazione e diffusione delle informazioni, di domandee proposte di interventi, di interdipendenza delle politiche di settore, diintegrazione di risorse, di determinazione di standards e livelli essen-ziali, di indirizzi e controlli.
Tutto ciò pone in evidenza la necessità di fare chiarezza sull'orditodelle relazioni tra centro, regioni ed enti locali. Il Codice evita di prende-re posizione in proposito e privilegia la soluzione di rapporti bilaterali ediretti tra Ministero e regioni o enti territoriali. È una scelta che si puòcomprendere, data la delicatezza e la conflittualità della materia e ladifficoltà di venirne a capo, ma che certamente non è condivisibile.
Non si tratta solo di optare tra un modello integrato di relazioni, ove irapporti tra centro e enti locali e viceversa sono necessariamente in-termediati dalla regione, e il più tradizionale modello binario, basato sulparallelismo di relazioni Ministero-regione e Ministero-enti locali. Que-stione che, come si sa, coinvolge da sempre il versante centro-periferia, che in parte dipende dai diversi settori e che comunque va ar-ticolata, perchè non tutte le situazioni territoriali sono eguali, a comin-ciare dalla distinzione tra grandi e piccoli comuni, e variano da regionea regione.
Il punto è (anche) un altro, e consiste nel fatto che per molti aspettiè necessario favorire l'aggregazione tra la «domanda» e l'«offerta» dicomuni limitrofi, e che solo a livello più elevato (sistemi intercomunali,città metropolitana, provincia, regione) è possibile affrontare i problemidella interdipendenza delle politiche di settore. Le regioni e gli enti ter-ritoriali più avanzati hanno maturato alcune esperienze apprezzabili inproposito, ma un Ministero che concepisca le proprie ipotesi di decen-tramento e collaborazione in modo episodico, per singoli enti, o co-munque prescindendo da tali aspetti, non favorisce nessuna di questedinamiche e rischia di accentuare, lo si voglia o meno, le difficoltà dipartenza.
Anche questo è un modo di svolgere consapevolmente un ruolo di«centro» del sistema e altrettanto lo è la sottoscrizione di protocolli diintesa con le fondazioni ex bancarie (art. 121): uno strumento certa-

56 - Il Codice tra centro e periferia
mente utile, specie nella versione congiunta ipotizzata dalla disposizio-ne, ma che presuppone la consapevolezza che tali fondazioni sonoconcentrate quasi interamente nel centro-nord ed implica, di conse-guenza, la capacità del «centro» di tenere conto di tali asimmetrie intermini di ripartizione territoriale dei propri finanziamenti ordinari.
Un riferimento, infine, alle modalità procedimentali delle fasi deci-sionali nella cooperazione. Il nostro ordinamento ha operato ricorso inmodo massiccio da poco più di un decennio agli accordi e alle intesecome strumenti giuridici della collaborazione ma è ancora ai primi passinella relativa disciplina. Per lo più, e anche nel nostro settore, ci si è li-mitati a mutuare dal diritto privato gli ingredienti base del contratto sal-vo poi introdurre a forza, dinnanzi al rischio del grippaggio causato daldissenso, la clausola della decisione unilaterale di una delle parti. Con ilrisultato che la collaborazione o è evitata, perchè non paritaria, o nasceviziata da tale asimmetria.
Una disciplina che, come quella introdotta dal Codice, scommette inmisura così estesa sulla collaborazione interistituzionale, necessita evi-dentemente di strumenti più raffinati o comunque più adeguati. In altrisettori, come per la localizzazione di infrastrutture di interesse nazio-nale o di impianti di telecomunicazione, la legge e soprattutto la Cortecostituzionale stanno elaborando modalità nuove, basate sul principioche la competenza di ognuna delle parti è rispettata a condizione chesia esercitata e che se questo non avviene l'interlocutore attivo è legit-timato ad avanzare, anche se la materia è di altri, una soluzione chevarrà fino a quando il soggetto astrattamente competente non si sia at-tivato.
In breve. Pieno rispetto della complessità e nessun premio all'iner-zia: il che però, data la circolarità e l'interdipendenza di cui si è detto,deve valere per ognuna delle parti e quindi, ovviamente, anche per ilMinistero.
Veniamo, infine, agli elementi più strettamente legati alla fase di av-vio della disciplina dettata dal Codice, nella quale vanno privilegiateazioni e attività più che interventi strettamente normativi.
lntendiamoci. Interventi legislativi, peraltro previsti nel biennio dal-l'entrata in vigore del Codice, saranno certamente utili per chiarire ointegrare i punti dubbi o lacunosi del medesimo, come il rapporto tral'art. 12 ultimo comma e legge 326/03, la disciplina dei conferimenti difunzioni, i principi fondamentali in materia di gestione, la «doverosità»della collaborazione tra Stato e regioni nella redazione dei piani pae-saggistici o la permanenza o meno dei vincoli apposti alle aree tutelateex lege dopo l'approvazione di questi ultimi.

Marco Cammelli - 57
Resta però la necessità di porre mano a forme efficaci e riconoscibilidi controllo, di valutazione integrata delle risorse globalmente disponibilie di ripartizione di quelle centrali, di censimento e catalogazione delpatrimonio culturale, di acquisizione e circolazione di saperi su cui co-struire standards e livelli essenziali delle prestazioni, di formazione (au-spicabilmente congiunta per compiti o settori omogenei) del personale.Se a questo si aggiungono le numerose ipotesi nelle quali il Codice rin-via a criteri da determinarsi in via generale per le più svariate attività, ilmeno che può dirsi è che la cooperazione tra centro e governo localedeve avviarsi fin da questi momenti e deve poter contare sui saperi e leinformazioni che solo le attività appena citate possono assicurare.
Molto di tutto questo è al centro, ma altrettanto e forse più è nelledisponibilità delle regioni e del sistema locale, basti pensare allo statutodi organizzazione dei servizi e del personale, alle intese con il centroper la determinazione dei profili professionali per conservazione e re-stauro, allo studio e alla sperimentazione (prima ancora che la norma-zione) delle forme di gestione, specie dopo la sentenza della Corte co-stituzionale 272/2004, di cui si è detto, al nodo cruciale delle politiche disettore connesse a quelle sui beni culturali e sul paesaggio, alla coope-razione tra regione e enti locali e alla necessaria messa a punto delruolo dell'una e degli altri.
Decisamente la fase che si è aperta con l'entrata in vigore del Codi-ce è molto di più del semplice «recepimento» del d. lgs. 42/ 2004.
* Il presente testo riproduce, con alcune modifiche e integrazioni, la parte conclusiva
dell’introduzione de ”Il Codice dei beni culturali e del paesaggio”, Bologna, Il Mulino,2004, curato dal professor Cammelli, che ne ha svolto le tematiche in veste di coordinato-re della prima sessione del Convegno.


Daniele Carletti - 59
Dalla parte dello StatoDaniele CarlettiMinistero per i Beni e le Attività Culturali
MiBAC - Ufficio LegislativoVia del Collegio Romano, 2700186 - Roma
Un plauso all’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Re-gione Emilia-Romagna per aver voluto offrire con il presente convegno,agli operatori del settore, ma anche ai semplici cittadini, l’opportunità diaffrontare temi rilevanti, quali quelli della tutela e della valorizzazionedel patrimonio culturale e dei paesaggi italiani, ascoltando le opinioni dicoloro che, per ragioni istituzionali o professionali, “maneggiano”, percosì dire, la materia e possono offrire qualche utile contributo alla com-prensione e alla definizione dei problemi di interpretazione ed applica-zione delle norme, con particolare riguardo a quelle del nuovo Codicedei beni culturali e del paesaggio, entrato in vigore - come noto - loscorso 1° maggio.
Ritengo che occasioni come questa siano particolarmente opportu-ne, non solo per l’approfondimento delle tematiche che esse consento-no, ma anche perché favoriscono un confronto pacato tra le opinioni;ciò che non sembra costituire la nota dominante del dibattito sul Codi-ce.
Prendo spunto volentieri dal dettagliato resoconto fatto da Alessan-dro Zucchini dell’andamento dei lavori della “Commissione Trotta”, in-caricata di elaborare la bozza del Codice applicando i principi e i criteridirettivi formulati dalla legge di delega n. 137 del 2001; dal quale, tutta-via, si potrebbe ricavare una immagine del Ministero che non mi sentodi accreditare: quella del “Signor NO!” che si oppone a qualunque solu-zione che non sia perfettamente in linea con le sue posizioni. Credoche questo non si possa dire del Ministero, alla luce dei fatti.
Innanzitutto, è bene ricordare quali erano le posizioni originarie delleparti all’avvio dei lavori della Commissione Trotta. Concordo con Zuc-chini sul fatto che, nell’ambito della Commissione, fossero prevalenti letesi di chi voleva lasciare alla funzione di valorizzazione un contenutoresiduale, considerando di pertinenza della stessa tutto ciò che nonpotesse essere ricondotto, anche in via indiretta, nell’ambito della tute-la.

60 - Dalla parte dello Stato
Ma va detto che la tesi contrapposta appariva non meno“integralista”. Si sosteneva, infatti, da parte dei rappresentanti delle re-gioni e degli enti locali, che la funzione di tutela del patrimonio culturalesi esaurisse nella vigilanza sulle condizioni di conservazione materialedel bene e nel controllo sugli interventi di restauro, tutto il resto rien-trando nell’orbita della valorizzazione: la ricerca, lo studio e la diffusionedei relativi risultati, il miglioramento delle condizioni di conservazione, lafruizione e, soprattutto, la gestione; termine, quest’ultimo, con il quale siintendeva ogni attività avente ad oggetto beni culturali che non fossestrettamente legata ad esigenze di conservazione.
Con il paradossale risultato di sottomettere alle disposizioni regiona-li, emanate nell’esercizio della potestà legislativa concorrente ricono-sciuta dall’art. 117 della Costituzione alle regioni in materia, appunto, divalorizzazione, l’attività di chi, ogni mattina, apre il portone di un museostatale, attiva l’illuminazione ed il sistema di regolazione termica dellesale, regola l’afflusso dei visitatori, sorveglia, dà informazioni al pubbli-co, etc.: insomma, tutto ciò che fino a ieri rientrava nella ordinaria ge-stione dell’istituto.
La situazione non era certo più rosea nel settore dei beni paesaggi-stici, in relazione al quale si è a lungo sostenuto, da parte dei rappre-sentanti degli enti territoriali in seno alla Commissione, che si trattassedi un aspetto afferente la materia del “governo del territorio”, oggettoanch’essa di potestà concorrente; se non, addirittura, di un’area dicompetenze riconducibile alla residuale potestà legislativa esclusivaregionale, dal momento che il citato art. 117 della Costituzione nonparla di paesaggio ma di “ambiente” o di “beni ambientali”.
Fortunatamente, in virtù della ragionevolezza degli interlocutori, maanche - devo dirlo - della tenacia del Ministro nel perseguire, ancheall’indomani della presentazione della prima bozza di Codice da partedella Commissione Trotta, l’obiettivo di un testo “condiviso”, quellafrattura tra Ministero e regioni che era apparsa profonda, si è progres-sivamente ricomposta e le parti hanno ricominciato, anzi, si può forsedire iniziato, a lavorare “insieme”.
È stata una bella esperienza. Ma soprattutto - io credo - proficua:Stato e regioni ed autonomie locali hanno insieme trovato la quadraturadel cerchio, rappresentata dal ricorso generalizzato al modello collabo-rativo su base pattizia. La chiave di volta del sistema dei rapporti tra ledescritte istituzioni è, infatti, costituita dagli “accordi ed intese” tra i pre-detti enti da raggiungere ai diversi livelli, a seconda dell’ampiezza degliobiettivi prefissati: in linea, come dirò tra breve, con le previsioni costi-tuzionali ed in piena coerenza con il principale criterio direttivo fissato

Daniele Carletti - 61
dalla delega: “adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione”(art. 10, comma 2, lett. a, della legge n. 137/2002).
Ma analizziamo più da vicino alcune delle previsioni del Codice re-lative all’assetto delle competenze statali, regionali e locali nelle mate-rie della tutela e della valorizzazione.
Partiamo dalla tutela, rammentando che la riforma del Titolo V dellaCostituzione, operata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, ha apertonell’ambito di tale funzione spazi di competenza regionale, attivabilisulla base delle “forme di intesa e coordinamento” tra le amministrazio-ni interessate disciplinate con legge dello Stato. Ebbene la legge delloStato, ossia il Codice, fissa all’articolo 5 e, dunque, tra i principi genera-li, il paradigma dei rapporti tra Stato ed enti territoriali in materia di tu-tela, ispirato al principio della (leale) cooperazione.
Possono distinguersi tre livelli di cooperazione. Il primo livello è co-stituito dal conferimento ope legis alle regioni dell’esercizio delle fun-zioni di tutela sui c.d. beni librari (più esattamente: “manoscritti, auto-grafi, carteggi, documenti, incunaboli, raccolte librarie non appartenentiallo Stato o non sottoposte alla tutela statale, nonché libri, stampe e in-cisioni non appartenenti allo Stato”), la cui titolarità rimane allo Stato invirtù del principio di unitarietà espresso all’art. 4, comma 1, del Codice.Occorre rilevare come le funzioni cui si fa riferimento risultano assai piùampie di quelle già esercitate dalle regioni sulla base della delega di cuiall’art. 9 del d.P.R. n. 3 del 1972: al di là, infatti, del potere di imporre ilvincolo e di quello di autorizzare la spedizione o l’esportazioneall’estero, le regioni altro non potevano fare se non “vegliare” sulla con-servazione e riproduzione dei beni e “proporre al Ministero” gli inter-venti di restauro, gli espropri e gli acquisti. Grazie al Codice, invece, leregioni possono oggi sostituirsi in toto allo Stato nella gestione dellatutela afferente i beni in argomento. Della stessa natura è il conferi-mento delle funzioni di tutela in materia di paesaggio, previsto dalle di-sposizioni dettate nella Parte terza del Codice.
Il secondo livello di cooperazione è costituito dal conferimento alleregioni dell’esercizio delle funzioni di tutela su ulteriori tipologie di benilibrari o ad essi assimilabili indicate dall’art. 5, comma 3, del Codice(“raccolte librarie private, nonché… carte geografiche, spartiti musicali,fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi ematrici, non appartenenti allo Stato”). In questo caso, il conferimentonon avviene direttamente per legge ma è attivabile mediante “specificiaccordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bol-zano”.

62 - Dalla parte dello Stato
Il percorso potrebbe essere il seguente: la Regione presentaall’organo ministeriale territorialmente competente (ora la direzione re-gionale, in base al nuovo regolamento di organizzazione del Ministero)la richiesta di conferimento in via temporanea dell’esercizio delle fun-zioni di tutela relative ad una determinata tipologia di beni, sulla base diun dettagliato progetto recante la descrizione dell’obiettivo prefissato, intermini di miglioramento qualitativo e/o quantitativo degli standard at-tuali di ricerca, studio, protezione o conservazione (e della eventualefruizione), l’indicazione delle risorse umane e strumentali disponibili, lafissazione dei tempi di realizzazione del progetto, le modalità di con-trollo sulle fasi della sua attuazione e di verifica dei risultati ottenuti. Ildirettore regionale formula eventuali osservazioni e proposte e, ove ne-cessario, collabora alla rimodulazione del progetto; quindi lo trasmetteal competente dipartimento che, esaminatolo e raccolti i pareri ritenutiopportuni, decide sulla richiesta regionale e, in caso di accoglimento,stipula l’accordo con la regione e lo sottopone alla Conferenza unifica-ta.
Il terzo livello prevede il ricorso alle stesse procedure appena de-scritte per l’individuazione di “forme di coordinamento” con le regioni inmateria di tutela, nonché di “particolari forme di cooperazione”, nellastessa materia, con gli enti locali.
Le forme di coordinamento possono riguardare sia funzioni il cuiesercizio sia stato conferito sia funzioni direttamente esercitate dal Mi-nistero, al fine di migliorarne il rendimento.
Relativamente alle funzioni il cui esercizio è stato in qualunquemodo oggetto di conferimento, competono al Ministero i poteri di vigi-lanza, di indirizzo e, in caso di perdurante inerzia o inadempienza, disostituzione.
Questo sul piano generale. Ma le disposizioni del Codice prevedonovariegate forme di collaborazione in settori particolari della tutela, talu-ne nuove, altre già utilmente praticate sotto la previgente disciplina.
Ricordiamo la cooperazione con le regioni in materia di catalogazio-ne dei beni culturali (art. 17 del Codice), che assume diverse forme. Leregioni, infatti:
- concorrono all’individuazione e definizione delle “metodologie co-muni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livellonazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delleregioni e degli altri enti pubblici territoriali”, ai fini della fissazione, daparte del Ministero, delle procedure e modalità di catalogazione;

Daniele Carletti - 63
- concorrono (anche con la collaborazione delle università) alla“definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziativescientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione”;
- curano, assieme agli enti locali, la catalogazione dei beni di rispet-tiva appartenenza e, previe intese con gli enti proprietari, degli altri beniculturali pubblici presenti sul territorio di pertinenza.
Ai sensi dell’art. 18, forme di intesa e di coordinamento con le regio-ni possono essere individuate dal Ministero anche per l’esercizio deipoteri di vigilanza sui beni culturali appartenenti alle regioni e agli altrienti pubblici territoriali.
L’art. 57 prevede la consultazione delle regioni e, per il tramite diqueste, degli enti locali, nel corso del procedimento di autorizzazioneall’alienazione di beni del demanio culturale, al fine di favorirnel’acquisto da parte di un ente territoriale ed il conseguente uso per fina-lità pubbliche, con evidenti vantaggi sul piano della conservazione edella fruizione collettiva del bene.
Gli artt. 60-62 confermano la possibilità dell’acquisto coattivo di unbene, in via di prelazione, da parte delle regioni e degli enti locali, conl’importante novità che ora l’ente interessato ha il potere di adottare ilrelativo provvedimento, allorché il Ministero abbia rinunciato ad eserci-tare a proprio vantaggio il relativo potere.
Ancora una conferma all’art. 83: si tratta dell’obbligo di consultare leregioni in merito alla destinazione più appropriata da dare al bene diproprietà privata che sia stato illecitamente trasferito all’estero e suc-cessivamente restituito all’Italia a seguito del proficuo esperimentodell’azione di restituzione, allorché il proprietario non lo abbia reclamatonel termine previsto, ai fini della migliore tutela e della pubblica fruizio-ne “nel contesto culturale più opportuno” .
Veniamo ora alla valorizzazione, la cui disciplina costituisce, proba-bilmente, la parte più innovativa del Codice per quel che attiene ai beniculturali; disciplina che si è resa necessaria per dare attuazione all’art.117 della Costituzione nel testo risultante alla riforma costituzionale,che inserisce la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali” tra lematerie di legislazione concorrente.
Tralascio di sottolineare una volta di più quanto artificiosa sia la di-stinzione tra tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, operata dallegislatore costituzionale in sede di riforma del Titolo V, quale criteriodistributivo delle competenze tra Stato e regioni (facendo dei beni cultu-rali e paesaggistici un caso unico nel panorama dell’art. 117, laddovetutte la altre competenze risultano distribuite in base al criterio dellamateria, con i limiti derivanti dall’attribuzione alla potestà legislativa

64 - Dalla parte dello Stato
dello Stato, in ogni caso, della “determinazione dei livelli essenzialidelle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono esseregarantiti su tutto il territorio nazionale” e, nella materie oggetto di pote-stà legislativa concorrente, della “determinazione dei principi fonda-mentali”); mentre mi preme evidenziare come il Codice, chiamato a ri-ordinare i rapporti tra lo Stato e le regioni in subiecta materia alla lucedi quel criterio, e tenendo conto dei nuovi equilibri politici prodotti dallastessa riforma, abbia individuato una soluzione equilibrata: quella di di-stinguere, concettualmente, la fruizione dalla valorizzazione propria-mente detta, riportandola nell’ambito della tutela, della quale essa rap-presenta il fine ultimo. Non v’è dubbio, infatti, che si studia, si ricono-sce, si protegge e si conserva il bene culturale affinché possa essereofferto alla conoscenza ed al godimento collettivi dei contemporanei edelle future generazioni.
Atteso che la “gestione” del bene culturale non è un’autonoma fun-zione, come lasciava intendere la confusa nozione di “gestione” fornitadal D.Lgs. 112 del 1998, ma è l’insieme delle attività strumentali a sup-porto sia della tutela sia della valorizzazione, la fruizione dei beni cultu-rali pubblici consiste nella ordinaria attività volta alla loro conservazionee musealizzazione ai fini della offerta al pubblico godimento. Così inte-sa, la fruizione viene a sanare l’indebita “frattura” fra tutela e valorizza-zione, poiché rappresenta il punto di sintesi tra le due funzioni, dell’unacostituendo il fine ultimo ed indefettibile, dell’altra, il presupposto ne-cessario.
Pur nella distinzione teorica, tuttavia, il Codice privilegia ancora unavolta, in ordine all’esercizio di entrambe le funzioni, il modello conven-zionale: Stato, regioni ed enti locali agiscono sulla base di programmiconcordati, di intese ed accordi, con l’obiettivo di agevolare la realizza-zione di sistemi integrati di fruizione e valorizzazione, aventi tenden-zialmente ad oggetto tutti i beni pubblici presenti sul territorio regionale.
In tal modo, il nuovo assetto costituzionale risulta non soltanto for-malmente rispettato, bensì attuato nella forma più efficace.
Anche in questo caso, oggetto di accordo è, innanzitutto, un pro-getto ad iniziativa statale o regionale che individui tempi, modi e risorseper la fruizione o la valorizzazione integrata di beni dello Stato e deglienti pubblici territoriali; secondariamente, le opportune forme di gestio-ne delle attività progettate, scelte tra quelle previste dall’art. 115 delCodice.
Ove all’accordo non si giunga, alla fruizione e valorizzazione deipropri beni provvede il singolo soggetto pubblico, in attuazione dei prin-cipi contenuti negli artt. 1, comma 3, 102, comma 4, e 112, comma 4.

Daniele Carletti - 65
Mi preme, prima di concludere, tornare brevemente su alcuni deipunti che il professor Cammelli nel suo intervento ha voluto inserire trale “pecche” del Codice.
Due di queste presunte mende meritano, in particolare, di essereconsiderate.
La prima riguarda l’introduzione dell’obbligo di denunciare il trasfe-rimento della detenzione di immobili di interesse storico-artistico, cheavrebbe creato incertezze e preoccupazioni nei proprietari e negli in-quilini di tali immobili, soprattutto in relazione alla necessità o meno didi provvedere alla denuncia ex articolo 59 dei contratti di locazione incorso alla data del 1° maggio 2004 (corrispondente alla entrata in vigo-re del Codice).
Va subito detto che l’obbligo di denunciare all’Amministrazione sia ipassaggi di proprietà che i passaggi di detenzione era già previsto dallalegge Bottai del 1939, dalla quale lo ha ripreso il Testo unico del 1999introducendo il termine di trenta giorni per l’adempimento. Il Codice hasoltanto mutato il soggetto obbligato alla denuncia del trasferimento didetenzione, sostituendo al “detentore” il “cedente la detenzione”; con laconseguenza che dal 1° maggio 2004 il conduttore-detentore di un im-mobile locato con un contratto in corso alla data del 1° maggio 2004,che abbia omesso di farne denuncia in violazione delle prescrizioni delTesto unico, non è più tenuto a farla, in quanto l’abrogazione della pre-vigente normativa ha determinato il venir meno, nei suoi confronti, siadell’obbligo di denuncia sia delle conseguenze penali connesse allasua violazione.
Con il Codice è, invece, il proprietario dell’immobile che assume an-che l’obbligo di denunciare ogni contratto che comporti la cessionedella detenzione (quali, ad esempio, i contratti di locazione, affitto, co-modato, cessione in uso); obbligo che vale, ovviamente, solo per i con-tratti stipulati a partire dal 1° maggio 2004, poiché prima di quella datatale obbligo non sussisteva.
Mi sembra di poter dire, allora, che l’allarme lanciato dalle associa-zioni di categoria dei proprietari e degli inquilini di immobili di valoreculturale, non ha fondamento alcuno.
Pure ingiusta, mi pare, l’accusa - garbatamente rivolta dal professorCammelli al Ministero - di non aver recuperato, dell’abrogato Dpr 283del 2000, recante la disciplina regolamentare delle alienazioni degliimmobili del demanio storico e artistico, almeno la disposizione cheprevedeva l’inserimento nel contratto di alienazione di immobili già de-maniali della clausola risolutiva di cui all’art. 1456 del codice civile per ilcaso di inosservanza delle prescrizioni dettate dal provvedimento auto-

66 - Dalla parte dello Stato
rizzatorio e riguardanti le misure di conservazione del bene, gli usi in-compatibili, le condizioni di fruizione pubblica.
Al riguardo, è il caso di osservare che quella clausola, in quantoclausola contrattuale, doveva essere fatta valere dall’ente alienante, ilquale, in caso di contestazione, avrebbe dovuto adire il giudice civile.Tutto ciò sulla base di una comunicazione del competente organo mini-steriale (all’epoca il Soprintendente regionale), cui spettava, quindi, divigilare sull’utilizzazione dell’immobile da parte del privato acquirente.Mi chiedo a questo punto: quanto è efficace la previsione di cui stiamoparlando? Lo è, evidentemente, nella misura in cui risulta efficacel’attività di vigilanza espletata dalle Soprintendenze nei confronti deibeni di proprietà privata sottoposti a tutela.
Sappiamo tutti che, per i ben noti motivi, tale vigilanza è molto menoassidua di quanto occorra, cosicché, tralasciando i casi di sistematicaviolazione delle norme, un controllo effettivo circa l’uso del bene inmodo conforme a quanto indicato nell’autorizzazione alla vendita potràessere effettuato soltanto in sede di esame dei progetti degli interventidi tutela e/o di valorizzazione previsti sul bene, ai fini della loro appro-vazione: questo sembra essere, infatti, l’unico strumento davvero effi-cace per esigere il rispetto delle prescrizioni dettate dall’Amministra-zione.
Il Codice, pertanto, ha puntato sul contenuto delle prescrizioni dadettare in sede di autorizzazione alla vendita, consapevole del fatto cheesse sono elemento essenziale per orientare la successiva valutazionedei progetti di intervento da parte del Soprintendente; ed ha previstoche tali prescrizioni abbiano ad oggetto, nel caso dei beni del demanioculturale, non gli “usi incompatibili”, come voleva il regolamento del2000, bensì le “destinazioni d’uso compatibili con il carattere storico edartistico degli immobili”, limitando in tal modo assai più incisivamente lospazio di manovra dei privati acquirenti.

Mariella Zoppi - 67
Regioni e Codice dei beni culturaliMariella ZoppiAssessore alla Cultura della Regione Toscana
Assessorato alla cultura, Regione ToscanaVia Farini, 850121 - Firenze
I rapporti fra le Regioni ed Ministero dei Beni ed Attività Culturali(semplifico la dizione) sono stati finora piuttosto tesi su molteplici mate-rie: il conflitto è originato dall'applicazione del Titolo V della Costituzio-ne e dall'insieme del sistema della legislazione cosiddetta concorrenteinerente al settore delle attività (spettacolo, sport) nonché alle ipotesi dipossibile attuazione di Autonomie Speciali definite dall'art.116 III com-ma del Titolo V della Costituzione, nel confronti del quale Regioni comela Toscana hanno da tempo dichiarato un interesse specifico. Alla con-troversa applicazione del Titolo V (rispetto alla quale aspettiamo di co-noscere le motivazioni del parere negativo espresso dalla Corte Costi-tuzionale in materia di regolamento sullo spettacolo) si è aggiunta lanon applicazione della Bassanini (es. art. 150 /112, sul passaggio digestione agli Enti locali dei beni statali) e un clima di dominazione trop-po spesso autoritaria degli organi periferici del Ministero sui territori diloro competenza, a questo possiamo aggiungere l'uso centralizzato distrumenti privatistici come l'Arcus Spa (Agenzia, peraltro ereditata dalprecedente Governo) e più in generale su una mancata dialettica fraMinistero, Regioni ed Enti locali.
In breve, si è vissuta una separazione quasi ossessiva dei poteri edelle competenze, sostenuta da un sospetto pregiudiziale per cui qual-siasi delega agli Enti locali andava a costituire di per sé un pericologravissimo per il patrimonio culturale nazionale, rispetto al quale persi-no i privati sembravano dare più garanzie.
Va detto che il Codice dei Beni Culturali sembra correggere questaanacronistica tendenza, che però non trova corrispettivo né nella re-cente riforma del Ministero stesso né nelle nomine dei direttori generaliregionali che sono passati sulla testa di ogni logica di possibile dialogo.
Vogliamo tuttavia non chiuderci in una contrapposizione aprioristicae continuare a vedere il Codice come un possibile campo di applica-zione di quella "leale collaborazione" che sembra aprire alcuni interes-santi campi di cooperazione fra Stato e Regioni, schiudendo prospetti-ve anche nell'esercizio dei compiti di tutela. Infatti possiamo dire che ilCodice propone un quadro sufficientemente chiaro nell'ambito del pae-

68 - Regioni e Codice dei beni culturali
saggio e ribadisce e allarga la delega sui Beni librari. Allo stato attuale,dunque, il Codice segna un passo avanti in quella che la stessa Costi-tuzione definisce "leale collaborazione" fra lo Stato e le sue Autonomielocali.
Non voglio certo dare qui una lettura del Codice, in quanto ormai loconosciamo assai bene, tuttavia è opportuno ricordare come, oltre legrandi definizioni esplicitate relativamente alla nozione di bene cultu-rale, di tutela, di valorizzazione (o forse ormai dovremo parlare di frui-zione che sembra sostituirsi all'ormai antico "valorizzazione-gestione"),le novità di maggiore interesse per le Regioni ed il sistema degli entilocali potrebbero essere gli accordi o intese enunciate dall'art. 5 chearriva a prospettare che "ulteriori funzioni di tutela possono essereconferite alle Regioni che ne facciano richiesta". Dico "potrebbero es-sere" perché nulla è detto sulle modalità con cui queste potranno avve-nire, attraverso quale iter e rispetto a quale organo esse possano esse-re stipulate.
Ma voglio continuare ad essere possibilista ed a cercare le altreaperture verso un possibile decentramento che si trovano nel testo eriguardano in particolare: la catalogazione del patrimonio culturale (art.17) ovvero le operazioni volte ad una leale e condivisa conoscenza delpatrimonio che è uno dei nodi fondamentali in un momento nel quale sipropongono smembramenti, ipotesi di vendita e vendite (aldilà delleproblematiche relative al silenzio-assenso ed ai suoi tempi). Non bastala protezione generalizzata su tutto quanto ha più di 50 anni, ma sononecessari strumenti consultabili di catalogazione che permettano diprendere decisioni "consapevoli" e rapide. In quest'ottica la Toscanadispone di un Atlante dei vincoli, ovvero di una cartografia su supportoinformatico (fra poco consultabile via internet) contenente la georefe-renziazione di tutti i vincoli (archeologici, ex leggi '39, Galasso, ecc.)riportati sulla carta tecnica regionale, con rimandi alle planimetrie cata-stali e la contemporanea possibilità di consultare direttamente anche ildecreto di vincolo. Un lavoro di due anni che costituisce un'anticipazio-ne preziosa di quella cooperazione fra la Regione e lo Stato di cui ilCodice parla.
Un altro punto attiene alla vigilanza sui beni (art. 18) e alla definizio-ne delle linee di indirizzo, nonché alle norme tecniche ed ai criteri inmateria di conservazione di beni culturali (art. 29, comma 5). Non ap-pare trascurabile l'istituzione di Centri di ricerca, la sperimentazionesulla conservazione ed il restauro (art. 29 comma 11) che apre tutto iltema dell'innovazione e delle tecniche di restauro non invasive, su cuimolte Regioni sono da tempo impegnate in accordo con le loro Univer-sità ed i Centri di ricerca. Tuttavia è necessario stare attenti ai duplicati:

Mariella Zoppi - 69
esistono già tante sedi in cui si lavora su questi temi e forse sarebbepiù opportuno pensare a creare le reti per collegare i centri esistenti equelli, eventualmente, da costituire in modo da garantire non solo latrasparenza e una più ampia apertura alla ricerca, ma anche una mag-giore disponibilità per gli utilizzatori finali con una migliore interazionefra i progetti, scambio di informazioni, buone pratiche, tecnologie adot-tate ed esperienze sul campo.
Dunque, se è vero che siamo di fronte ad una prima (se pur confu-sa) apertura verso le Regioni e gli Enti locali, tuttavia le Regioni sonoapparse caute rispetto a questo provvedimento ed il motivo è ravvisa-bile nei passi successivi che il Ministero dovrà fare per dare corpo alCodice e con i quali dovrà con maggior chiarezza individuare le formee le modalità delle collaborazioni. Il dubbio è legittimo soprattutto seconfrontato con provvedimenti anche molto recenti quali la già ricordataRiforma del Ministero e la politica degli interventi e della distribuzionedelle risorse attraverso l'Arcus Spa, che rafforzano una concezionecentrale e burocratica contrapposta al sistema delle Autonomie localied, inoltre, è legittimo chiedersi se sia giusto, ed in che misura, far in-tervenire un soggetto esterno (agenzia) stabilendo percorsi paralleliagli strumenti ordinari interni.
Ma questo fa parte di un dibattito sulle forme (e sulla chiarezza delleregole) della privatizzazione che in questo momento non è il caso diaffrontare.
Certo è doveroso sottolineare la mancanza di dialettica fra il Mini-stero e gli Enti locali che dovrebbe essere alla base del lavoro a "tutti ilivelli" nell'area della tutela-valorizzazione dei beni culturali e, visto chesiamo tutti freschi della notizia, è doveroso un accenno al metodo, deltutto autocratico, con cui il ministero ha nominato i soprintendenti re-gionali, quando tutte le Regioni si auguravano (è troppo dire "sperava-no"?) ad una Soprintendenza regionale "terza" rispetto sia allo Statoche alle Regioni stesse. Ma evidentemente le "collaborazioni" possonoessere intese in vario modo. E questo, per la verità, getta nuove ombreanche su chi, come me, aveva visto nel Codice una svolta, sia pur timi-da e reticente, nei rapporti fra Stato e Regioni.
In ogni caso, resto del parere che il Codice vada preso sul serio finoin fondo e valutato ed attuato in tutte le sue possibilità di collaborazioneed integrazione di competenze. Fatto questo che impegna le Regionisu due versanti: quello dei rapporti con lo stato e quello dei rapporti congli Enti Locali.
Infatti la capacità di dare risposte adeguate al sistema degli Enti lo-cali rappresenterà un capitolo decisivo nell'attuazione del Codice stes-

70 - Regioni e Codice dei beni culturali
so ed implica una capacità legislativa ed organizzativa tutt'altro chesemplice.
Spero proprio che non si debba andare ad organizzazioni parallelefra Stato e Regioni nei campi di cooperazione quali le parti riguardantila tutela, come pure la catalogazione o la vigilanza.
Temi che troveranno una risposta -che mi auguro il più unitaria pos-sibile fra le diverse regioni- nei provvedimenti legislativi ed amministra-tivi che andremo a prendere per riallineare le nostre legislazioni regio-nali al Codice.
Termino con una considerazione che vuol mettere in relazione poli-tiche, territori e risorse e che passa per il concetto di collaborazione"necessaria” che costituisce una sia pur piccola garanzia per il sistemadegli Enti locali.
Infatti, l'aver introdotto il concetto di collaborazione, induce un crite-rio di compartecipazione delle risorse che, in un momento finanziaria-mente non esaltante (riduzione del 30% delle risorse nazionali dal 2001al 2003, secondo il rapporto annuale Federculture), potrebbe indurre acomporre un diverso quadro di relazioni, che saranno comunque assaivarie rispetto al complesso del territorio nazionale e rispetto alle quali loStato sarà sempre l'elemento forte sia come capacità di intervento checome capacità impositiva sulle scelte che si faranno sul territorio, unterritorio che tuttavia non può più essere considerato indifferente allecomunità che lo abitano e alle politiche degli enti che lo amministrano.
Dovremo, dunque, da una parte continuare nella nostra logica diprogrammazione culturale e dall'altra far fronte a politiche ed interventi"necessariamente" condivisi, pena la casuale episodicità delle stesseazioni che lo Stato intenda svolgere, se non si vogliono recare danniirreparabili proprio a quell'integrità del patrimonio culturale ed alla suaconservazione, che tutti invochiamo come prioritaria per il nostro pae-se.

Elio Garzillo - 71
I princìpi ed il contestoElio GarzilloSoprintendente Regionale per i Beni e le attività Culturali dell’Emilia-Romagna
MiBACVia del Collegio Romano, 2700186 - Roma
I numerosi spunti offerti dalle relazioni presentate, e la loro esausti-vità, mi inducono a concentrare l’intervento solo su alcune fra le“novità” introdotte dal Codice.
Le pratiche della tutela e della gestione del nostro patrimonio ven-gono articolate, attraverso la nuova normativa, in un ambito organico esistematico e in un’ottica fortemente collaborativa, in una sorta di“rivoluzione copernicana” che vede protagonisti - con lo Stato - gli Entipubblici territoriali, attraverso un nuovo modello pattizio. Il nuovo mo-dello (quasi una nuova “stagione”), peraltro, è stato anticipato, in ma-niera assai concreta e propositiva, proprio qui, in Emilia-Romagna, apartire dallo scorso mese di ottobre.
Infatti, Ministero, Regione e Associazioni delle Autonomie localihanno sottoscritto un accordo (sulla scorta delle previsioni della LeggeRegionale 31/2002) finalizzato ad attuare una (forte) forma di collabo-razione istituzionale che impegna le parti a garantire la corretta gestio-ne della tutela del territorio, la valutazione consapevole delle trasforma-zioni e la salvaguardia dei valori storici, culturali, naturalistici e paesag-gistici, attraverso il riconoscimento di un chiaro e condiviso quadro diriferimento strumentale e normativo. Una legge (la 31/02) ed un“accordo” quanto mai significativi e propositivi: ma è il caso di questaRegione e del modello collaborativo (in cui ha avuto un ruolo determi-nante la stessa Soprintendenza Regionale) che qui è andato forman-dosi, nel tempo.
C’è stato un accenno alla “realtà astratta delle Regioni”: ed infatti,prendendo in considerazione la sola tutela paesistica, oggi, a circaventi anni dall’entrata in vigore della “legge Galasso”, sono presenti sulterritorio realtà regionali in controtendenza, che si sono - ad esempio -faticosamente dotate di piani dal carattere meramente (ed esclusiva-mente) descrittivo, quindi sostanzialmente inutili, o che sono addiritturaprive di qualsiasi forma di pianificazione paesaggistica.

72 - I princìpi ed il contesto
Come dire che le previsioni della “parte terza del Codice” dovrannoconfrontarsi - necessariamente - con realtà che sono eterogenee fraloro e che hanno assunto, nel tempo comportamenti diversi (potrebbeanche determinarsi una forma di sottovalutazione di importanti “dati or-ganizzativi reali”, come l’esistenza in Emilia-Romagna di un organismoquale l’IBC). E, naturalmente, legge-delega sull’ambiente (sempre diottobre u.s.) permettendo.
Vorrei, invece, sottoporvi -come mi è stato chiesto- alcune breviconsiderazioni sul tema dell’alienabilità dei beni in mano pubblica: chenon è di sicuro l’unico argomento della “parte seconda del Codice”, mane è certamente un fondamento, nel suo costituire l’opportuna unitariaricomposizione di un complesso normativo che si presentava troppoarticolato e quasi caotico.
Si è molto discusso (in termini generalmente negativi) sull’istituto delsilenzio-assenso, cioè sulla determinazione di un termine finale (120giorni) per il procedimento di preventiva verifica dell’eventuale interesseculturale del patrimonio immobiliare pubblico da parte delle competentiSoprintendenze, pena la presunzione di esito negativo.
Prescindendo dal fondamento giuridico delle critiche, ritengo, forseun po’ fuori dal coro, che il termine previsto sia assolutamente congruoe calibrato. Come esempio, posso riferirvi che, recentemente,nell’attività propria della Soprintendenza Regionale, sono stati effettuatiaccertamenti numerosi e in tempi ben più ristretti: e, questo, senza -all’epoca - reali riferimenti normativi e senza schede di sorta (attingen-do informazioni solo dagli elenchi dell’Agenzia del Demanio pubblicatisulla G.U. e “marcati” da riferimenti esclusivamente di carattere cata-stale), in condizioni quindi di gran lunga più problematiche. Verità è, alriguardo, che il sistema di schedatura previsto dal decreto interministe-riale del febbraio scorso (a firma del Direttore Generale per i Beni Ar-chitettonici ed il Paesaggio e del Direttore Generale dell’Agenzia delDemanio), mette a fuoco un autentico identikit di ciascun bene e con-sente un’attività valutativa dell’interesse tanto veloce quanto motivata ecoscienziosa.
I tempi di trasmissione e la consistenza numerica delle schede de-scrittive vengono concordate e definite caso per caso: ma ritengo chela tempistica nel suo insieme (includendo, quindi, anche gli accerta-menti riferiti agli immobili appartenenti alla Regione, alle Province, aiComuni e ad ogni altro Ente ed Istituto pubblico) debba necessaria-mente essere articolata in modo da non far superare i tre, massimoquattro, anni per la ricognizione completa del valore storico-artistico delpatrimonio.

Elio Garzillo - 73
Questa del censimento è, d’altronde, un’occasione assolutamentestorica, epocale, con -al suo interno- un validissimo sistema di rileva-zione ed informatizzazione, con dati (finalmente completi) che vengonoinseriti in un database a disposizione on-line. Come SoprintendenzaRegionale, ho ritenuto necessario -per brevità ed omogeneità- poter fa-re riferimento anzitutto ad un accordo in grado di coinvolgere unitaria-mente tutti gli Enti Pubblici Territoriali della Regione (un unico accordo,quindi, con ben 351 Enti, coordinati e rappresentati da Regione Emilia-Romagna, ANCI ed UPI).
L’accordo, in avanzata fase di elaborazione, verrà definitivamentesottoscritto a breve e terrà conto della necessità di fornire adeguateforme di collaborazione e di supporto tecnico (specie per i Comuni chenon posseggono adeguate risorse professionali e strumentali peradempiere alle procedure previste), di forme di monitoraggio e verificaperiodica, con conseguente inserimento e gestione dei dati -tutti i dati,anche quelli oggetto di verifica “negativa”- all’interno dei sistemi infor-mativi territoriali, utili ed accessibili alla più vasta comunità.
È prevista, in una fase immediatamente successiva, l’estensionedell’accordo agli altri Enti o Istituti interessati: in ogni caso, pur dividen-do gli Enti in “classi dimensionali” differenziate, la tempistica comples-siva, assai facilitata -peraltro- dagli esaustivi contenuti delle schede de-scrittive e del modello informatico predisposto, dovrà consentire il com-pletamento della ricognizione non oltre il tempo sopraindicato. La mes-sa in moto di una nuova, forse inedita, forma di cooperazione fra am-ministrazioni pubbliche agevolerà non poco il raggiungimento, indila-zionabile, del risultato. Potrà anche tenersi in adeguato conto -e finan-che esaminato nel merito: altrimenti si entrerebbe quasi in una logicapremiale degli Enti che non hanno fatto nulla- il materiale (con elenchi)prodotto, a suo tempo, ai sensi e per gli effetti del “Decreto Melandri”,abrogato, come è noto, prima che potesse espletare (anche nella tem-pistica) il suo ruolo e la sua funzione. Non appare assolutamente op-portuno, in ogni caso, rinviare ad una fase successiva l’inserimento deidati delle schede prese in esame (e valutate attraverso la necessariaattività valutativa-ricognitoria) ai sensi del 283/00 nel database unitarioa disposizione on-line: i rischi conseguenti a tale mancato o rinviato in-serimento sarebbero infatti elevati e comunque non accettabili.
In un ambito di chiarezza (e trasparenza) l’eventuale inclusione dialcuni beni immobiliari nella nuova categoria “testimonianza dell’identitàe della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose” (dilatazio-ne della componente storicistica del “demanio culturale”) va opportu-namente, per le sue conseguenze (non alienabilità), dichiarata già nella

74 - I princìpi ed il contesto
fase di valutazione, piuttosto che rinviata al momento autorizzativo.Momento, quest’ultimo, in cui vanno solo precisate le prescrizioni,contenute nell’autorizzazione, nei confronti del privato acquirente. Pre-scrizioni, queste, che costituiscono il fulcro del sistema di garanzia inbase al quale il bene culturale demaniale venduto può effettivamentecontinuare ad espletare la propria funzione.
Questo, davvero fondamentale, aspetto, cioè il valore obbligatoriodelle prescrizioni in grado di consentire ed obbligare ad una condotta diutilizzo adeguata, sia il soggetto acquirente (che i successivi possesso-ri), non sembra adeguatamente valorizzato nel Codice. Lo strumento diprotezione, di indubbia efficacia, previsto dal Dpr 283/00 (clausola ri-solutiva esplicitata nel negozio di trasmissione della proprietà, con di-verse ulteriori clausole al proprio interno) non è stato recepito esplici-tamente nel Codice. Al di là delle previsioni di carattere generale (con-tenute nell’art.20 o nell’art.170), non vi è un modello che, con il precet-to, preveda un meccanismo sanzionatorio in grado di attribuire efficaciaal precetto medesimo.
Ecco: i rischi, o i motivi di perplessità, sono concentrati proprio in al-cune forme di discrasia (o possibile tale) fra la norma e la sua concretaapplicazione.
Come nei casi, che dovrebbero essere non rari, di beni immobili chesi caratterizzano per la loro funzione identitaria per la storia delle istitu-zioni, come “testimonianza dell’identità e della storia delle istituzionipubbliche, collettive o religiose” (categoria di beni non alienabili, da cir-ca quattro anni) ma di cui non sono a conoscenza di esempi fuori dallanostra Regione. Nella “rassegna stampa” che ci è stata consegnatacompare, ad esempio, un articolo (datato 24 marzo) in cui un Soprin-tendente romano denuncia la gravità della scelta dell’Amministrazionefinanziaria di alienare l’edificio del Poligrafico dello Stato, storica sededella Zecca. Non avrei dubbi sul fatto che un edificio del genere, noncasualmente scelto come emblema e simbolo del Poligrafico e Zeccadello Stato, inserito come logo anche in pubblicazioni del Ministero per iBeni Culturali, dovesse essere dichiarato di interesse particolarmenteimportante quale “testimonianza dell’identità” e della storia diquell’istituzione. Non avrei dubbi, quindi, sul carattere demaniale e nonalienabile di quell’importante edificio.
Altra forma di “discrasia” è quella che sembra reiterarsi attraverso leGazzette Ufficiali del 23 (o 24) dicembre, per ora degli anni 2002 e2003.
Nel primo caso (2002), sono stati alienati -ma questo viene compre-so solo in progress- 40 beni, fra cui alcuni notoriamente “storici” dello

Elio Garzillo - 75
Stato e numerose ex Manifatture Tabacchi, senza consentire alcunapreventiva verifica da parte del Ministero (né sull’eventualità che vi fos-sero, nell’elenco, beni extra commercium, né sulla necessità di prescri-zioni per la salvaguardia per i beni di interesse culturale). La pur tem-pestiva esplicitazione dell’interesse culturale di uno di quei beni, la Ma-nifattura Tabacchi di Modena, all’Agenzia del Demanio (ritenuta, inge-nuamente, sicuro riferimento proprietario), ha provocato la stizzita re-azione della Fintecna Spa, che ha comunicato di aver acquistatol’intero “blocco” (ivi incluso il complesso immobiliare modenese), atrattativa privata, con rogito del notaio Parenti, in Roma e in data 27 di-cembre 2002. Tutto questo, quindi, molto prima che il D.L. di riferimen-to, “disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali,di riscossione e di procedure di contabilità” (n.282 del 24.12.02, art. 7)venisse tempestivamente convertito nella legge n .27 del successivo 21febbraio.
Nel secondo caso (2003), la procedura si è sviluppata, se mai pos-sibile, ancor più rapidamente: un elenco di 276 beni immobili ubicatisull’intero territorio nazionale (D.M.10.12.03, pubblicato sulla G.U.del23.12.2003), beni appartenenti agli ex Monopoli dello Stato, è stato og-getto -ma anche questo viene compreso solo in progress- di vendita inblocco lo stesso giorno 23 dicembre alla medesima Fintecna Spa. Nonera stata predisposta alcuna scheda descrittiva di cui all’art. 27(D.L.269/03) né alcun’altra procedura, pur prevista dal medesimo arti-colo ed esplicitamente richiamata nel testo normativo pubblicato sullaG.U. del 23 dicembre. In più, il successivo 22 marzo, la Direzione Cen-trale Area Operativa dell’Agenzia del Demanio comunicava formal-mente che “si trattava di immobili con vetustà inferiore ai 50 anni e nongravati dal vincolo di interesse storico artistico.” Facendo riferimentoall’Emilia-Romagna, posso comunicare che nell’elenco era incluso ungruppo di “case dei salinari” di Cervia (immobili assai noti ed oggetto dipubblicazioni), risalenti al settecento, i coevi magazzini del sale e/o se-de dei Monopoli di Cervia, nonché alcuni terreni dichiarati di interessearcheologico (due categorie, queste ultime, esplicitamente extra com-mercium).
Il primo gruppo era alienabile, quindi, con le condizioni e le prescri-zioni cui prima si è fatto cenno, i secondi facevano parte di fattispecietipologiche inalienabili. Non sono a conoscenza, al momento, degli esitiche hanno sortito le conseguenti, articolate azioni e decisioni assunteresponsabilmente (dopo aver previamente informato e sollecitato gli or-gani centrali) dalla Soprintendenza Regionale. Non sono neppure a co-noscenza di quanti analoghi casi si siano verificati fra i complessivi 276

76 - I princìpi ed il contesto
“pezzi” posti in vendita con questa procedura e quante SoprintendenzeRegionali abbiano assunto analoghi provvedimenti.
Una conseguenza, che ritengo opportuno trarre, è quelladell’urgenza - quindi non solo culturale (occasione storica ed epocale,la definivamo nel corso del convegno) ma anche di pratica tutela- diprocedere senza indugi alla prevista fase di ricognizione. I rallentamen-ti, in qualche misura auspicati anche da alcune strutture ministeriali,non possono portare a nulla di buono: le vendite (fra cui anche le“svendite” di fine anno) non vengono affatto fermate in attesa dellaschedatura. Il problema (un problema, però essenziale) è la vendita diquello che non è schedato, e, spesso, non è neanche noto: come nelcaso di recenti aste dell’Usl di Firenze, con parti di collina e storici ca-scinali (o ville) venduti, con evidenza pubblica, senza preventiva verifi-ca. La differenza sta tutta fra metodo codificato e normato (su cui si ac-centrano attenzioni e critiche a volta ingenerose) e prassi operativa(che sembra in alcuni casi procedere autonomamente e nella diffusadisattenzione).

Alberto Vanelli - 77
Fra tutela e valorizzazioneAlberto VanelliDirettore ai Beni Culturali della Regione Piemonte
Regione PiemonteVia Meucci, 110121 Torino
In base alle considerazioni puntuali e acute del professor Cammellie degli altri intervenuti, come pure all’inquadramento delle problemati-che politiche sollevate dall’Assessore Zoppi, mi pare che molte cosesiano state dette e sia inutile ripetere. Quindi mi concentrerei su tre oquattro osservazioni “laterali” al problema del Codice.
La prima è la denuncia di un dispiacere già palesatonell’introduzione, mi riferisco al fatto che mentre la trattativa sul Codiceera in corso e coinvolgeva in modo appassionato l’ufficio amministrativodel ministero e le rappresentanze delle regioni e degli enti locali, a que-sto confronto non ha fatto eco un dibattito culturale-politico pubblico. Equesto ha in qualche modo indebolito l’elaborazione del Codice.
Mi pare che il dibattito pubblico sia stato un po’ astioso e si sia sof-fermato soprattutto su due temi: il problema patrimonialedell’alienazione della proprietà pubblica o non pubblica del bene e ladenuncia, in senso negativo, della distinzione fra tutela e valorizzazionecon l’evidenziazione dei rischi.
Questo ha fatto sì che in merito, la distinzione, delle funzioni di tu-tela da quelle di valorizzazione, dettata dalla Costituzione, anziché ave-re un contributo che arricchisse la ricerca di un equilibrio, di una siste-matizzazione delle funzioni, dei poteri, delle competenze, delle organiz-zazioni relative, abbia prodotto una discussione abbastanza sterile per-ché, come dire, denunciava un dato concettualmente esistente che do-veva orientare l’elaborazione del Codice e che, invece, non ha offertospunti e stimoli per un approfondimento. Forse comincia adesso, a Co-dice ormai approvato, e quindi un po’ in ritardo.
Io appartengo a quella categoria limitatissima di persone che condi-vide quella distinzione per una considerazione di tipo logico: la neces-sità di una distinzione tra una funzione di tutela e una funzione di valo-rizzazione, l’una di competenza esclusiva dello stato e l’altra di potestàlegislativa concorrente, a mio avviso, deriva dal fatto che in Italia, unicopaese, esiste una legislazione specifica di tutela che attribuisce a un

78 - Fra tutela e valorizzazione
unico soggetto, il ministero dei beni culturali, ovvero una struttura di go-verno centrale, una serie di funzioni amministrative in qualche modo inderoga rispetto alla legislazione esistente in tutti gli altri paesi.
Ho sentito dire tante volte nella discussione:” tutto il mondo ci invidiala nostra legislazione di tutela e noi invece di difenderla andiamo a di-stinguere la valorizzazione dalla tutela stessa”. Nel resto della legisla-zione la tutela e la valorizzazione sono funzioni unificate come attribu-zione del responsabile del patrimonio.
La legislazione nazionale porta la garanzia conservativa che stadietro all’espressione della tutela a una funzione esterna al responsa-bile del patrimonio stesso, cioè all’ufficio dello stato, questo a mio avvi-so rende indispensabile la concettualizzazione di ciò che non è tutela,di chi esercita queste altre funzioni sia sul piano normativo, sia sul pia-no amministrativo e sia, infine, sul piano gestionale. Sarebbe stato, echiudo su questo punto, assai interessante se si fosse aperto, tra glioperatori, tra gli intellettuali, tra i professori, tra gli addetti ai lavori, unconfronto di approfondimento su questa concettualizzazione e sugliequilibri possibili, che appoggiasse e arricchisse il negoziato sul Codicee non lo lasciasse, invece, in qualche modo in solitudine. Solitudine re-lativa perché poi i soggetti che se ne sono occupati sono stati tanti, main qualche modo, nella discussione sull’impianto del Codice, i soggettinegoziatori due e poco più. E in questa solitudine negoziale a me pareche (passo alla seconda considerazione), il Codice sia, nelle luci e om-bre che gli interventi precedenti hanno già enunciato, un risultato sod-disfacente proprio in merito alla distinzione dei due concetti di tutela edi valorizzazione. Sono un po’ più soddisfatto del professor Cammellidelle definizioni, di tutela e di valorizzazione: nelle definizioni dovrem-mo mettere l’accento sui verbi più che sulle funzioni.
L’accento va messo sui due verbi: riconoscere il bene e garantirnela conservazione e la protezione. La specificità, l’originalità della defini-zione di tutela, l’innovazione anche rispetto alla definizione del D.Lgs112 sta nei due verbi, ovvero l’atto di riconoscere un bene diverso dauna cosa e riconoscergli una sua pertinenza culturale e sottoporlo alregime amministrativo di cui è la norma a garantire la conservazione ela protezione dove mi pare che l’accento stia sul verbo “garantire” cioèoperare al fine di garantire la conservazione e la protezione del bene,attività svolta da un ufficio pubblico.
Dall’altra parte la valorizzazione: i verbi sono “promuovere” la cono-scenza ed assicurare la miglior fruizione e utilizzazione del bene. Laconoscenza è presente anche nella tutela perché il riconoscimento av-viene attraverso il processo di conoscenza del bene e invece la

Alberto Vanelli - 79
“promozione” cioè il promuovere la conoscenza, la parte pubblica delbene stesso è un atto di valorizzazione, d’altra parte anchenell’assicurare la miglior fruizione e utilizzazione del bene l’accento èsul verbo assicurare, che assomiglia di nuovo a garantire, cioè fare inmodo che quel bene sia utilizzato e fruito nel modo migliore possibileda parte della collettività pubblica. Pertiene alla valorizzazione anche(di nuovo due verbi) “sostenere” e “promuovere” la conservazione, cosìcome nella tutela afferiva alla finalità della conservazione la finalitàdella fruizione pubblica del bene stesso.
Tutto il negoziato ha avuto due punti di conflittualità: da una parte larichiesta ministeriale che anche la parola fruizione comparisse comeuna delle funzioni della tutela e dall’altra parte la rivendicazione regio-nale che anche la parola conservazione fosse una delle possibilità,delle opportunità dell’azione della valorizzazione. A me pare che la so-luzione del Codice sia una soluzione in qualche modo compromissoria,sia un punto di equilibrio, un equilibrio raggiunto nella redazione dei te-sti, ma che vada profilandosi un modello teorico e di organizzazionedell’attività amministrativa concernente il patrimonio culturale. Mi sem-bra cioè che le due funzioni conservare e fruire, che sono le funzionifondamentali che riguardano il patrimonio culturale, siano funzioni chesono analogamente pertinenti sia alla tutela che alla valorizzazione,dove la tutela ha funzione di garantire la conservazione per consentirnela fruizione, mentre la valorizzazione ha il problema che per assicurareuna fruizione, una conoscenza larga del patrimonio culturale deve con-correre a promuovere e a sostenere l’attività di conservazione.
Io credo che il Codice non sia ordinato, non sia preciso, anche per-ché non aveva alle spalle della sua redazione questa organicità cheadesso io cerco di rappresentare, ma credo che il negoziato, la ricercadi una soluzione che consentisse un incrocio delle due funzioni, porticon sé, in qualche modo, la necessità di un approfondimento teoricodel problema, di un ripensamento complessivo, diciamo, del ciclo checoncerne l’amministrazione del patrimonio culturale.
Riepilogando ci sono due funzioni, tutela e valorizzazione, ma cheoperano entrambe sulle due specificità dell’azione amministrativa sulbene, conservare e fruire, l’una garantisce la conservazione per con-sentirne la fruizione, l’altra assicura la fruibilità del bene, le migliori con-dizioni di fruibilità del bene concorrendo attraverso questa operazioneanche alla sua conservazione, alla sua protezione. In qualche modo, inaltre parole, quello che è stato distinto da un punto di vistadell’attribuzione dei poteri e delle funzioni è stato ricompostonell’esercizio delle funzioni sul bene stesso e nella sua utilizzabilità.

80 - Fra tutela e valorizzazione
Ripeto non c’era questa solidità teorica nell’impianto concettuale delCodice, ma mi pare che la rilettura degli esiti del Codice stesso con-senta di dare degli elementi di dignità all’equilibrio del tutto. In questosenso mi sembra che sia vero che la tutela tende ad essere allargata,però, mi pare che con questa precisazione dei verbi in qualche modoessa sia ampia dal punto di vista della funzione ma abbia un elementodi limitazione per quanto riguarda le attività possibili, cioè le attivitàvolte a garantire la conservazione.
Il D.Lgs 112/98 diceva “ogni attività volta a conservare i beni” quindispostava sull’azione pratica, mentre direi che nel nuovo Codice si riportia una funzione sostanzialmente amministrativa di autorizzazione, per-messo, divieto e quant’altro.
Terza osservazione: l’attuazione del Codice sia nel confronto con ilMinistero sia nell’elaborazione di leggi regionali, ma anche di provve-dimenti, di azioni regionali. Sul primo punto chiedo aiuto ai giuristi. Noiavevamo operato dagli anni ‘70 in poi utilizzando due istituti in merito alruolo delle regioni sulla tutela del patrimonio culturale; l’istituto delladelega e l’istituto del trasferimento. Semplifico: noi avevamo trasferitole funzioni “amministrative” in ordine all’organizzazione dei musei edelle biblioteche e operavamo per delega le attività di tutela sul patri-monio librario.
Nel nuovo quadro costituzionale questi due istituti non esistono piùe quindi quando abbiamo redatto il testo il problema è stato posto, cioèin che modo possono le regioni mantenere l’esercizio delle funzioniamministrative di tutela in ordine ai beni librari e ai beni paesaggistici,ed anche completare l’attribuzione in ordine ai beni librari estendendolaa tutti i materiali audiovisivi, ecc? Ma se non possiamo trasferire, senon con legge dello stato, e se non possiamo delegare perché la dele-ga non è richiamata dalla funzione costituzionale, in che modo, in primaistanza, può avvenire questa conferma e in seguito questo completa-mento possibile?
Ci sembrava alla luce di una reciproca valutazione leale fra ministe-ro e regioni che il decreto legislativo 42 potesse configurarsi come lalegge dello stato che norma la possibilità del conferimento. Però il pro-fessor Cammelli oggi già dice che questo non è possibile, che ci vuoleun’altra legge dello stato che conferisca. Cioè noi abbiamo datol’interpretazione che il decreto legislativo 42, essendo norma dello statoe dando una procedura amministrativa per il conferimento, in qualchemodo fosse la legge che rendeva possibile il processo di conferimento,la cui fonte legislativa era la 42 stessa. Questa era la consapevolezzacredo che l’ufficio legislativo e noi abbiamo avuto, orientando non su

Alberto Vanelli - 81
consenso di senso politico ma su adeguatezza e differenziazione i cri-teri per la individuazione della geometria variabile di attribuzioni di pote-ri. Questo è uno dei grossi temi che dovremmo approfondire e cercaredi capire come sia realizzabile.
L’ultimo punto che vorrei affrontare pertiene al tema della valorizza-zione sul quale Cammelli critica, credo giustamente per alcuni aspetti, ilfatto che non sia procedimentato l’accordo sulle funzioni di organizza-zione della valorizzazione e la scelta dei meccanismi di gestione con-seguenti. Anche su questo credo che l’esito cui il Codice è giunto fossel’unico percorribile, nel senso che superando la logica dell’articolo 150che operava per trasferimenti sistematici della responsabilità di gestio-ne, ma proponendo che la valorizzazione fosse condivisa fra stato eregioni, in particolare per il patrimonio statale, l’unica strada percorribilesia quella di cercare di avviare una fase sperimentale in cui regione perregione o sottoterritorio per sottoterritorio, ricercare mediante accordisu progetti, e non su prerogative di competenza, idee originalinell’organizzazione della fruibilità dei beni.
Mi rendo conto, ci rendiamo tutti conto della fragilità del percorso:basta un no ministeriale a una proposta di riorganizzazione della valo-rizzazione del patrimonio dei beni culturali per rendere debole questopercorso, però mi chiedo in questa fase ancora bisognosa di esperien-ze nuove, di ricerca di modelli nuovi, quale altra sanzione, quale altroprocedimento sia possibile, se non la sanzione politica del dissenso frail proponente e il ricevente il progetto, quale altra idea sia diversa dalmodello della consensuale identificazione e divisione di un progetto.
Piuttosto che avviare una rischiosa negoziazione nazionale per ladefinizione di un quadro di riferimento unitario nella ricerca dei modellidella valorizzazione uniformi sul territorio nazionale, cosa che peraltrola norma prevede, ma la prevede alla fine dell’avvio di una fase di ac-cordi regionali, ritengo sia forse più opportuno, e questo è un mio sug-gerimento e sarà oggetto, probabilmente, di approfondimento futuro,che regione per regione, caso per caso, laddove vi siano delle istanze edelle esigenze, si possa provare a mettere in piedi delle esperienze digestione del patrimonio culturale integrate fra patrimonio statale e pa-trimonio di altre amministrazioni pubbliche o anche di patrimoni privati.Solo alla luce di forti esperienze, e supportati da una legislazione re-gionale importante, si può poi pervenire alla ricerca di standard e dimodelli nazionali.


Michele Trimarchi - 83
Il patrimonio culturale italiano tra vincoli eopportunità: la prospettiva economicaMichele TrimarchiStraordinario di scienze delle Finanze, Università di Catanzaro “Magna Graecia”
ECCOM-Centro Europeo per l'Organizzazione e il Management CulturaleVia Emilia, n. 8100187 Roma
Il sistema del patrimonio culturaleIn un periodo di polemiche come questo, è corretto - come chiede
Marco Cammelli - attenersi ai fatti. Però appare indispensabile, comun-que, fare riferimento alla temperie nella quale importanti provvedimentivedono la luce; la Commissione Cultura della Camera ha convocatouna serie notevole di operatori culturali, esperti e associazioni adesprimere un parere sul Codice dei beni culturali che avrebbe dovutoessere portato per la votazione in aula dopo appena due giornidall’inizio della convocazione; questo ha comportato lo snocciolarsi diun inutile rosario di osservazioni che la Commissione si è limitata adascoltare, prendendone atto e invitando i convocati alla brevità e allavelocità.
Pertanto, pur nella consapevolezza che sono comunque le regole aparlare, e non gli atteggiamenti, va tuttavia registrata una totale assen-za di disponibilità a un confronto con operatori tecnici su una serie dinorme che modificano radicalmente il quadro della tutela e dei vincoliinerenti il patrimonio culturale. Tutto ciò rientra in un contesto più gene-rale che mostra una caduta della cultura nella gerarchia delle prioritàgovernative e legislative, e soprattutto una costante disattenzione neiconfronti di alcuni dirimenti problemi strutturali.
Il Codice dei beni culturali, al di qua delle valutazioni che si posso-no fare rispetto a sue specifiche parti, appare in questo senso comel’ultimo atto di un progressivo smottamento che parte dal 1994 e che sifonda su un duplice convincimento, suffragato da decine di dichiarazio-ni e documenti ufficiali dei diversi ministri che si sono succeduti al Col-legio Romano: che il settore pubblico non sia in grado di gestire effica-cemente il patrimonio culturale e che addirittura non sia capace di co-noscerne l’effettiva estensione; che il settore privato sia preferibile aifini di una gestione efficiente del patrimonio culturale, e possa apporta-re elementi di imprenditorialità necessari all’autosufficienza finanziariadella cultura.

84 - Il patrimonio culturale italiano tra vincoli e opportunità
In questa lettura a dir poco sommaria del patrimonio culturale, nonsorprende che l’interpretazione ufficiale del patrimonio culturale italianocontinui a enfatizzare sciovinisticamente la leggenda metropolitana chene vorrebbe le dimensioni assolute quelle più ampie del mondo, anzi-ché svolgere una seria analisi sulle caratteristiche specifiche, sulle mo-dalità di accesso, sulle relazioni con il territorio di una dotazione cultu-rale che certo appare straordinaria, ma non tanto per le sue dimensio-ni, quanto per le sue capacità dialogiche e narrative, per la sua valenzainformativa e conoscitiva, per la sua capacità di esplicitare il valoreidentitario del suo territorio di riferimento.
Probabilmente questa visione muscolare del patrimonio culturaletorna comoda per la stampa, e l’aria da costante emergenza che dasempre permea il settore culturale finisce per giustificare interventi sin-goli (che consistono in poche, esigue boccate d’ossigeno finanziario)senza mai affrontare la questione di fondo: il funzionamento del siste-ma culturale è adeguato alle dinamiche della società e dell’economia?Risponde efficacemente alla crescente domanda di conoscenza inte-grata proveniente dalla comunità? È coerente con l’assetto del territorioe delle sue attività?
La prospettiva dell’economia pubblica ci suggerisce che i beni cultu-rali sono beni pubblici, fruiti e fruibili congiuntamente e in quanto tali ri-conducibili alla responsabilità gestionale e finanziaria della collettività;ciò implica, per esempio, la necessità di identificare con un sufficientegrado di precisione la corrispondenza tra chi paga e chi gode dei bene-fici. Si capisce subito che questa necessità impone una riletturadell’attuale interesse verso il turismo estero, che certamente può con-tribuire alle sorti finanziarie del patrimonio culturale ma che non puòessere oggetto di mero desiderio quantitativo (un’altra tentazione mu-scolare…) senza tenere conto dei costi di congestione, dello spiazza-mento spesso prodotto nei confronti della comunità residente, dei mag-giori costi di gestione di un’offerta culturale destinata a un pubblico in-ternazionale, della distribuzione dei benefici materiali tra diverse cate-gorie di imprese produttrici e commerciali.
Si consideri inoltre che, anche ai fini della crescita o comunque dellagestione del turismo culturale internazionale, il nostro Paese non hamai elaborato alcuna strategia complessiva di governance del turismointerno ed esterno, limitandosi ad accogliere i turisti in strutture spessoadattate ma quasi mai specificamente concepite ad hoc, e assistendopassivamente ai risultati di quella che in definitiva appare una merasomma aritmetica tra turisti e cultura: è un po’ poco per parlare di turi-smo culturale in senso stretto, soprattutto alla luce delle esperienze

Michele Trimarchi - 85
sempre più diffuse nel quadro europeo di progettazione del turismoculturale da parte di molte amministrazioni regionali e municipali.
Se poi si allarga il campo dell’analisi, si evidenziano problemi anco-ra più delicati, si pensi per tutti all’alterazione dei valori immobiliari neicentri storici per effetto della presenza di beni culturali aperti alla visitae della possibile congestione derivante da flussi di visita massicci. Laprogettazione appare tanto più necessaria, infine, se si fa riferimento asituazioni di isolamento territoriale: l’esempio dei Bronzi di Riace, opereimportantissime e inserite in un eccellente allestimento nel Museo Sta-tale di Reggio Calabria, mostra come non basta l’eccellenza artisticaper garantire l’attrattività, se il contesto territoriale non è leggibile nelsuo complesso dai fruitori potenziali, e se esistono incisivi ostacoli (ladistanza geografica, la presenza della criminalità organizzata, la scarsadotazione di infrastrutture) a una fruizione soddisfacente.
Evoluzioni e motivazioniSe l’analisi del Codice dei beni culturali fornisce spunti contradditto-
ri, affiancando norme e provvedimenti efficaci a norme e provvedimentiregressivi, è comunque la sintesi a scoraggiare. La prospettiva giuridi-ca può certo salutare con sollievo la definizione di beni culturali come“cose”, il che consente l’adozione di un’ampia disciplina, eliminandocon ogni probabilità dubbi e controversie che certo non fanno bene allacultura ed alla sua protezione e diffusione. Ma da un punto di vista di-verso questa norma in qualche modo finisce per mummificare ognipossibile evoluzione del settore culturale, e impedisce l’attribuzione diuna dignità equipollente a beni culturali che non si possono definirecome “cose”. Proprio nell’anno in cui l’Unesco e l’ICOM mettono alcentro delle proprie riflessioni la rilevanza del patrimonio culturale im-materiale, l’Italia si arrocca su una posizione materialista del patrimonioculturale, il che certamente evita una serie di possibili disastri, ma fer-ma un orologio che già camminava con comoda e aristocratica lentez-za.
Continua a mancare la percezione di un sistema culturale nel suocomplesso, con il bizzarro effetto che da una parte si enfatizzano nessitra cultura ed enogastronomia, tra monumenti e prêt-à-porter; dall’altrasi parcellizza l’analisi e soprattutto la normativa di un sistema comples-so di beni e attività che sempre più richiede una visione e una gestioneorganica e coerente. E tutto questo avviene in una fase nella quale siridisegnano in modo viscerale e approssimativo i confini tra governocentrale e amministrazioni periferiche, così come quelli tra pubblico,privato e non-profit. L’effetto complessivo di questo rompicapo è la pro-

86 - Il patrimonio culturale italiano tra vincoli e opportunità
liferazione di interventi di settore e l’allontanamento di una prospettivaefficacemente unitaria.
Tale situazione impedisce l’accoglimento di alcune importanti istan-ze: innanzitutto la necessità di rivedere sostanzialmente i criteri, glistrumenti e i meccanismi dell’intervento pubblico, oggi costituito per laquasi totalità da sussidi finanziari a pioggia; inoltre, l’opportunità deri-vante da un razionale intervento sul sistema fiscale e tributario, non giàattraverso aumenti o diminuzioni del carico individuale o societario, maattraverso una finalizzazione di quote del gettito in modo da tenereconto della struttura dei costi e dei benefici generati per effettodell’esistenza e del consumo di beni e attività culturali; infine, il bisognodi fornire una risposta efficace alla domanda emergente di occasioniculturali, attraverso la realizzazione di forme di promozione, diffusionee accesso che superino la dominante tassonomia dei consumatori cul-turali i giovani e anziani, colti e incolti, italiani e stranieri.
La mancata comprensione di queste evoluzioni, e la mancata presad’atto di un necessario cambiamento di registro nella politica culturaleitaliana, perde di vista un ulteriore aspetto che ha permeato il dibattitonegli ultimi anni: l’impatto economico della cultura, la sua misurazione esoprattutto la sua adozione come unico possibile criterio per valutarel’efficacia della spesa e dell’azione pubblica a sostegno della culturastessa. Introdotto nel dibattito internazionale negli anni Ottanta, sfrut-tato in modo estensivo dalle amministrazioni municipali statunitensi, iltema dell’impatto economico finisce per condurre in modo fuorviante aragionamenti secondo i quali le uniche risorse da spendere per la cultu-ra devono mostrare un ritorno finanziario almeno pari alla loro dimen-sione originaria.
Questa lettura mostra almeno due falle, tanto sul piano filosoficoquanto su quello operativo: intanto, si accredita l’idea che le impostepagate dai cittadini debbano essere utilizzate in modo redditizio, comese consistessero in una sorta di investimento individuale; lo scopodell’imposizione è la fornitura di servizi pubblici, possibilmente in modoampio e generale, preferibilmente in modo equo ed efficace. Se passal’idea che le risorse destinate alla cultura sono “improduttive” se nongenerano una cascata di reddito, allora si capisce come il settore cultu-rale si avvia concretamente verso il proprio cimitero degli elefanti.
Inoltre, l’enfasi posta sulla misurazione dell’impatto economico dellacultura, e la necessità che tale impatto venga registrato entro la pros-sima scadenza elettorale (centrale o locale poco importa, al massimocomplica ulteriormente il quadro), finisce per porre l’accento sulla pro-duzione di reddito monetario e di posti di lavoro, ignorando il ventagliodi benefici intangibili che la cultura riesce infungibilmente a generare

Michele Trimarchi - 87
sulla comunità e sul territorio di riferimento; ignorando la qualità el’evoluzione dell’occupazione (nuova o vecchia che sia) con effetti po-sitivi sull’allocazione delle risorse umane; ignorando l’impatto di lungoperiodo che la cultura genera sullo sviluppo economico, sulla capacitàinnovativa, sulla creatività e sulla competitività del sistema economicoterritoriale nel suo complesso.
Naturalmente non possiamo aspettarci che effetti così importanti ecomplessi siano generati limitando l’offerta culturale alla mera conser-vazione del patrimonio edificato, contando sulla sua importanza mon-diale per conseguire flussi almeno costanti di visitatori. I più eclatanticasi di impatto della cultura sul benessere complessivo della comunitàresidente, sull’economia e sulla qualità della vita vengono dagli StatiUniti e dai paesi scandinavi; non è un caso che nei confronti di questiPaesi la vulgata italiana ha sempre mostrato uno snobismo molto forte,fondato su una “misurazione” canonica della qualità culturaledell’offerta. Ma se alla qualità “certificata” si sostituisce il grado di atti-vità culturale, l’intensità della produzione culturale, delle attività creati-ve, dei collegamenti tra patrimonio culturale e società, allora si vedecome il nostro Paese non ha sviluppato alcuna capacità in questa dire-zione, limitandosi a riposare sugli allori di una concezione borghese ecomunque ampiamente superata dall’evidenza.
Il nostro è un Paese sistematicamente musealizzato, ed è compren-sibile - per quanto con dolore - che un’offerta statica possa risultareuna sorta di zavorra se vista con gli occhi di un operatore pubblico daivincoli di bilancio sempre più stretti e cogenti. Il Codice dei beni cultu-rali, in questo senso, appare del tutto coerente non soltanto con latemperie di questi anni, che mostra quasi fastidio per la cultura e la co-noscenza, ma anche con una lettura dimensionale e commerciale delsettore culturale che ha radici più antiche. La necessità di superare lavisione conservatrice e statica del patrimonio culturale non ha condottoverso l’indispensabile elaborazione di una più adeguata interpretazioneche comprendesse il nuovo innesto della cultura nella gerarchia di va-lori della società emergente, ma verso il comodo e semplicistico rinvioalle “regole del mercato”.
Vecchi e nuovi dilemmiL’approvazione del Codice dei beni culturali lascia immutati, anzi
amplifica, tre dilemmi di fondo che con tutta probabilità continueranno acaratterizzare ed a condizionare il dibattito e la politica della cultura nelnostro Paese nei prossimi anni. Il primo di questi dilemmi consiste nellacontrapposizione, del tutto pretestuosa e forzata, tra tutela e valorizza-zione. Nell’inevitabile questione territoriale che questa contrapposizio-

88 - Il patrimonio culturale italiano tra vincoli e opportunità
ne apre (fin dove si parla di tutela? Da dove in poi si parla di valorizza-zione?), la soluzione che sembra farsi strada non è certo capace di af-frontare il problema in modo efficace: l’uso di un criterio residuale perdefinire la valorizzazione (tutto ciò che non è tutela si può definire valo-rizzazione) finisce per diventare fondamento di dispute giuridiche, con-flitto di attribuzione tra amministrazioni dello Stato ovvero contenziosotra enti pubblici e fornitori privati di servizi pubblici. Le due attività ap-paiono assolutamente inscindibili, se si adotta una prospettiva sostan-ziale, e quindi suggeriscono un governo unitario, o nel più complicatodei casi, comunque un dialogo permanente e complice tra soggettipreposti in modo da garantire coerenza ed efficacia sul piano operati-vo.
Va detto che molto probabilmente il legislatore - e il dibattito, nonmeno colpevole sotto questo profilo - traduce l’ambiguo termine“valorizzazione” con una vaga spettacolarizzazione che dovrebbe ren-dere nei suoi intenti il patrimonio culturale più appetibile per il turista dimassa. Dalla sistematizzazione dei possibili “son et lumière” sui mo-numenti del Paese alla presenza di qualche touch screen alla fine dellemostre, questa concezione della valorizzazione allontana l’effettivaesplicitazione del possibile valore della fruizione culturale da parte deisingoli consumatori, che dovrebbero poter disporre di una gamma am-pia e versatile di informazioni in modo da poter costituire progressiva-mente un proprio vocabolario di apprendimento dell’offerta culturale. Sedi valore si parla allora la fruizione, lo studio e la ricerca occupano unaposizione focale, e pretendono non già una superficiale e banalizzanteproduzione di effetti speciali, ma una seria erogazione di informazioniche possano arricchire il patrimonio di conoscenze tanto in capo alprofano appassionato (e al visitatore occasionale) quanto in capo allostudioso.
In questo contesto, si capisce anche quanto possa risultare aliena lastrategia delle grandi mostre che viene perseguita con sempre maggio-re ostinazione da istituzioni pubbliche, amministrazioni locali, enti pri-vati. Una grande mostra in sé non dovrebbe costituire oggetto di idola-tria, né di stigmatizzazione. In un contesto “normale” si tratterebbe diuna tra le possibili attività culturali. Ma nella recente esperienza italianala grande mostra è diventata strumento di propaganda territoriale (al-cuni azzardano addirittura che sia anche un efficace mezzo di marke-ting territoriale), l’ennesimo mezzo per “mostrare i muscoli” da parte difondazioni bancarie o comuni che sciorinano i numeri per affermare lavalidità del proprio “scommettere sulla cultura”. Ora, le grandi mostrepotrebbero risultare un efficace volano del consumo culturale se sol-tanto le istituzioni facessero un doveroso sforzo di collegamento

Michele Trimarchi - 89
dell’esposizione straordinaria con la dotazione ordinaria di patrimonioculturale. È possibile portare i visitatori di una grande mostra a visitareuna collezione permanente? La risposta può essere affermativa se allabase si svolge un lavoro di informazione e attrazione che certo non de-ve passare attraverso la spettacolarizzazione o la creazione di ulterioriidentità di status. Anche soltanto una sistematica rilevazione del pub-blico delle mostre, e una continuità di contatto, potrebbero aprire leporte dei musei italiani a una buona parte di quell’80% di residenti chenon ha mai messo piede in un museo. E questa è una tipica area diintervento pubblico: qualunque sia la natura giuridica dell’organizzatoredi una grande mostra, il settore pubblico può utilmente destinare leproprie risorse alla promozione e alla diffusione della cultura anche perquesta via, conseguendo effetti sistematici e di lungo periodo.
Un altro dilemma è quello, accesamente dibattuto negli ultimi dueanni, tra centro e periferia. Si tratta, com’è ovvio, di un dilemma moltopiù ampio e intricato di quanto non appaia dal punto di osservazionedel settore culturale. Ma anche nel settore culturale rischia di produrrequalche corto circuito, a tutto svantaggio di una razionale organizza-zione del patrimonio e della sua gestione, e trasferendo anche su que-sto piano la disputa territoriale; con la complicazione derivante da unforte scollamento tra desiderio di attribuzione e renitenza alla respon-sabilità finanziaria. In altre parole: sia lo stato che le regioni e gli entilocali ritengono, a colpi di Codice e normativa, di occupare una posi-zione centrale nel ventaglio delle attribuzioni e delle competenze, conl’effetto che ciascun livello di governo lavora per ottenere una più am-pia area di amministrazione; sul versante della responsabilità finanzia-ria, però, ciascun livello istituzionale sembra volere “scaricare” sugli al-tri il compito di far fronte con proprie risorse al fabbisogno del patrimo-nio culturale e della sua gestione.
Il dilemma porta con sé alcune conseguenze di non poco conto, trale quali la più incomprensibile è quella relativa al timore che, regionaliz-zato, il settore culturale subirebbe un trattamento dispari nelle diversearee del territorio, a causa della distanza tra regioni “forti” e “deboli”.
Basterebbe osservare che la struttura stessa dello Stato italiano èregionale, e che molti servizi pubblici di cruciale importanza sono offertidalle Regioni fin dagli anni Settanta, senza che questo abbia provocatoalcun disastro (non basta l’osservazione che in molti casi la gestionedei servizi pubblici è perfettibile, ciò vale sempre e comunque, e in ognicaso deve essere di stimolo per una più appropriata legislazione sta-tale e regionale, ma non certo per l’abolizione del sistema). Non si di-mentichi, inoltre, che in molti dei casi in cui singole amministrazioni re-gionali si mostrano zavorrate da un eccesso di rigidità, è perché gruppi

90 - Il patrimonio culturale italiano tra vincoli e opportunità
locali di interesse e operatori destinatari dell’azione regionale esercita-no una forte ed esplicita resistenza alla fluidificazione dell’intervento (sipensi alla resistenza delle istituzioni culturali finanziate, nei confrontidell’ingresso di nuove istituzioni tra i candidati al finanziamento).
L’ultimo dei dilemmi irrisolti riguarda la dicotomia tra pubblico e pri-vato. Anch’essa vittima di una più ampia e radicale disputa caratteriz-zata da più che alcune venature ideologiche, nel settore culturale pro-duce un abbassamento vistoso nella qualità e nella motivazione dellerisorse utilizzate, oltre a non generare alcun visibile beneficio per ilfruitore o per lo studioso. In un settore ancora condizionato da bizanti-nismi e da una rigidità esemplare in tutti i rapporti inerenti il mercato dellavoro, dipendenti pubblici dall’elevata specializzazione sono ampia-mente sottoutilizzati (leggi: storici dell’arte condannati a fare i custodi) acausa dell’assoluta mancanza di flessibilità, e dipendenti privati inemersione subiscono contratti precari per svolgere un’attività per lo piùmeccanica (leggi: giovani storici dell’arte condannati a fare i cassierinelle librerie dei musei). Il risultato è la massimizzazione della frustra-zione, l’amplificazione del contrasto e della reciproca diffidenza tra glianomali “colleghi”, la dispersione delle risorse pubbliche.
E se il settore privato può dare un importante contributo al valoredel patrimonio culturale, non è certo attraverso la facile via aritmetica diuna presunta efficienza misurata dividendo i metri quadri per il numerodei custodi, o il numero dei dipinti esposti per il numero dei visitatori.
Queste alchimie da pallottoliere servono soltanto ad allontanare unaconcreta presa di responsabilità da parte dei decisori del settore cultu-rale. Naturalmente, basterebbero alcuni passi precisi per trasformare lasituazione; il primo è l’attribuzione di totale autonomia decisionale, ge-stionale e di spesa ai musei e alle istituzioni culturali, senza dimentica-re (come è stato fatto nel caso della Soprintendenza speciale di Pom-pei) la gestione della forza lavoro; il secondo è l’allentamento dei vincolinell’uso delle risorse (soprattutto di quelle umane), con una soglia dirispetto che garantisca i diritti dei lavoratori ma certamente oltrel’attuale mummificazione che impedisce qualsiasi scelta che vada oltrela routine burocratica.
Pubblico e privato dovrebbero uscire dalla loro natura statica di ter-ritorio per diventare invece un metodo. Può essere molto utile, nel set-tore culturale, ridisegnare la mappa delle attribuzioni e delle responsa-bilità non tanto con riferimento al soggetto istituzionale che deve farse-ne carico, quanto alle modalità con le quali ogni azione va caratteriz-zata, dosando accortamente e pertinentemente il delicato bilancia-mento tra garanzia e flessibilità, tra opportunità e vincoli, ragionando intermini di sistema e di progetto.

Andrea Emiliani - 91
La fine del “sistema delle arti”?Andrea EmilianiAccademico dei Lincei
Accademia Clementinavia Belle Arti, 5640126 - Bologna
Il mio contributo è focalizzato innanzitutto, dalla parte, ormai ridottaal silenzio, della storia e della critica dell'arte e cioè della disciplina cheritengo centrale al sistema delle arti largamente tali, la vicenda esteticache dall’Ottocento ad oggi è cresciuta addirittura a coscienza naziona-le. Essa è stata infatti anche impulso storico costituzionale, tutela e sal-vaguardia del patrimonio. Come pure "arra" - si diceva, appunto, nelRisorgimento - dovere pubblico e debito collettivo di fedeltà nazionale.
Giungeva a noi, in cerca di libertà, dal folto dei secoli che quel pa-trimonio avevano progressivamente, orgogliosamente creato e tutelato,illuminato e paragonato all’Europa.
Tutte le nazioni civili avevano celebrato la bellezza totale italiana,congiunta alla natura e al paesaggio. L’educazione dei grandi intellet-tuali aveva voluto praticare da vicino la sua conoscenza in uno studiodiretto e in una ammirata esperienza di vita.
Il Grand Tour aveva elevato questa educazione al centro d’ogniprogresso della bellezza. La conoscenza diretta di un patrimonio nonsolo ereditato, ma vivente e pulsante, era il metro più vero della bellez-za e della qualità.
In quegli anni, la nozione che guidò nella cultura italiana l’ideadell’arte, prese forma politica e sottrasse l'arte stessa alle speculazionidi un estetismo mercantile e antiquariale. L’immagine permanente eopportuna di una intelligenza molto italiana si convertì in una collabora-zione intensa, tesa tra storicismo e idealismo, a rinsaldare la coscienzadel passato, nonché le prospettive del presente: tanto da sottrarre dallemani di un mercantilismo dilagante l'ormai avviata corruzione dell'im-magine e dell’identità italiana. La prima decade della società culturaledel Novecento, segnata da un idealismo moderno quale fu quello do-minato dal Croce de L’Estetica nel 1902, pur tra molte incertezze offrìalla borghesia il paragone d’uno sviluppo europeo. Tra il 1907 e il 1909nacque concretamente il primo definito e meditato “sistema delle arti”sulla base degli avanzamenti di Adolfo Venturi e dei suoi giovani allievi,e dello stesso Corrado Ricci salito sollecitamente ad un ormai rimar-chevole livello dirigenziale tecnico e scientifico. Fu questa la Direzione

92 - La fine del sistema delle arti?
Generale alle Antichità e Belle Arti, con i suoi laboratori periferici ag-giunti.
Genesi e fondazione del”'sistema delle arti”Il “sistema” si presentava ormai forte d'una ragione generale mar-
catamente suddivisa - anche per ragioni strumentali - tra le grandi di-scipline, dall’arte all'archeologia, dall'architettura all'archivistica e alIabibliologia entro cui spartire in centri di ricerca e di tutela un solo desti-no di comunità e di ricerca.
La multipolarità e polidisciplinarietà mediavano tra loro vantaggi diconoscenza come insieme di reciprocità di pubblico servizio. Da allora,pur tra tentativi generosi, a cominciare dallo sforzo richiesto dal Mini-stero Spadolini (1974), e alla legge sul paesaggio disegnata da Giu-seppe Galasso (1985), non abbiamo avvertito altro che i segni d'un de-clino strutturale e culturale, connesso di recente ad un generale inde-bolimento di società e anche di economia. E anche al tentativo di risol-vere il problema della evidente crisi della tutela e dell'organizzazionemuseografica come più genericamente d'arte e di servizi culturali, sen-za mai ricorrere alla consultazione delle forze di lavoro: che a differen-za di altri ambiti di attività non sono costituite da normali, banali impie-gati, bensì da operatori del settore di marcata capacità tecnico-scientifica, e anche di altra specifica progettualità. Il veloce ricorso aduna risoluzione qualsiasi, costruito per lo più con brani di ingegneriaimprenditoriale delle aree centrali e dirigenziali, non poteva far altro cheaggravare l’avvicinarsi d'una crisi dei valori basilari del settore.
Oggi siamo giunti (come si vedrà chiaro tra qualche mese) alla dis-soluzione del rapporto che univa ricerca scientifica, conoscenza reale,indagine critica e quotidiana scoperta delle incalcolabili sedimentazionicreative del progresso dell'incivilimento italiano. Il raccolto delle So-printendenze non viene più né apprezzato né mietuto.
C'è chi pensa, in nitida trasparenza, che accendere ai vertici mini-sterialistici una serie di relazioni e anche di connivenze, tagliando allabase ogni e qualsiasi continuità del field-work, del lavoro sul campo edella sua quotidianità, possa risolvere molti problemi: naturalmente, to-gliendo di mezzo ogni specificità dei problemi stessi, tramutati in inop-portunità e limitazioni indisponenti piuttosto che in discussione e dibat-tito.
Pubblico e privato, una volta ancoraNon è diversa la nostra attuale situazione. Molti pensano che le
condizioni del “sistema” non siano mai mutate. Non è vero, gli stati

Andrea Emiliani - 93
preunitari e i cessati governi, a cominciare da quello pontificio, avevanofortemente collaborato allora ad una idea pubblica e politica dell’arte.
Un'idea strumentale dell'arte, permeata anzi di un materialismo me-diocre come quello che ispira l'intera e appena divulgata legge di go-verno, e il suo contrasto tra interesse pubblico e utile privato ormai pre-cipitato a termini giuridici e etici molto bassi. Il seme di un Codice comequello che trae nome dal ministro Urbani (2004, 1° maggio), avrebbeallora incontrato una furibonda reazione. E a pensarci bene l'incontrò,se non sempre in sede istituzionale e governativa, certo invocandolipresso le pagine e gli avvertimenti degli intellettuali e le grandi ideolo-gie della società e della storia, chiamandoli con il loro nome ad assiste-re gli storici e i dilettanti della storia dell'arte. Da Romagnosi a Catta-neo, da Mazzini a Cavalcaselle, da Roberto D'Azeglio a Giovanni Mo-relli e ad Adolfo Venturi: e da questi via via fino a Benedetto Croce, adArgan, a Gnudi, a Bianchi Bandinelli, a Brandi e ai numerosi altri dellagenerazione della Resistenza e del dopoguerra.
L’arte italiana, la sua sostanza estetico-storica, gli stessi suoi mate-riali, sono diventati indubbiamente negli anni un riconoscibile (e succo-so?) punto di interesse comune, e gradualmente un obbiettivo verso ilquale sono affluite molte discipline, numerosissime pulsioni tanto di ri-cerca storica che di inchiesta di attualità. La finalità è stata sempre alta,e i risultati di collaborazioni multiple sono stati certo apprezzati (anchese non tutti apprezzabili). Il corpo fresco e creativo delle arti ha chia-mato sulla sua epidermide odorosa quantità improvvise e numerose diinteressati cultori. Il paradigma a tanti lati offerto dall’arte è stato as-saltato da studi e da interessi intinti in molte ideologie e rivolti a moltefinalità e di genesi talora un poco dubbie, di quelle che or non è moltosi definivano eteronomiche e discoste rispetto alla inevitabile purezzadell'arte come creazione.
E tuttavia ci sembra più necessario, di questi tempi, difendere so-prattutto il senso specifico dell’arte, che troppe volte - a fin di bene, macon argomenti lontani dalla conoscenza critica e storica, e piuttostoesaltati da superficialità strumentali - è stato traversato, sventrato, mo-dificato e talora imprigionato ad opera di eteronomie, da forze aliene eanche diversamente ispirate.
Ricordiamo tutti l'eccedente voga sociologica che pure illumino l’etàdella conoscenza del museo postbellico, I'amour de I'art alIa Bourdieuche, trattenuto entro i confini della realtà, ha portato vantaggi indubbiall'arte e al suo rapporto con la comunità locale e internazionale. Masoprattutto negli anni '80, grazie alla violenza di una interpretazione fi-nanziaria che si servì troppo spesso del corpo della bellezza italianaper versare denaro nelle tasche di crisi industriali macroscopiche, do-

94 - La fine del sistema delle arti?
vemmo conoscere anche i confronti non sempre eloquenti, e la lorostrategia, tra costi e benefici: e assoggettare la sorte dell'arte stessa aconsiderazioni di aliena finalità e mentalità.
Il potere di questa politica, talvolta anche positiva -del resto- fu taleda poter parlare della stessa storia dell’arte come di un accumulo indi-viduale di doti autoreferenziate. Il che dimostra come l'opera di Longhie di Toesca, di Arcangeli e di Zeri, sia stata già piegata a strumentaliz-zazioni banali e bugiarde. Nata e cresciuta nell'ultimo secolo, la disci-plina storico-artistica ha invece ereditato una lunga storia ed ha avuto ilvantaggio di assorbirne l'insito valore di democrazia. Infatti, la sedi-mentazione costante e ammirevole del patrimonio culturale e d'arte,che nei decenni ha continuato ad accumularsi possiede caratteri e datigenetici eminentemente pubblici, dovuti alla fantasia delle comunità,saldati alle possibilità reali del mondo da economie e da società, inizia-tive di cultura e valori di bellezza, che ne fanno un blocco forte e unicocon quella che si definisce volontà creativa.
In Italia, infatti, non è possibile fare politica del territorio, e neanchedella città, del centro come delle periferie, delle province profonde odelle grandi aree metropolitane, se si rimane privi della conoscenzaideale e pratica, di pensiero e di azione, di alcune migliaia di anni diKunstwollen, e cioè di volontà comunitaria, come si può ritenere inten-desse affermare un grande studioso austriaco, Alois Riegl: una volontàcreativa, e senza collocarsi -scienziati e operatori- dentro la enorme,esigente, affascinante posterità di quest'arte. Che è la nostra vita. Sidirebbe che il patrimonio abbia in questo senso sostituito il sensodell’Antico, guida costante del passato italiano.
In queste affermazioni e nelle precedenti, che possono sembrareretoriche a chi non conosce la forza della critica storica, si racchiudonoanche i caratteri che hanno condotto alla creazione dello stesso Istitutodei Beni Culturali.
La figura morale della Legge artistica tradizionaleMolti tra i critici attenuano la brutalità del dettato del Codice Urbani,
oggi, tenendosi piuttosto alle dichiarazioni orali del Ministro stesso, chevede le affermazioni nate dalla sua realtà consolidarsi sperimental-mente nell'attesa di almeno un paio di anni. "Questo è un codice chepuò essere corretto" ha detto più d'una volta. Non siamo d'accordo, ilcorpo propositivo del Codice ha addirittura stravolto in profondità la fi-gura morale della legge, l'immagine garantista e fedele della tutela delpatrimonio artistico italiano - dove tutto era inalienabile, salvo rari casi-nella sua opposta e contraria immagine - ove tutto è vendibile salvopoche eccezioni.

Andrea Emiliani - 95
Di fronte a tanta distruzione, nella quale crollano i precedenti del di-ritto pubblico di oltre duemila anni di storia, mi auguro che anche il pas-so sempre gagliardo dei nostri amici e compagni di strada (gli econo-misti, i sociologi, i legislatori) trovi il tempo e il modo d'una riflessione.Dobbiamo ripensare al problema e studiare una strada comune. Lospecifico della critica d'arte deve ritrovare la sua voce autentica. Affer-mazioni come "possediamo tanta roba" ed il suo seguito "dobbiamo diconseguenza fare cassa" rivelano una mancata conoscenza perfinostatistica di ciò che intendiamo essere il patrimonio.
Solo negli anni della filosofia idealistica più recente e moderna - daMorpurgo Tagliabue a Luciano Anceschi - ogni creazione d’arte eraautonoma, e questa sua innegabile purezza doveva essere difesa dal-l'eventuale assalto d'ogni invadente eteronomia che ne turbasse la figu-ra.
Spremere il patrimonio, ad esempio, con l'intenzione di ricavarnedenaro è una violenza fatta alla comunità ed un danno interpretativo,soprattutto quando si pensi che già oggi il valore indotto generato daldinamismo intelligente, informato, del turismo ci aiuta di fronte alla crisidel bilancio generale dell'economia. Ed è la sola entrata reale di questopaese in crisi come si è visto bene tra primavera ed estate 2004. Do-mani ci potrà aiutare ancor di più di quanto - e fu molto - è accadutonegli anni del dopoguerra. Come di consueto, l'obbligo è quello di nondisperdere irrazionalmente la nostra preziosa materia prima.
Autonomia ed eteronomia dell'arteUn'ultima precisazione. Dal profondo di un'estetica tanto tradizio-
nale quanto fedele alle forme idealistiche che il nostro Novecento ci haconsegnato, noi abbiamo sempre coltivato una convinzione quasi reli-giosa che ci ha consentito di credere a lungo nell’autonomia dell’artecome di avere fiducia similmente nella sua libertà. L'autonomia investe,oltre all'atto artistico, gli esiti stessi della sua creazione, quella lunga epossente scia di sedimenti di forme paesaggistiche e di bellezze ar-chitettoniche; di valori d’arte e di poesia, che sono appunto le tracceindelebili dell’incivilimento di cui parlava Carlo Cattaneo. E che si collo-cano nel quadro della nostra posterità culturale. Chiunque manomettao infranga questa autonomia e questa bellezza ereditate da un passatoaltissimo, si macchia di un volgare tradimento dell'arte stessa.
L’autonomia nasce dall'indipendenza espressa dalla volontà e dallasua capacità di determinarsi grazie alla ragione. Affermava Kant che,per questa libertà, "ogni essere ragionevole deve considerarsi comefosse il fondatore d’una legislazione universale": l'arte pone in se stes-sa la sua propria validità e dichiara ogni regola necessaria alla sua

96 - La fine del sistema delle arti?
azione. Contro di lei agisce l'eteronomia, che è il fallimento e anche ilsolo condizionamento della libertà che viene assalita e condizionata daaltre suggestioni e da altri, alieni desideri.
AI solo riflettere, il museo nacque proprio come conservatorio, edunque luogo di ‘conservazione’ e di salvezza in modo analogo ai‘conservatori’ femminili. II museo ha sempre cercato di tenere lontane ediscoste le occasioni particolari, i desideri esteriori, le seduzioni dellapiacevolezza esteriore dell'evento artistico, l’esibizionismo eccessivo,le bellezze superficiali ed effimere, le false comunicazioni della modaecc.
Oggi queste eteronomie effimere e anche superficiali si sono alleatecon altri interessi che strisciano attorno al monumento dell'autonomiaartistica, e che sono alimentati dal mondo della speculazione economi-cistica, dall'eccesso di interesse sociologico e perfino dal succoso pa-sto che il mondo ardimentoso delle consulenze giuridiche, dei suggeri-menti amministrativi, delle risoluzioni burocratiche, ideologiche e politi-che mettono davanti al cammino dei professionisti della storia e dellaconoscenza in ovvia difficoltà di percorso.
Pochi lavorano per l’arte, quasi tutti adattano la sua libertà a esi-genze lontane dalla sua autonomia e dalla specificità estetica.
Una onesta riforma del tragitto reazionario e capitalistico che è statorecentemente imposto all’arte e alla sua eredità si impone ora esatta-mente come anche una riabilitazione ideologica e morale del pensierodestinato al “sistema delle Arti”. II compito della critica d'arte riprendeora anche questo rinnovato sforzo e risponde alle accuse e alle devia-zioni con una rinnovata volontà di libertà.

Bruno Toscano - 97
La cultura del CodiceBruno ToscanoOrdinario di Storia dell’Arte Moderna, Università di Roma tre
Via Gregorio Elladio, 306049 Spoleto (PG)
Vorrei premettere che essendo io professore e storico dell’arte,quello che cercherò di dire, riassumendo il più possibile, somiglia assaipoco alle molte e interessanti osservazioni precedentemente svolte; eaggiungere che la constatazione è abbastanza preoccupante poichérivela che ciascuna esperienza professionale fornisce dati di vero rilie-vo e analisi estremamente raffinate, ma queste, nell’insieme, non co-municano tra di loro, forse perché non hanno ancora trovato una sedeadatta per confrontarsi. A guardar bene, questo nostro convegno ne èun po’ la prova: ognuno ha utilizzato magistralmente le proprie compe-tenze, ma non si è avvertito quanto sarebbe stato desiderabile un veroe proprio collegamento, per esempio, fra un’analisi di carattere giuridi-co e l’intervento di Andrea Emiliani.
Che cosa mi ero proposto di dire? A me interessa molto un obietti-vo, se così posso dire, globale, cioè prendere in esame il Codice percercare di capire quale cultura rispecchia1.
Mi sembra che si tratti di una curiosità legittima. Se scorriamo, adesempio, il chirografo di Pio VII, del 1802, subito riconosciamo nel suodispositivo generale la cultura del neoclassicismo. Vi si riflettono contutta efficacia il gusto e l’esperienza dello scavo, la straordinaria molti-plicazione dei reperti, in un clima in cui l’antico era diventato il riferi-mento ineludibile della pratica artistica e della speculazione estetica.Da qui nasceva anche una forte esigenza di protezione, o almeno dilimitazione dei danni, con disposizioni che del resto nel chirografo arri-vano anche a traguardi, mi sembra, più avanzati di quelli corrispondentidel Codice attuale.
Ad esempio, la verifica dei beni di proprietà privata è delineata conestrema energia e chiarezza e si parla specificamente di beni privatiche possono essere oggetto di ispezione. Questa disposizione che,come voi sapete, ha una lunga storia che continua fino alla legge del1939 sul diritto di accesso, compare in una forma abbastanza mimetiz-zata in un articolo del Codice di trasparenza non proprio esemplare, 1 Ho trattato lo stesso argomento, ma con diverso sviluppo, nella rivista “Economia dellacultura”, 3, 2004, 375-384.

98 - La cultura del Codice
dove si legge tra l’altro che “i sovrintendenti possono procedere in ognitempo con preavviso non inferiore ai 5 giorni” - la sottolineatura è mia -un lasso di tempo che si può ben immaginare sufficiente affinchél’avveduto proprietario si affaccendi a rendere platonica qualsiasi vel-leità ispettiva. “Fatti salvi i casi di estrema urgenza”, aggiunge il Codice.
Insomma ai soprintendenti si chiede che, indossata l’armatura, ca-lato l’elmetto e cinta la spada, pur solo potendo procedere, e una voltadiagnosticata la maggiore o minore urgenza, compiano l’atto eroico diispezionare.
Tornando alla questione più generale della cultura rispecchiatadalla legge, quella del Codice è evidentemente lontana dal chirografo diPio VII ma è anche diversa da quella implicita nella legge del ’39, che sistaglia così nitidamente sullo sfondo idealistico dominante in Italia intutta la prima metà del secolo, cui facilmente si collega anche il sensoaristocratico del bene da proteggere che si coglie sia nella L.1497 chenella L.1089. Naturalmente, abbiamo il diritto di prendercela con lacultura idealistica, che forse nella storia d’Italia ha avuto durata ed esitisenza certi confini ma, in ogni caso, possiamo riconoscere l’esistenzadi una stretta relazione fra le sue direttrici, i suoi assiomi el’elaborazione delle leggi di tutela sul finire del decennio Trenta.
La domanda è: il Codice promosso dal ministro Giuliano Urbani aquale scenario culturale corrisponde?
Dal mio punto di vista, a questa domanda si può rispondere soltantoin un modo, cioè cercando di definire la ricerca storico-artistica cosìcome si è sviluppata nella seconda metà del Novecento e verificandose si può cogliere una qualche collimazione tra i punti nodali del Codi-ce, per esempio l’articolo 10, e le metodologie ma anche i risultati chehanno caratterizzato in modo molto forte linee di ricerca non certo mar-ginali della storia dell’arte non soltanto italiana, sebbene in particolareproprio di quella italiana.
Ora, detto in due parole, la ricerca storico-artistica nella secondaparte del secolo scorso, ma con radici anche più antiche, ha sortito ilrisultato di produrre un panorama dei beni culturali - chiamiamoli purecosì - completamente diverso da quello che costituiva l’orizzonte dellaricerca precedente. Intendo cioè ricordare come l’atlante dell’arte italia-na, risultante dall’enorme mole delle indagini e delle riflessioni svoltenella seconda metà del Novecento, è incomparabile con quello eredi-tato dagli studi, e non solo quantitativamente incomparabile, cioè tantopiù capillarmente gremito di segni, ma del tutto innovativo inun’accezione ancora più rilevante, che implica una profonda trasforma-zione nel giudizio di valore sia sulle opere singole sia su intere areeculturali.

Bruno Toscano - 99
Visto che siamo a Bologna viene spontaneo un esempio e cioè cheprima del corso di Roberto Longhi sul Trecento bolognese, le opere,diciamo, forse non di Vitale ma di qualche suo discendente della se-conda metà del secolo non erano considerate così importanti comedopo quelle famose lezioni. Del resto, per quel che riguarda il Trecento,quasi l’intero atlante è un prodotto della ricerca storico-artistica dellaseconda metà del Novecento, ivi compresa la “carta” della Toscana,cioè della regione culturale che apparentemente si sarebbe potuto cre-dere di ormai stabilita composizione e che invece è stata anch’essagrazie ai nuovi studi sorprendentemente arricchita di presenze, centri,periferie.
Il fenomeno della trasformazione quantitativa e qualitativadell’atlante ci si rivela di tale importanza da far squillare un campanellodi allarme, intanto quando riflettiamo sul tema del catalogo dei beniculturali, ma ancor più quando affrontiamo il punto particolarmente deli-cato dell’accertamento di interesse, proprio a causa dell’evidenza diquesto continuo dinamismo ermeneutico sia delle qualità che dellequantità dei beni. In altre parole, come trovare un raccordo forte e fun-zionale tra la riscoperta incessante di valori - per cui ciò che non inte-ressava interessa o diventerà interessante, ciò che non era valutato èvalutato o sarà valutato, ciò che sembrava concentrato è invece diffu-so, ciò che sembrava poco è invece molto, e via dicendo - e la praticasancita dal Codice degli accertamenti ministeriali d’interesse, vale a di-re con atti puramente burocratici?
E, in particolare, a proposito dell’articolo 12, più volte ricordato que-sta mattina e della cui acribia francamente non so se si sentisse poitanto il bisogno, sulla verifica della “sussistenza d’interesse”, se insor-gono dubbi poi chi decide?
Seguendo il Codice, a decidere sarà il funzionario ministeriale, cioèun direttore generale (proprio ora sono stati generosamente moltiplicatie ve ne sono, tra i nominati, che non provengono dall’ambito tecnicoma da quello amministrativo) “sulla base di indirizzi di carattere gene-rale stabiliti dal Ministero […] al fine di assicurare uniformità di valuta-zione”. Ora, è davvero prioritario accertare se un bene è ancora bene ose deve essere regredito a cosa, tanto da farne un quesito rilevante cuidedicare un intero articolo con specifiche, particolari normative?
Curiosamente è questo l’unico eventuale spostamento del pianovalutativo contemplato dal Codice, mentre non c’è traccia di quei dina-mismi, ben più ricchi di implicazioni, di cui parlavamo prima, in forza deiquali è del tutto prevedibile l’esatto contrario, e cioè che sia la cosa adessere promossa a bene.

100 - La cultura del Codice
L’accertamento di interesse, che, tra l’altro, così come è descrittonei commi 2 e 3 dell’articolo 12 comporterebbe la disponibilità, perl’intero patrimonio pubblico dei beni mobili, di un catalogo continua-mente monitorato ad diminuendum, finisce per configurarsi comeun’operazione astratta e astorica, cioè non calata nelle singolarità inmovimento di specifiche realtà e situazioni culturali. Al contrario, il valo-re diventa valore assoluto - e qui rispunta un tratto caratteristico delleleggi del 1939 - è in sostanza una invariante, dopo di che rischia di in-terrompersi qualsiasi comunicazione con la ricerca, tanto più che sel’interesse non è più “riscontrato” l’ex bene può essere sdemanializzatoe venduto (comma 4). Ma è chiaro che questa invarianza è del tutto ir-reale e che le coordinate di tempo e di luogo sono fattori decisivi diun’estrema varietà di situazioni in continuo movimento che, come la ri-cerca ci insegna, tendono ad essere promosse e non regredite.
Si può prevedere l’obiezione che neppure le leggi precedenti, ivicompreso l’immediatamente precedente Testo Unico, avevano apertola strada ad un sano relativismo di natura ermeneutica, dunque non aquello unilateralmente riduttivo sulla “sussistenza di interesse”. Si trattadi un’osservazione che potrà interessare, diciamo, la storia dei processilegislativi dei beni culturali, ma mi sembra del tutto legittimo giudicare ilCodice in quanto datato primo maggio 2004. Ora, passando all’articolo10 e leggendolo per esteso c’è davvero da smarrirsi, tanto è ampiol’arco semantico delle definizioni di interesse, che oscilla da interesseparticolarmente importante a interesse senza aggettivi, da eccezionaleinteresse culturale a eccezionale interesse artistico e storico a interes-se artistico o storico, da interesse storico o etno-antropologico a carat-tere di rarità e di pregio: parametri, si badi, da applicare a tutto, dai ta-bernacoli ai galleggianti.
Lettera per lettera, comma per comma, si può immaginare in qualidifficoltà verrà a trovarsi chi dovrà dare un seguito a questa normanell’unico modo in cui la si potrebbe interpretare ed applicare, cioè gra-zie ad una meditata consapevolezza della moderna ricerca storica edelle soglie epistemologiche che gli studi hanno raggiunto. Natural-mente questo complicherebbe moltissimo l’applicazione delle norme daparte di ispettori, soprintendenti e direttori generali. Tanti di essi meri-tano stima e comprensione e tutti un caldo augurio, ma non credo dioffendere nessuno se aggiungo che fra i molti di loro che ho conosciutoi più adatti alla delicata funzione mi sono sempre sembrati quelli cheben lontani dal ritenersi padreterni onniscienti erano animati da unaprofonda convinzione dell’opportunità di confrontarsi con esperienzediverse e di giovarsi di altre competenze. Ora, se accostiamo la sicu-mera prescrittiva, ad esempio, del comma 2 dell’articolo 12 sulla

Bruno Toscano - 101
“Verifica dell’interesse culturale” al dettato decisamente eventuale delcomma 5 dell’articolo 29 (“Il Ministero definisce, anche con il concorsodelle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ri-cerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli diintervento in materia di conservazione dei beni culturali”, le sottolinea-ture sono mie) siamo, mi sembra, autorizzati a domandarci se è davve-ro così che può configurarsi una diversa prospettiva, aperta ad una ve-ra collegialità a garanzia di un costante approfondimento dei metodi edegli obbiettivi.
Mi auguro che sia ormai fuori del nostro orizzonte la figura, o piut-tosto il fantasma, che ha a lungo aleggiato nella storia della tutela inItalia, del soprintendente persuaso di essere davvero una specie di on-nivoro della cultura della tutela, tanto da consacrare anche con targhemarmoree epigrafate in latino meriti, spesso discutibili, di“restauratore”. Ma, in ogni caso, non so fino a che punto il Codice pre-supponga una figura diversa, che è poi quella di una persona di culturadi sicuro orientamento, che apprezzi i vantaggi della cooperazione neidelicati processi valutativi che sempre precedono e accompagnanoogni intervento. Nella cultura del Codice si avverte una forte intenzionein questa direzione? O, almeno, è possibile scorgervi le necessariepremesse per un simile avanzamento? Fra di esse, comunque, nonpuò certo contarsi quella specie di altalena semantica del concetto diinteresse, che raggiunge un apice di incongruenza allorché è sottopo-sta ad un singolare adattamento a seconda che il bene sia di proprietàpubblica o appartenga a privati. A stare al Codice, il valutatore - il so-printendente o un ispettore - posto davanti a due quadri, uno di GuidoReni e l’altro di Denis Calvaert (siamo a Bologna…), può rischiare uncomportamento split mind. Infatti, arrampicato sulla malferma scalettadel maggiore o minore interesse fornitagli dal Codice, sarà indotto astabilire che, se di proprietà pubblica, tanto il Reni che il Calvaert devo-no essere considerati beni di particolare importanza, mentre se appar-tengono a un privato il Reni continua ad essere importante e il Calvaertinvece può essere venduto o comunque perduto di vista. Capisco cheanche qui si ereditano vecchi vizi da precedenti dispositivi, ma èugualmente lamentevole che oggi, nel 2004, non sia stato fatto un pas-so avanti.
In sostanza - arrivo alla conclusione - vorrei insistere sul fatto chequesta gradualità del concetto di interesse che emerge dall’articolo 3,ma non solo da quello, non basta a superare il limite di una visionecompletamene irrelata rispetto all’evolversi della disciplina storico-artistica. Questa inadeguatezza sorprende tanto più se si riflette cheera lecito pretendere dal legislatore piena consapevolezza di una inne-

102 - La cultura del Codice
gabile specificità del patrimonio italiano, che per il modo in cui si è sto-ricamente distribuito nei territori - centri grandi e minori, piccoli inse-diamenti sparsi, reti dei comuni e delle diocesi anche in zone montaneo interne e inoltre beni conservati negli attuali circa tremila musei locali- è diverso da quello di ogni altro paese europeo. Si tratta di un vero eproprio tessuto connettivo di luoghi d’arte e di storia, opere, segni cultu-rali, diffuso con maggiore o minore densità nell’intera penisola e in nes-sun altro paese sviluppatosi e stratificatosi nei secoli come in Italia.
Poiché i caratteri di capillarità e di spessore storico che lo distinguo-no sono, nonostante le enormi perdite, tuttora presenti è innanzituttocon questi caratteri, e naturalmente con i significati che ne scaturisco-no, che qualsivoglia tentativo di normativa dovrebbe misurarsi. Se suun patrimonio rappresentato da una mappa gremita di tanti segni e daun atlante così “pieno”, che rispecchiano la sua reale, profonda identi-tà, esercitiamo azioni non abbastanza controllate di scrematura o diselezione, ovvero ne creiamo le premesse anche attraverso l’attivitàlegislativa, facciamo un danno enorme. E quelle premesse non manca-no certo nel Codice. Le nuove norme non si calano nella specificità delnostro patrimonio, si direbbero anzi agnostiche non solo rispetto allainnegabile eterogeneità del concetto di valore tra area e area, ma an-che ai caratteri storici di concentrazione/diffusione e perfinoall’evidenza che non soltanto la qualità ma anche la quantità va intesacome un valore e, dunque, per continuare a significare deve rimaneretale e non può essere diminuita.
Ma naturalmente a destare in questo senso il più forte allarme sonole norme sull’alienabilità, che hanno in ogni sede provocato reazioni deltutto giustificate. L’abbondanza di letteratura di segno negativo mi esi-me dal trattenermi a lungo sull’argomento, ma vorrei anche io almenosottolineare, come già è stato efficacemente negli interventi precedenti,quanto il trattamento di questa materia nel Codice risulti preoccupanteanche dimensionalmente.
Avrà pure un significato che si sia sentito il bisogno di dedicare adessa ben quattro articoli, dal 54 al 57, esponendosi in tal modo allapolemica, comprensibile anche nella sua asprezza, di quanti hannocondannato il fatto che la strategia economicistica dell’una tantum,escogitata dal governo nazionale per far momentaneamente quadrare ibilanci dismettendo la proprietà pubblica, non ha eccettuato i beni cul-turali.
Nonostante le dichiarazioni rassicuranti del relativo dicastero è deltutto evidente che, nella logica della alienabilità, ad un bene culturaledemaniale non si prepara un destino molto diverso da quello di un ge-nerico immobile pubblico, dalla cui vendita lo Stato intende ricavare un

Bruno Toscano - 103
guadagno. Il danno - attenzione! anche economico - di cui queste nor-me costituiscono l’immediata premessa, è ancora più grave se si riflettesullo stato reale delle conoscenze analitiche relative al patrimonio pub-blico, così precario e così parziale che un edificio di interesse storico eartistico rischia di essere venduto come un generico immobile perchétale può apparire nelle condizioni in cui è pervenuto fino a noi. Per chinon finge di ignorare la fragilità delle strutture della tutela e le condizio-ni effettive in cui operano soprintendenti e ispettori è inconsistentel’obbiezione che il Codice predisponga atti di accertamento e controlloda parte degli uffici, da espletare, si badi, in tempi assurdamente ri-stretti.
Non è affatto esagerato affermare che lo Stato aliena ciò che nonconosce, o che non conosce abbastanza. E il danno subito dal nostropatrimonio è, ancora una volta, particolarmente grave perché anchel’alienazione senza efficaci verifiche equivale ad una riduzione prelimi-nare di possibilità di riscoperta e di riattribuzione di valore, che è datoordinario della ricerca storico-artistica. Ma, in ogni caso, la domandache viene spontanea è questa: chi sbroglierà la matassa dei gradi diinteresse, millimetrandoli sia nel patrimonio pubblico che nel patrimonioprivato? Come? Attraverso quali strumenti? E chi sbroglierà la matassaancora più imbrogliata della dichiarazione di alienabilità? Si dà perscontato che sia sempre e comunque disponibile sul campo una figuratroppo spesso idealizzata di ispettore, di soprintendente e, ora, di di-rettore regionale. Fra l’altro, si tratta spesso di validissime persone, matroppe volte catapultate a causa di non sempre comprensibili criteri dipromozione-assegnazione in aree di complessa costituzione geo-artistica di cui non si diventa familiari in quattro e quattr’otto.
Viene in mente che sarebbe salutare coordinarsi con altre fonti diconoscenza, con altre esperienze di ricerca, con standard valutativi giàcalibrati, ma è dato rinvenire nel Codice aperture sufficienti in questadirezione?
A me sembra che quasi pagina per pagina vi si avverta un impastonon proprio gradevole, per certi versi anche sorprendente perché allasua elaborazione hanno lavorato anche persone di tutto rispetto, di i-dées reçues e di assaggi sperimentali - sono stati notati anche negliinterventi precedenti - che oscillando vistosamente praticano insiemetutela e liberismo, acribia definitoria e aperture possibilistiche, serven-dosi di una strumentazione apparentemente contraddittoria: moltiplica-re in modo esponenziale il lavoro di accertamento e controllo senzaprevedere strumenti che ne garantiscano una soddisfacente esecuzio-ne e dunque senza accrescerne l’efficacia.


Il paesaggio


Giovanni Losavio - 107
II paesaggio dal Testo Unico del 1999al Codice del 2004Giovanni LosavioMagistrato
via San Remo, 11941100 Modena
Si deve riconoscere che la legge delega (I'art. 10 della legge n.82del 2003) è assai avara di "principi e criteri direttivi" cui avrebbe dovutoattenersi “la codificazione delle disposizioni legislative in materia di: a)beni culturali e ambientali". Sicchè non stupisce che, al di là delle am-bizioni sbagliate di cui è stata caricata l'operazione, il prodotto che ne èrisultato è in pratica la (maldestra) riscrittura del Testo Unico del 1999,con qualche espressione enfatica in più e taluni strappi, pur se nonnumerosi ma gravi tuttavia, nel tessuto compatto della tutela. E paleseè perciò l'eccesso dalla delega che poneva l'espresso divieto di "abro-gazione degli strumenti attuali".
Vanta dunque il ministro che questo Codice abbia operato "il pienorecupero del paesaggio nell'ambito del patrimonio culturale, del qualecostituisce parte integrante alla pari degli altri beni culturali del nostropaese". Ed è vero che nelle disposizioni generali della prima parte (art.2) si proclama che “il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali edai beni paesaggistici", ma che si tratti di una unificazione meramentemeccanica è rivelato dall'immediato rinvio ("Sono beni paesaggistici…")alle categorie tradizionali delle bellezze naturali ereditate dalla legge1497 del 1939 e delle "aree" tutelate per legge Galasso (Ia 431 del1985), la cui rispettiva disciplina è sostanzialmente ripresa con i pochiadattamenti anche peggiorativi, dal Testo Unico del 1999, e separata-mente rimessa alla terza parte del Codice.
Né può valere ad aggiornare il significato della tutela l’affermazioneche quelle categorie di beni paesaggistici costituiscono "espressionedei valori storici, culturali. naturali, morfologici ed estetici del territorio",che è un modo di dire approssimativo e concettualmente poco control-lato, in ogni caso privo di sostanza normativa.
Procede infatti per vie separate la terza parte del Codice dedicataappunto ai beni paesaggistici e subito si cimenta nell'ardua (e forsenormativamente inutile) definizione del paesaggio che vuole intenderecome “una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dallanatura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni", definizione

108 - Il paesaggio dal Testo Unico del 1999 al Codice del 2004
che si integra con il riferimento alle funzioni di tutela e valorizzazionedel paesaggio che "salvaguardano i valori che esso esprime quali ma-nifestazioni identitarie percepibili ".
È agevole trovare in queste pretenziose proposizioni, che orecchia-no le riflessioni di discipline estranee alle tecniche normative la confer-ma che non spetta al legislatore prender partito nelle dispute culturali edecretare che paesaggio è solo una parte (per di più e perchè mai)omogenea (cioè composta di elementi distribuiti in modo uniforme) delterritorio nella quale soltanto, e non altrove, sarebbero riconoscibili“manifestazioni identitarie percepibili” e i cui caratteri deriverebbero("derivano", proprio così) “dalla natura, dalla storia umana, o, in alter-nativa, interrelazioni". Sono parole, come si vede, in libertà, che certopoco aiutano a praticare la tutela.
Anzi "Ia tutela e la valorizzazione" secondo quell’endiadi concet-tualmente inscindibile che si è voluto sciogliere per fondare su questaartificiosa distinzione (concepita io credo da giuristi, da chi in ogni casonon si era mai misurato con la prassi operosa dei beni culturali, noncerto dagli storici dell'arte) la ripartizione di potestà legislativa tra statoe regioni e di funzioni amministrative tra stato, regioni, province e co-muni. Sembrò con questo artificio di aver risolto elegantemente il con-flitto che ha accompagnato i rapporti tra stato e regioni fin dalla primaattuazione dell'ordinamento regionale, e si è voluto sanzionare la rottu-ra del principio unitario dell'art. 9 della Costituzione nella stessa riformadel Titolo V, contrapponendo a "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema edel beni culturali" [lettera s) del secondo comma dell'art.117]“valorizzazione dei beni culturali e ambientali” (terzo comma dello stes-so articolo), senza neppure preoccuparsi di uniformare il lessico nelledue espressioni, che non riprende per altro quello dell’art. 9. Che conquesta costruzione normativa (che ha fatto violenza, si può ben dire,sull'oggetto delicatissimo così voluto disciplinare) ci si sia cacciati in unginepraio senza uscita comincia ad essere convinzione non più isolatae anche la lettura di questo Codice ce ne offre una significativa confer-ma.
Già si è detto che il Codice rinuncia a operare una innovativa siste-mazione organica della disciplina di tutela e paesaggio, né la delegapressoché priva di principi e criteri direttivi lo avrebbe consentito. Si èadeguato allora fedelmente al sistema binario ricevuto dalla legislazio-ne vigente, fondato sui due modelli delle "bellezze naturali" secondo lalegge 1497 del 1939, e delle vaste aree assoggettate a vincolo per di-retta previsione normativa, secondo la legge 431 del 1985 (l'unica inci-siva riforma nella tutela del paesaggio dall'entrata in vigore della costi-tuzione), aggiornando i rispettivi procedimenti riprodotti nel loro nucleo

Giovanni Losavio - 109
essenziale, tanto che si sono potute mantenere espressamente in vigo-re perfino le disposizioni del regolamento per l'applicazione della leg-ge1497/ 1939, "approvato con regio decreto 3 giugno 1940 n.1357"(esito francamente mortificante per la codificazione del 2004).
Quanto in particolare al procedimento di individuazione delle cosìdette bellezze naturali, l'esasperato garantismo assicurato agli interessipotenzialmente in contrasto con le esigenze di tutela certo non obbedi-sce al criterio di “snellimento e abbreviazione" e rende arduo l'approdoalla conclusiva dichiarazione di notevole interesse pubblico.
Si deve però dare atto della preoccupazione di raccordare i due si-stemi, attraverso la prescrizione nel senso che le proposte di notevoleinteresse pubblico definiscano una specifica disciplina di tutela e valo-rizzazione che “costituisca parte integrante di quella prevista dal pianopaesaggistico”, si proietti cioè nella pianificazione.
Così come si deve riconoscere che si è inteso valorizzare appieno ilpiano paesaggistico (che la legge “Galasso” aveva prescritto qualeadempimento regionale) come il più appropriato strumento di tutela,non limitato alla considerazione dei soli beni “vincolati” per legge maesteso all’intero territorio, con efficacia anche prescrittiva immediata-mente prevalente sulla ordinaria pianificazione territoriale (tenuta per-ciò ad adeguarsi ad esso), secondo il modello, dunque, cui si era atte-nuta la regione Emilia-Romagna nella elaborazione del proprio pianopaesaggistico.
L’art.143 si esibisce in una minuziosissima disciplina di contenuti eobbiettivi del piano, di sapore scolastico e perfino pedantesco, maomette di prescrivere alle regioni alcun termine per l’approvazione alriguardo valendo quello di quattro anni solo per l'adeguamento dei pianipaesaggistici di cui le regioni siano dotate nel vigore della legge 431. Irapporti tra stato e regioni sono regolati secondo modelli di collabora-zione e intesa essendo prevista Ia presenza dei soprintendenti nellecommissioni provinciali competenti ad elaborare le proposte di dichia-razione di notevole interesse pubblico (mentre al riguardo è dato allostato l'esercizio di poteri sostitutivi a fronte della negata attivazionedella commissione provinciale dell'inerzia della regione).
È rimessa per altro alla facoltà di stato e regione di accordarsi per laelaborazione di intesa (o per l'adeguamento) del piano paesistico, es-sendo espressamente previsti poteri sostitutivi dello stato nei soli casidi inosservanza del termine convenuto nell’accordo, per la conclusivaapprovazione regionale.
Benché fuori dalla ipotesi della (facoltativa) elaborazione di intesadel piano paesistico (o del suo adeguamento) non sia, in questa sedeespressamente previsto il potere sostitutivo dello stato, neppure per il

110 - Il paesaggio dal Testo Unico del 1999 al Codice del 2004
più grave inadempimento della regione alla prescrizione di dotarsi delpiano, deve ritenersi che una tale lacuna nella tutela non possa rimane-re priva di riparazione, soccorrendo quindi il disposto dettato nelle“disposizioni generali" dall'art.5, comma 7, del Codice, che pure in temadi funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici conferite alleregioni (a termini della terza parte dello stesso Codice) prevede in viagenerale l'esercizio del potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia oinadempimento. (In tali ipotesi permane, per altro, il potere di annulla-mento delle autorizzazioni paesistiche che il Testo Unico del 1999 ri-metteva al ministero e per esso al soprintendente, e che il Codiceesclude a regime).
Certamente intenzionale e a lungo ponderato è invece il dispostoche, nella gestione del vincolo attraverso la valutazione di congruenzadelle trasformazioni fisiche, pone il soprintendente, quale organo delloStato, in un modo subaIterno di mero consulente giacché il suo parereè obbligatorio ma non vincolante e l'autorizzazione rilasciata in diffor-mità da quel parere non è soggetta al controllo successivo per annul-lamento (come invece prevedeva l'art. 151, comma 4, del Testo Unicodel 1999), non rimanendo al ministero a estrema difesa del vincolo inipotesi disatteso che ricorrere alla giustizia amministrativa, al pari diogni altro soggetto, anche privato interessato. La questione interessa,come si vede, il modello costituzionale dell’esercizio delle funzioni am-ministrative attribuite a prescindere, dalla corrispondenza alla potestàlegislativa in materia, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazio-ne ed adeguatezza e se, in linea di tali principi, non v’è ostacolo a ri-mettere ad enti diversi dallo stato anche i compiti che attengano allatutela dei beni culturali, il limite al riguardo però è dato all’esigenza diassicurare l’esercizio unitario della funzione, dovendo perciò necessa-riamente prevalere, in caso di contrasto nell’apprezzamento di merito,la valutazione del ministero al cui livello è assicurata la considerazionedei valori unitari (del patrimonio storico e artistico e) del paesaggio.
Già si è per altro osservato che l'annullamento ministeriale dell'auto-rizzazione paesistica, previsto dal Testo Unico del 1999 come estremopresidio della tutela, costituisce per certo uno “strumento attuale", nelsenso inteso dalla legge di delega [art.10, comma 2, sub d), legge82/2003], che Ia stessa legge fa espresso divieto di abrogare. E perciòla tuttavia disposta abrogazione di un tale "strumento" integra un sicuroeccesso di delega, sanzionabile con la dichiarazione di illegittimità co-stituzionale. Così come non sembra ragionevole prevedere che il pianopaesaggistico, se sia stato concertato con il ministero, possa sottrarrele trasformazioni di certi ambiti territoriali tutelati alla autorizzazionepaesistica, essendo perciò escluso il parere del soprintendente nella

Giovanni Losavio - 111
gestione in concreto del vincolo (come se la disciplina del piano, solperchè elaborata di concerto con il ministero, per ciò stesso si sottrag-ga ad ogni discrezionalità applicativa e alla possibile trasgressione).
Sul fondamento di una delega priva in sostanza di principi e criteridirettivi (necessari anche per sostenere l’adeguamento alla riforma delTitolo V della Costituzione) non era dato di rielaborare la sistemazioneorganica dell'intera disciplina della tutela del paesaggio (e del patrimo-nio storico e artistico), sussistendo in realtà le sole condizioni per il me-ro aggiornamento del Testo Unico del 1999. A questa linea, per cosìdire minore, si è in realtà attenuto il Codice; e, privo di principi anchesul punto, ha indebitamente risolto il conflitto che si manifesti in sede digestione del vincolo (con l'autorizzazione paesistica), attribuendo allaregione un ruolo che contrasta con l'esigenza di esercizio unitario dellefunzioni di tutela.


Giancarlo Poli - 113
Il contributo regionale alla definizione di unanuova politica del paesaggioGiancarlo PoliResponsabile del servizio di valorizzazione e tutela del Paesaggio della RegioneEmilia-Romagna
Regione Emilia-RomagnaVia dei Mille, 2140121 Bologna
Qualora si intenda affrontare in modo razionale il tema delle innova-zioni introdotte dal nuovo Codice dei Beni culturali e del paesaggio nelmodello di tutela del nostro Paese, e degli effetti che si determinerannosulla gestione e sulla pianificazione dobbiamo considerare che oggi,anche per quanto riguarda il paesaggio, ci troviamo ad operare in uncontesto europeo per effetto dell'emanazione della Convenzione euro-pea del paesaggio (v. sezione documenti), sottoscritta a Firenze il 20ottobre del 2000 da 14 stati europei tra cui l'Italia.
Ciò che cambia con la Convenzione di Firenze non è l'obiettivo difondo, che rimane quello della conservazione del paesaggio, sono iconcetti, le metodologie, gli strumenti adottati per il raggiungimento ditale finalità.
L'approccio al paesaggio si dilata all'intero territorio, assume formedemocratiche in quanto a condivisione dei valori e partecipazione alladefinizione delle tutele, concepisce una gestione basata sui principidello sviluppo sostenibile.
Questo rappresenta evidentemente, per un paese come il nostro,che vanta regole di salvaguardia risalenti al 1922, una vera rivoluzioneculturale.
I fondamenti di questa nuova visione sono così riassumibili:- nell'estensione del significato di paesaggio a tutto il territorio e
a tutti i tipi di paesaggio. Paesaggi belli, brutti, integri o degra-dati, che comportano, necessariamente, l'adozione di strumentidiversi rispetto a quelli utilizzati fino ad oggi poiché l’attenzionesi sposta dagli oggetti alle loro relazioni, alle dinamiche del ter-ritorio, ai soggetti che rappresentano e determinano i diversipaesaggi;
- nella trasformazione concettuale, ma sostanziale, del “benepaesaggistico” in "patrimonio culturale" da realizzare attraversoprocessi di interpretazione, sensibilizzazione, formazione, af-finché l’intera popolazione sia messa in grado di riconoscere i

114 - Il contributo regionale alla definizione di una nuova politica del paesaggio
valori del proprio ambiente di vita, di apprezzarne il significatoper poter condividere la responsabilità della tutela;
- nell’interpretazione del paesaggio come risorsa, in quanto op-portunità di sviluppo, anche economico, da ottenere attraversoforme di "tutela attiva" derivanti dall’elaborazione di “progetti dipaesaggio” che abbiano come obiettivo azioni di riqualificazio-ne, recupero, valorizzazione e come esito il miglioramentodella qualità complessiva ed il rafforzamento delle sue diversi-tà.
Un’altra questione è relativa all'equipaggiamento legislativo e stru-mentale che stiamo tuttora utilizzando, che fonda le sue origini culturalie concettuali nel lontano 1922. Un modello non solo obsoleto per la vi-sione a cui si ispira, ma perché è ampiamente dimostrata la sua ineffi-cacia a contrastare i processi indesiderati di trasformazione del pae-saggio. Un’inefficacia di cui il Ministero per i Beni e le attività culturaliha tenuto conto nella elaborazione del nuovo Codice del paesaggio.
Ciò nonostante esistono radicate e radicali resistenze culturali eistituzionali all'innovazione delle politiche di tutela del paesaggio a favo-re della conferma di una filosofia della tutela appiattita sul vincolo esulla limitazione delle attività.
Ma è corretto che l'esercizio della tutela possa risolversi esclusiva-mente in una attività di continuo contrasto alle iniziative ed ai progettiche si sviluppano nel territorio?
È possibile che la società civile ed i suoi organi rappresentativi nonsiano direttamente coinvolti nella definizione dei valori e delle tutele delterritorio che gli è proprio?
È legittimo perseguire una politica di cristallizzazione del paesag-gio?
Il Codice del paesaggio, pur costituendo un compromesso tra diver-se concezioni e opposte esigenze, è apprezzabile in quanto rende fat-tibile una evoluzione delle attuali modalità e strumenti di gestione delpaesaggio.
Questo Codice costituisce inoltre una importante conferma dellavalenza dell’operato della Regione Emilia-Romagna, ma, soprattuttodel percorso di rinnovamento intrapreso con l'attuazione dell'Accordo19 aprile 2001 sulla pianificazione paesaggistica e con il successivoAccordo del 9 ottobre 2003, tra la Regione Emilia-Romagna, il Ministe-ro per i beni e le attività culturali e l'Associazione delle Autonomie localiin materia di gestione delle tutele paesaggistiche (v. sezione documen-ti).
Un rinnovamento che si compirà con l’attuazione dei contenuti delCodice Urbani e che si sta perseguendo anche mediante l'evoluzione

Giancarlo Poli - 115
del quadro normativo regionale, in materia di governo del territorio, cheutilizza sempre più frequentemente, il paesaggio come termine di con-fronto per la definizione degli obiettivi di qualità territoriale, per la pro-gettazione, la pianificazione di settore e la valutazione degli effetti degliinterventi.
La L.R. 16/02 sul recupero degli edifici storico-artistici e la promo-zione della qualità architettonica e del paesaggio, ad esempio, ha este-so il concetto di riqualificazione anche al territorio extraurbano e ha tra isuoi obiettivi l'eliminazione delle "opere incongrue" rispetto al contestopaesaggistico. La L.R. 31/02 relativa alla "Disciplina generale dell'edili-zia" ha previsto l'istituzione di una Commissione per la qualità architet-tonica e del paesaggio, del tutto analoga a quella contemplata dal Co-dice Urbani, specificatamente dedicata alla valutazione degli effetti de-gli interventi sul contesto paesaggistico. La L.R. 20/00 (art. 49) chepromuove e cofinanzia progetti integrati di tutela e valorizzazione delpaesaggio a favore degli enti locali e in particolare di quei territori chenecessitano di attività di riqualificazione, rafforzamento delle identità,messa in rete dei valori o di un nuovo assetto paesaggistico. Una atti-vità che in 11 anni ha prodotto circa 60 progetti e che ha impegnato ri-sorse per oltre 2 milioni di euro reperiti da contributi regionali e deglienti locali.
La volontà di rinnovamento manifestata dalla Regione Emilia-Romagna non è casuale ma ha origine da una esperienza di gestioneche ha mostrato i limiti e l'inadeguatezza degli strumenti impiegati perla conservazione del paesaggio. Inadeguatezza determinata non solodalla concezione evolutiva indicata dalla Convenzione di Firenze, maanche dal quotidiano esercizio della tutela.
Proprio dall’ordinaria gestione sono emerse due situazioni oggettivesu cui era necessario intervenire.
La prima riferita alla pianificazione paesaggistica, che pure innovati-va in quanto estesa all'intero territorio, ad ulteriori categorie di beni (ol-tre a quelle indicate dalla L. 431/85) e con una tutela modulata in fun-zione dei valori e dei livelli di integrità del territorio, ha esaurito una pri-ma, importante fase di attuazione, attraverso il trasferimento, l'assimi-lazione e lo sviluppo dei suoi contenuti nei nove Piani Territoriali di Co-ordinamento Provinciali approvati che articolano il sistema territorialeregionale. Questa attività ha restituito un quadro più articolato e aggior-nato dei contesti locali ma ha altresì evidenziato inefficienze e criticitàche devono essere affrontate e risolte.
L'altra situazione problematica è rappresentata dalla gestione ordi-naria delle tutele paesaggistiche, affidata ai Comuni fin dal 1978 con laL.R. 26, gestione non soddisfacente per alcuni aspetti:

116 - Il contributo regionale alla definizione di una nuova politica del paesaggio
- per l'esistenza di un doppio regime di tutela separato e sovrap-posto riferito a strumenti e modelli di gestione diversi. Il PianoTerritoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) e l'insieme dei vin-coli di derivazione statale (aree di interesse pubblico,“galassini”, categorie di beni ambientali ope legis), che compli-cano l’esercizio della tutela a causa della confusione applicativadeterminata negli operatori pubblici e privati;
- per una gestione essenzialmente burocratica che privilegia gliaspetti formali e le prerogative istituzionali ma che non si preoc-cupa di cosa succede realmente al paesaggio. Una gestioneche ammette modalità discordanti di valutazione delle trasfor-mazioni che prendono origine da esperienze e processi signifi-cativamente differenti. Dalla valutazione, asettica e insufficiente,di conformità ai piani, a quella soggettiva e discrezionale deinulla-osta paesaggistici e dei conseguenti, eventuali, annulla-menti;
- per la mancanza di collaborazione e coordinamento tra i diversisoggetti preposti alla gestione del paesaggio, difetto che hadato origine, spesso, ad una deleteria conflittualità tra Soprin-tendenze, Enti locali e privati.
Approfittando del cambiamento determinato dalla Convenzione diFirenze, proseguito con la legge di modifica al Titolo V della Costituzio-ne e confermato dal Codice Urbani si è valutata quindi l'opportunità diintervenire sia sulla pianificazione paesaggistica sia sulla gestione delletutele paesaggistiche.
Adeguamento della pianificazione paesisticaIl tema dell’adeguamento della pianificazione paesistica è stato am-
piamente illustrato e dibattuto nel Convegno "Paesaggi senza confini"che si è tenuto a Bologna il 7 maggio 2004 quale esito dell’attività di ve-rifica del PTPR, realizzata con la collaborazione di OIKOS Centro Stu-di, in ottemperanza agli impegni assunti con la sottoscrizione dell'Ac-cordo del 19 aprile 2001 tra il Ministero per i Beni e le attività culturali ele regioni italiane.
In questa sede è opportuno ricordare che la verifica di conformitàdella strumentazione vigente ai nuovi contenuti di piano è stata con-fermata dal nuovo Codice del paesaggio e che tale attività risulta indi-spensabile e propedeutica alla prefigurazione della strategia e deicontenuti che preludono all’adeguamento del piano paesistico vigente.

Giancarlo Poli - 117
L’accordo 9 ottobre 2003Per qualificare e rendere maggiormente efficace la gestione ordina-
ria delle tutele paesaggistiche, che costituisce un aspetto fondamentaledel processo di miglioramento della qualità dei nostri paesaggi, è statoelaborato uno specifico Accordo tra la Regione Emilia-Romagna, il Mi-nistero per i Beni e le attività culturali, e l'Associazione delle Autonomielocali.
Questo Accordo, sottoscritto il 9 ottobre 2003, costituisce un atto diassoluta rilevanza per tutti i soggetti firmatari, al di là dei suoi contenutitecnici, in quanto sancisce l'avvio di un percorso di collaborazione econcertazione istituzionale in precedenza assente.
L'Accordo è stato previsto dalla L.R. 31/02 "Disciplina generale del-l'edilizia" (art. 46), legge che si è posta, tra gli altri, l’obiettivo di perveni-re alla "puntuale definizione dei criteri e delle modalità per il rilasciodelle autorizzazioni paesaggistiche e per l’apposizione e la modifica deivincoli paesaggistici" affinché l’attività dei diversi soggetti che interven-gono nel processo di proposizione, valutazione e controllo delle tra-sformazioni possa farsi garante di quella tanto auspicata “qualità pae-saggistica”.
A tal fine l'Accordo è stato configurato come strumento di speri-mentazione e confronto mettendo a disposizione degli enti locali, deiprofessionisti, dei funzionari delle Soprintendenze e del sistema regio-nale nel suo complesso, regole certe, ruoli definiti e strumenti condivisida utilizzare nella progettazione e nella valutazione della compatibilitàdegli interventi in ambiti tutelati, rendendo corretto e omogeneo l'iter diautorizzazione paesaggistica.
Un Accordo in perfetta sintonia con le attività previste dal nuovoCodice del paesaggio, che deve diventare "laboratorio di esperienze”da riversare nella pratica quotidiana e nel futuro adeguamento dellapianificazione paesistica. Un laboratorio che ha già avviato la sua atti-vità grazie alla collaborazione delle Soprintendenze, del Ministero, dimolti enti locali e con l'appoggio fondamentale dell'Associazione delleAutonomie locali dell’Emilia-Romagna.
L'Accordo del 9 ottobre 2003 si prefigge, in realtà, obiettivi moltoambiziosi prospettando percorsi di gestione assolutamente nuovi, qualila pianificazione condivisa; l’integrazione degli strumenti di tutela; losnellimento delle procedure autorizzative; la prefigurazione di un diver-so ruolo del sistema vincolistico di derivazione statale e molto altro.
I temi principali sulla base dei quali sono stati sviluppati i contenutidell'Accordo sono sostanzialmente tre e afferiscono alla:

118 - Il contributo regionale alla definizione di una nuova politica del paesaggio
1. Regolarizzazione del procedimento autorizzativo e valutativoPreso atto che oltre il 50% degli annullamenti delle autorizzazioni
paesaggistiche rilasciate dei Comuni nasceva dalla mancanza di moti-vazioni all'assenso dell'intervento di trasformazione, ovvero dalla ca-renza descrittiva delle sue caratteristiche e degli effetti che poteva de-terminare sul contesto paesaggistico di riferimento, è stata prevista:• la predisposizione di una “variante ricognitiva” agli strumenti urba-
nistici comunali relativa alla perimetrazione delle aree soggette avincolo paesaggistico, al fine di rendere certo l'ambito di applica-zione dell’autorizzazione. Tale variante costituisce, tra l'altro, unaanticipazione della "Carta unica del territorio" prevista dalla leggeurbanistica regionale n. 20/2000 e la base essenziale per la revi-sione e la successiva integrazione degli ambiti vincolati negli stru-menti di pianificazione;
• la elaborazione di una "Relazione paesaggistica-ambientale", daallegare all'istanza di autorizzazione, contenente la documentazio-ne necessaria per fornire gli elementi conoscitivi indispensabili perla valutazione degli effetti dell'intervento sul paesaggio così daevitare la richiesta di documentazione integrativa;
• la definizione di principi di valutazione a cui la "Commissione per laqualità architettonica e del paesaggio" potrà riferirsi per formularele motivazioni di merito che dovranno obbligatoriamente corredarel'autorizzazione paesaggistica o il suo eventuale diniego.
2. Definizione di un quadro strumentale univoco e condivisoRelativamente alla necessità di dare avvio al processo di progressi-
va eliminazione del doppio regime di tutela attualmente operante èstata prevista:• la definizione, d'intesa con la Soprintendenza regionale di “criteri
per l’apposizione e la modifica dei vincoli paesaggistico-ambientali”. Criteri che porteranno all’attribuzione di un diversoruolo delle zone vincolate ed alla costruzione di un sistema di valo-ri, riconoscibili e condivisi, rappresentativi del patrimonio identitariodel territorio emiliano-romagnolo;
• la ricognizione del sistema dei valori del proprio territorio, da partedelle Province, nell'ambito dell'attività di redazione o di aggiorna-mento dei PTCP, stabilendo l'eventuale necessità di revisione deivincoli esistenti per realizzare l'integrazione funzionale e strumen-tale richiesta dal Codice Urbani. Tale attività prevede l'elaborazione

Giancarlo Poli - 119
di una specifica normativa sugli interventi e sugli usi ammessi per isingoli beni tutelati.
3. Semplificazione e accelerazione del procedimento autorizza-tivoQuesto obiettivo presenta delle evidenti restrizioni determinate
dalla rigidità del quadro normativo statale di riferimento, pur tuttavia so-no state individuate alcune soluzioni concretamente praticabili, riferitealle seguenti attività:
• il raggiungimento da parte dei Comuni, di una forma di pianifi-cazione condivisa da realizzare in accordo con le Soprinten-denze, in sede di "Conferenza di pianificazione". Tale condivi-sione è relativa alla definizione dei livelli di tutela da assegnarealle differenti parti del territorio comunale e conseguentementealla diversa attenzione da riservare alle trasformazioni edilizie einfrastrutturali. Su tale base può scaturire una intesa, tra il Co-mune e la Soprintendenza, finalizzata alla compressione deitempi d'esame delle pratiche relative ad alcune tipologie di in-terventi, definibili di "modesto rilievo" o a "basso impatto pae-saggistico". Interventi che per la loro frequenza e ripetitivitàpossono essere assoggettati ad una valutazione standardiz-zata. Le tipologie, concordate con la Soprintendenza e de-scritte in appositi abachi corredati dalle relative modalità di in-tervento, devono necessariamente trovare formalizzazione nelRUE (Regolamento Urbanistico Edilizio). Ottenendo in talmodo un alleggerimento dell’attività della Commissione per laqualità architettonica e del paesaggio che potrà dedicare unmaggiore impegno a valutare gli effetti di opere a rilevante im-patto paesaggistico;
• il ricorso più esteso alla Conferenza dei Servizi, in particolareper le opere pubbliche e di interesse pubblico, organizzate pe-riodicamente, in forma concordata con le Soprintendenze com-petenti e concentrate in un'unica sede, in modo da potereesaminare nella medesima giornata le istanze di più ammini-strazioni comunali.
L'Accordo prevede poi altre attività, rivolte al raggiungimento diobiettivi di supporto al rafforzamento di una nuova consapevolezza delruolo e delle potenzialità del paesaggio.
Tra questa meritano citazione:• la promozione di "Progetti pilota" rivolti alla realizzazione di
obiettivi di qualità paesistica, in determinati contesti o su de-

120 - Il contributo regionale alla definizione di una nuova politica del paesaggio
terminati aspetti, finalizzati a ottenere esperienze per la formu-lazione di linee guida e buone pratiche da estendere alle varieparti del territorio regionale, provinciale o comunale;
• la promozione di attività formative di alta specializzazione, indi-rizzate ai componenti delle Commissioni per la qualità archi-tettonica e del paesaggio e ai professionisti del settore pubblicoe privato. Attività in grado di migliorare significativamente laqualità dei progetti; la valutazione degli effetti sul paesaggio,ma soprattutto capaci di realizzare un’evoluzione del concettodi paesaggio.
• La realizzazione di banche dati informatizzate e georeferen-ziate per rendere disponibili le informazioni in possesso dellediverse amministrazioni; il reciproco scambio di dati; il monito-raggio delle trasformazioni del paesaggio e dell’andamentodella gestione.
In conclusione questo Accordo rappresenta una sfida, non solo perla Regione Emilia-Romagna che l'ha promosso, ma per l'affermazionedi una nuova cultura del paesaggio. Un paesaggio che finalmente siimpone in quanto diventa patrimonio comune e distintivo dei suoi abi-tanti, immagine e motore di un equilibrio tra bisogni sociali, attività eco-nomiche e ambiente.

Edoardo Salzano - 121
Tutela, valor d’uso e pianificazioneEdoardo SalzanoUrbanista
Dorsoduro 104630123 Venezia
Una legge può essere valutata in sè nelle parole del suo testo. Èuna lettura del tutto legittima, ed è quella con la quale, con grande chia-rezza, Marco Cammelli ha aperto il convegno. Forse perché il mio me-stiere è fare l’urbanista, sono abituato invece ad analizzare e a valutarele leggi nel contesto - storico, culturale, sociale, politico - nel quale so-no formate e agiscono. Elio Garzillo ha svelato stamattina una porzionedel contesto. Al contesto si riferirà l’insieme del mio intervento: uncontesto, voglio sottolinearlo, non emiliano-romagnolo, ma italiano,dell’Italia nel suo complesso.
Prima di affrontare il tema del paesaggio vorrei brevemente inqua-drare la questione sottolineando alcuni principi cardine che caratteriz-zano storicamente l’impostazione italiana dell’azione di tutela del patri-monio comune che è costituita dai beni culturali, di cui il paesaggio èparte rilevante.
Il principio dell’inalienabilitàVorrei ricordare, sia pure per incidens, le origini molto antiche di
questo principio, affermato per la prima volta dal soprintendente alleantichità di Roma Raffaello Sanzio, nel 15171.
Vorrei ricordare come questo principio, più volte ripreso nei secolisuccessivi, sia stato ribadito nella prima legge organica dello Stato ita-liano sull’argomento (1909), in cui si proclama l’assoluta inalienabilitàdei beni culturali.
Credo che si possa dire che la premessa della “linea italiana” suibeni culturali è insomma la statuizione della sua appartenenza alla sfe-ra dell’interesse pubblico. Ciò comportava la finalizzazione dell’uso edelle trasformazioni all’interesse comune, e la tendenziale preferenzaper la proprietà pubblica.
1 V. Emiliani, Da Raffaello al 2001, Il Paese che tutelava il bello, in Maria Serena Palieri(a cura di), Patrimonio s.o.s. La grande svendita del tesoro degli italiani, Roma, l’Unità,2004.

122 - Tutela, valor d’uso e pianificazione
Un secondo principio cardine mi sembra che sia costituito dallaconsapevolezza della rilevanza del paesaggio ai fini della determina-zione della identità nazionale.
Questo principio è stato portato a piena dignità d’espressione e dinorma da Benedetto Croce, ministro dell’ultimo governo Giolitti: il pae-saggio "è la rappresentazione materiale e visibile della Patria, coi suoicaratteri fisici particolari, con le sue montagne, le sue foreste, le suepianure, i suoi fiumi, le sue rive, con gli aspetti molteplici e vari del suosuolo".2
Esso è stato ripreso dall’articolo 9 della Costituzione: “la Repubblicatutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.
Entrambi questi principi mi sembrano messi in crisi dal nuovo Codi-ce. Come molti hanno osservato, nel decreto legislativo Urbani il princi-pio dell’alienabilità come eccezione è ribaltato nel suo opposto: ogniqual volta vi sia la convenienza economica l’alienazione è la regola, laconservazione al patrimonio pubblico è l’eccezione. Questa valutazio-ne, che condivido, era affermata per esempio con grande forzanell’intervento di Andrea Emiliani.
Contraddetto è, di fatto, anche l’altro principio: quello dell’interessenazionale, non frammentabile né ripartibile, della tutela del paesaggio;un principio che non a caso è stato posto - come ho appena ricordato -tra i fondamenti della Repubblica nella Carta costituzionale. Su questoaspetto tornerò fra breve. Voglio però domandarmi prima: perché que-sto capovolgimento?
La premessa è, a mio parere, nell’introduzione tra gli idola tribus diquesti decenni di alcune nuove priorità: privato è meglio di pubblico,mercato è meglio di Stato, individuale è meglio di collettivo. Idola chenon hanno prevalso solo nelle tribus di destra. Su questi nuovi idola èintervenuto con molta efficacia Trimarchi, stamattina, quando ha osser-vato che la tesi corrente è che lo Stato non è capace di tutelare il no-stro patrimonio, e quindi si aspetta il privato risolutore come nei filmwestern si aspetta il settimo cavalleggeri.
In questo quadro, mi sembra che abbia avuto un ruolo rilevante, eche costituisce un rivelatore efficace, il larghissimo impiego del terminevalorizzazione.
È un termine che non c’è nell’articolo 9 della Costituzione (“la Re-pubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Na-zione”). È un termine che compare nell’articolo 117 novellato il quale,
2 B. Croce, Relazione al disegno di legge per la tutela delle bellezze naturali, Atti par-
lamentari, Roma, 1920.

Edoardo Salzano - 123
come tutti sappiamo, colloca la “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema edei beni culturali”, tra le materie di esclusiva competenza statale, e la“valorizzazione dei beni culturali e ambientali”, tra le materie di com-petenza concorrente.
È un termine a proposito del quale ho molto apprezzato le cose checi ha detto Vanelli, dello sforzo di superare la dicotomia tra valorizza-zione e tutela riconducendo ciascuno dei due termini all’altro, come hoapprezzato l’angolazione economica intelligente sotto cui ci ha pre-sentato il termine Trimarchi. Vorrei aggiungere un’ulteriore considera-zione, che si riferisce alle categorie economiche che mi sono consuete.
Mi avevano insegnato che ci sono due forme del valore: il valord’uso e quello di scambio. Il primo riferito agli oggetti come beni, il se-condo agli oggetti come merci. A quale delle due forme si riferisce lavalorizzazione della quale si parla oggi? Se si tratta del valor d’uso, al-lora mi sembra che coincida senza residui con tutela. Se invece si rife-risce al valore di scambio, allora coincide con una visione economici-stica, commercialistica, mercantilistica.
È certamente a quest’ultima l’interpretazione che rinvia il contestoculturale e politico: è questa che è coerente con la logica della separa-zione, e con il trend culturale, iniziato con la proposta Craxi-De Michelisdei giacimenti culturali.
La separazione significa: tutela l’oggetto come bene, valorizzal’oggetto come merce. Ma affidare la tutela allo stato, la valorizzazionesostanzialmente alla regione, significa allora introdurre una dialetticarischiosa. Impone comunque di porre su un piano di co-decisione (dicondominio del potere) stato e regione. Una ragione forte a favore di unruolo forte dei poteri specialistici dello Stato: ragione che, come vedre-mo, è negata e capovolta dal nuovo Codice.
Un ulteriore principio cardine dell’impostazione italiana dei beniculturali mi sembra sia costituito dal legame tra il bene culturale e ilcontesto. Questo principio è implicito nelle prime affermazionidell’inalienabilità come divieto di estrarre dal contesto (ordinanze che siritrovano già nella seconda metà del XVI secolo). Esso trova del restola sua radice in quella straordinaria densità dei beni culturali nel conte-sto territoriale italiano, come ci ricordava Bruno Toscano: nel fatto che ilnostro territorio è intriso di beni culturali, che non sono da esso distin-guibili.
È da questo nucleo, mi sembra, che si sviluppa l’attenzione al pae-saggio: ricordiamo il Ministro Benedetto Croce, ricordiamo Giulio CarloArgan (il paesaggio come palinsesto nel quale possiamo leggere secolidi storia).

124 - Tutela, valor d’uso e pianificazione
Il principio della rilevanza culturale del paesaggio e dell’esigenzadella sua tutela da parte dello Stato ha una prima statuizione compiutanell’introduzione dei piani paesistici nella legge Bottai (1939), coevadella legge urbanistica del 1942. Ma è la legge Galasso (1985) il tra-guardo più significativo:
- si riprende l’intuizione crociana del paesaggio come espressio-ne dell’identità nazionale;
- si individuano, prescrittivamente i lineamenti del paesaggio na-zionale, la sua grande orditura e si vincolano (con vincolo soloprocedimentale) i suoi elementi caratterizzanti;
- si amplia e si precisa lo strumento della pianificazione territo-riale e urbanistica come strumento principe per la tutela delpaesaggio (del contesto), passando da una visione settorialedel paesaggio a una visione tendenzialmente integrata con lapianificazione ordinaria: una anticipazione delle novità dellaconvenzione europea del paesaggio, che Poli ci ricordava;
- si definisce un sistema equilibrato competenze (e i doveri) deipoteri centrali e di quelli sub-nazionali: l’individuazione concretadei beni da tutelare e delle specifiche regole da imporre per laloro tutela era affidata al sistema (prevalentemente regionale esub-regionale) della pianificazione, mentre alla responsabilitàdello Stato permaneva il potere di stabilire finalità, criteri e me-todi della tutela, nonché quello di intervenire con l’annullamentodi disposizioni amministrative qualora queste fossero in contra-sto con la finalità della tutela dei beni: era, quest’ultimo, un pote-re di estremo arbitrato e di deterrenza, ma in esso risiedeval’ultima garanzia della tutela di interessi nazionali.
Il nuovo Codice mantiene l’insieme del sistema Galasso, apportan-do utili integrazioni per quanto riguarda:
- il contenuto della pianificazione, secondo una linea che a mesembra convincente;
- la precettività delle determinazioni del piano paesaggistico;- l’attività della ricognizione, del riconoscimento,
dell’individuazione come fondamento della tutela, come ci illu-strava efficacemente Vanelli.
Il nuovo Codice rompe però drasticamente l’equilibrio tra poterecentrale e potere regionale, eliminando il potere d’annullamento degliinterventi contrastanti con le finalità della tutela e sostituendolo conl’espressione di un parere non vincolante delle sovrintendenze. In que-sto senso le critiche al Codice (ad esempio quelle che abbiamo sentitonell’intervento di Lo savio) mi sembrano motivate e giuste, e sottolinea-no anche in questo capitolo la linea generale di spoliazione dei poteri

Edoardo Salzano - 125
della nazione in quanto tale, che pervade tutta l’impostazione di questalegge, e di questa legislatura.
Credo che sia utile, e in questa sede necessario, passare dalla criti-ca alla proposta. Occorre domandarsi insomma che cosa fare, nelcampo della tutela del paesaggio, per riprendere un cammino in avanti,che non sia di semplice resistenza ma che indichi prospettive positive:sia come preparazione di nuove regole (a livello nazionale e a livelloregionale e subregionale) sia come azioni concrete.
1. A me sembra che sia in primo luogo necessario ribadire ilprincipio di un interesse nazionale nella tutela del paesaggio:è un principio, del resto, dettato dalla Costituzione. È statoannebbiato negli ultimi anni dal cedimento alla demagogiadella ‘devoluscion’, che si è manifestata già negli ultimi gover-ni di centro sinistra. Ribadire il principio dell’interesse nazio-nale del paesaggio non significa negare l’impianto regionalistadella nostra Repubblica (prima o seconda che sia), ma signifi-ca richiamare l’idea dello Stato come “intero e armoniosocomplesso delle istituzioni” (v. Emiliani, cit.), e la concezionedel paesaggio come elemento fondante dell’identità del tuttonazionale e delle sue singole parti. (Montale, “Il tutto è più im-portante delle sue parti”).
2. Ritengo che sia da apprezzare e da difendere, nel nuovo Co-dice, l’aver mantenuto la coerenza dell’impianto della leggeGalasso, e in particolare il passaggio dal vincolo (indubbia-mente valido come forma transitoria di protezione) alla pianifi-cazione (come metodo e strumento per una considerazionecomplessiva delle esigenze di tutela del paesaggio edell’ambiente e di sintesi con le altre esigenze). Non concordoperciò con la critica al Codice in merito alla vincolatività pe-renne dei vincoli ope legis, peraltro meramente procedimenta-li.
3. Ritengo che sia da ribadire ulteriormente la priorità delle de-terminazioni relative alla tutela (le invarianti strutturali) rispettoalle esigenze di trasformazione. È una priorità che ha un suorilevante precedente nella pianificazione paesistica della Re-gione Emilia-Romagna (1986), e che è stata incorporata nellamigliore legislazione regionale (Toscana, lex 5/1995, Ligurialex 36/1997, Emilia-Romagna lex 20/2000).
4. Ritengo che il principio dell’interesse nazionale non debbanecessariamente manifestarsi nella forma dell’annullamento,e neppure in quello della autorizzazione, ma debba esprimersisia, nell’immediato, con la vincolatività del parere preventivo,

126 - Tutela, valor d’uso e pianificazione
sia e soprattutto con la sempre più larga applicazione di prati-che di co-pianificazione: con la partecipazione paritaria allescelte della pianificazione dei beni ambientali, culturali e pae-saggistici degli enti che esprimono gli interessi della tutela aidiversi livelli, a partire da quello nazionale.
Un positivo precedente mi sembra del resto costituito dalla normadell’articolo 57 del d. lgs. n. 112 del 31 marzo 19983, che dà alla piani-ficazione provinciale il valore di pianificazione di tutela di competenzastatale “sempreche’ la definizione delle relative disposizioni avvenganella forma di intese fra la provincia e le amministrazioni, anche statali,competenti”.
Vorrei aggiungere due considerazioni che non mi sembrano margi-nali, benché possano sembrare (e forse siano) delle assolute ovvietà.
La prima. Sono ormai trascorsi vent’anni dall’entrata in vigore dellaLegge Galasso. Mi sembrerebbe assolutamente indispensabile fare fi-nalmente un’analisi seria del modo in cui essa è stata applicata: sianelle concrete esperienze di pianificazione e nei loro effetti, sia deicomportamenti amministrativi, sia infine nelle ricadute sulla legislazioneregionale.
Risulterebbero molte cose interessanti, alcune delle quali si posso-no già intuire:
- le enormi differenze tra regione e regione, che porrebbero inevidenza l’assoluta assenza di coordinamenti nazionali o di au-tocoordinamenti interregionali.
- le notevoli diversità di criteri adottati nelle diverse situazioni, avolte - ma non sempre - motivate da differenze sostanziali delleculture e delle realtà.
- l’inefficacia del sistema sanzionatorio, e quindi la scarsa garan-zia fornita dalla potestà di annullamento.
- la variegata traduzione (e spesso lo sviluppo) del “sistema Ga-lasso” nelle legislazioni regionali.
La seconda. Se si condividono i punti che ho prima esposto, e inparticolare l’esigenza di esprimere l’interesse nazionale nella formadella partecipazione preventiva delle strutture statali alle decisioni dellapianificazione, si deve necessariamente convenire sul fatto che
3“La regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento pro-vinciale di cui all'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma il valore e gli ef-fetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente,delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, sempreché ladefinizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la provincia e leamministrazioni, anche statali, competenti”.

Edoardo Salzano - 127
l’interesse nazionale non potrà essere tutelato finché l’apparato tecni-co-scientifico dello stato sarà nelle tragiche condizioni di scarsità di ri-sorse nelle quali versa, e verso le quali sempre più le sospingono il go-verno Berlusconi e il Ministro Urbani.
Se nelle preture e nei tribunali mancano cancellieri, attrezzature in-formatiche, e perfino codici, carta da fotocopie e carta igienica, noncredo che le carenze di personale specializzato, di strumenti di lavoro edi materiali da consumo siano minori nelle sovrintendenze. Per di piùqueste ultime, invece di godere dell’autogoverno proprio del Terzo po-tere, sono gratificate da una burocrazia ministeriale la cui prevalenzami sembra molto accentuata nell’ultima fase.
I sovrintendenti - lo sostiene Losavio nel suo intervento - sono rele-gati dal nuovo Codice “a un ruolo subalterno di mera consulenza”. Ed èfacile immaginare la conseguenza di quella differenza tra il 2° e il 3°comma dell’articolo 115, che ci raccontava Cammelli: chiediamoall’ente pubblico di essere attrezzato, efficace ed efficiente, dotato deglistrumenti e delle competenze adeguate, non lo mettiamo nelle condi-zioni richieste dal 2° comma, e allora siamo legittimati a dare i beniculturali nelle mani dei privati, cui il 3° comma non chiede nulla di simi-le.
Il gioco è fatto.


Alberto Clementi - 129
Paesaggio, territorio, Codice UrbaniAlberto ClementiSegretario Società Italiana degli Urbanisti
Via Basento, 7800198 Roma
Siamo in una fase incerta e controversa nella lunga tradizione di po-litiche pubbliche del paesaggio in Italia. Stimolante per le nuove op-portunità, ma anche preoccupante per i rischi a cui si va incontro. Stia-mo infatti mettendo mano su un corpo di strumentazioni concettuali,normative e organizzative che da lungo tempo è rimasto sostanzial-mente immobile.
Va ricordato che il nostro Paese fin dal 1939 dispone di una legge diprotezione delle bellezze naturali, allora tra le più avanzate al mondo eancora oggi fortemente radicata nei comportamenti delle istituzioni re-sponsabili della tutela. È stata poi la Carta Costituzionale a sancireespressamente l’importanza pubblica del paesaggio, introducendoneper la prima volta una esplicita definizione: “la Repubblica tutela il pae-saggio e il patrimonio storico-artistico della Nazione” (la Repubblica,cioè l’insieme delle istituzioni Stato-Regioni-Enti locali, non solo loStato centrale!) e affermando al tempo stesso il primato del valoreestetico del paesaggio rispetto ad ogni altro interesse pubblico e pri-vato (ciò che ha permesso di imporre vincoli non risarcibili ai soggettiprivati colpiti dai provvedimenti di tutela). Infine l’importante legge del1985 (legge “Galasso”) ha esteso la tutela del paesaggio all’ambiente,innovando le concezioni estetiche con una visione sistematica e ogget-tiva dei beni da tutelare e soprattutto attribuendo alla pianificazione (opaesistica o territoriale con valenza paesistica) il compito di definire imodi e i contenuti della tutela. E oggi, con il Codice Urbani, si completauna codificazione normativa per il paesaggio che almeno nelle sueenunciazioni di principio appare tra le più avanzate in Europa.
Dunque un apparato poderoso e ben fondato di valori, istituzioni estrumenti legislativi. Eppure l’esperienza fatta fino ad oggi ci dice chel’Italia non riesce a governare bene il proprio paesaggio. Al più riesce aimporre molti vincoli, che peraltro raramente risultano efficaci a proteg-gerlo dai mutamenti del territorio contemporaneo. Ma ancora non hasaputo trovare soluzioni convincenti nella prospettiva di una positivaconvergenza tra politiche del paesaggio e politiche del territorio e dellosviluppo locale, una convergenza equilibrata che non sacrifichi né le

130 - Paesaggio, territorio, Codice Urbani
istanze della tutela né quelle dello sviluppo, e che anzi assuma il pae-saggio come risorsa anche economica.
Non si riesce a governare il paesaggio per la oggettiva difficoltà difar fronte ai processi di mutamento economici e sociali che stravolgonoi delicati paesaggi ereditati dalla storia. Ma anche perché non si è ri-usciti a far collaborare in modo soddisfacente gli organismi dello Statocompetenti per la tutela (il Ministero per i Beni e le Attività culturali e lasua rete delle soprintendenze regionali e locali) con le Regioni e i Co-muni, che invece hanno il potere di pianificare e governare il territorio.
Insoddisfatto di come stanno andando le cose, lo Stato vorrebbe ri-prendere su di sé almeno i poteri di tutela, dopo l’esperienza di almenoquindici anni di piani paesistici che hanno fatto sperimentare da vicinole difficoltà di gestione dei vincoli nel rapporto con le Regioni e con iComuni. Ma le ambizioni di neocentralismo si scontrano con un quadropolitico e istituzionale in controtendenza, per molti versi a favore di unfederalismo sempre più spinto e non sempre attento alle ragioni delpaesaggio.
In questa situazione in movimento e dagli esiti ancora incerti, nonsappiamo se alla lunga prevarranno le tendenze alla separazione dellecompetenze, dei poteri e degli stessi saperi disciplinari e accademicitra paesaggio e territorio. O se, al contrario - come noi auspichiamo-vinceranno le tendenze alla cooperazione e al partenariato tra Stato,Regioni ed Enti locali, in un sistema di government integrato che per-metta a ciascun soggetto di esercitare le proprie funzioni in modo coor-dinato con quelle degli altri.
Di certo oggi in Italia per tutto il sistema del paesaggio sembramancare un vero centro in grado di tenere le fila dei processi di riformain atto. Siamo in bilico tra due tendenze opposte: verso il ritorno allaautosufficienza del sistema della tutela che porta alla dissociazione ri-spetto alle politiche territoriali locali; oppure verso la apertura alla co-operazione non gerarchica tra Stato e Regioni, che dovrebbe facilitarela impostazione di politiche integrate di territorio e di gestione del pa-trimonio culturale alla scala sia regionale che provinciale e comunale.
Limiti della pianificazione paesisticaQueste incertezze si riflettono anche sul modo di intendere e utiliz-
zare gli strumenti di intervento, che come noto in Italia sono soprattuttoincardinati sul piano paesistico di iniziativa regionale, introdotto nel1985. Questo piano può essere interpretato come lo strumento per im-porre valori separati dal territorio, accertati attraverso competenze eprocedure ricognitive che fanno capo alle diverse amministrazioni dellatutela. Oppure come strumento per mediare e portare a sintesi condivi-

Alberto Clementi - 131
se tra istanze di tutela dei valori del paesaggio e istanze di sviluppo so-stenibile del territorio, secondo combinazioni che a volta a volta sonocalibrate sulla specificità dei territori da pianificare. Tutte e due le acce-zioni per la verità sono praticabili, e la variegata esperienza dei pianipaesistici di questi quindici anni lo testimonia abbondantemente (comedel resto la stessa formulazione della legge ammetteva: o piani paesi-stici o piani territoriali con valenza paesistica).
Proprio l’esperienza di questi anni mette in luce però alcuni limiti difondo nella pianificazione del paesaggio italiano. Limiti culturali, in pri-mo luogo, dovuti alla difficoltà di integrare e fondere i diversi regimi ditutela che invece riflettono la eterogeneità dei valori storico-culturali, diquelli botanico-vegetazionali e di quelli geomorfologici e idrologici re-golamentati da differenti leggi dello Stato. Ma anche limiti metodologici,dovuti alla assenza di linee di indirizzo concordate preventivamente traStato e Regioni per la redazione e la attuazione dei piani paesistici.
Ne è scaturito uno sconcertante “effetto Arlecchino”. Rimontando inun quadro d’insieme i piani fatti nelle diverse regioni, appare veramenteproblematico comporre un plausibile atlante dei paesaggi italiani, e an-cora più problematico ricostruire una credibile disciplina organica delletutele, data la grande varietà e discrezionalità delle singole interpreta-zioni adottate localmente .
Paradossalmente, si potrebbe affermare che ciò che in fondo è ge-neralmente mancato ai piani paesistici è stato proprio il riconoscimentodelle singolarità dei paesaggi italiani, le loro infinite diversità generatedalle mutue interdipendenze tra i differenti caratteri costitutivi delle spe-cifiche identità locali. È andato perso il valore relazionale tra storia,natura e società locali che modella la mirabile polifonia dei paesaggiitaliani, rendendo inconfondibile la loro personalità ben oltre il mero ri-conoscimento di valore dei singoli aspetti storico-culturali, botanico-vegetazionali, geomorfologici ed estetici.
Il paesaggio, come noi sappiamo, non è una sommatoria di valori datutelare. È una totalità contestuale, che viene plasmata in modo dina-mico dalla combinazione dei caratteri identitari locali che si fondono inuna figura specifica, riconoscibile per il suo senso d’insieme. Il paesag-gio è fatto di differenze, mentre i piani tendono ad omogeneizzare tuttocon le loro categorie normative.
A questa discutibile interpretazione omogeneizzante delle tutele siispira del resto la pianificazione dei Parchi Naturali, regolata da unalegge quadro imposta più di dieci anni fa dalle lobbies ambientaliste.Qui tutto il territorio viene scomposto rigidamente in differenti zone ditutela, con livelli di protezione che sono graduati in funzione della ge-rarchia di valori individuati.

132 - Paesaggio, territorio, Codice Urbani
Dalle “zone santuario” della natura, dove niente è permesso, si vaalle zone della conservazione e poi della trasformazione, dove si pos-sono realizzare progetti di trasformazione ambientale e valorizzazionedel parco. Si tratta di una concezione semplicistica, che va in contrastocon l’idea di assecondare e di valorizzare le diversità dei paesaggi lo-cali, sacrificandole all’insegna di un malinteso primato dei valori di natu-ralità.
Un nuovo contesto per l’azionePer fortuna l’adesione dell’Italia alla Convenzione europea del pae-
saggio firmata a Firenze nel 2000 e la conseguente legge di riformadella pianificazione paesistica nota come “Codice Urbani” (che peraltrofa seguito all’importante Accordo Stato - Regioni del 2001) stannocambiando le condizioni, e aprono alla possibilità di nuovi rapporti trapianificazione paesistica e pianificazione territoriale.
Come noto, la Convenzione richiede agli Stati membri di rilanciarecon forza le politiche a favore del paesaggio, mirando anche ad“integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, ur-banistiche, e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, so-ciale ed economico”. In questa prospettiva si dovrà tenere conto dei“valori specifici dei paesaggi che sono attribuiti dai soggetti e dalle po-polazioni interessate”, concertando con le società locali gli obiettivi diqualità da perseguire.
Interpretando a modo suo la Convenzione (peraltro colpevolmenteancora non ratificata dallo Stato italiano) il Codice Urbani ridefinisce icontenuti della pianificazione paesistica, attribuendo a ciascun territoriospecifici obiettivi di qualità del paesaggio in funzione dei livelli di valorericonosciuti.
Queste prospettive appaiono decisamente più avanzate rispetto allepratiche correnti nel nostro Paese. Riflettono positivamente i “ Principidirettori per lo sviluppo sostenibile del continente europeo” adottatinella XII sessione della Conferenza europea dei Ministri responsabilidella pianificazione territoriale ad Hannover nel 2000. Anche in questocontesto si fece infatti un esplicito riferimento alla necessità di integrarepianificazione del paesaggio e pianificazione del territorio, dando luogoa politiche orientate simultaneamente verso la salvaguardia, la gestionee la riqualificazione di tutti i paesaggi culturali che compongono lo spa-zio europeo.
Sbaglia invero chi crede che oggi l’Italia, con la sua sofisticata tradi-zione di conservazione dei beni culturali e ambientali, si trovi davveropiù avanti rispetto ai principi sottoscritti nella Convenzione. Disponiamoinfatti di una rete fatta da bravi soprintendenti ministeriali “custodi delle

Alberto Clementi - 133
memorie” e di alcune buone leggi di tutela. Ma, nonostante alcuneesperienze positive avviate in questi anni dalle Regioni pilota come To-scana ed Emilia-Romagna, siamo ancora ben lontani dall’avere una ve-ra politica per il paesaggio. Soprattutto, siamo lontani da una culturatecnica e amministrativa capace di coniugare positivamente le istanzedella tutela con quelle di governo del mutamento, nel segno di uno svi-luppo realmente sostenibile per il territorio.
Del resto è proprio questo il punto su cui la Convenzione apre nuoviscenari per il futuro. Non solo perché impone di estendere l’attenzionea tutti i paesaggi, anche quelli fatti di qualità minime o addirittura privi diqualità perché trasfigurati dalle pressioni dello sviluppo. E non soloperché invita a considerare come un valore il mutamento, evitando so-luzioni di arbitrario congelamento delle forme ereditate dalla storia. Maanche - e soprattutto - perché pone l’accento sulle politiche, cioè sulleazioni, sugli attori e sulle risorse necessarie per preservare, mantenereo riqualificare i paesaggi esistenti. Non più solo vincoli, ma forme di ge-stione attiva che devono coinvolgere, motivare e responsabilizzare imolteplici soggetti che a vario titolo intervengono nella costruzione delpaesaggio.
Con conseguenze invero rilevanti per la situazione italiana. In as-senza di un centro condiviso tra Stato, Regioni, Province e Comuni, achi deve toccare il difficile compito di raccordare le diverse politiche disettore che producono effetti decisivi sul paesaggio, dall’agricolturaall’urbanistica, all’ambiente, alle infrastrutture e opere pubbliche? Chisaprà incarnare le sintesi necessarie per garantire la qualità della con-servazione e della trasformazione del paesaggio, mobilitando proget-tualità, saperi, risorse e attori che vanno ben oltre i tradizionali recintidella tutela? Perché la nuova politica induce a promuovere progetti einvestimenti pubblici e privati a favore della riqualificazione dei paesag-gi, non soltanto vincoli e tutele. Anche la conservazione - non diversa-mente dalla valorizzazione - si esercita attraverso il progetto. Ben sa-pendo peraltro che non c’è e non può esserci un progetto di paesaggio.Piuttosto, si può dare un progetto per il paesaggio, poiché agire sulpaesaggio vuol dire intervenire all’interno dei molteplici processi di pro-gettazione del territorio che coinvolgono una grande quantità di sogget-ti, competenze ed esperienze, tutte altrettanto legittime e abilitate amodificare gli spazi esistenti. Alla progettazione del paesaggio contri-buisce ogni attore della modificazione, a qualsiasi scala essa sia; e laprogettazione del paesaggio non ha un termine.

134 - Paesaggio, territorio, Codice Urbani
Quattro errori da evitareQuale che sia lo scenario che si imporrà nella situazione ancora
fluida e incerta del nostro Paese, appare comunque opportuno fissarealcune chiodature concettuali che possono aiutarci ad indirizzare me-glio la sperimentazione almeno regionale nella attuale congiuntura ditransizione.
Quattro sono a mio avviso gli errori principali da scongiurare: unaconcezione riduttiva del paesaggio come bene culturale;un’impostazione separata delle attività di tutela e valorizzazione; unagraduazione delle tutele settorializzata spazialmente sul modello dellearee naturali protette; una interpretazione autoreferenziale dei valoriestetici del paesaggio e dei conseguenti poteri di controllo degli inter-venti.
a. Oltre la concezione tradizionale del paesaggio.Nonostante l’avanzamento del dibattito e delle posizioni espressein sede comunitaria, permane tuttora - soprattutto all’interno delmondo dei giuristi e dei soprintendenti - una concezione sostan-zialmente monumentalistica del paesaggio, che tende ad enuclearedal loro contesto quei beni culturali a cui si applicano i dispositividella tutela. Ma come abbiamo detto il paesaggio non deve essereconsiderato la risultante della somma dei beni culturali esistenti. Èun patrimonio culturale che coinvolge in modo relazionale tutto ilterritorio e che chiede strategie di intervento articolate, in grado diassecondare e valorizzare le differenze riconoscibili nei contesti lo-cali. Al tempo stesso è una risorsa che può assumere una impor-tante valenza economica in una politica dello sviluppo che sappiamettere a frutto le qualità universalmente riconosciute dei paesaggiitaliani.
Per migliorare l’abitabilità del territorio occorre dunque rivolgerela attenzione non soltanto ai luoghi dell’eccellenza ma anche aivalori diffusi e ordinari, visibili o latenti, che contribuiscono altret-tanto a configurare i paesaggi della quotidianità come paesaggiculturali a pieno titolo. Mentre per migliorarne la competitività si do-vranno curare con particolare riguardo quelle qualità di paesaggioche fungono da marchio per tutte le articolazioni dei sistemi pro-duttivi locali e per l’esperienza stessa dei luoghi, vero valore ag-giunto per l’economia oltre che per la cultura.

Alberto Clementi - 135
b. Contro la scomposizione dei poteri della tutela e della valo-rizzazione.Pensare che si possano governare separatamente la tutela e lavalorizzazione, facendo capo per la prima alla amministrazionedello Stato centrale e per la seconda alle Regioni, contraddice ilprincipio di unitarietà del paesaggio affermato in sede comunitaria.Si tende così a generare artificiose separatezze nella gestione, conil rischio di spezzare le reti di relazioni che strutturano dinamica-mente il paesaggio, e di produrre imprevedibili effetti di snatura-mento del senso di uno stesso territorio. Purtroppo questa conce-zione divaricata del paesaggio è entrata nella Carta costituzionale,e ora è difficile liberarsene. Ma rimane un ampio spazio di manovraalla collaborazione tra istituzioni ai diversi livelli, e si può sperareche nelle diverse situazioni locali si possa recuperare quella unita-rietà di visione che è stata disarticolata artificiosamente dalla legge.
c. Contro il determinismo delle politiche di vincolo.Una posizione ben accreditata soprattutto nel mondo dei giuristi edella amministrazione centrale, vorrebbe impostare le disposizionidi vincolo del piano paesistico graduandone la cogenza in funzionedel pregio riconosciuto ai paesaggi. Si potrebbe agire così per de-creto, riducendo i margini di discrezionalità con un automatismo deiprocedimenti di piano che richiede soltanto di classificare preventi-vamente i valori del paesaggio in sede ricognitiva (magari attraver-so un Atlante dei paesaggi prodotto separatamente) per poi farscattare i vincoli di tutela.Ma a ben guardare questa posizione è il frutto avvelenato di undeterminismo che nega il valore del progetto, cioè di un giudiziocritico e contestualizzato. La graduazione delle tutele non va infattiintesa come traduzione speculare di una concezione gerarchizzatadei valori del paesaggio, ma come espressione di una progettualitàche combina diversamente azioni di salvaguardia, di sviluppo com-patibile e di riqualificazione pianificata in relazione ai diversi profilidi identità e di valori patrimoniali riconosciuti come caratterizzantiper le diverse parti del territorio.
Si deve evitare di ripetere l’errore concettuale compiuto con lalegge quadro nazionale sulle aree protette richiamata in preceden-za, che ha imposto una zonizzazione del territorio modulata sui di-versi livelli di protezione richiesti, separando artificiosamente i re-gimi della tutela dall’insieme delle previsioni di regolazione e ge-stione delle trasformazioni ammissibili all’interno dei parchi in coe-renza con gli obiettivi di qualità perseguiti. Salvaguardia, gestione

136 - Paesaggio, territorio, Codice Urbani
sostenibile e riqualificazione pianificata sono aspetti strettamenteinterdipendenti di una strategia globale della tutela e valorizzazioneche deve esaltare le qualità specifiche di ogni paesaggio e le suedifferenze con tutti gli altri, consentendo di realizzarne le possibilitàevolutive giudicate compatibili con gli obiettivi di qualità prefiguratinel piano.
d. Oltre il giudizio estetico tradizionale.Grazie all’art. 9 della Carta costituzionale, il valore estetico-culturale è l’architrave su cui poggia l’intera politica di tutela delpaesaggio, poiché legittima la mancata risarcibilità dei vincoli im-posti ai proprietari. Sulla scia dell’idealismo crociano che ha im-prontato di sé per tanti anni la amministrazione dei beni culturali,molti ritengono tuttora che il giudizio estetico debba essere affidatoad una cultura specialistica, incarnata materialmente da un espertoche nella sua soggettività è depositario di tutti i saperi necessariper decidere del valore estetico di un bene o di un progetto senzaalcun bisogno di misurarsi con altri interlocutori. Ma l’irrompere delpensiero delle differenze nella politica come anche nella esteticadella contemporaneità sta mettendo seriamente in crisi questaconcezione elitaria e autoreferenziale.
Il riconoscimento della bellezza del paesaggio appare ora in-scindibilmente connesso alla pluralità dei significati che assume ri-spetto ai diversi soggetti coinvolti. Il posto del giudizio tende alloraad essere preso dalla giustificazione, costringendo a ricorrere adargomentazioni condivise intersoggettivamente piuttosto che a ve-rità soggettive affermate da uno specialista. Occorre allora rivederesotto questo profilo gli attuali processi amministrativi, ancora troppocondizionati dalla figura tradizionale di un interprete della bellezza -il soprintendente o dal suo equivalente nella nuova geografia deipoteri introdotta dal Codice Urbani - dotato autonomamente di po-teri di decisione.
Un paesaggio è bello se è sano, se è ricco di capacità di evo-cazione, se è in grado di donare un senso all’esperienza del luogointercettando le identità latenti e offrendole alla percezione dellepopolazioni interessate. Dunque sostenibilità ambientale, valore te-stimoniale, pregnanza simbolica, figurabilità e rappresentatività so-no altrettante dimensioni che vanno prese in carico nella valutazio-ne estetica del paesaggio, emancipandola dalle obsolete categoriedello storicismo e aprendola al confronto dialogico e al pluralismodei processi di significazione radicati nel contesto.

Alberto Clementi - 137
Opportunità e rischi del nuovo Codice UrbaniRispetto ad una impostazione delle politiche di paesaggio che do-
vrebbe evitare gli errori denunciati e che dovrebbe saper cogliere tuttele opportunità offerte dal nuovo contesto culturale e istituzionale le re-centi iniziative legislative, e in particolare il nuovo “Codice Urbani”, of-frono un panorama fatto di luci e ombre.
In particolare, va considerata a mio avviso positivamente la tenden-za ad una ridefinizione organica dei beni paesaggistici e beni culturaliintesi come articolazioni del patrimonio culturale complessivo, riservan-do i primi alla iniziativa delle Regioni e i secondi alla iniziativa delloStato. Soprattutto va apprezzato il fatto che il Codice individui univoca-mente lo statuto di bene paesaggistico, indipendentemente dalle fontigiuridiche di provenienza (legge del ’39, legge Galasso e singoli pianipaesistici). Sarà infatti la Regione - sulla base delle proposte di unacommissione mista a scala provinciale - a decretare il “notevole inte-resse pubblico” che fa scattare il regime di tutela dei beni paesaggisticiindividuati. Mentre per i beni culturali la dichiarazione d’interesse èpromossa e adottata dal ministero sulla base delle proposte avanzatedai propri soprintendenti.
Inoltre va salutata con favore la definizione dei contenuti dei pianipaesistici e delle metodologie di elaborazione, in precedenza lasciatealla discrezionalità dei progettisti. E va colto con altrettanto favore il ri-chiamo del Codice al necessario coordinamento dei piani paesistici conla pianificazione territoriale e di settore, e perfino con gli strumenti na-zionali e regionali di programmazione dello sviluppo economico. La tu-tela e la valorizzazione del patrimonio tende così ad assumere final-mente una valenza programmatica e non più soltanto vincolistica, po-nendo concretamente il problema delle risorse da investire anche perincentivare la realizzazione dei progetti e delle best practices.
Per contro, poco convincenti appaiono alcune formulazioni tradizio-nali degli obiettivi di qualità da conseguire e più complessivamente ilpeso ancora eccessivo che viene attribuito ai contenuti vincolistici dellapianificazione rispetto a quelli di promozione dei progetti di paesaggio eal loro raccordo con le politiche di gestione del territorio.
Ma è soprattutto il tema della partecipazione delle popolazioni inte-ressate che appare trattato in modo insoddisfacente, a partire dalla va-ghezza della definizione dell’art.131: “La tutela e la valorizzazione delpaesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioniidentitarie percepibili”: da chi? Dagli esperti, dagli amministratori, dairesidenti, dai turisti, dagli imprenditori, dalla società locale, da quellasovralocale, dalle associazioni culturali e dall’opinione pubblica mano-vrata dalla stampa?

138 - Paesaggio, territorio, Codice Urbani
Sotto il peso di questa ambiguità forse ben calcolata ma comunqueforiera di incertezze, le procedure di individuazione dei beni paesaggi-stici e di attribuzione del valore appaiono nei fatti ancora troppo pocoorientate alla partecipazione delle popolazioni interessate, certo menodi quanto previsto nella Convenzione europea del Paesaggio.
Si sconta probabilmente il difficile compromesso tra le derive auto-ritarie della nostra cultura della conservazione e la diffidenza strisciantenei confronti degli enti locali, che effettivamente hanno dato spessocattiva prova di sé nelle vicende che hanno portato al depauperamentodei nostri paesaggi.
Come è noto, l’introduzione del Codice sta provocando accanitepolemiche che dividono gli ultraconservatori nostalgici curiosamentealleati a frange di urbanisti radicali, preoccupati dal rischio di indebolirele tradizionali forme di tutela del paesaggio, entrambi contrapposti adun variegato fronte di riformisti che invece ritengono di avere raggiuntouna mediazione accettabile tra le visioni contrapposte degli attori istitu-zionali.
La ragione delle divergenze sta infatti proprio nella diversa valuta-zione del ruolo che dovrebbero assumere Regioni e Soprintendenzenelle politiche del paesaggio. Il nuovo Codice è troppo a favore delleRegioni per gli uni, che contro la devoluzione predicanol’autosufficienza del sistema statale come unica garanzia per una cor-retta conservazione. È invece equilibrato per gli altri, che intravedono inquesta formulazione (del resto coerente con il precedente AccordoStato-Regioni) una prospettiva di governo del paesaggio più vicina allepolitiche territoriali che devono essere necessariamente decentrate.
Ma a ben guardare il Codice nella sua positiva ambivalenza può es-sere considerato come il difficile punto di incontro tra due impostazionieffettivamente alternative: o si disarticola il patrimonio dei beni culturalie paesaggistici, o si coopera nelle politiche sia di paesaggio che di ter-ritorio.
Forse perché non si era pienamente convinti della possibilità di farcooperare effettivamente istituzioni centrali e locali, si è preferito distin-guere almeno tra beni culturali e beni paesaggistici, affidandoli rispetti-vamente alle cure dello Stato e delle Regioni. Confidando poi che unauspicabile processo di concertazione interistituzionale potesse portarea coerenza le politiche complessive del patrimonio culturale e paesag-gistico, nelle sue articolazioni centrali e periferiche.
Una ricerca della Società Italiana degli UrbanistiQuale che sia la combinazione tra poteri centrali e regionali, non c’è
dubbio che la revisione delle metodologie della pianificazione rappre-

Alberto Clementi - 139
senti un importante banco di prova della possibilità di innovare le stra-tegie per il paesaggio, cogliendo appieno le opportunità del nuovo cli-ma culturale e del quadro legislativo. Occorre in effetti trovare una basecomune di nozioni concettuali e operative che venga condivisa tra mi-nistero per i Beni e le Attività Culturali e Regioni. L’esperienza accu-mulata con la generazione precedente dei piani paesistici può esserepreziosa. Ma le condizioni sono profondamente cambiate, e anche ipiani migliori appaiono invecchiati rispetto alla nuova situazione.
Un utile contributo alle nuove prospettive di elaborazione dei pianipuò provenire dalla ricerca affidata alla Società Italiana degli Urbanistidall’Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici del Ministeroper i Beni e le Attività Culturali1.
Alla ricerca era stato richiesto di mettere a punto criteri di riferimentoe indirizzi operativi per dare seguito alla Convenzione Europea delPaesaggio e all’Accordo Stato-Regioni allora appena firmato. Le que-stioni poste alla ricerca riguardavano le metodologie per identificare ipaesaggi analizzandone i caratteri, le dinamiche di mutamento e leconseguenti pressioni di trasformazione; le metodologie di valutazionetenuto conto anche dei giudizi soggettivi delle popolazioni coinvolte; einfine le metodologie per definire gli obiettivi di qualità paesistica.
Assumendo come riferimento una visione patrimoniale, (il paesag-gio come un patrimonio di risorse identitarie, che per essere conser-vate e valorizzate richiedono la comprensione dei processi di accumu-lazione selettiva dispiegati nel tempo, attraverso la costante interazionetra quadri ambientali, dinamiche insediative, pratiche di vita e di lavorodelle società locali e valori culturali e simbolici dell’epoca) la ricerca hatrattato le questioni della identificazione / valutazione / previsione / qua-lificazione-regolazione dei paesaggi articolando tre distinti livelli di ela-borazione: una riflessione a più voci sullo stato delle conoscenze esulle vie dell’innovazione più accreditate; la definizione dei nuovi indi-rizzi di guida; una sperimentazione sul campo necessaria per metterealla prova le ipotesi avanzate.
La riflessione critica ha toccato alcuni temi di fondo del dibattito incorso che orientano implicitamente le strategie di intervento. In parti-colare: la positiva pluralità dei modi di intendere la stessa nozione dipaesaggio; la attenzione verso i mutamenti in corso nel territorio chegenerano nuovi paesaggi e cambiano di senso quelli ereditati; la esi-genza di introdurre forme di concertazione interistituzionale e nuovistrumenti di gestione integrata del paesaggio; la affermazione di unanuova progettualità capace di coniugare positivamente conservazionee innovazione; la riforma dei profili formativi necessari per le nuove po-litiche del paesaggio.

140 - Paesaggio, territorio, Codice Urbani
La definizione degli indirizzi guida si è invece concentrata su quattro pas-saggi chiave della costruzione operativa del piano:A. Come identificare il patrimonio paesaggistico integrando la interpretazione
delle specifiche risorse identitarie storico culturali, ecologiche, sociali e dipercezione del senso e tenendo conto delle specifiche razionalità di fun-zionamento che caratterizzano i diversi paesaggi.
B. Come attribuire valori diversificati alla luce anche del riconoscimento delgrado di integrità e di rilevanza introdotto dall’Accordo Stato-Regioni.
C. Come ricostruire i processi di mutamento in atto e anticipare i rischi neiconfronti del paesaggio.
D. Come impostare gli obiettivi di qualità e i modi di regolazione dei muta-menti in funzione delle strategie prefigurate e delle risposte delle societàlocali.
Infine una sperimentazione sul campo ha cercato di far interagirel’elaborazione degli indirizzi di metodo con la loro concreta applicazione sul ter-ritorio. Scegliendo l’area di Camerino nelle Marche come banco di prova dellaricerca, si sono prodotte otto carte tematiche che rappresentano un possibileriferimento per il futuro adeguamento dei piani paesistici richiesto dall’AccordoStato-Regioni.
La ricerca della SIU è servita in un certo senso soprattutto a prendere le mi-sure dei problemi e ad impostare le logiche attraverso cui dare pienamente se-guito ai nuovi indirizzi della Convenzione europea del paesaggio nonché delCodice Urbani. Ma in realtà il lavoro di revisione dei piani vigenti è ancora tuttoda fare. Si tratta di passare ad una fase di concreto impegno istituzionale, spe-rimentando attraverso iniziative pilota di livello regionale le implicazioni di que-sta nuova visione del paesaggio e le possibili convergenze tra attori centrali,regionali e locali. C’è da augurarsi che, come nel passato, le Regioni più inte-ressate si muovano da battistrada, aprendo i nuovi percorsi delle politiche dipaesaggio nella direzione di una interdipendenza sempre più marcata con lepolitiche di territorio e di sviluppo locale. 1 Alla ricerca, da me coordinata per conto della SIU e dall’arch. Manuel Guido del ministero peri Beni e le Attività Culturali, hanno contribuito specialisti di molteplici università, provenientiprevalentemente dall’area dell’urbanistica e della pianificazione del territorio. In particolare suitemi di fondo hanno lavorato rispettivamente Roberto Gambino (Torino), Paolo Urbani (Pesca-ra), Bruno Dolcetta (Venezia), Piercarlo Palermo (Milano), Stefano Boeri (Genova), CesareMacchi Cassia (Milano), Salvatore Dierna (Roma). Alla definizione degli indirizzi di metodohanno partecipato per i diversi tematismi sopra citati Anna Palazzo (Roma), Rita Colantonio(Ancona), Paolo Castelnovi (Torino), Lucina Caravaggi (Roma), Lionella Scazzosi (Milano),Arturo Lanzani (Pescara), Edoardo Zanchini (Legambiente) e Mosé Ricci (Pescara), che haassicurato anche il coordinamento operativo di queste ricerche. Infine l’applicazione speri-mentale, che ha coinvolto un folto gruppo di ricercatori, è stata coordinata da Lucina Caravaggicon Massimo Angrilli e Cristina Imbroglini, mentre Paolo de Stefano ha realizzato l’Atlante fo-tografico del paesaggio. I risultati della ricerca sono sintetizzati in Alberto Clementi, Revisionidi paesaggio, Roma, Meltemi, 2002 e presentati in modo più sistematico nel successivo Al-berto Clementi (a cura di), Interpretazioni di paesaggio, Roma, Meltemi, 2002.

Marina Foschi - 141
Il paesaggio dei beni culturali nell’esperienzadell’IBCAnna Marina FoschiResponsabile del Servizio Beni architettonici e ambientali, Istituto Beni Culturali,Regione Emilia-Romagna
Via Pedriali, 1247100 - Forlì
I diversi titoli del Codice, ed in particolare il terzo, presentano fortidifformità concettuali e disciplinari, tanto è vero che le competenzenelle Regioni sono spesso divise fra più assessorati.
E tuttavia è innegabile il rapporto stringente fra beni culturali e ter-ritorio sia per l'efficacia della tutela, sia per la concertazione delle ini-ziative di valorizzazione. Per i primi (i beni culturali) appare a moltistrumentale la divisione fra tutela e valorizzazione; per il paesaggio èvista da molti con diffidenza la tutela inserita nella gestione del territo-rio.
Da parte delle associazioni ambientaliste è segnalata quantomenola necessità di garantire una maggiore omogeneità fra le Regioni chehanno affrontato in modo eterogeneo la precedente esperienza dellapianificazione paesistica. Vanno individuati procedure e strumenti digestione in tal senso, ma anche per mettere in relazione le diverse ti-pologie di patrimonio.
D'altra parte, la preoccupazione di garantire una superiore tutelastatale sarebbe più credibile senza vendita del patrimonio e condonoedilizio, senza la dispersione dei funzionari e delle più qualificate pro-fessionalità che operano nelle Soprintendenze.
C'è una sorta di partito trasversale che attraversa Governo e cittadi-ni e coinvolge le amministrazioni locali più deboli: è la rinuncia al benecomune che è l’interesse pubblico, dallo stato sociale al patrimoniodemaniale, la cui natura strumentale è garanzia delle finalità pubblicheben rappresentate, per dettato costituzionale, da gran parte dei beniculturali e paesaggistici.
Ma solo poche Soprintendenze hanno esercitato il potere di segna-lare nel breve termine assegnato il patrimonio non cedibile. Coopera-zione e sussidiarietà promosse dal Codice (art. 5) impongono in questadelicata fase la massima partecipazione di ogni livello di governo. Per ibeni architettonici e il paesaggio tutelati si assiste al duplice rischiodella vendita e della compromissione: sia per quanto riguarda le coste,

142 - Il paesaggio dei beni culturali nell’esperienza dell’IBC
i fiumi o le foreste, sia per le testimonianze di civiltà e di identità: dailuoghi di culto e di potere, a quelli di assistenza e beneficenza, che im-plicano anche l’esercizio della prelazione.
È chiaro che non si mette in discussione il privato, ma è nel cam-biamento di proprietà e di funzione che si gioca l’interesse o meno dellatutela.
Se per il paesaggio il maggiore sostegno alle politiche di salvaguar-dia viene dalla Convenzione europea, per la pianificazione urbanisticae la qualità architettonica si assiste a nuovi segnali nella legislazioneregionale e nazionale.
Dal 2000 una serie di provvedimenti a cascata fra Unione europea,Stato e Regioni sta rinnovando radicalmente il quadro normativo deibeni culturali, dell'ambiente, del paesaggio e della pianificazione territo-riale. In Emilia-Romagna il processo avviato con la legge urbanistica20/2000 segna alcune tappe significative, nelle quali si ravvisa unaproficua utilizzazione delle ricerche prodotte e delle attività svoltedall’IBACN.
In primo luogo è d’obbligo il riferimento all’accordo (già ampiamentedescritto, v. relazione Poli) del 9 ottobre 2003 fra la Regione e il Mini-stero Beni e Attività culturali e le Associazioni delle Autonomie localiper l'esercizio della tutela del paesaggio finalizzato: "a realizzare unaforma di collaborazione istituzionale che impegni le parti a garantire lacorretta gestione della tutela del territorio, la valutazione consapevoledelle trasformazioni e la salvaguardia dei valori storici, culturali, natura-listici e paesaggistici, attraverso il riconoscimento di un quadro stru-mentale e normativo che sia univoco e condiviso". La condivisione congli organi dello stato si basa sulla chiarezza e l'elaborazione di obiettivicomuni e su questa strada Assessorato e Istituto hanno collaborato findall’elaborazione del PTPR.
Esso è preceduto dall'Accordo ministeriale del 2001 che ha avutomerito di estendere definitivamente a tutto il territorio il riconoscimentogiuridico di valenza paesistica.
Nel contesto più generale del coordinamento fra le Regioni questoaccordo era parso ad alcuni una fuga in avanti, ad altri un passo indie-tro rispetto a competenze acquisite per le Regioni. Si tratta in realtàdella conclusione logica di un processo maturato a lungo dopo la rea-lizzazione del Piano paesistico, attento agli obiettivi di tutela e valoriz-zazione del patrimonio e non limitato alle sole competenze, entrato nelmerito dei risultati da ottenere, dei metodi e delle procedure per realiz-zarli.
Un accordo che apre anche prospettive di approfondimenti e di ela-borazioni finalizzate ad un Istituto (per i beni culturali) che è organo

Marina Foschi - 143
della Regione e strumento delle politiche per i beni artistici, culturali enaturali, di supporto, anche, agli enti locali.
Del resto lo stesso Codice, riconoscendo nel settore ambientale lecompetenze connesse alla gestione del territorio, non può non fare rife-rimento all'esigenza di strutture regionali in grado di organizzare le co-noscenze e riversarle in livelli diversi di programmazione e valorizza-zione.
Significativi in proposito gli articoli 132 e 135 del Titolo III che ri-chiamano, il primo la cooperazione tra amministrazioni pubbliche el'istituzione di Osservatori nazionali e regionali con il compito di elabo-rare studi, analisi e proposte per la qualità del paesaggio; il secondo,ribadendo la competenza regionale in materia, afferma il carattere ur-banistico-territoriale dei piani paesistici che debbono definire le tra-sformazioni compatibili, le azioni di recupero e riqualificazione e gli in-terventi di valorizzazione in relazione con le prospettive di sviluppo so-stenibile.
Nei successivi articoli viene ripresa l'interrelazione fra piano paesi-stico e pianificazione territoriale e vengono previsti (art. 156) conven-zioni e accordi fra Ministero e Regioni per stabilire "le metodologie e leprocedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degliimmobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per laloro rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicura-re la interoperabilità dei sistemi informativi". Nonostante il tono accatti-vante delle enunciazioni, un'associazione ambientalista come Italia No-stra lamenta un'attenzione insufficiente per i temi ambientali ed esortale Regioni a valorizzare l'attività di censimento in questo campo.
Nel dicembre 2003 è stata approvata la legge nazionale 378 per la"tutela e valorizzazione dell'architettura rurale", un provvedimento incontrotendenza dopo decenni di rinuncia a gestire l'abbandono agricolodelle campagne, ma in grado di rafforzare i provvedimenti regionali in-dirizzati alla valorizzazione dell'architettura e del paesaggio agrario:l'IBC, in particolare, può fornire il supporto conoscitivo ed i criteri diclassificazione e valutazione affinati negli anni.
Fra il 2002 ed il 2003 ulteriori provvedimenti confermano e defini-scono la volontà regionale di puntare ad una migliore qualità dell' ar-chitettura e del paesaggio, regolando i processi di progettazione con-nessi al rispetto delle normative urbanistiche.
Un rilancio della progettualità come dibattito aperto sulla cultura delterritorio è dato dalla LR n.16 del 2002. Partita dal recupero edilizio,con alle spalle le rielaborazioni della legge per i centri storici ed una se-ria esperienza sugli studi di fattibilità legati ai piani di recupero, ha tesoa ricucire il filo conduttore fra paesaggio e costruito storico, demolizio-

144 - Il paesaggio dei beni culturali nell’esperienza dell’IBC
ne di opere incongrue e rilancio dell'architettura contemporanea. Infondo il denominatore comune è la qualità di un progetto che non puòprescindere da un confronto approfondito con il contesto ambientale.
Questo paradigma complesso va al di là della proposta di legge perla qualità architettonica presentata dal Ministero. Sarebbe però con-traddittorio vedere in questi provvedimenti la rivalsa degli architetticontemporanei sui veti ad intervenire nei centri storici. La constatazioneoggettiva di perdita della "bellezza" in Italia non può essere risolta soloda sporadiche demolizioni di "mostri", né da sostituzioni frettolose. Apartire dalle periferie urbane e dai paesaggi compromessi, il rilancio delprogetto di qualità, l'apertura di concorsi, il sostegno ai giovani profes-sionisti vanno praticati per il risarcimento delle ferite ambientali comeper le nuove realizzazioni. L'Istituto Beni Culturali è chiamato ad unruolo importante da questa legge: non solo nella partecipazione ad unavalutazione dei progetti, ma anche nel mettere a disposizione materialie metodiche acquisite ed infine nella ricerca sulle opere dell'architetturacontemporanea.
Anche le nuove norme che la Regione ha elaborato sull'abusivismoedilizio in risposta al condono sono un'occasione per ribadire le finalitàdella salvaguardia del territorio e dell'ambiente come interesse premi-nente della comunità regionale, affiancando così il principio della con-servazione preventiva a quello della vigilanza e delle sanzioni control’abusivismo. La tempestività nel reprimere gli abusi si raccorda conl’organizzazione preordinata e finalizzata delle conoscenze, a partireda una chiara individuazione delle aree più sensibili e a rischio.
Significativo e da sostenere in tale legge è il ruolo delle Commissio-ni per la qualità architettonica e del paesaggio, alle quali l'Istituto puòfornire indicazioni e documentazione.
Nei più recenti indirizzi per la pianificazione territoriale presentatidalla Provincia di Modena all'inizio del 2004, fra gli indicatori di sosteni-bilità, viene data priorità di riconoscimento ed esigenza di comunica-zione ai cittadini per le aree non idonee ai nuovi insediamenti, quelleche il Piano paesistico del 1993 aveva definito "invarianti" del paesag-gio. Ma la puntuale analisi modenese tende a recuperare nelle realtàcircoscritte dalla pianificazione comunale quell'elemento originario di"vocazionalità" dei suoli già chiaramente espresso negli anni '70 e tut-tavia non interamente colto da un piano di rango regionale: la parteci-pazione dell' insediamento umano, dalle più remote origini ai giorni no-stri alla formazione strutturale del paesaggio.
Ciò che in sostanza intendiamo per "sostenibilità" riprende in chiaveaggiornata quelle metodologie messe a punto in Emilia-Romagna e inaltre regioni nella prima fase del governo regionale.

Marina Foschi - 145
Una considerazione centrale, attuale oggi come ieri, è l'esigenza diprevenzione dei rischi connessi alle trasformazioni del paesaggio e allalocalizzazione degli insediamenti. I diversi termini con i quali nel tempoè stato definito il percorso (carta degli scavi, vocazione dei suoli, cartadei beni culturali, carta del rischio) hanno un evidente denominatorecomune: la possibilità di prevedere con analisi mirate (dalla strutturageologica - all'evoluzione morfologica, dall'uso del suolo alla stratifica-zione insediativa), l’impatto e le conseguenze delle scelte sull'ambien-te. E non v'è dubbio che la prevenzione sia la migliore garanzia per laconservazione del patrimonio.
Fra le recenti realizzazioni dell'Istituto che riprendono aggiornandoloquesto percorso nello spirito di una fattiva collaborazione con gli organidello Stato e con gli enti locali per la tutela del patrimonio e del pae-saggio e per la conservazione dell'ambiente, si possono citare: confe-renza di pianificazione, criteri e metodologie per esaminare le trasfor-mazioni del paesaggio, Agenda 21 e “città sostenibili”.
Cartografia archeologica e pianificazione territoriale. Il progettoC.A.R.T.
II progetto della creazione di una Carta Archeologica del Rischionasce ufficialmente nel 1995: fu l'allora Soprintendente Pietro GiovanniGuzzo che, sull'esempio dell'esperienza del Museo Civico Archeologi-co Etnologico di Modena, sentì l'esigenza di estendere alla Regioneuna "politica del dialogo" con le amministrazione locali ed i privati: pro-getto caldamente sostenuto anche dal Soprintendente successivo - Mi-rella Marini Calvani - e che rappresenta il segno della volontà di opera-re assieme per lo sviluppo del territorio nel rispetto della salvaguardiadel patrimonio storico archeologico, facendo della Carta Archeologicadel Rischio Territoriale uno strumento attivo entro un reale processo ditutela preventiva.
Il progetto ECONETII progetto vincitore quest'anno del "Panda d'Oro" del WWF, coordi-
nato per la Regione Emilia-Romagna dall'Istituto Beni culturali, in colla-borazione con la Contea inglese del Cheshire, la Provincia olandesedel Gelderland, le Province di Modena e di Bologna, la Regione Abruz-zo, ha prodotto una metodologia per misurare le modificazioni ecologi-che del territorio nel corso del tempo, grazie anche alla cartografia ealle foto aeree storiche raccolte all'IBC. Nelle aree di studio il progettoha formato lo schema di riferimento per interventi di restauro e di rico-struzione ambientale e per costruire una rete ecologica efficiente ecoerente.

146 - Il paesaggio dei beni culturali nell’esperienza dell’IBC
Nel corso dei lavori le due Province hanno inserito il progetto di retenei loro strumenti pianificatori, in modo da assicurare i necessari svi-luppi futuri, mentre le amministrazioni comunali sono coinvolte sia perla realizzazione che per la gestione della rete ecologica.
L'Istituto per i Beni Culturali dell'Emilia-Romagna nacque, prima an-cora del Ministero voluto da Spadolini, come supporto alla programma-zione della Regione e degli enti locali nel momento in cui una politicadei beni culturali sembrò lo strumento per governare con il consensodei cittadini le trasformazioni del territorio regionale.
II concetto di "bene culturale", coniato dalla Commissione France-schini nel 1964, all'inizio degli anni Settanta venne ripreso con il de-centramento regionale per esaltare il valore collettivo delle radici pro-fonde delle culture locali, fatte di aspetti eterogenei da mettere a con-fronto con criteri non selettivi. Vennero così prodotte e sperimentatemetodologie di studio delle componenti naturali ed antropiche che inperiodi diversi avevano conformato porzioni di territorio conferendoprecise identità.
È utile rileggere tratti dell'inserto speciale al n.5 del 1975 di "Bolo-gna Incontri" in occasione dell'insediamento ufficiale degli Organi del-l'Istituto nominati dalla Regione. "Si è voluto affermare come l'organiz-zazione tradizionale della cultura istituzionalizzata, per intendersi, deimusei e delle biblioteche, non potesse più a lungo restare separata daaltre attività che vi si connettono, sia da un punto di vista sociale e poli-tico, sia da un punto di vista scientifico-amministrativo. Non si vede in-fatti come la salvaguardia del singolo oggetto possa essere slegatadallo studio del suo contesto culturale e territoriale né come i beni natu-rali possano essere studiati fuori dalle loro sedimentate e capillari stra-tificazioni. E si è altresì ritenuto di dover precisare come l' impresa dicatalogazione dei beni artistici, culturali e naturali, che l’Istituto definiràin termini corretti di metodologie unificanti, vada subordinata a una po-litica di piano che ravvisi nell'inventariazione generale la fonte primariadi materiali informativi, a livello di elaborazione scientifica anche la piùraffinata e che consenta di porre propriamente e avviare i problemidello sviluppo sociale economico e culturale della regione [...] l’Istituto[...] assume a compito specifico della propria attività l'esame minuziosoe dettagliato della condizione storico- culturale e socio-economica delterritorio, puntando cioè - attraverso l'adozione di tutte le moderne me-todologie - ad una conoscenza ‘globale’ del territorio stesso in tutta lagigantesca vastità del sistema spazio-temporale.
Proprio perciò l'Istituto seguirà metodi largamente interdisciplinari,gli unici che consentano l'esatta, costante interazione nel complessoprocesso conoscitivo della realtà, gli unici che rendano valida l'azione

Marina Foschi - 147
didattica che al censimento deve intendersi ovviamente legata; gli unici,infine, che possano facilitare fin dal suo primo attuarsi sperimentale, ilmomento della conoscenza analitica dell'inventario verso una tensioneprogettuale, e cioè dall'inventario alla politica di piano. [...] l'Istituto nonvuole costituirsi come uno strumento di propulsione scientifica, e tutta-via squisitamente isolato, ma gettare invece le sue più profonde radicinella realtà culturale e politica delle comunità locali, esprimere a livellodi ricerca le scelte culturali e politiche, servirne le necessità reali".
La complessità dei temi trattati dal Codice impone alle Regioni diattrezzarsi con strumenti adeguati per la gestione di una tutela e frui-zione diversificata, fortemente intrecciata in campi spesso separati.
L’esperienza dell’IBC, certo variata dall’impostazione iniziale e ri-spondente ad esigenze mutate, può però rappresentare nella sua natu-ra tecnica e scientifica interdisciplinare una formula efficace, un'autho-rity ideale per la sua gestione.


documenti


Convenzione Europea del paesaggio - 151
Convenzione europea del paesaggio Firenze, 20 ottobre 2000
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,1 con-siderando che il fine del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono il loro patrimonio comune, e che tale fine è perseguito in particolare attraverso la conclusione di accordi nel campo economico e sociale;
Desiderosi di pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente;
Constatando che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'at-tività economica, e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro;
Consapevoli del fatto che il paesaggio coopera all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Euro-pa, contribuendo cosi' al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consoli-damento dell'identità europea;
Riconoscendo che il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana;
Osservando che le evoluzioni delle tecniche di produzione agricola, forestale, indu-striale e pianificazione mineraria e delle prassi in materia di pianificazione territoriale, ur-banistica, trasporti, reti, turismo e svaghi e, più generalmente, i cambiamenti economici mondiali continuano, in molti casi, ad accelerare le trasformazioni dei paesaggi;
Desiderando soddisfare gli auspici delle popolazioni di godere di un paesaggio di qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione;
Persuasi che il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo;
Tenendo presenti i testi giuridici esistenti a livello internazionale nei settori della sal-vaguardia e della gestione del patrimonio naturale e culturale, della pianificazione territo-riale, dell'autonomia locale e della cooperazione transfrontaliera e segnatamente la Con-venzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa (Berna, 19 settembre 1979), la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architet-tonico d'Europa (Granada, 3 ottobre 1985), la Convenzione europea per la tutela del pa-trimonio archeologico (rivista) (La Valletta, 16 gennaio 1992), la Convenzione-quadro eu-ropea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (Madrid, 21
1Traduzione del testo ufficiale in inglese e francese predisposta dal Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici, in occasione della Conferenza Ministeriale di Apertura alla firma della Convenzione Europea del Paesaggio. La traduzione e la pubblicazione del testo sono state curate da Manuel R. Guido e Da-niela Sandroni dell'Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici.

152 – Firenze, 20 ottobre 2000
maggio 1980) e i suoi protocolli addizionali, la Carta europea dell'autonomia locale (Stra-sburgo, 15 ottobre 1985), la Convenzione sulla biodiversità (Rio, 5 giugno 1992), la Con-venzione sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 novembre 1972), e la Convenzione relativa all'accesso all'informazione, alla partecipazione del pub-blico al processo decisionale e all'accesso alla giustizia in materia ambientale (Aarhus, 25 giugno 1998) ;
Riconoscendo che la qualità e la diversità dei paesaggi europei costituiscono una ri-sorsa comune per la cui salvaguardia, gestione e pianificazione occorre cooperare;
Desiderando istituire un nuovo strumento dedicato esclusivamente alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione di tutti i paesaggi europei;
hanno convenuto quanto segue:
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Definizioni
Ai fini della presente Convenzione: a. "Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle
popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;
b. "Politica del paesaggio" designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano l'adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare gestire e pianificare il pa-esaggio;
c. "Obiettivo di qualità paesaggistica" designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popola-zioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita;
d. "Salvaguardia dei paesaggi" indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento uma-no;
e. "Gestione dei paesaggi" indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sosteni-bile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali;
f. "Pianificazione dei paesaggi" indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valo-rizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

Convenzione Europea del paesaggio - 153
Articolo 2 Campo di applicazione
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15, la presente Convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa com-prende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che pos-sono essere considerati eccezionali, che i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi de-gradati.
Articolo 3 Obiettivi
La presente Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la ge-stione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in que-sto campo.
CAPITOLO II
PROVVEDIMENTI NAZIONALI
Articolo 4 Ripartizione delle competenze
Ogni Parte applica la presente Convenzione e segnatamente i suoi articoli 5 e 6, se-condo la ripartizione delle competenze propria al suo ordinamento, conformemente ai suoi principi costituzionali e alla sua organizzazione amministrativa, nel rispetto del prin-cipio di sussidiarietà, tenendo conto della Carta europea dell'autonomia locale. Senza derogare alle disposizioni della presente Convenzione, ogni Parte applica la presente Convenzione in armonia con le proprie politiche.
Articolo 5 Provvedimenti generali
Ogni Parte si impegna a : a. riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del con-
testo di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimo-nio culturale e naturale e fondamento della loro identità;
b. stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi tramite l'adozione delle misure specifiche di cui al se-guente articolo 6;
c. avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche pae-saggistiche menzionate al precedente capoverso b;
d. integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nel-le altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

154 – Firenze, 20 ottobre 2000
Articolo 6
Misure specifiche
A Sensibilizzazione Ogni parte si impegna ad accrescere la sensibilizzazione della società civile, delle organizzazioni private e delle autorità pubbliche al valore dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione. B Formazione ed educazione
Ogni Parte si impegna a promuovere : a. la formazione di specialisti nel settore della conoscenza e dell'intervento sui pae-
saggi; b. dei programmi pluridisciplinari di formazione sulla politica, la salvaguardia, la gestio-
ne e la pianificazione del paesaggio destinati ai professionisti del settore pubblico e privato e alle associazioni di categoria interessate;
c. degli insegnamenti scolastici e universitari che trattino, nell'ambito delle rispettive discipline, dei valori connessi con il paesaggio e delle questioni riguardanti la sua salvaguardia , la sua gestione e la sua pianificazione.
C Individuazione e valutazione 1. Mobilitando i soggetti interessati conformemente all'articolo 5.c, e ai fini di una
migliore conoscenza dei propri paesaggi, ogni Parte si impegna a: a.
i. individuare i propri paesaggi, sull'insieme del proprio terri-torio;
ii. analizzarne le caratteristiche, nonché le dinamiche e le pressioni che li modificano;
iii. seguirne le trasformazioni ; b. valutare i paesaggi individuati, tenendo conto dei valori specifici che
sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate. 2. I lavori di individuazione e di valutazione verranno guidati dagli scambi di espe-
rienze e di metodologie organizzati tra le Parti, su scala europea, in applicazio-ne dell'articolo 8 della presente Convenzione.
D Obiettivi di qualità paesaggistica Ogni parte si impegna a stabilire degli obiettivi di qualità paesaggistica riguardanti i paesaggi individuati e valutati, previa consultazione pubblica, conformemente all'articolo 5.c. E Applicazione Per attuare le politiche del paesaggio, ogni Parte si impegna ad attivare gli strumenti di intervento volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione dei paesaggi.
CAPITOLO III COOPERAZIONE EUROPEA
Articolo 7
Politiche e programmi internazionali
Le Parti si impegnano a cooperare perchè venga tenuto conto della dimensione pae-saggistica nelle loro politiche e programmi internazionali e a raccomandare, se del caso, che vi vengano incluse le considerazioni relative al paesaggio.

Convenzione Europea del paesaggio - 155
Articolo 8 Assistenza reciproca e scambio di informazioni
Le Parti si impegnano a cooperare per rafforzare l'efficacia dei provvedimenti presi ai sensi degli articoli della presente Convenzione, e in particolare a:
a. prestarsi reciprocamente assistenza, dal punto di vista tecnico e scientifico, tramite la raccolta e lo scambio di esperienze e di lavori di ricerca in materia di paesaggio;
b. favorire gli scambi di specialisti del paesaggio, segnatamente per la formazione e l'informazione;
c. scambiarsi informazioni su tutte le questioni trattate nelle disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 9
Paesaggi transfrontalieri Le Parti si impegnano ad incoraggiare la cooperazione transfrontaliera a livello locale e regionale, ricorrendo, se necessario, all'elaborazione e alla realizzazione di programmi comuni di valorizzazione del paesaggio.
Articolo 10 Controllo dell'applicazione della Convenzione
1. I competenti Comitati di esperti già istituiti ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto
del Consiglio d'Europa, sono incaricati dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del controllo dell'applicazione della Convenzione.
2. Dopo ogni riunione dei Comitati di esperti, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmette un rapporto sui lavori e sul funzionamento della Convenzio-ne al Comitato dei Ministri.
3. I Comitati di esperti propongono al Comitato dei Ministri i criteri per l'assegna-zione e il regolamento del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa.
Articolo 11
Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa
1. Il Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa può essere assegnato alle col-lettività locali e regionali e ai loro consorzi che, nell'ambito della politica pae-saggistica di uno Stato Parte contraente della presente Convenzione, hanno at-tuato una politica o preso dei provvedimenti volti alla salvaguardia, alla gestio-ne e/o alla pianificazione sostenibile dei loro paesaggi che dimostrino una effi-cacia durevole e possano in tal modo servire da modello per le altre collettività territoriali europee. Tale riconoscimento potrà ugualmente venir assegnato alle organizzazioni non governative che abbiano dimostrato di fornire un apporto particolarmente rilevante alla salvaguardia, alla gestione o alla pianificazione del paesaggio.
2. Le candidature per l'assegnazione del Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa saranno trasmesse ai Comitati di Esperti di cui all'articolo 10 dalle Parti. Possono essere candidate delle collettività locali e regionali transfronta-liere, nonché dei raggruppamenti di collettività locali o regionali, purché gesti-scano in comune il paesaggio in questione.

156 – Firenze, 20 ottobre 2000
3. Su proposta dei Comitati di esperti di cui all'articolo 10, il Comitato dei Ministri definisce e pubblica i criteri per l'assegnazione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa, ne adotta il regolamento e conferisce il premio.
4. L'assegnazione del Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa stimola i sog-getti che lo ricevono a vigilare affinché i paesaggi interessati vengano salva-guardati, gestiti e/o pianificati in modo sostenibile.
CAPITOLO IV
CLAUSOLE FINALI
Articolo 12 Relazioni con altri strumenti giuridici
Le disposizioni della presente Convenzione non precludono l'applicazione di disposi-zioni più severe in materia di salvaguardia, gestione o pianificazione dei paesaggi conte-nute in altri strumenti nazionali od internazionali vincolanti che sono o saranno in vigore.
Articolo 13 Firma, ratifica, entrata in vigore
1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio
d'Europa. Sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segre-tario Generale del Consiglio d'Europa;
2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo;
3. Per ogni Stato firmatario che esprimerà successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del depo-sito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Articolo 14 Adesione
1. Dal momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Mini-
stri del Consiglio d'Europa potrà invitare la Comunità Europea e ogni Stato europeo non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione, con una decisione presa dalla maggioranza prevista all'articolo 20.d dello statuto del Consi-glio d'Europa, e all'unanimità degli Stati Parti Contraenti aventi il diritto a sedere nel Comitato dei Ministri;
2. Per ogni Stato aderente o per la Comunità Europea in caso di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Convenzione Europea del paesaggio - 157
Articolo 15 Applicazione territoriale
1. Ogni Stato o la Comunità europea può, al momento della firma o al momento del
deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di ade-sione, designare il territorio o i territori in cui si applicherà la presente Convenzione;
2. Ogni Parte può, in qualsiasi altro momento successivo, mediante dichiarazione indi-rizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la dichiarazione è stata ricevuta dal Segretario Generale;
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata per quanto riguarda qualsiasi territorio specificato in tale dichiarazione, con notifica in-viata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 16 Denuncia
1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione, me-
diante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa; 2. Tale denuncia prenderà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di
un periodo di tre mesi dalla data in cui la notifica è stata ricevuta da parte del Segre-tario Generale.
Articolo 17 Emendamenti
1. Ogni Parte o i Comitati di Esperti indicati all'articolo 10 possono proporre degli e-
mendamenti alla presente Convenzione. 2. Ogni proposta di emendamento è notificata per iscritto al Segretario Generale del
Consiglio d'Europa, che a sua volta la trasmette agli Stati membri del Consiglio d'Eu-ropa, alle altre Parti contraenti e ad ogni Stato europeo non membro che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione ai sensi dell'articolo 14.
3. Ogni proposta di emendamento verrà esaminata dai Comitati di Esperti indicati al-l'articolo 10 e il testo adottato a maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti delle Parti verrà sottoposto al Comitato dei Ministri per l'adozione. Dopo la sua adozione da parte del Comitato dei Ministri secondo la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati Parti Contraenti aventi il diritto di partecipare alle riunioni del Comitato dei Ministri, il testo verrà trasmesso alle Parti per l'accettazione.
4. Ogni emendamento entra in vigore, nei confronti delle Parti che l'abbiano accettato, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Parti Contraenti, membri del Consiglio d'Europa avranno informato il Se-gretario Generale di averlo accettato. Per qualsiasi altra Parte che l'avrà accettato successivamente, l'emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese succes-sivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la detta Parte avrà infor-mato il Segretario Generale di averlo accettato.

158 – Firenze, 20 ottobre 2000
Articolo 18 Notifiche
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato o alla Comunità Europea che abbia aderito alla presente Conven-zione: 1. ogni firma; 2. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesio-
ne; 3. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli arti-
coli 13, 14 e 15; 4. ogni dichiarazione fatta in virtù dell'articolo 15; 5. ogni denuncia fatta in virtù dell'articolo 16; 6. ogni proposta di emendamento, cosi' come ogni emendamento adottato conforme-
mente all'articolo 17 e la data in cui tale emendamento entrerà in vigore; 7. ogni altro atto, notifica, informazione o comunicazione relativo alla presente Con-
venzione. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato la pre-sente Convenzione. Fatto a Firenze, il 20 ottobre 2000, in francese e in inglese, facendo i due testi ugualmen-te fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, nonché a ciascuno degli Stati o alla Comunità Europea invitati ad aderire alla presente Convenzione.2
2 L'Assemblea parlamentare e il Comitato del patrimonio culturale del Consiglio d'Europa, come pure il Comitato delle regioni dell'Unione europea, il Comitato per la tutela del pa-trimonio mondiale dell'Unesco, la Commissione per le zone protette e la Commissione del diritto dell'ambiente dell'Unione mondiale per la natura (UICN) hanno espresso il loro pa-rere ufficiale nel quadro della Conferenza di Firenze. In tale occasione, un certo numero di organizzazioni non governative qualificate sotto il profilo tecnico nel campo del pae-saggio hanno ugualmente espresso un parere favorevole sul progetto preliminare di con-venzione.

Convenzione Europea del paesaggio - 159
Convenzione europea del paesaggio Relazione esplicativa
I. Origini della Convenzione
1. Nel marzo del 1994, alcuni mesi prima della Prima Sessione plenaria del Congresso
dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa (CPLRE), l'allora Conferenza permanente dei poteri locali e regionali d'Europa ha adottato la Risoluzione 256 (1994) relativa alla 3a Conferenza delle regioni mediterranee. Nel testo, l'allora Con-ferenza permanente ha invitato il Congresso, l'organo che l'ha sostituita, "ad elabo-rare, in base alla Carta del paesaggio mediterraneo - adottata a Siviglia dalle Regio-ni Andalusia (Spagna), Languedoc-Roussillon (Francia) e Toscana (Italia) - una convenzione-quadro sulla gestione e la tutela del paesaggio naturale e culturale di tutta l'Europa ".
2. Un anno dopo, in seguito alla prima Conferenza dei ministri europei dell'Ambiente, svoltasi a Dobríš nel giugno del 1991, l'Agenzia europea dell'ambiente dell'Unione europea ha pubblicato L'ambiente dell'Europa, la relazione di Dobríš, che presenta un'analisi approfondita della situazione e delle prospettive dell'ambiente nella Gran-de Europa. Il Capitolo 8 di questo testo è dedicato alla questione del paesaggio e nelle sue conclusioni esprime l'auspicio che il Consiglio d'Europa prenda l'iniziativa di elaborare una convenzione europea sul paesaggio rurale.
3. Nel 1995, l'Unione mondiale per la natura (UICN) ha pubblicato il documento Parchi per la vita : delle iniziative per le aree protette d'Europa; con il supporto, tra l'al-tro, dell'Agenzia svedese di protezione dell'ambiente, del ministero dell'Agricoltura, dell'Assetto territoriale e della Pesca olandese, del Ministero dell'ambiente norgeve-se, della Countryside Commission britannica, del ministero dell'ambiente, della con-servazione della natura e della sicurezza nucleare tedesco, del ministero dell'am-biente francese e del Fondo mondiale per la natura (WWF). Tale testo raccomanda la stesura di una convenzione internazionale sulla tutela dei paesaggi rurali in Euro-pa, cui dovrebbe partecipare il Consiglio d'Europa.
4. In base a tali raccomandazioni e alla crescente domanda sociale, il Congresso ha deciso di elaborare un progetto di convenzione europea del paesaggio, in vista della sua adozione da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Per la stesu-ra di tale progetto, il Congresso ha istituito, nel settembre del 1994, un gruppo di la-voro ad hoc. Nel novembre dello stesso anno si è svolta la prima riunione del sud-detto gruppo, composto di membri della Camera dei poteri locali e della Camera del-le regioni del Congresso. In applicazione del principio di consultazione e di parteci-pazione, sono stati invitati a partecipare ai lavori di questo gruppo numerosi enti e programmi internazionali, nazionali e regionali. Tra questi citiamo: l'Assemblea par-lamentare e il Comitato del patrimonio culturale del Consiglio d'Europa (CC-PAT), il Comitato per le attività del Consiglio d'Europa in materia di diversità biologica e pae-saggistica (CO-DBP), il Comitato per la tutela del patrimonio mondiale dell'Unesco, l'UICN, il Comitato delle Regioni e la Commissione europea dell'Unione europea, l'Ufficio della Strategia paneuropea per la diversità biologica e paesaggistica, non-ché le regioni Andalusia (Spagna), Languedoc-Roussillon (Francia) e Toscana (Ita-lia).
5. Vista la complessità scientifica delle tematiche e la diversità delle impostazioni giuri-diche seguite nei vari paesi, il gruppo di lavoro ha elaborato, in quanto documenti preparatori, una versione completa del progetto di convenzione in termini non giuri-dici e uno studio del diritto comparato europeo in materia di paesaggio. Tale studio è stato effettuato al fine di conoscere le situazioni giuridiche e pratiche in merito alla

160 – Firenze, 20 ottobre 2000
protezione, alla gestione e alla pianificazione del paesaggio negli Stati membri del Consiglio d'Europa.
6. Inoltre, nel corso della sua attività, il suddetto gruppo di lavoro si è costantemente riferito ai testi giuridici già esistenti in materia, a livello internazionale e nazionale. Tra tali testi, occorre citare - oltre alla Convenzione sulla tutela del patrimonio mon-diale, culturale e naturale dell'Unesco- la Convenzione per la salvaguardia del pa-trimonio architettonico d'Europa, la Convenzione sulla conservazione della vita sel-vatica e dell'ambiente naturale d'Europa, la Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico, la Raccomandazione 95 (9) del Comitato dei Ministri relati-va alla conservazione dei siti culturali integrata alle politiche riguardanti il paesaggio, la Raccomandazione (79) 9 del Comitato dei Ministri relativa alla scheda di indivi-duazione e di valutazione dei paesaggi naturali in vista della loro protezione, la Car-ta del paesaggio mediterraneo, il Regolamento delle Comunità europee sui metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze dell'ambiente e il mantenimento dello spazio naturale, la direttiva delle Comunità europee sulla conservazione degli habitat naturali, nonché della fauna e della flora selvatica, la direttiva delle Comunità europee sulla valutazione dell'impatto ambientale, nonché altri importanti testi di di-ritto nazionale, comunitario ed internazionale.
7. In considerazione delle esigenze della democrazia, come pure delle specificità, della polivalenza e della varietà dei valori e degli interessi paesaggistici di cui tener conto, il Gruppo di lavoro ha indetto a Strasburgo due audizioni specifiche, nel quadro del suo programma di consultazioni in merito al progetto di convenzione. La prima di queste, rivolta agli organismi scientifici nazionali e regionali, pubblici e privati e alle organizzazioni non governative europee interessate, si è svolta l'8 e il 9 novembre 1995 ; la seconda, svoltasi il 24 marzo 1997, era rivolta alle organizzazioni interna-zionali e alle autorità regionali europee interessate.
8. A seguito di tali audizioni, in occasione della sua 4a Sessione plenaria, che si è te-nuta a Strasburgo dal 3 al 5 giugno 1997, il Congresso ha adottato il progetto preli-minare di convenzione europea del paesaggio, contenuto nella sua Risoluzione 53 (1997). Il progetto di convenzione espresso in termini non giuridici e lo studio del di-ritto comparato europeo del paesaggio già citati sono stati presentati come allegati alla motivazione di tale risoluzione (CG (4) 6, parte II).
9. Nella stessa occasione, con la sua Raccomandazione 31 (1997), il Congresso ha chiesto all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa di esaminare il progetto preliminare di convenzione europea del paesaggio contenuto nella sua Risoluzione 53 (1997), di esprimere il proprio parere, e, se possibile, di sostenerlo. La stessa ri-chiesta di parere e di sostegno è stata rivolta dal Congresso al Comitato delle regio-ni dell'Unione europea.
10. Da notare che, prima di raccomandare al Comitato dei Ministri l'adozione della Con-venzione europea del paesaggio, il Congresso ha deciso, sempre nella sua Risolu-zione 53 (1997), di consultare i rappresentanti dei ministeri nazionali interessati. Ha pertanto incaricato il gruppo di lavoro di organizzare una conferenza di consultazio-ne rivolta a tali rappresentanti, come pure alle principali organizzazioni internazionali e non governative qualificate sotto il profilo tecnico nel campo del paesaggio.
11. Su invito del Ministero italiano per i beni culturali ed ambientali, tale importante Con-ferenza si è svolta a Firenze (Italia), dal 2 al 4 aprile 1998.
12. Grazie a questa conferenza di consultazione, il Congresso ha potuto stabilire un dialogo costruttivo con le autorità governative degli Stati membri del Consiglio d'Eu-ropa responsabili delle questioni connesse con il paesaggio. Più particolarmente, mediante questo scambio di vedute aperto ed informale tra i membri del gruppo di lavoro, affiancati dagli esperti che li hanno assistiti nella preparazione del progetto di convenzione e i rappresentanti dei ministeri preposti al paesaggio, il Congresso è stato in grado di comprendere le esigenze di questi Stati per quanto riguarda la defi-

Convenzione Europea del paesaggio - 161
nizione di norme comuni volte alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione dei loro paesaggi attraverso il diritto internazionale.
13. In base ai risultati molto incoraggianti della Conferenza di Firenze e ai pareri positivi delle istituzioni internazionali interessate in merito al progetto preliminare di conven-zione1, e in considerazione delle proposte avanzate nel corso delle succitate audi-zioni, il gruppo di lavoro ha redatto il progetto finale di convenzione europea del pa-esaggio, in vista della sua adozione da parte del Congresso nel quadro del progetto di raccomandazione presentato in occasione della sua 5a Sessione plenaria (Stra-sburgo, 26-28 maggio 1998).
14. Questo progetto di raccomandazione, adottato dal Congresso il 27 maggio 1998 (Raccomandazione 40 (1998), chiede al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa di esaminare il progetto di convenzione europea del paesaggio in vista della sua a-dozione in quanto convenzione del Consiglio d'Europa, se possibile già in occasione della campagna sul patrimonio comune decisa dai capi di Stato e di governo nel corso del loro 2° Vertice a Strasburgo nell'ottobre del 1997.
15. Tale raccomandazione ha invitato inoltre l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa a sostenere il progetto di convenzione europea del paesaggio in vista della sua adozione da parte del Comitato dei Ministri.
16. Nel corso della loro 641a riunione (15-18 settembre 1998), i Delegati dei Ministri del Consiglio d'Europa hanno esaminato la Raccomandazione 40 (1998) del CPLRE ed hanno chiesto al Comitato per le attività del Consiglio d'Europa in materia di diversi-tà biologica e paesaggistica (CO-DBP), come pure al Comitato del patrimonio cultu-rale (CC-PAT) di prendere in esame l'opportunità e la fattibilità di elaborare sotto gli auspici del Consiglio d'Europa un testo di convenzione europea del paesaggio, te-nendo conto del progetto di convenzione europea del paesaggio del CPLRE conte-nuta nella Raccomandazione n° 40 (1998).
17. Sia il CC-PAT che il CO-DBP hanno espresso un parere favorevole, rispettivamente il 17 febbraio e il 19 aprile 1999.
18. Su tale base, nel corso della sua 676a riunione (1-2 luglio 1999), il Comitato dei Mi-nistri ha deciso la creazione di un Comitato ristretto di esperti governativi incaricato della redazione della convenzione europea del paesaggio, basata sul progetto pre-parato dal Congresso. In particolare, il Comitato dei Ministri ha raccomandato al Comitato ristretto di esperti di porre un'attenzione particolare agli articoli riguardanti l'organo incaricato di controllare l'applicazione della convenzione e l'individuazione dei paesaggi di interesse europeo.
19. Il suddetto Comitato di esperti si è riunito tre volte (settembre, novembre 1999 e gennaio 2000) ed ha trasmesso un nuovo progetto di convenzione al CC-PAT e al CO-DBP nel gennaio 2000. I due comitati hanno esaminato congiuntamente il testo il 10 marzo 2000 ed hanno deciso di presentarlo per esame al Comitato dei Ministri, corredato dal rapporto della loro riunione [T-LAND (2000) 4], ai fini della sua even-tuale adozione ed apertura alla firma.
20. Sulla base dei testi contenuti nel suddetto rapporto e dei Pareri dell'Assemblea par-lamentare e del Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa, rispettivamente del 25 maggio 2000 e del 26 giugno 2000, il Segretario generale del Consiglio d'Europa ha sottoposto un progetto di Convenzione al Comitato dei Ministri per adozione. Il Comitato dei Ministri ha adottato il testo della Convenzione il 19 luglio 2000 ed ha fissato al 20 ottobre 2000 la data di apertura alla firma.

162 – Firenze, 20 ottobre 2000
II. Obiettivi e struttura della Convenzione 21. Le popolazioni europee chiedono che le politiche e gli strumenti che hanno un im-
patto sul territorio tengano conto delle loro esigenze relative alla qualità dello speci-fico ambiente di vita. Ritengono che tale qualità poggi, tra l'altro, sulla sensazione che deriva da come esse stesse percepiscono, in particolar modo visualmente, l'ambiente che le circonda, ovvero il paesaggio e hanno acquisito la consapevolezza che la qualità e la diversità di numerosi paesaggi si stanno deteriorando a causa di fattori tanto numerosi, quanto svariati e che tale fenomeno nuoce alla qualità della loro vita quotidiana.
22. Le attività degli organi pubblici in materia di paesaggio non possono più limitarsi a studi o a un'area ridotta di interventi, appannaggio esclusivo di certi enti scientifici e tecnici specializzati.
23. Il paesaggio deve diventare un tema politico di interesse generale, poiché contribui-sce in modo molto rilevante al benessere dei cittadini europei che non possono più accettare di "subire i loro paesaggi", quale risultato di evoluzioni tecniche ed eco-nomiche decise senza di loro. Il paesaggio è una questione che interessa tutti i cit-tadini e deve venir trattato in modo democratico, soprattutto a livello locale e regio-nale.
24. Il riconoscimento di un ruolo attivo dei cittadini nelle decisioni che riguardano il loro paesaggio puo' offrir loro l'occasione di meglio identificarsi con i territori e le città in cui lavorano e trascorrono i loro momenti di svago. Se si rafforzerà il rapporto dei cit-tadini con i luoghi in cui vivono, essi saranno in grado di consolidare sia le loro iden-tità, che le diversità locali e regionali, al fine di realizzarsi dal punto di vista persona-le, sociale e culturale. Tale realizzazione è alla base dello sviluppo sostenibile di qualsiasi territorio preso in esame, poiché la qualità del paesaggio costituisce un e-lemento essenziale per il successo delle iniziative economiche e sociali, siano esse private, che pubbliche.
25. L'obiettivo generale della convenzione è di obbligare i pubblici poteri ad attuare, a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, delle politiche e dei provvedi-menti atti a salvaguardare, gestire e pianificare i paesaggi d'Europa, al fine di con-servarne o di migliorarne la qualità e di far si' che le popolazioni, le istituzioni e gli enti territoriali ne riconoscano il valore e l'interesse e partecipino alle decisioni pub-bliche in merito.
26. Il campo di intervento delle politiche e dei provvedimenti qui sopra citati deve riferirsi alla totalità della dimensione paesaggistica del territorio degli Stati. A tal proposito, la convenzione si applica all'insieme del territorio europeo, che si tratti degli spazi naturali, rurali, urbani o periurbani. Non la si potrebbe limitare unicamente agli ele-menti culturali od artificiali, oppure agli elementi naturali del paesaggio: si riferisce all'insieme di tali elementi e alle relazioni esistenti tra di loro.
27. L'estensione della portata dell'azione dei pubblici poteri in materia di paesaggio al-l'insieme della dimensione paesaggistica del loro territorio nazionale non significa che si debbano applicare le stesse misure e le stesse politiche all'insieme dei pae-saggi; tali misure e politiche dovranno potersi riferire a dei paesaggi che, a seconda delle loro caratteristiche, richiederanno degli interventi locali diversificati che vanno dalla conservazione più rigorosa alla creazione vera e propria, passando per la sal-vaguardia, la gestione e la pianificazione. Tali interventi possono permettere uno sviluppo socio-economico determinante dei territori interessati.
28. La convenzione esige un atteggiamento rivolto verso il futuro da parte di tutti i prota-gonisti le cui decisioni hanno un'influenza sulla salvaguardia, la gestione o la pianifi-cazione dei paesaggi. Ha delle conseguenze in numerosi settori della politica e del-l'azione pubblica o privata, dal livello locale a quello europeo.

Convenzione Europea del paesaggio - 163
29. I paesaggi d'Europa rappresentano un interesse locale, ma ugualmente un valore per l'insieme delle popolazioni europee. Sono apprezzati oltre il loro ambito locale e oltre le frontiere nazionali. Inoltre esistono paesaggi che presentano delle caratteri-stiche comuni da entrambi i lati di una frontiera e sono allora necessarie delle misu-re transfrontaliere per attuare degli interventi. Infine, i paesaggi sono esposti alle in-fluenze, sia favorevoli, che sfavorevoli, di processi che possono essere provocati in altre zone e far sentire i loro effetti al di là delle frontiere. Per questo, è legittimo oc-cuparsi dei paesaggi a livello europeo.
30. La diversità e la qualità dei valori culturali e naturali legati ai paesaggi europei costi-tuiscono un patrimonio comune degli Stati europei, elemento che li obbliga a definire insieme i mezzi atti a garantire in modo concertato la tutela di tali valori. Soltanto una convenzione internazionale a livello del Consiglio d'Europa puo' contribuire a conseguire tale obiettivo, al fine di fornire un riferimento giuridico alle altre iniziative internazionali che operano nello stesso campo.
31. Alcuni strumenti giuridici internazionali hanno una certa incidenza sul paesaggio, sia direttamente, che indirettamente. Non esiste tuttavia uno strumento giuridico inter-nazionale che tratti in modo diretto, specifico e completo dei paesaggi europei e del-la loro tutela, malgrado il loro valore culturale e naturale inestimabile e le molteplici minacce che pesano su di loro. La convenzione è destinata a colmare tale lacuna.
32. Una convenzione internazionale costituisce uno strumento giuridico vivo, che evolve insieme all'oggetto trattato nelle sue disposizioni. E' essenziale che uno strumento giuridico internazionale mirante a tener conto dei valori e degli interessi del paesag-gio possa evolvere seguendo il carattere variabile di tali valori ed interessi.
33. La Convenzione presenta il vantaggio di applicarsi per un periodo indeterminato e di essere applicata sotto gli auspici di una organizzazione internazionale, in questo ca-so il Consiglio d'Europa. La Convenzione europea del paesaggio è considerata il complemento di strumenti giuridici internazionali, quali:
a. la Convenzione dell'Unesco sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 novembre 1972) ; b. la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla conservazione della vita selva-tica e dell'ambiente naturale d'Europa (Berna, 19 settembre 1979) ; c. la Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (Granada, 3 ottobre 1985); d. la Convenzione del Consiglio d'Europa per la tutela del patrimonio archeolo-gico (rivista) (La Valletta, 16 gennaio 1992) ; e di iniziative internazionali, quali la Strategia paneuropea della diversità biolo-gica e paesaggistica (Sofia, 25 ottobre 1995). La Convenzione europea del pa-esaggio deve consentire di stabilire dei legami formali, se del caso, tra i mec-canismi della convenzione stessa e tutti questi altri strumenti o iniziative.
34. La Convenzione europea del paesaggio lascia alle Parti la scelta dei mezzi da atti-vare nei loro ordinamenti giuridici interni per soddisfare gli obblighi che ne derivano. Gli strumenti giuridici, amministrativi, fiscali e finanziari messi in atto in ogni paese per applicare la convenzione devono inserirsi nel modo più armonioso possibile nel-le tradizioni nazionali. Inoltre, in virtù del principio di sussidiarietà, la responsabilità dei provvedimenti a favore del paesaggio spetta anche ai pubblici poteri del livello locale e regionale, e non unicamente a quelli del livello nazionale ed internazionale.
35. Il testo della Convenzione europea del paesaggio consiste in un preambolo e in quattro parti principali: a. il capitolo I, che definisce gli obiettivi e il campo d'applicazione della conven-
zione, nonché i suoi termini-chiave; b. il capitolo II, che elenca i provvedimenti da prendere a livello nazionale;

164 – Firenze, 20 ottobre 2000
c. il capitolo III, che precisa i fondamenti della cooperazione europea e le misure da prendere a livello internazionale, come pure il ruolo dei Comitati responsabili del controllo dell'applicazione della Convenzione;
d. il capitolo IV, che tratta delle procedure per l'adozione della convenzione e del-le questioni connesse.
III. Commenti sulle disposizioni della Convenzione
Preambolo
36. Il preambolo della Convenzione mira a sottolineare le poste in gioco che sono alla
base della Convenzione europea del paesaggio, ponendo in rilievo i punti enunciati qui appresso. La convenzione si inserisce nel contesto dei lavori del Consiglio d'Eu-ropa nel campo del patrimonio naturale e culturale, dell'assetto territoriale, dell'am-biente e dell'autonomia locale. La preoccupazione dello sviluppo sostenibile enunciata alla Conferenza di Rio del 1992 accorda al paesaggio un posto essenziale in quanto fattore di equilibrio tra pa-trimonio naturale e culturale, riflesso dell'identità e della diversità europea e una ri-sorsa economica creatrice di posti di lavoro e legata allo sviluppo di un turismo so-stenibile. Il paesaggio svolge un ruolo importante in quanto elemento dell'ambiente e del con-testo di vita delle popolazioni, sia nelle aree urbane, che rurali e sia per i paesaggi con caratteristiche eccezionali, che per quelli della vita quotidiana. Per questo, le popolazioni sono invitate a svolgere un ruolo attivo nella sua gestione e nella sua pianificazione e devono sentirsi responsabili del loro futuro. Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, desiderosi di promuovere gli ideali che rap-presentano il loro patrimonio comune mediante accordi internazionali, dispongono quindi, con il paesaggio, di un bene prezioso da mantenere e da gestire mediante una cooperazione internazionale effettiva ed organizzata nel quadro di uno strumen-to giuridico esclusivamente dedicato al paesaggio.
CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Definizioni
37. L'articolo dà la definizione di una serie di termini utilizzati nella convenzione, al fine di garantire la loro interpretazione uniforme da parte di tutti coloro che intendono a-doperarsi a favore dello stato dei paesaggi europei.
38. Il termine " paesaggio " viene definito come una zona o un territorio, quale viene percepito dagli abitanti del luogo o dai visitatori, il cui aspetto e carattere derivano dall'azione di fattori naturali e/o culturali (ossia antropici). Tale definizione tiene con-to dell'idea che i paesaggi evolvono col tempo, per l'effetto di forze naturali e per l'a-zione degli esseri umani. Sottolinea ugualmente l'idea che il paesaggio forma un tut-to, i cui elementi naturali e culturali vengono considerati simultaneamente.
39. I termini " politica del paesaggio " e" obiettivo di qualità paesaggistica " indicano le fasi della strategia che gli Stati devono mettere a punto in due tappe:
1. la " politica del paesaggio " è l'espressione della consapevolezza, da parte dei pubblici poteri, della necessità di enunciare una politica pubblica in materia di paesaggio. Consisterà nel formulare degli orientamenti fonda-mentali, dei principi generali e delle scelte strategiche che serviranno da guida alle decisioni relative alla salvaguardia, alla gestione e alla pianifi-cazione del paesaggio;

Convenzione Europea del paesaggio - 165
2. un " obiettivo di qualità paesaggistica" consiste, per un determinato pae-saggio, dopo che è stato individuato e valutato, nell'indicazione dettagliata delle caratteristiche che le popolazioni locali interessate aspirano a veder riconosciute per il loro ambiente di vita.
40. L'articolo 1 contiene poi delle definizioni relative a tre espressioni che si ritrovano frequentemente nella convenzione, ossia " salvaguardia ", " gestione " e " pianifica-zione " dei paesaggi, che sono dei principi di azione sul paesaggio previsti in modo dinamico e prospettivo.
" Salvaguardia dei paesaggi " riguarda i provvedimenti presi allo scopo di pre-servare il carattere e la qualità di un determinato paesaggio al quale le popola-zioni accordano un grande valore, che sia per la sua configurazione naturale o culturale particolare. Tale salvaguardia deve essere attiva ed accompagnata da misure di conservazione per mantenere gli aspetti significativi di un paesaggio. " Gestione dei paesaggi " riguarda i provvedimenti presi conformemente al principio dello sviluppo sostenibile per accompagnare le trasformazioni provo-cate dalle esigenze economiche, sociali o ambientali. Tali provvedimenti po-tranno riguardare l'organizzazione dei paesaggi o gli elementi che li compon-gono. Mirano a garantire la cura costante di un paesaggio e a vigilare affinché evolva in modo armonioso, allo scopo di soddisfare i fabbisogni economici e sociali. La gestione dovrà essere dinamica e dovrà tendere a migliorare la qua-lità dei paesaggi in funzione delle aspirazioni delle popolazioni. " Pianificazione dei paesaggi " riguarda il processo formale di studio, di proget-tazione e di costruzione mediante il quale vengono creati nuovi paesaggi per soddisfare le aspirazioni della popolazione interessata. Occorre elaborare au-tentici progetti di pianificazione, soprattutto nelle aree maggiormente colpite dal cambiamento e fortemente deteriorate (periferie, zone periurbane ed industriali, litorali). Tali progetti di pianificazione si pongono come obiettivo la radicale ri-strutturazione dei paesaggi degradati.
41. In ogni zona paesaggistica, l'equilibrio tra questi tre tipi di attività dipenderà dal ca-rattere della zona e dagli obiettivi definiti per il suo futuro paesaggio. Certe zone possono richiedere una protezione molto rigorosa. Invece, possono esistere delle zone il cui paesaggio estremamente rovinato richiede di venir completamente ristrut-turato. Per la maggior parte dei paesaggi, si rende necessario l'insieme delle tre ti-pologie di intervento, mentre altri richiedono uno specifico grado di intervento.
42. Nella ricerca di un buon equilibrio tra la protezione, la gestione e la pianificazione di un paesaggio, occorre ricordare che non si cerca di preservare o di "congelare" dei paesaggi ad un determinato stadio della loro lunga evoluzione. I paesaggi hanno sempre subito mutamenti e continueranno a cambiare, sia per effetto dei processi naturali, che dell'azione dell'uomo. In realtà, l'obiettivo da perseguire dovrebbe esse-re quello di accompagnare i cambiamenti futuri riconoscendo la grande diversità e la qualità dei paesaggi che abbiamo ereditato dal passato, sforzandoci di preservare, o ancor meglio, di arricchire tale diversità e tale qualità invece di lasciarle andare in rovina.
Articolo 2 - Campo di applicazione
43. L'articolo precisa che la convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti e riguar-da gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Riguarda tanto il paesaggio terrestre, che acquatico e concerne le acque interne (laghi, stagni), come pure le aree marit-time (acque costiere, mare territoriale).
44. La riserva dell'articolo 15 si riferisce alla facoltà lasciata a certi Stati, per ragioni co-stituzionali, di non applicare automaticamente un trattato internazionale ratificato ad alcuni dei loro territori, in particolar modo quelli di oltremare (si veda il commento re-lativo all'articolo 15).

166 – Firenze, 20 ottobre 2000
45. L'originalità della Convenzione risiede nella sua applicazione tanto ai paesaggi ordi-nari, che a quelli eccezionali, poiché sono tutti determinanti per la qualità dell'ambito di vita delle popolazioni in Europa. Comprende in tal modo i paesaggi della vita quo-tidiana, quelli eccezionali o degradati. Un campo d'applicazione cosi' vasto è giustifi-cato dalle seguenti ragioni: ogni paesaggio costituisce un ambito di vita per la popo-lazione che vi risiede; esistono delle interconnessioni complesse tra i paesaggi ur-bani e rurali; la maggior parte degli Europei vive nelle città (grandi e piccole), la cui qualità paesaggistica ha un'enorme influenza sulla loro esistenza; infine, i paesaggi rurali occupano un posto importante nella sensibilità europea. Altro motivo che giu-stifica questo vasto campo di applicazione sono le profonde modifiche che subisco-no attualmente i paesaggi europei, in particolar modo quelli periurbani.
Articolo 3 – Obiettivi
46. L'articolo enuncia l'obiettivo della convenzione, che è quello di garantire la protezio-
ne, la gestione e la pianificazione dei paesaggi europei mediante l'adozione di prov-vedimenti nazionali e l'attuazione di una cooperazione europea tra le Parti.
47. Il capitolo II (articoli 4-6) e il capitolo III (articoli 7-11) della convenzione trattano dei provvedimenti nazionali e della cooperazione europea.
CAPITOLO II - PROVVEDIMENTI NAZIONALI
Articolo 4 - Ripartizione delle competenze
48. Ai sensi di questo articolo, ogni Parte contraente dovrà applicare la convenzione al
livello amministrativo meglio appropriato per l'adozione di misure riguardanti il pae-saggio, tenendo conto del principio di sussidiarietà e della Carta europea dell'auto-nomia locale. Ne consegue che, quando necessario, gli enti locali e regionali, come pure i loro consorzi devono avere la garanzia di essere chiamati a partecipare in modo ufficiale al processo di applicazione.
49. Nei casi in cui le autorità locali e regionali dispongano delle competenze necessarie, la protezione, la gestione e la pianificazione dei paesaggi risulteranno maggiormen-te efficaci se la responsabilità della loro messa in atto verrà affidata - nel quadro co-stituzionale legislativo previsto a livello nazionale - alle autorità più vicine alla popo-lazione interessata. Ogni Stato deve definire precisamente i compiti e le misure che vengono affidati ad ogni livello (nazionale, regionale o locale) e stabilire delle norme per il coordinamento di tali provvedimenti tra i vari livelli, segnatamente per quanto riguarda gli strumenti relativi all'urbanistica e alla pianificazione territoriale.
Articolo 5 - Provvedimenti generali
50. L'articolo determina i provvedimenti necessari per l'applicazione della convenzione
in ogni Stato firmatario. Si tratta dei seguenti provvedimenti: a. riconoscere giuridicamente il paesaggio, in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio, naturale, culturale, ambientale e socio-economico e fondamento delle loro identità locali. Vale la pena di notare che numerosi Stati europei già fanno dei riferimenti al paesaggio nella loro costituzione o nella loro legislazione sul patrimonio naturale o culturale, oppure sull'ambiente; b. formulare ed attuare delle politiche volte alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione dei paesaggi, nel rispetto delle disposizioni della convenzione, adottando le misure particolari previste all'articolo 6;

Convenzione Europea del paesaggio - 167
c. avviare delle procedure per la partecipazione delle popolazioni, degli enti locali e regionali e degli altri soggetti interessati, ai fini di definire ed attuare le suddette politi-che. Il paesaggio è un elemento che interessa l'insieme della popolazione: la cura del paesaggio richiede un partenariato tra una nutrita schiera di individui e di organizzazioni; d. tener conto sistematicamente del paesaggio nelle politiche nazionali in materia di pianificazione territoriale e di urbanistica, nelle politiche culturali, ambientali, agricole, socioeconomiche, come pure nelle altre politiche settoriali suscettibili di avere un'inciden-za, diretta od indiretta, sul paesaggio, cosi' come per esempio i trasporti. Alla base di questa disposizione c'è l'idea che il paesaggio non è un tema da prendere in esame in quanto settore specializzato di competenza degli affari. pubblici Il paesaggio può subire influenze positive o negative esercitate da interventi plurisettoriali. Ne deriva la necessità per i governi di vigilare affinché gli obiettivi connessi con il paesaggio siano presi in con-siderazione in tutti i settori pertinenti della vita pubblica.
Articolo 6 - Misure specifiche
51. L'articolo si riferisce alle misure specifiche che le Parti dovranno prendere a livello
nazionale, regionale o locale.
Paragrafo A – Sensibilizzazione 52. Il paragrafo tratta della questione chiave della sensibilizzazione. Il paesaggio appar-
tiene in parte ad ogni cittadino, che ha il dovere di averne cura. Ne deriva che la buona condizione dei paesaggi è strettamente connessa al livello di sensibilizzazio-ne delle popolazioni. In tale prospettiva dovrebbero essere indette delle campagne di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini, dei rappresentanti eletti e delle associazioni sul valore dei paesaggi di oggi e di domani. Paragrafo B - Formazione ed educazione
53. La salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi possono rivelarsi una questione complessa che coinvolge molteplici enti pubblici e privati e che comporta lavori pluridisciplinari di competenza di varie professioni. Le Parti sono pertanto invi-tate: a realizzare una formazione di livello elevato per gli specialisti nel settore della co-noscenza e degli interventi sui paesaggi; a promuovere dei programmi pluridisciplinari di formazione alle questioni connesse con il paesaggio per gli amministratori eletti e il personale tecnico delle autorità loca-li, regionali e nazionali e degli altri enti pubblici o privati interessati. Obiettivo di tali sforzi è il miglioramento delle competenze tecniche degli enti responsabili del pae-saggio. Tali enti possono essere per esempio delle organizzazioni di categoria inca-ricate della pianificazione territoriale, dell'ambiente e della gestione del patrimonio, interessate all'utilizzo delle terre ai fini dell'agricoltura, del turismo o dell'industria, oppure essere coinvolte nei lavori di edilizia e della costruzione di infrastrutture; a sviluppare degli insegnamenti scolastici ed universitari che trattino, nelle discipline interessate, dei valori legati al paesaggio e delle questioni relative alla sua salva-guardia, alla sua gestione e alla sua pianificazione, in modo che i giovani acquisi-scano la consapevolezza dei problemi connessi con il contesto nel quale vivono.
Paragrafo C - Individuazione e valutazione
54. Il paragrafo espone la natura dei lavori necessari per individuare e valutare i pae-
saggi, al fine di far poggiare su solide basi un'azione sul lungo periodo, volta a tute-

168 – Firenze, 20 ottobre 2000
larne e a migliorarne la qualità. Tale azione deve essere sostenuta da una cono-scenza approfondita delle particolarità di ogni paesaggio, del suo processo di evolu-zione e del valore che la popolazione interessata gli accorda. La valutazione potreb-be venir effettuata senza che si proceda necessariamente a stabilire una scala pre-cisa di valori.
55. Il sottoparagrafo C 1 a impegna le Parti ad intraprendere delle ricerche e degli studi finalizzati ad individuare i paesaggi e ad analizzarne le particolarità, come pure le dinamiche e le pressioni che li modificano. Alcuni paesi hanno effettuato a livello na-zionale un lavoro di esame e di censimento dei loro paesaggi. Tale lavoro ha rivela-to il carattere specifico dei paesaggi delle varie zone, poiché ciascuno possiede la propria combinazione di elementi naturali ed antropici. Sistemi informativi territoriali e moderne tecniche di cartografia informatizzata, anche a livello urbano, vengono impiegate per evidenziare le specificità di un paesaggio (suoi rilievi, schema del suo popolamento, principali utilizzazioni del suolo, attività economiche, zone residenziali, presenza o assenza di caratteristiche quali siepi o terrazzi, testimonianze delle attivi-tà umane del passato o ad habitat per delle specie selvatiche, ecc.).
56. Tale lavoro effettuato sul campo da professionisti deve obbligatoriamente rendere partecipi le comunità locali , i cittadini e i vari soggetti interessati mediante indagini e riunioni di informazione.
57. Il sottoparagrafo C 1 b impegna le Parti a stabilire la qualità dei paesaggi cosi' indi-viduati, tenendo conto del valore specifico loro attribuito dai cittadini e dai soggetti interessati, per esempio i proprietari fondiari o quelli che intervengono nel loro utiliz-zo e nella loro gestione. Obiettivo di tale valutazione è quello di fornire una base che consenta di determinare quali elementi, nel paesaggio di una zona determinata, so-no preziosi al punto da doverli proteggere, quali caratteristiche richiedono una ge-stione volta a preservare la qualità del paesaggio e quali elementi o quali zone meri-tano che se ne preveda la valorizzazione. E' un processo che deve tener conto del parere della popolazione interessata e degli interessi legati alle politiche settoriali; si tratta di punti di vista che possono rivelarsi estremamente vari e soggettivi. Per que-sto sarebbe forse saggio cominciare la valutazione basandosi su dei criteri obiettivi, e poi raffrontare i risultati con i diversi valori che la popolazione attribuisce al pae-saggio e ad interessi di altro tipo. Se del caso, tale confronto potrebbe essere ogget-to di un'indagine pubblica nell'ambito della quale i soggetti interessati potrebbero esprimere il loro parere. La partecipazione dei cittadini a questo tipo di processo po-trebbe venir incoraggiata mediante l'informazione del pubblico, la consultazione di tutti gli enti rappresentativi o ricorrendo ai mass media e alle campagne di sensibi-lizzazione condotte a tutti i livelli.
58. Il sottoparagrafo C 2 ricorda a tal proposito quanto puo' apportare lo scambio inter-nazionale di esperienze e di idee, previsto agli articoli successivi. Non esiste nessun metodo riconosciuto da tutti per studiare, individuare e valutare i paesaggi; esiste pero' tutto un insieme molto importante di conoscenze, di cui occorrerebbe avvaler-si. La cooperazione internazionale dovrà incoraggiare i paesi a prendere i provvedi-menti; garantirà che vengano accomunate le esperienze sui paesaggi e sul loro va-lore, come pure i problemi e le politiche attuali, consentirà infine di stabilire quali pa-esaggi o quali problemi meriterebbero un'attenzione internazionale.
Paragrafo D - Obiettivi di qualità paesaggistica
59. Il paragrafo impegna le Parti a definire per i paesaggi individuati e valutati degli o-
biettivi di qualità paesaggistica, mediante la consultazione della popolazione inte-ressata. Prima di adottare qualsiasi provvedimento di salvaguardia, gestione e piani-ficazione di un paesaggio, è essenziale dare al pubblico una definizione chiara degli obiettivi che si vogliono conseguire. Gli obiettivi devono essere definiti, presentati e

Convenzione Europea del paesaggio - 169
pubblicati dall'autorità competente, previa consultazione del pubblico e tenendo con-to di tutti gli interessi in gioco. Gli obiettivi possono essere stabiliti nell'ambito più generale di una politica condotta dagli enti territoriali o centrali interessati. La defini-zione degli obiettivi deve esporre in maniera chiara le caratteristiche e le qualità par-ticolari del paesaggio preso in esame, l'idea generale della politica relativa a detto paesaggio, gli elementi specifici del paesaggio interessati dalle misure di salvaguar-dia, di gestione o di pianificazione e deve quindi indicare quali sono gli strumenti che si intende utilizzare per conseguire gli obiettivi prefissati.
60. Deve apparire una chiara relazione tra gli obiettivi, i risultati delle analisi di indivi-duazione e di valutazione e i provvedimenti giudicati necessari per conseguire tali obiettivi.
Paragrafo E – Applicazione
61. Il paragrafo invita le Parti ad adottare gli strumenti legislativi, amministrativi, fiscali o
finanziari specifici per la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi, tenendo conto delle politiche sul paesaggio convenute. Tali strumenti possono esse-re svariati. Possono consistere nell'elaborazione di strumenti di pianificazione a va-lenza paesistica, di progetti sul paesaggio, nel regime speciale per certi paesaggi, nella presa in considerazione dei paesaggi negli studi di impatto e nelle autorizza-zioni alle attività o all'occupazione dei suoli, in misure urgenti per salvaguardare un determinato paesaggio minacciato, ecc. Spetta ad ogni Stato elaborare e adottare una serie di strumenti atti a soddisfare le esigenze dei propri paesaggi e conformi al suo ordinamento giuridico. I Comitati di esperti competenti di cui all'articolo 10 della convenzione potranno formulare delle raccomandazioni per agevolare l'applicazione della convenzione.
CAPITOLO III - COOPERAZIONE EUROPEA
Articolo 7 - Politiche e programmi internazionali
62. La convenzione dovrebbe stimolare una maggiore presa in considerazione del pae-
saggio presso i diversi organismi internazionali come pure nei programmi interna-zionali. A tal scopo, le Parti specialmente sensibilizzate al problema del paesaggio dovrebbero svolgere un ruolo attivo, coordinando le loro riflessioni e le loro proposte in seno ai Comitati di esperti competenti di cui all'articolo 10 della Convenzione. Il Consiglio d'Europa dovrebbe inoltre organizzare una cooperazione particolare sul tema del paesaggio, in collaborazione con altri organismi internazionali, governative, in particolare l'Unesco, l'Unione europea e l'IUCN, e altre organizzazioni non gover-native.
Articolo 8 - Assistenza reciproca e scambio di informazioni
63. Per facilitare l' applicazione della convenzione e rafforzarne l'efficacia, le Parti si im-
pegnano a cooperare tra di loro in tre settori: la reciproca assistenza tecnica e scientifica mediante lo scambio di esperienze e di lavori di ricerca in materia di paesaggio; gli scambi di specialisti del paesaggio, segnatamente al fine della formazione e del-l'informazione; lo scambio di informazioni su tutte le questioni trattate nelle disposizioni della con-venzione.

170 – Firenze, 20 ottobre 2000
64. In questi ultimi anni, si è potuto constatare un notevole aumento dell'interesse - poli-tico, professionale ed accademico - suscitato dalle questioni relative al paesaggio, da cui deriva lo sviluppo di tutto un insieme di esperienze e di competenze alle quali possono ispirarsi gli Stati membri, gli enti locali e regionali e gli altri soggetti per l'ap-plicazione della convenzione. Nel contempo, i mezzi disponibili per questo scambio di idee, - e per gli aspetti tecnici dello studio paesaggistico- sono stati radicalmente migliorati grazie al progresso delle comunicazioni elettroniche e all'arrivo di Internet. Tale evoluzione consente di portare avanti su una base molto più ampia rispetto sol-tanto ad una decina di anni fa lo scambio di idee e l'assistenza reciproca; in tal mo-do, in tutta Europa, i soggetti locali possono partecipare a questo scambio che con-sente di instaurare un'autentica "democrazia del paesaggio".
Articolo 9 - Paesaggi transfrontalieri
65. L'articolo impegna le Parti a mettere a punto dei programmi transfrontalieri per l'indi-
viduazione, la valutazione, la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei pae-saggi transfrontalieri. Nell'elaborare tali programmi, nel rispetto del principio di sus-sidiarità quale definito dalla Carta europea dell'autonomia locale, le Parti sono invita-te ad avvalersi del sostegno degli enti locali e regionali, utilizzando come strumenti di realizzazione quelli raccomandati dalla Convenzione-quadro europea del 21 maggio 1980 sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoria-li, e i suoi protocolli addizionali.
Articolo 10 - Controllo dell'applicazione della convenzione
66. E' emerso che gli obiettivi della convenzione sarebbero raggiunti più facilmente se i
rappresentanti delle Parti avessero la possibilità di incontrarsi regolarmente per met-tere a punto dei programmi comuni e coordinati e garantire in modo congiunto il con-trollo dell'applicazione della convenzione.
67. A tal proposito, è stato considerato che il Consiglio d'Europa rappresenta il quadro ideale, poiché dispone di strutture competenti nell'ambito delle quali tutte le Parti contraenti della convenzione possono farsi rappresentare.
68. Visto il carattere pluridisciplinare della nozione e delle attività legate al paesaggio, il controllo dell'applicazione della convenzione potrà quindi essere affidato al Comitato per le attività del Consiglio d'Europa in materia di diversità biologica e paesaggistica (CO-DBP) e al Comitato del patrimonio culturale (CC-PAT) che, nell'ambito del Con-siglio d'Europa, operano nel campo di attività trattate nelle disposizioni della con-venzione e hanno un accesso diretto al Comitato dei Ministri. Per svolgere tale compito, questi comitati potranno riunirsi congiuntamente in modo che la convenzio-ne possa avvalersi di un forum di discussione appropriato. L'Assemblea parlamenta-re e il Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa (CPLRE) saranno associati ai lavori dei suddetti comitati sul tema della convenzione.
69. Considerando le crescenti responsabilità delle autorità locali e regionali nel campo della salvaguardia, della gestione e della pianificazione dei paesaggi, il Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa (CPLRE), l'organo rappresentativo di tali autori-tà in seno al Consiglio d'Europa, potrà indirizzare dei pareri al Comitato dei Ministri circa i rapporti predisposti dall'istanza del Consiglio d'Europa incaricata del controllo dell'applicazione della convenzione, in base all'articolo 2, capoverso 2 della Risolu-zione statutaria (2000) 1.
70. Nello stesso spirito, il CPLRE è chiamato a partecipare attivamente alle iniziative intraprese nell'ambito del controllo e ad esprimere il proprio parere sui criteri seguiti

Convenzione Europea del paesaggio - 171
per l'assegnazione del Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa previsto dall'ar-ticolo 11.
Articolo 11 - Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa
71. L'articolo prevede che il Comitato dei Ministri, su proposta dei Comitati di esperti
competenti di cui all'articolo 10 della convenzione, e dopo aver preso in considera-zione il parere del Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa, assegnerà il Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa ad un ente locale o regionale, a un consorzio di tali enti (all'interno di un solo paese o su base transfrontaliera) e a delle organizzazioni non governative che abbiano attuato una politica o delle misure rela-tive alla salvaguardia, la gestione e/o la pianificazione dei paesaggi che dimostrino un'efficacia durevole e possano servire da esempio alle altre collettività attraverso l'Europa.
72. Tale premio si prefigge lo scopo di stimolare un processo che gli Stati potrebbero innescare in tutta Europa per incoraggiare e riconoscere una gestione esemplare dei paesaggi. Il Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa potrebbe in tal modo venir a completare un processo gestito a livello nazionale e comprendente eventualmente l'organizzazione di concorsi nazionali analoghi e un sostegno finanziario alle colletti-vità locali e regionali interessate.
73. Il paragrafo 1 indica che le autorità locali e regionali, i loro consorzi, le organizzazio-ni non governative possono presentare la loro candidatura per partecipare al con-corso per il premio del paesaggio attraverso il loro Stato membro. Lo Stato Parte della convenzione potrà in tal modo valutare le candidature, eventualmente median-te un concorso nazionale che potrebbe prevedere dei premi o delle ricompense, e presentare ai Comitati di esperti competenti il vincitore nazionale, oppure un numero limitato di candidati per l'assegnazione del premio.
74. I paragrafi 2 e 3 autorizzano i Comitati di esperti competenti a definire e a pubblicare i criteri secondo i quali verranno valutati i candidati al premio e a ricevere le propo-ste da parte degli Stati. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa conferisce il premio.
75. Il paragrafo 4 predispone che i titolari del premio vengano invitati a garantire in mo-do durevole la salvaguardia , la gestione e la pianificazione dei paesaggi considera-ti.
CAPITOLO IV - CLAUSOLE FINALI
76. Tranne poche eccezioni, le clausole finali si basano sul modello delle clausole finali
delle convenzioni e degli accordi stipulati in seno al Consiglio d'Europa, modello ap-provato dal Comitato dei Ministri alla 315a riunione a livello dei Delegati, nel febbraio 1980. La maggior parte degli articoli non richiede quindi delle osservazioni particola-ri, ma meritano una spiegazione i punti seguenti.

172 – Firenze, 20 ottobre 2000
Articolo 12 - Relazioni con altri strumenti giuridici
77. La redazione di questo articolo si ispira alle disposizioni tipo già adottate per altre convenzioni internazionali, per risolvere il problema dell'articolazione tra convenzioni che intervengono in settori simili.
78. La presente convenzione si distingue sia sul piano formale, che su quello sostanzia-le dalla Convenzione sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale del-l'Unesco del 16 novembre 1972. Hanno vocazioni distinte, al pari delle due organiz-zazioni sotto i cui auspici sono state elaborate. Una è a vocazione regionale, l'altra mondiale. La convenzione del Consiglio d'Europa appare come complementare di quella dell'Unesco. Sul piano sostanziale, la convenzione del Consiglio d'Europa raggruppa tutti i paesaggi, anche quelli che non hanno un valore universale ecce-zionale, ma non comprende i monumenti del patrimonio culturale, a differenza del testo dell'Unesco. Parimenti, il suo obiettivo principale non è quello di stabilire un e-lenco di beni che presentano un interesse eccezionale ed universale, bensi' di stabi-lire un regime di salvaguardia, di gestione e di pianificazione di tutti i paesaggi sulla base di una serie di principi. Ognuno dei due testi possiede pertanto la propria spe-cificità. Per coordinare l'azione complementare delle due convenzioni, si potrebbe prevedere una cooperazione scientifica tra il Comitato del patrimonio mondiale del-l'Unesco e i Comitati di esperti di cui all'articolo 10 della Convenzione europea del paesaggio, mediante un accordo tra l'Unesco e il Consiglio d'Europa, in applicazione dell'articolo 13.7 della Convenzione dell'Unesco del 16 novembre 1972 e in base al suggerimento contenuto all'articolo 7 della presente convenzione.
79. L'articolo 12 della convenzione europea del paesaggio intende prevenire delle even-tuali difficoltà con altri strumenti giuridici internazionali, precisando che non preclude l'applicazione di disposizioni più rigorose e più favorevoli eventualmentecontenute nei suddetti strumenti.
Articolo 13 - Firma, ratifica, entrata in vigore
80. La convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la ratifica da parte di dieci Stati
membri del Consiglio d'Europa.
Articolo 15 - Applicazione territoriale
81. Si tratta di una disposizione che interessa unicamente dei territori con statuto parti-colare, quali i territori d'oltremare, oppure le isole Feroe e la Groenlandia per la Da-nimarca, o Gibilterra, l'isola di Man, di Jersey e di Guernesey per il Regno Unito.
82. E' stato chiaramente convenuto che sarebbe contrario all'oggetto e allo scopo della convenzione il fatto che una Parte possa escludere dall'applicazione di questo stru-mento delle parti del suo territorio metropolitano e che non era necessario esplicitare questo aspetto nella convenzione.
Articolo 17 - Emendamenti
83. Gli emendamenti possono consentire di adattare o di migliorare la convenzione. I
comitati menzionati all'articolo 10 della convenzione possono preparare gli emen-damenti ed esaminare quelli che vengono proposti dalle Parti. Gli emendamenti vengono adottati dal Comitato dei Ministri a maggioranza dei tre quarti dei voti e-spressi, e poi accettati dalle Parti. Entrano in vigore tre mesi dopo la loro accettazio-ne da tre Stati Parti firmatari membri del Consiglio d'Europa.

Accordo MiBAC, RER, Autonomie locali - 173
Accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali,la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni delleautonomie locali Emilia-Romagna(AI SENSI DELL’ART. 46 DELLA LEGGE REGIONALE 25NOVEMBRE 2002, N. 31)Roma, 9 Ottobre 2003
Il Ministero per i beni e le attività culturaliLa Regione Emilia-RomagnaLe Associazioni delle Autonomie Locali
Visti:
− l’art. 9 della Costituzione;
− il decreto legislativo 31 ottobre 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni ecompiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo Idella legge 15 marzo 1997, n. 59”;
− il decreto legislativo 24 ottobre 1999, n. 490, recante “Testo unico delle disposizionilegislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge8 ottobre 1997, n. 352”, la quale, al titolo II, dispone la disciplina dei beni paesaggi-stici e ambientali;
− la Convenzione Europea del paesaggio, firmata a Firenze in data 20 ottobre 2000;
− l’Accordo tra il Ministro per i beni e le attività culturali, le Regioni e le Province auto-nome di Trento e Bolzano in materia di paesaggio, siglato dalla Conferenza perma-nente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano indata 19 aprile 2001;
− la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “Modifiche al titolo V parte se-conda della Costituzione”;
Vista la disciplina normativa disposta in materia di tutela del paesaggio dalla RegioneEmilia-Romagna con le leggi regionali e i provvedimenti qui di seguito elencati:
− la legge regionale 1 agosto 1978, n. 26, recante “Modificazioni ed integrazioni allalegge regionale 24 marzo 1975, n. 18, in materia urbanistica – Norme in materiaambientale”, così come modificata dalla legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6;

174 – Roma, 9 ottobre 2003
− la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, recante “Disciplina generale sulla tutela e
l’uso del territorio”;
− la legge regionale 15 luglio 2002, n. 16, recante “Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del terri-torio”;
− la legge regionale 25 novembre 2002, n. 31, recante “Disciplina generale dell’edilizia”;
− la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), e le deliberazioni regionali di approvazione dei Piani Territoriali di Coor-dinamento Provinciale (P.T.C.P.) e delle loro varianti, con i quali sono state attuate e specificate le previsioni dello stesso P.T.P.R;
Premesso che:
− la l. r. n. 31/02 all’art. 46 prevede che la Regione promuova la conclusione di un ac-
cordo con il Ministero per i beni e le attività culturali e le Associazioni delle autono-mie locali finalizzato alla puntuale definizione di:
-criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche; -criteri e modalità per l’apposizione e la modifica dei vincoli paesaggistici;
− l’Accordo dovrà prevedere inoltre:
-le modalità di cooperazione nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla ge-stione dei vincoli; -specifiche forme di iniziativa e di raccordo ai fini dell'esercizio del potere di annullamento per vizi di legittimità delle autorizzazioni paesaggistiche; -le modalità di attività formativa nei confronti dei tecnici e professionisti pre-posti alle valutazioni e al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;
− l’attività prevista dalla norma regionale rappresenta un passo importante verso un nuovo rapporto di collaborazione tra gli Enti realizzato sul presupposto della condivi-sione e del pieno riconoscimento dei principi sui quali si basa la tutela del paesag-gio, e che trova il proprio fondamento giuridico nell’art. 9 Cost., a norma del quale la tutela del paesaggio, elevata a principio costituzionale dell’ordinamento, deve esse-re attuata da parte di tutti gli Enti che istituzionalmente fanno parte della Repubblica;
− la modifica apportata al Titolo V, Parte II, della Costituzione da parte della l.cost. n. 3/01 ha sancito un nuovo e diverso equilibrio tra gli Enti istituzionali, riconoscendone la pari dignità e rafforzando in tal modo la necessità di trovare forme di collaborazio-ne tra loro, anche al fine di realizzare il principio costituzionale della tutela del pae-

Accordo MiBAC, RER, Autonomie locali - 175
saggio, nell’osservanza dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione;
− l’evoluzione culturale e normativa degli ultimi anni ha originato concezioni diverse inmateria paesistica, in particolare in relazione alla necessità di pervenire alla integra-zione delle competenze e degli strumenti di tutela, al fine di superare l’episodicità ela frammentarietà della tutela realizzata solo in fase di valutazione del singolo inter-vento di trasformazione e non basata su una programmata e pianificata protezionedel territorio;
− parte importante in questo processo di modificazione della concezione del paesag-gio e dell’attuazione della sua tutela ha avuto la Convenzione Europea del Paesag-gio, che ha imposto un diverso approccio in materia, tale da estendere il riconosci-mento giuridico di valenza paesistica a tutto il territorio, senza alcuna distinzione traciò che deve essere conservato e ciò che può essere indifferentemente trasformato;
− inoltre, la Convenzione ritiene fondamentale la partecipazione e la sensibilizzazionedelle comunità locali alla definizione e realizzazione delle politiche paesaggistichebasate sul riconoscimento del valore dei paesaggi, in quanto parte essenziale del lo-ro ambiente di vita, espressione della diversità del comune patrimonio culturale enaturale e fondamento della loro identità;
− infine, la Convenzione europea sollecita l’integrazione sistematica del paesaggionelle politiche di pianificazione territoriale e urbanistiche e di tutte le altre politichecomunque capaci di incidere, positivamente o negativamente, sulle condizioni pae-saggistiche-ambientali e sulla fruibilità del territorio;
− tale diversa impostazione della tutela del territorio conferma le scelte già realizzatedalla Regione Emilia-Romagna con il P.T.P.R. e i piani che ne hanno dato attuazio-ne, oltre che con la attività normativa che ha contribuito a realizzare un sistema ditutela e di valorizzazione differenziata in relazione alle specificità territoriali;
Ritenuto, alla luce di tutto quanto sopra detto, che:
− i ruoli della Regione e delle Soprintendenze devono conseguire un carattere unitarioe sinergico, così da coinvolgere Comuni e Province in un processo di riconosci-mento condiviso dei valori che conduca al miglioramento della qualità paesaggistica,alla riqualificazione ambientale del territorio regionale e al rafforzamento delle iden-tità dei luoghi;
− in tale contesto, i Comuni, quali enti attuatori delle politiche regionali e provinciali,pur nel rispetto della propria autonomia, devono pervenire all’ordinata gestione dellatutela del paesaggio, coordinata con le politiche regionali e statali e in osservanzadei principi fissati dalla giurisprudenza in materia;
− la gestione della tutela deve essere improntata alla semplificazione e accelerazionedella procedura di controllo delle trasformazioni del territorio, che tenga conto dellaloro incidenza sul paesaggio e dei diversi valori da questo espressi e riconosciuti;
− un ruolo determinante per il raggiungimento di una migliore qualità paesaggistica del

176 – Roma, 9 ottobre 2003
territorio regionale deve essere attribuito alla progettazione degli interventi, che deve assumere e rispettare i caratteri e i valori locali presenti ed essere coerente con il contesto ambientale e paesaggistico;
Visto, inoltre, l’Ordine del giorno approvato nella seduta del 20 novembre 2002, oggetto n. 2910/4, con il quale il Consiglio regionale, in sede di approvazione della legge regiona-le n. 31/02, ha impegnato la Giunta a sottoscrive l’Accordo previsto dall’art. 46 della stes-sa legge, fissando gli obiettivi che con esso devono essere raggiunti;
Tutto quanto sopra letto e condiviso Stipulano il seguente Accordo
Articolo 1
Recepimento delle premesse
1. Le premesse di cui sopra e gli allegati A e B fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo, in quanto ne rappresentano gli obiettivi da realizzare.
Articolo 2
Finalità dell’accordo
1. Il presente Accordo è finalizzato a realizzare una forma di collaborazione istituziona-le che impegni le Parti a garantire la corretta gestione della tutela del territorio, la va-lutazione consapevole delle trasformazioni e la salvaguardia dei valori storici, cultu-rali, naturalistici e paesaggistici, attraverso il riconoscimento di un quadro di riferi-mento strumentale e normativo che sia univoco e condiviso.
Articolo 3
Rapporti tra gli Enti
1. Ai fini dell’attuazione dell’art.114 della Costituzione, l’Accordo promuove lo sviluppo di un rapporto collaborativo e paritario tra gli Enti preposti alla tutela del paesaggio nella Regione Emilia-Romagna, finalizzato alla gestione del territorio e dei suoi valo-ri e in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.
Articolo 4
Ambito di applicazione
1. Il recepimento negli strumenti urbanistici delle aree soggette a vincolo paesaggistico effettuata dai Comuni in attuazione dell’art. 46, comma 4 e seguenti, della L. r. n. 31/02, costituisce, congiuntamente alle norme fissate dal P.T.P.R. così come speci-ficate dal P.T.C.P., il riferimento unico per l’applicazione delle procedure di autoriz-zazione paesaggistica.
Articolo 5
Procedimenti in materia paesaggistica
1. Le Parti, ai fini della gestione della tutela del territorio, concordano di applicare i cri-

Accordo MiBAC, RER, Autonomie locali - 177
teri e i principi riportati negli allegati A e B al presente Accordo, in attuazione delle disposizioni del Titolo II del T.U. n. 490/99 oltre che dei contenuti e della normativa regionale in materia.
Articolo 6 Pianificazione condivisa
1. Al fine di pervenire alla condivisione delle modalità e dei livelli di trasformazione del
territorio, i Comuni, nell'elaborare gli strumenti di pianificazione a scala comunale che recepiscano la disciplina di tutela e valorizzazione del paesaggio, avviano spe-ciali forme di collaborazione con la Regione e le Soprintendenze.
2. Le forme di collaborazione di cui al presente articolo, devono essere attivate in via prioritaria nei Comuni ove si riscontri un valore paesaggistico del territorio di indi-scussa rilevanza o una forte presenza di vincoli paesaggistici e ambientali.
3. Le Soprintendenze di settore competenti in materia vengono convocate ai sensi dell’art. 14 della L. R. n. 20/2000 alla Conferenza di Pianificazione prevista dal pro-cedimento di predisposizione dei piani comunali, e si impegnano a partecipare al fi-ne di pervenire alla condivisione dei livelli di tutela e dei conseguenti obiettivi di qua-lità paesistica del territorio comunale.
4. A seguito dell’approvazione del piano comunale, qualora i contenuti finali siano già stati condivisi dalla Soprintendenza in sede di Conferenza di Pianificazione, i Comu-ni e la Soprintendenza sottoscrivono un’intesa finalizzata a realizzare forme di sem-plificazione e accelerazione amministrativa del procedimento autorizzativo, per de-terminate categorie di opere o di intervento, in base alla loro diversificata incidenza sul paesaggio e sui valori espressi dal territorio.
Articolo 7
Apposizione e modifica dei vincoli paesaggistici
1. La Regione e la Soprintendenza regionale definiscono d'intesa criteri per l'apposi-zione e la modifica dei vincoli paesaggistico-ambientali di cui all'art. 140 del T.U. n. 490/99, affinché questi risultino integrativi della tutela realizzata dalla pianificazione regionale, così da costituire un sistema unitario, riconoscibile e condiviso, finalizzato a identificare i valori rappresentativi del patrimonio paesaggistico e culturale del ter-ritorio emiliano-romagnolo.
2. I P.T.C.P. costituiscono la sede ordinaria per la definizione della disciplina speciale di tutela delle aree assoggettate a vincolo paesaggistico-ambientale, oltre che per la verifica del sistema vincolistico esistente relativamente alla apposizione di nuovi vin-coli ovvero alla modifica di quelli esistenti.
3. Le Province, nell’ambito dell’attività di redazione o di aggiornamento dei P.T.C.P., provvedono alla definizione del sistema dei valori del proprio territorio, anche attra-verso la verifica dei vincoli esistenti sulla base dei criteri di cui al comma 1 e in ac-cordo con la Soprintendenza di settore competente in materia, formulando proposte di modifica ovvero di apposizione di nuovi vincoli, al fine di realizzare l’integrazione degli strumenti di tutela.
4. Le proposte formulate dalle Province a seguito dello svolgimento dell’attività di cui al comma precedente, sono presentate alle Commissioni provinciali per le bellezze na-turali, le quali avviano il procedimento di cui all’art. 8 della L.R. 26/78, come sostitui-to dall’art.10 della L.R.6/95, predisponendo, nel contempo, la specifica normativa sugli interventi e usi ammissibili dei beni paesaggistico-ambientali tutelati, integrativa della tutela realizzata dalla pianificazione regionale. I beni inseriti negli elenchi di cui all’art. 140 del T.U. n. 490/99 sono esplicitamente individuati nella cartografia dei

178 – Roma, 9 ottobre 2003
PTCP.
Articolo 8 Corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici
1. L’attività di verifica dei vincoli paesaggistici di cui al precedente art. 7, è estesa an-
che ai corsi d'acqua pubblici di cui all'art. 146, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 490/99, al fine di perfezionare il procedimento previsto al comma 3 del medesimo articolo, già avviato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 2531 del 29 di-cembre 2000.
2. Saranno oggetto della suddetta verifica anche i corsi d’acqua considerati paesaggi-sticamente irrilevanti dalla Regione nella attività di ricognizione già effettuata e per i quali sia stata eventualmente formulata proposta di conferma del vincolo da parte del Ministero, al fine di verificarne tra le Parti l’effettività del valore paesaggistico.
Articolo 9
Autorizzazioni paesaggistiche
1. È competenza del Comune rilasciare l’autorizzazione paesaggistica sulla base del parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.
2. La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio formula la valutazione di merito sulla proposta di trasformazione territoriale, attraverso la quale il Comune persegue l’obiettivo del miglioramento della qualità del progetto, dell'opera architet-tonica e del contesto paesaggistico in cui questa si inserisce.
3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al precedente comma, la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, sulla base della documentazione di cui all’allegato B e della verifica di conformità alla pianificazione sovraordinata, si espri-me in merito alla compatibilità dell’intervento di trasformazione proposto con la sal-vaguardia dei valori paesaggistico-ambientali.
4. La verifica di conformità alla pianificazione sovraordinata svolta dal Responsabile dello Sportello unico e la valutazione paesaggistica formulata dalla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della L.R. 31/02, formano la motivazione della autorizzazione paesaggi-stica in base alla quale il Comune da atto della propria decisione in merito all’intervento proposto.
5. La Regione Emilia-Romagna promuove, anche attraverso specifiche forme di finan-ziamento, l'istituzione di Commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio an-che in forma associata tra più Comuni.
Articolo 10
Specifiche forme di intesa
1. La Regione, il Ministero per i beni e le attività culturali e gli Enti locali interessati, s’impegnano a realizzare forme di collaborazione e di risoluzione in specifiche situa-zioni nelle quali la gestione della tutela paesaggistica risulti particolarmente com-plessa e problematica.
2. Qualora insorgano contrasti in relazione agli ambiti di applicazione e ai contenuti della legislazione in materia di paesaggio, le Parti firmatarie ricercano una interpre-tazione condivisa della normativa vigente.

Accordo MiBAC, RER, Autonomie locali - 179
Articolo 11 Conferenze dei Servizi
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, e per esso le Soprintendenze di settore
competenti in materia, s’impegna a partecipare alle conferenze dei servizi indette dalle Parti al fine di realizzare una attività preventiva di semplificazione delle proce-dure di assenso ai progetti di trasformazione paesaggistica.
2. Qualora sia il Comune sia la Soprintendenza diano il proprio assenso al progetto, il provvedimento finale della conferenza sostituisce l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 151 del T.U. 490/99, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e seguenti della L. 241/90, e successive modifiche e integrazioni.
3. Al fine di agevolare la partecipazione delle Soprintendenze, le conferenze di servizi sono indette presso la sede della Amministrazione provinciale competente per terri-torio ovvero presso la sede del Comune capoluogo. Per lo stesso motivo, le convo-cazioni dovranno avere carattere periodico e prevedere l’esame di più oggetti, se-condo un calendario preventivamente concordato con la Soprintendenza.
Articolo 12
Adeguamento della pianificazione paesistica
1. Ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo tra il Ministro-Regioni-Province Autonome del 19 aprile 2001, la Regione Emilia-Romagna si impegna a promuovere la partecipazione della Soprintendenza regionale e delle Soprintendenze di settore competenti in ma-teria, alle eventuali attività di adeguamento della pianificazione paesistica regionale agli obiettivi della Convenzione europea del paesaggio.
Articolo 13
Monitoraggio
1. Le Parti si impegnano a realizzare il potenziamento e l'integrazione delle rispettive banche dati, relative ai vincoli e a renderli disponibili anche al fine di consentire ai Comuni di realizzare la Carta Unica del Territorio, di cui all'art. 19 della legge regio-nale n. 20/2000.
2. Allo scopo di realizzare un flusso informativo finalizzato all'analisi e alla valutazione delle trasformazioni del paesaggio, le Parti definiscono i dati e le informazioni che dovranno essere raccolte dai Comuni, nonché i tempi e le modalità di trasmissione degli stessi alla Regione, in attuazione dell'art. 47 della legge regionale n. 31/2002.
Articolo 14 Tutela attiva del paesaggio
1. La Regione Emilia Romagna ed il Ministero per i beni e le attività culturali promuo-
vono, attraverso specifici finanziamenti, l’attuazione di progetti pilota rivolti alla rea-lizzazione degli obiettivi di qualità fissati dalla Convenzione europea del paesaggio e delle forme di pianificazione condivisa di cui al comma 3, dell'art. 150, del T.U. n. 490/99.
2. I progetti pilota perseguono i seguenti obiettivi: mantenimento delle caratteristiche, dei valori costitutivi e delle morfologie; previsione di linee di sviluppo compatibili con i diversi livelli di valori riconosciuti; riqualificazione delle parti compromesse o degra-date per il recupero dei valori preesistenti ovvero per la creazione di nuovi valori pa-

180 – Roma, 9 ottobre 2003
esistici coerenti e integrati.
3. La suddetta sperimentazione verrà condotta in collaborazione con le Soprintenden-ze, le Province e i Comuni, o loro associazioni, nei cui territori si riscontrino le condi-zioni per realizzare gli obiettivi di cui al comma precedente, al fine di creare modelli progettuali applicabili all’intero territorio regionale.
Articolo 15
Attività di formazione
1. In attuazione degli obiettivi di cui all’art. 46, comma 3, della L.R. 31/2002 la Regione promuove, d'intesa con le Parti stipulanti, e in collaborazione con le Università e gli Ordini professionali, attività di formazione di alta specializzazione indirizzata ai com-ponenti delle Commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio e ai professio-nisti del settore pubblico e privato.
2. La formazione ha prioritariamente la funzione di fornire strumenti per una corretta valutazione dei progetti, per il miglioramento delle loro qualità e per il corretto inse-rimento degli interventi nel contesto paesaggistico-ambientale.
Articolo 16
Adeguamento normativo
1. Nel caso di sopravvenute modifiche normative in materia, che influiscano sulle attivi-tà previste del presente Accordo, le Parti concordano di effettuare d’intesa i neces-sari adeguamenti attraverso una procedura semplificata.
Articolo 17
Gruppo di coordinamento
1. Con determinazione del Direttore Generale regionale competente per materia, viene istituito un gruppo di coordinamento, composto da rappresentanti designati dalle Parti contraenti, che avrà il compito di organizzare e soprintendere alle attività per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente Accordo, vigilando sulla loro attua-zione.
Roma, 09 ottobre 2003
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Giuliano URBANI
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vasco ERRANI
COORDINAMENTO AUTONOMIE LOCALI EMILIA-ROMAGNA Per conto di
A.N.C.I. U.P.I.
LEGAUTONOMIE U.N.C.E.M.
Antonio GIOIELLIERI

Accordo MiBAC, RER, Autonomie locali - 181
ALLEGATO “A”
L’Accordo tra la Regione Emilia-Romagna, il Ministero per i beni e le attività culturalie l’Associazione delle autonomie locali ha per fondamento la condivisione el’accettazione dei principi fissati dalla normativa statale e regionale e dalla più recente econsolidata giurisprudenza, che di frequente è stata investita del compito di dare la pro-pria interpretazione in materia. La gestione della tutela del paesaggio, infatti, ha semprerisentito della compresenza e della sovrapposizione degli strumenti di tutela previstidall’ordinamento, fatto che ha causato spesso difficoltà ed incertezze nell’applicazionepratica delle procedure. Si ritiene, opportuno, quindi, richiamare i principi derivanti dallainterpretazione giurisprudenziale, in particolare per quanto riguarda l’articolazione dellecompetenze tra Stato e Regioni, la procedura di individuazione e apposizione del vincolopaesaggistico, la gestione degli strumenti di tutela, oltre che il potere statale di annulla-mento del nulla osta paesaggistico, al fine di definire i punti cardine su cui si basa la di-sciplina del paesaggio e il necessario rapporto di collaborazione tra gli Enti.
Ambito di applicazione della tutela paesaggistica
L’art. 9 Cost., elevando la tutela del paesaggio a rango di principio primariodell’ordinamento, ha inteso consentire che essa debba essere improntata ai principi diintegralità e globalità, concernendo, pertanto, l’intero territorio al fine di salvaguardarne ilvalore estetico-culturale, pur nella considerazione delle specificità e differenze che necaratterizzano il profilo storico-culturale, naturalistico e morfologico (Corte Cost., 27 giu-gno 1986, n. 151).
La tutela del paesaggio, pertanto, deve avere primariamente carattere dinamico egestionale, superando l’ottica meramente conservativa ed estetica delle “bellezze natura-li” individuate da provvedimenti amministrativi specifici e puntuali, per trovare più ampiorespiro nel riconoscimento delle risorse paesistiche di vaste aree del territorio, per le qualidettare, attraverso la pianificazione paesaggistica, una normativa d’uso e di valorizzazio-ne graduata e differenziata sulla base del riconosciuto valore ambientale e culturale, dellespecificità dei luoghi, degli strumenti di tutela e di controllo delle trasformazioni.
Articolazione delle competenze tra Stato e Regioni
Le competenze statali e regionali in materia di paesaggio sono articolate in un rap-porto di integrazione fondato sul principio della leale collaborazione fra gli Enti, in base alquale i compiti di gestione sono attribuiti ordinariamente alla Regione, mentre i compitirelativi alla tutela e alla vigilanza sono svolti in forma concorrente, come già riconosciutodal Testo unico n. 490/99.
Gli strumenti di tutela del paesaggio
Il piano territoriale paesistico o urbanistico-territoriale, già previsto dalla legge n.431/85 ed ora dall’art. 149 del T.U. n. 490/99, è lo strumento che garantisce la tutela di-namica e globale del territorio in attuazione dell’art. 9 Cost. Il piano, infatti, individuando ivalori territoriali e definendo gli ambiti di tutela e valorizzazione, determina la normativad’uso e di valorizzazione ambientale e paesaggistica dell’intero territorio, e risulta perciòessenziale alla programmata e razionale gestione del paesaggio, permettendo di evitarevalutazioni episodiche e non coordinate al contesto ambientale e paesaggistico dei luo-

182 – Roma, 9 ottobre 2003
ghi.Le caratteristiche funzionali della pianificazione paesistica permettono di realizzare la
necessaria integrazione con il sistema di tutela costituito dai vincoli paesaggistici impostia singoli beni e località in forza di provvedimenti amministrativi o normativi. Infatti, sia ivincoli paesaggistici disposti dall’amministrazione ai sensi dell’art. 139 del T.U. n. 490/99(ex legge n. 1497/39), sia i vincoli ope legis su intere categorie di beni individuate di cuiall’art. 146 dello stesso testo unico (ex art. 1 della L. 431/85) sia infine i vincoli di immodi-ficabilità assoluta fino alla redazione dei piani paesistici dei beni e delle località indivi-duate ai sensi del DM 21 settembre 1984 (cosiddetti Galassini), coordinandosi con il pia-no, completano la disciplina già determinata dalla pianificazione paesistica, consentendoin tal modo di evitare la frammentarietà della tutela.
L’integrazione dei sistemi di tutela e la conseguente predefinizione della disciplinadelle aree aventi valore paesaggistico, favorisce la certezza giuridica dei limiti e dellecondizioni all’uso e alle trasformazioni di tutto il territorio, così da realizzare la tutela glo-bale voluta dalla Costituzione.
La pianificazione paesistica regionale
La tutela paesistica nella Regione Emilia-Romagna è garantita dalla pianificazioneterritoriale regionale, così come realizzata dal P.T.P.R., oltre che dai P.T.C.P. e daiP.R.G. che ne danno attuazione.
La Regione Emilia-Romagna, nel sottoporre a specifica normativa d’uso e di valoriz-zazione il proprio territorio attraverso la redazione del Piano Territoriale Paesistico Re-gionale (P.T.P.R.), che ha natura di piano urbanistico-territoriale con specifica considera-zione dei valori paesistici ed ambientali (Corte Cost., 26 giugno 1990, n. 327; TAR Emilia-Romagna, 8 febbraio 2002, n. 366), ha considerato i vincoli paesaggistici presenti nelterritorio regionale, ricomprendendoli nella disciplina di piano.
Il piano regionale è l’esito di un’attività di analisi del territorio, finalizzataall’individuazione delle specifiche caratteristiche storico-culturali, naturalistiche, morfolo-giche; esso ha indicato le aree di tutela e i sistemi del territorio regionale determinandoneil regime d’uso, allo scopo di predefinire, in base a principi e livelli di valore preordinati, lemodificazioni compatibili attraverso la predisposizione di norme costituenti prescrizionicogenti, indirizzi e direttive destinati a prevalere sulla pianificazione locale con esso in-compatibili.
Le previsioni e le zonizzazioni dettate dal P.T.P.R. sono successivamente state at-tuate dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), e dai Piani comunali,ai quali è stato dato il compito di approfondire le suddette previsioni, al fine di specificarleed integrarle conformandole alle caratteristiche del proprio territorio.
Ai sensi dell’art. 24 della L.r. n. 20/00, i Piani Territoriali di Coordinamento Provincialeadeguati al P.T.P.R. costituiscono, in materia di pianificazione paesaggistica, l'unico rife-rimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa. Nelmomento in cui la pianificazione urbanistica comunale abbia recepito e coordinato le pre-scrizioni e i vincoli territoriali, paesaggistici e ambientali che derivano da piani sovraordi-nati, da singoli provvedimenti amministrativi ovvero da previsioni legislative, essa costitui-sce la Carta Unica del territorio di cui all’art. 19 della L.r. n. 20/00, e rappresental’esclusivo riferimento per la pianificazione e per la verifica di conformità urbanistica ededilizia, anche per i primari profili che attengono alla tutela del paesaggio.
Individuazione e apposizione dei vincoli paesaggistici
Al fine di esercitare la competenza relativa alla individuazione e apposizione del vin-

Accordo MiBAC, RER, Autonomie locali - 183
colo paesaggistico, la Regione Emilia-Romagna ha istituito, con l’art. 8 della legge regio-nale n. 26/78, le Commissioni provinciali per le bellezze naturali, alle quali è affidato ilpotere di modificare la cartografia del P.T.P.R., assoggettando alla disciplina di tutela evalorizzazione ulteriori aree che presentino le caratteristiche delle zone previste dalP.T.P.R., così da garantire loro l’applicazione del regime più congruo tra quelli assicuratidalle disposizioni del piano.
Inoltre, è attribuito alle stesse Commissioni provinciali il compito di individuare ele-menti meritevoli di tutela, non adeguatamente salvaguardati dalle norme del piano, tali dadeterminare la proposta di apposizione di nuovi vincoli paesaggistici, che sono oggetto diapprovazione da parte della Giunta regionale. Con la proposta di vincolo, la Commissio-ne deve dettare la normativa sugli interventi e usi ammissibili, al fine di realizzare la tutelapiù idonea allo specifico bene e di assicurare la valorizzazione paesaggistico-ambientaledel territorio. Ai sensi del comma 6 del suddetto art. 8, in seguito alla approvazione regio-nale i vincoli così individuati costituiscono parte integrante del P.T.P.R.
Resta salvo il potere integrativo di individuazione dei beni da assoggettare a vincolopaesaggistico in capo al Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’art. 144 delTesto unico n. 490/99. Questa individuazione deve in ogni caso essere svolta prioritaria-mente nell’ambito delle attività di redazione e aggiornamento dei P.T.C.P., ai sensidell’artt. 7 e 8 del presente Accordo.
Autorizzazione paesaggistica
La competenza al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 151 del T.U.n. 490/99 è stata attribuita ai Comuni già dalla L. r. n. 26/78. Ai sensi della L.r. n. 31/02, ilprovvedimento di rilascio viene emanato dal dirigente responsabile dello Sportello unicoper l’edilizia, previo parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per la qua-lità architettonica e il paesaggio. Il Ministero conserva un potere di intervento sia su ri-chiesta dell’interessato in caso di inerzia del Comune (art. 151, comma 5, del T.U. n.490/99), sia in caso di interventi relativi a opere pubbliche (art. 156 del T.U. n. 490/99).
L’autorizzazione paesaggistica deve essere rilasciata, in base ad idonea istruttoria,entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione della domanda; in sede diesame della domanda di autorizzazione, il Comune deve rispettare il principio della lealecollaborazione tra gli Enti, oltre che i principi di legittimità degli atti amministrativi (Cons.di Stato, 14 dicembre 2001, n. 9). La valutazione di compatibilità paesaggistica del pro-getto proposto deve in primo luogo essere coerente alle previsioni del P.T.P.R., così co-me specificato ed integrato dai P.T.C.P. e dai piani comunali, oltre che verificare la con-creta incidenza delle opere sui valori e sul contesto ambientale.
A norma dell’art. 94 della L.r. n. 3/99, nell’esaminare i contenuti della domanda diautorizzazione relativa agli ambiti soggetti al vincolo di cui all’art. 146 del T.U. n. 490/99, ilComune si attiene alla disciplina dettata dagli strumenti di pianificazione territoriale, inquanto attuativi del P.T.P.R.; nelle zone sulle quali incidano vincoli puntuali, l’ulterioreparametro di riferimento sarà costituito dalle specifiche motivazioni e dalle disposizioniprescritte dal provvedimento di apposizione del vincolo.
L’autorizzazione paesaggistica deve essere sostenuta da una adeguata motivazione,anche quando consista in un provvedimento positivo. Funzione della motivazione èquella di permettere la ricostruzione dell’iter logico seguito dal Comune in ordine al giudi-zio di compatibilità del progetto proposto con la tutela dei luoghi. Il contenuto della moti-vazione è costituito dalla verifica di conformità alla pianificazione paesistica oltre chedalla valutazione in ordine agli aspetti compositivi e architettonici dell’intervento e al suoinserimento nel contesto paesaggistico e ambientale. L’esame dell’intervento propostodeve essere effettuato prendendo in considerazione il progetto nella sua globalità. Se-

184 – Roma, 9 ottobre 2003
condo la giurisprudenza, quando la valutazione di compatibilità effettuata dal Comune siabasata sulla mancata considerazione di un rilevante elemento di fatto, essa si traduce inuna oggettiva deroga del vincolo, che si risolve in una autorizzazione illegittima per svia-mento o travisamento (tra le ultime, Cons. di Stato, sez. VI, 13 febbario 2001, n. 685). Èfacoltà dell’amministrazione comunale, nel rilasciare il nulla osta, introdurre nel provvedi-mento puntuali prescrizioni finalizzate alla mitigazione degli eventuali effetti negatividell’intervento proposto sul contesto ambientale e paesaggistico.
L’autorizzazione paesaggistica costituisce un provvedimento autonomo rispettoall’atto di concessione edilizia. La valutazione paesaggistica precede e condiziona ilprovvedimento urbanistico, senza che tale valutazione di compatibilità sia in qualchemodo condizionata dalla scelte urbanistiche comunali (Cons. di Stato, sez. II, 31 marzo1999, n. 268).
Potere di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica
In attuazione del principio di integrazione delle competenze in materia, a seguito delrilascio della autorizzazione paesaggistica il procedimento prosegue in una fase, neces-saria e non autonoma, nella quale il Ministero, e per esso la Soprintendenza locale, entroil termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione della documentazione, ha la facoltà diannullarla in caso rilevi vizi di legittimità dell’atto amministrativo. Solo allo scadere di taletermine l’atto autorizzatorio può considerarsi perfetto e produttivo di effetti giuridici; nelcaso in cui l’amministrazione statale non si pronunci entro il termine, l’autorizzazione pro-duce immediatamente i suoi effetti.
Il termine perentorio dei 60 giorni, che attiene esclusivamente all’esercizio del poteredi annullamento e non comprende anche l’ulteriore fase di comunicazione o notificazioneall’interessato (tra le tante, Cons. di Stato, sez. V, 15 settembre 1997, n. 963), decorredalla ricezione da parte della Soprintendenza dell’autorizzazione rilasciata, completadella documentazione tecnico-amministrativa, predisposta in ottemperanza a quanto sta-bilito nell’allegato B, sulla cui base il provvedimento è stato adottato. Nel caso di omessao incompleta trasmissione della documentazione in base alla quale il Comune si è pro-nunciato, il termine di cui sopra non decorre; in questo caso, risulta legittima, e producel’interruzione del termine previsto dalla legge, la richiesta di integrazione documentale daparte della Soprintendenza relativamente agli elementi conoscitivi e valutativi definitidall’allegato B.
Nell’esercizio dell’attività di competenza, la Soprintendenza non può effettuare unapropria valutazione tecnico-discrezionale sugli interessi in conflitto e sul valore che devein concreto prevalere; il provvedimento statale di annullamento non può basarsi esclusi-vamente sulla apodittica affermazione del pregiudizio del valore ambientale e paesaggi-stico, ma deve invece fondarsi sulla constatazione dell’esistenza di circostanze di fatto edelementi specifici che il Comune non abbia considerato o che abbia valutato in modo ir-razionale, in contrasto con il principio di leale collaborazione o con gli altri principi di legit-timità dell’azione amministrativa. Inoltre, la Soprintendenza non ha la facoltà di imporremodifiche o di subordinare l’efficacia dell’atto all’adeguamento del progetto a proprie va-lutazioni in difformità alle valutazioni regionali (Cons. di Stato, Ad. plen., 14 dicembre2001, n. 9).
La giurisprudenza è ferma nel ritenere che l’autorizzazione paesaggistica può essereannullata esclusivamente quando risulti illegittima, per vizio di incompetenza, di violazio-ne di legge o di eccesso di potere, in tutti i suoi profili (travisamento dei fatti, sviamento,insufficiente motivazione, difetto di istruttoria, illogicità manifesta, incoerenza) e non an-che per ragioni di merito (Cons. di Stato, sez. VI, 8 agosto 2000, n. 4345; Ad. plen., 14dicembre 2001, n. 9).

Accordo MiBAC, RER, Autonomie locali - 185
Risulta pertanto chiaro che assume un ruolo determinante in tale fase la motivazioneposta alla base del rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune, in quanto deve es-sere immediatamente riconoscibile l’iter logico che ha portato l’amministrazione comunalea risolversi in tal senso; lo stesso provvedimento ministeriale di annullamento della auto-rizzazione paesaggistica deve essere congruamente motivato, nel senso che devono es-sere evidenziate le carenze dell’attività procedimentale del Comune e tutti i profili che siritengano causa dell’illegittimità del provvedimento (Cons. di Stato, Ad. plen., 14 dicem-bre 2001, n. 9; sez. VI, 21 maggio 2002, n. 6665).
Conferenze di servizi
Le valutazioni paesaggistiche sul progetto di trasformazione proposto possono esse-re effettuate contestualmente da parte delle amministrazioni coinvolte anche in sede diconferenza dei servizi. Ad esse si applica la disciplina di cui agli artt. 14 e seguenti dellaL. 241/90, e successive modifiche e integrazioni.
Al fine di realizzare compiutamente l’istituto della conferenza dei servizi, è opportunoche il Comune interessato invii la documentazione completa del progetto proposto (per icui contenuti si rinvia alle indicazioni dell’allegato B) agli Enti coinvolti nel procedimento,in tempo utile per permetterne l’esame preliminare.
L’esercizio del potere di riesame e di annullamento previsto dall’art. 151 del T.U. n.490/99 resta assorbito nella procedura innestata con la stessa conferenza. In caso di dis-senso della Soprintendenza in seno alla conferenza, la determinazione finale e conclusi-va a componimento dei contrastanti interessi in gioco viene assunta dal Consiglio dei Mi-nistri, in sede di alta amministrazione. Nel caso in cui, invece, il Ministero o la Soprinten-denza esprimano il loro assenso al progetto, opera il meccanismo in base al quale ilprovvedimento sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta oatto di assenso comunque denominato, ai sensi dell’art. 14ter, comma 9, della legge n.241/90, e pertanto il potere di riesame non può essere successivamente esercitato(Cons. di Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2001, n. 9; sez. II, Parere 6 febbraio 2002, n.2457).
Autorizzazione ex post
Il Consiglio di Stato, ha ripetutamente affermato (in ultimo con il parere dell’Adunanzagenerale n. 2340/2001 reso in data 11 aprile 2002) la possibilità del rilasciodell’autorizzazione ex post a fini paesaggistico-ambientali per gli abusi che rientrino nellafattispecie dell’art. 13 della legge n. 47/85 e ricadenti in area vincolata. Il supremo organodi giustizia amministrativa, infatti, ha ritenuto che l’abusiva esecuzione di un’opera nonimpedisca di per sé all’amministrazione preposta alla tutela di emettere provvedimenti diautorizzazione postuma dell’intervento abusivamente eseguito, nella sua interezza o perparte di esso, determinando nel contempo i limiti e le condizioni della modalità di rilascio.
Pertanto, considerato che in situazioni rientranti in tale fattispecie è possibile chel’interessato richieda al Comune competente il rilascio dell’autorizzazione ex post, si ri-tiene necessario fissare alcune disposizioni a riguardo, tenendo presente che il rilasciodel nulla osta paesaggistico prescinde dalla sanatoria urbanistica dell’abuso, la qualerisponde a valutazioni di tipo diverso e che si basa su una differente normativa.
In primo luogo, il Comune nell’esaminare l’intervento abusivo non deve essere condi-zionato dall’abuso conseguente alla realizzazione dell’opera né dalla sua sanabilità urba-nistica, mentre deve, in ogni caso, verificare la mancata produzione di effetti pregiudizie-voli dell’opera già eseguita in relazione allo stato dei luoghi antecedente alla realizzazio-ne dell’opera, dandone adeguata motivazione nel provvedimento autorizzativo. Al contra-

186 – Roma, 9 ottobre 2003
rio, il giudizio dovrà essere negativo, e quindi prevedere la possibilità di demolire le opereabusive, ove il confronto dimostri che l’opera realizzata abbia prodotto effetti negativi ov-vero distruttivi nei confronti del bene sottoposto a tutela.
A tale scopo, l’interessato ha l’obbligo di produrre, oltre alla normale documentazioneda presentare al momento della richiesta di autorizzazione, la documentazione attestantel’effettivo attuale stato dei luoghi così come modificati dall’intervento, in modo tale daconfrontarlo con la descrizione dettagliata della situazione paesaggistica e ambientaleprecedente all’intervento abusivo.
L’esame avrà quindi per oggetto la valutazione di compatibilità dell’opera già eseguitacon i valori paesaggistico-ambientali alla luce delle ordinarie verifiche prescritte in caso diautorizzazione paesaggistica, e quindi relative alla conformità dell'intervento con le pre-scrizioni contenute nella pianificazione di riferimento; alla coerenza dello stesso con gliobiettivi di qualità paesistica; alla sua congruità con i valori riconosciuti dal vincolo; infine,alla correttezza, formale e sostanziale, dell'intervento in merito al suo inserimento nelcontesto urbano, paesaggistico e ambientale.
È possibile, inoltre, che in sede di esame della richiesta di autorizzazione postuma laCommissione per la qualità architettonica e il paesaggio rilevi che la incompatibilitàdell’opera eseguita derivi da connotati morfologici o particolari costruttivi non compatibilicon la ragione del vincolo, i quali, pertanto, potranno essere oggetto di precise prescri-zioni finalizzate al loro superamento, allo scopo di assicurare l’inserimento paesaggisticodell’intervento.L’autorizzazione in sanatoria, che produce i suoi effetti dal momento in cui viene emanatoil relativo provvedimento, non costituisce un pieno equipollente sul versante degli effettidell’autorizzazione preventiva. Infatti, il suo rilascio non esclude il dovere della compe-tente amministrazione comunale di infliggere la sanzione pecuniaria di cui all’art. 164 delT. U. n. 490/99, fermi restando gli ulteriori profili di responsabilità previstidall’ordinamento. In buona sostanza, la verifica della compatibilità ambientale svolta suc-cessivamente alla realizzazione dell’opera, se anche non produce danno all’integritàpaesaggistica, non cancella la compromissione sostanziale dell’obbligo di conseguire invia preventiva il titolo di assenso necessario all’intervento modificativo dello stato dei luo-ghi. Pertanto, il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria deve essere con-siderato parte integrante della documentazione finalizzata al rilascio del nulla osta, equindi sarà inviato alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e per il pae-saggio, assieme allo stesso nulla osta e alla documentazione relativa, costituendol’insieme di tutti questi elementi la documentazione complessiva in base alla quale il Co-mune si è determinato al rilascio del provvedimento.
Resta integro il potere statale di annullamento della autorizzazione paesaggistica di cuiall’art. 151 del Testo unico n. 490/99, e pertanto nella procedura relativa dovranno essereapplicate le indicazioni e le prescrizioni stabilite dal presente Accordo.

Accordo MiBAC, RER, Autonomie locali - 187
ALLEGATO “B”
Il sistema di tutela così come descritto dalla normativa e dalla evolutiva interpretazio-ne giurisprudenziale mostra uno dei punti più critici nella assenza di criteri e principi uni-voci che disciplinino l’attività di valutazione delle trasformazioni del territorio. Tale valuta-zione, che, sulla base dei valori riconosciuti o riconoscibili e dei caratteri peculiari presentinell’area dell’intervento, muove dalla comparazione tra lo stato attuale del luogo e la si-tuazione che potrà assumere a seguito della realizzazione dell’opera progettata, deveinfatti necessariamente fondarsi su una adeguata documentazione atta a consentire alComune di pervenire ad un giudizio consapevole. La mancanza di un indirizzo univoco inmerito, ha favorito il consolidamento di un potere discrezionale di decisione in capo alleamministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento di autorizzazione paesaggistica,sia in fase di rilascio sia in quella di esercizio del potere di riesame, con la conseguenzadi non realizzare la necessaria uniformità di valutazione dei singoli progetti da parte dellestesse amministrazioni. D’altra parte, la necessità di corredare il provvedimento autoriz-zatorio con una adeguata motivazione, che dia atto della correttezza e congruitàdell’esame svolto dal Comune sulla base della documentazione presentata, mette in evi-denza chiaramente l’opportunità di determinare elementi e modalità del procedimentoche siano condivisi dalle amministrazioni interessate e che favoriscano l’accelerazione ela semplificazione della procedura, la quale inoltre in tal modo risulta più trasparente per ilcittadino.
Si è ritenuto pertanto, nell’ambito dell’Accordo tra il Ministero, la Regione Emilia-Romagna e l’Associazione delle autonomie locali, di individuare i criteri e le modalità cheprioritariamente orientino l’attività di valutazione svolta dai Comuni e dalle Commissioniper la qualità architettonica e il paesaggio in sede di esame degli interventi di trasforma-zione in area tutelata, in quanto tale analisi è necessaria al raggiungimento di un correttoe consapevole giudizio di merito sui progetti di trasformazione da parte dei Comuni. Lafinalità è quella non soltanto di precisare l’ambito di applicazione della procedura di auto-rizzazione paesistica, tentando un suo snellimento, ma anche e soprattutto quella di con-dividere tra le amministrazioni interessate gli obiettivi cui deve tendere l’attività di con-trollo e valutazione delle trasformazioni del territorio e la documentazione ritenuta a talfine necessaria. Si sottolinea, inoltre, l’opportunità di valutare le proposte di trasformazio-ne nel merito del contesto locale, tenendo presente che il concetto di paesaggio risultadefinito sia dall'oggettività dei caratteri fisici del territorio sia dalla soggettività con cui talicaratteri vengono recepiti in rapporto alle differenti articolazioni culturali così come indi-cato dalla Convenzione europea che definisce il paesaggio come “una determinata partedel territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione difattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”.
Resta, in ogni caso, salva in capo alle Commissioni per la qualità architettonica e ilpaesaggio la competenza di definire i principi e i criteri compositivi e formali di riferimentoper l’emanazione dei pareri prevista dall’art. 3, comma 2, lett. c) della L.R. n. 31/02.
Ambito di applicazione
In base al Testo unico n. 490/99 sono soggetti a vincolo paesaggistico e pertantosottoposti al procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 151 dello stessodecreto legislativo, gli interventi previsti nei seguenti ambiti:− immobili o località compresi negli elenchi di cui all’art. 140 del Testo unico, già art. 2
della L. n. 1497/39, individuati e perimetrati da provvedimenti amministrativi inquanto riconosciuti rientranti in una delle seguenti categorie di beni (art. 139 del Te-

188 – Roma, 9 ottobre 2003
sto unico n. 490/99):
- cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o singolaritàgeologica (lett.a);
- ville, giardini e parchi pubblici che si distinguono per la loro non comune bellez-za (lett. b);
- complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto aventevalore estetico e tradizionale (lett. c);
- bellezze panoramiche considerate come quadri, punti di vista o di belvederedai quali si goda spettacolo di quelle bellezze (lett. d);
− immobili e località oggetto di proposte di vincolo pubblicate successivamente alladata del 18 febbraio 1995 e per le quali non sia ancora stato emanato il provvedi-mento conclusivo da parte della Giunta regionale ovvero del Ministero competente;
− zone sottoposte a vincolo di tutela paesistico ambientale in virtù dei decreti ministe-riali emanati ai sensi della L. n. 431/85, ora art. 146 del Testo unico;
− zone rientranti nelle categorie di cui all’art. 146, comma 1, del Testo unico, già art. 1della L. n. 431/85, e che sono così individuati:
- territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla batti-gia, anche per i terreni elevati sul livello del mare (lett. a);
- territori contermini a laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metridalla linea di battigia, anche per i territori elevati sul livello del mare (lett. b);
- fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi dal Testo unico delle disposi-zioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio decreto 11dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fasciadi 150 metri ciascuna (lett. c), così come individuati dalla deliberazione dellaGiunta della Regione Emilia-Romagna del 29 dicembre 2000, n. 2531, con laquale, ai sensi dell’art. 146, comma 3, sono stati individuati i fiumi, torrenti ecorsi d’acqua irrilevanti ai fini paesaggistici;
- le montagne per la parte eccedente i 1600 metri sul livello del mare per la cate-na alpina e i 1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e le isolelett. d);
- i ghiacciai e i circhi glaciali (lett. e);
- i parchi e le riserve naturali e regionali, nonché i territori di protezione ester nadei parchi (lett. f);
- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dalfuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento (lett. g);
- le aree assegnate alle Università agrarie e le zone gravate da usi civici (lett. h);
- le zone umide incluse nell’elenco di cui al decreto del Presidente della
- Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (lett. i);
- i vulcani (lett. l);
- le zone di interesse archeologico (lett. m).

Accordo MiBAC, RER, Autonomie locali - 189
A seguito dell’attuazione dell’art. 46, comma 5, della L. R. n. 31/02, una volta appro-vata la variante al PRG relativa alla perimetrazione delle aree soggette a vincolo paesag-gistico e delle aree di esclusione dallo stesso vincolo, questa costituisce l’unico riferi-mento per l’applicazione della procedura di autorizzazione paesaggistica.
Pertanto, i Comuni, attraverso la suddetta variante, sono chiamati a operare, ai fini diassicurare la certezza degli ambiti sottoposti a vincolo e quelli esclusi dallo stesso vinco-lo, la ricognizione non già delle zone omogenee individuate dai piani regolatori alla datadel 6 settembre 1985, ma l’accertamento, ora per allora, delle parti del tessuto urbanoche, alla data suddetta, presentavano le caratteristiche proprie delle zone A e B secondoquanto definito dall’art. 2 del DM n. 1444/68. Tali ambiti sono costituiti dalle parti del ter-ritorio interessate da agglomerati urbani storici oppure dalle parti del territorio totalmenteo parzialmente edificate nelle quali la superficie coperta dagli edifici esistenti non fosseinferiore a 1/8 della superficie fondiaria della zone e la densità territoriale superiore a 1,5mc/mq, ovvero delle parti dello stesso territorio urbano ricomprese nei Piani pluriennali diattuazione (P.P.A.) previsti in zone diverse da quelle A e B, o, nei Comuni sprovvisti di talistrumenti urbanistici, delle aree che ricadevano all’interno delle perimetrazioni di centriedificati effettuate ai sensi dell’art. 18 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865. Questa verifi-ca si impone in quanto le definizioni delle zone omogenee fissate dalla L.R. n. 47/78 sidiscostano da quelle determinate dal citato DM n. 1444/68. A tale scopo, i Comuni do-vranno, innanzitutto, avere riguardo delle risultanze degli strumenti urbanistici vigenti alladata del 6 settembre 1985. Qualora, poi, alla stessa data risultasse adottato uno stru-mento urbanistico, approvato successivamente ad essa, destinato a dare una rappre-sentazione più aggiornata degli effettivi ambiti relativi agli agglomerati urbani che pre-sentavano le caratteristiche proprie delle zone A e B, i Comuni dovranno tenere conto,altresì, delle indicazioni di detti piani adottati, in quanto questi concorrono alla ricostruzio-ne dell’effettivo stato del tessuto urbano nel periodo di riferimento. Deve essere, infine,sottolineato che i P.P.A. adottati successivamente alla suddetta data del 6 settembre1985, non producono l’effetto di esonero dal vincolo concesso dall’art. 146 del Testo Uni-co.
Considerato che si può con certezza sostenere che qualunque opera o interventoproduce una forma di trasformazione del contesto paesaggistico di riferimento, negli am-biti assoggettati a vincolo paesaggistico sono conseguentemente oggetto di valutazione iprogetti di opere e interventi di trasformazione del territorio in grado di alterare, in mododiretto o indiretto, permanente o temporaneo, l'aspetto, il significato e la funzione di unaqualsiasi componente paesaggistica-ambientale o di un paesaggio nel suo complesso.Restano salvi i casi in cui intervengano intese particolari tra gli Enti interessati, finalizzatealla semplificazione e alla accelerazione della procedura di controllo delle trasformazioniin relazione a interventi o opere di modesta entità ovvero di minore incidenza sul territo-rio, attraverso regole e parametri preventivamente concordati (art. 5, comma 3, del pre-sente Accordo).
Ai sensi dell’art. 152 del T.U. 490/99, non sono in ogni caso assoggettati a procedi-mento di autorizzazione paesaggistica gli interventi di manutenzione ordinaria, di manu-tenzione straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alte-rino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici.
Contenuto della attività di valutazione delle Commissioni per la qualità ar-chitettonica e il paesaggio
Gli aspetti principali da considerare nella valutazione degli interventi di trasformazio-ne proposti sono stati definiti dall'art. 9 dell’Accordo Ministro-Regioni del 19 Aprile 2001oltre che dall'art. 3, comma 2, lett. b), della L.R. 31/02. Essi riguardano:

190 – Roma, 9 ottobre 2003
1. la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei piani;
2. la coerenza dell'intervento proposto con gli obiettivi di qualità paesistica;
3. la congruità dell'intervento proposto con i valori riconosciuti dal vincolo;
4. la correttezza, formale e sostanziale, dell'intervento proposto in merito al suo inseri-mento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale.
Analizzando nel merito le fasi sopra delineate, si rileva che, riguardo alla valutazioneprevista al punto 1, la verifica di conformità deve essere condotta in riferimento alle di-sposizioni del PTPR, così come specificato e articolato dai PTCP a dai PRG che ne ab-biano attuato i contenuti e gli obiettivi ai sensi degli artt. 24 e 28 della L.R. 20/00. Ciò tro-va conferma anche nelle premesse all'Accordo Ministro-Regioni del 19 Aprile 2001, nellequali si sottolinea che “gli interventi di trasformazione del paesaggio possono essere rea-lizzati solo se coerenti con le disposizioni dettate dalla pianificazione paesistica”.
Per quanto riguarda l’attività di verifica di cui al precedente punto 2, elementi di rife-rimento ai fini della definizione degli “obiettivi di qualità paesistica” possono essere consi-derati gli obiettivi di tutela e di limitazione alle trasformazioni fissati dai piani e riconducibilialle diverse zonizzazioni effettuate dal PTPR e specificate e articolate dai PTCP, ovverodai PRG nei casi in cui questi abbiano proceduto a tale individuazione. In ogni caso,sembra opportuno ricordare che già la Convenzione europea afferma che gli obiettivi diqualità devono essere strettamente collegati alla politica del paesaggio determinata daipubblici poteri, la quale dovrà formulare gli orientamenti fondamentali, i principi generali ele scelte strategiche che serviranno da guida alle decisioni relative alla salvaguardia, allagestione e alla pianificazione.
A tale proposito si evidenzia la circostanza che le zonizzazioni di tutela definite dalPTPR articolano in modo gerarchico le diverse parti dal territorio regionale in funzione dellivello di integrità, di identità e di rilevanza dei valori paesistici, assegnando a ciascunadelle zone individuate limitazioni alle trasformazioni possibili in relazione ai valori pae-saggistico-ambientali riscontrati.
Questa impostazione è in sintonia con le finalità dell'art. 4 dell'Accordo Ministro-Regioni del 19 Aprile 2001 il quale affida alla definizione degli "Obiettivi di qualità paesi-stica" le seguenti finalità:a) il mantenimento delle caratteristiche, dei valori costitutivi e delle morfologie, tenendo
conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali
costruttivi tradizionali;
b) la previsione di linee di sviluppo compatibili con i diversi livelli di valori riconosciuti e
tali da non diminuire il pregio paesistico del territorio, con particolare attenzione alla
salvaguardia delle aree agricole;
c) la riqualificazione della parti compromesse o degradate per il recupero dei valori
preesistenti ovvero per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati.
Le due attività di verifica fin qui descritte sono da eseguirsi a curadell’amministrazione comunale, in particolare dal dirigente responsabile dello Sportellounico, trattandosi di attività che deve necessariamente relazionarsi con gli strumenti dipianificazione e gli obiettivi di qualità del territorio determinati dal Comune. Le successivefasi di esame dei progetti di trasformazione, relative alla congruità con i valori riconosciutidal vincolo e alla correttezza del suo inserimento nel contesto urbano, paesaggistico eambientale, competono invece alla Commissione per la qualità architettonica e il paesag-

Accordo MiBAC, RER, Autonomie locali - 191
gio nell’esercizio di espressione del relativo parere di merito.La verifica di congruità del progetto con i valori riconosciuti dal vincolo deve necessa-
riamente rivolgere la propria attenzione alle caratteristiche ed agli effetti derivantidall’intervento nel suo complesso, oltre che alle parti accessorie e di servizio.
Stante la sostanziale difficoltà di fissare a priori criteri e parametri da applicare in ma-niera generalizzata allo svolgimento di tale valutazione, che richiede una conoscenzaspecifica dei luoghi in cui si realizzerà l'intervento, dei valori paesaggistico-ambientali esi-stenti, delle loro caratteristiche e delle fragilità territoriali presenti, diventa fondamentale ilcontributo di esperienza e sensibilità dei membri delle Commissioni per la qualità archi-tettonica e il paesaggio, che pertanto dovranno essere scelti tra persone particolarmentecompetenti in materia di paesaggio.
Allo scopo di riconoscere i valori salvaguardati dal vincolo, una prima distinzione de-ve essere fatta sulla base delle tipologie di beni tutelati che rientrano nell’ambito di appli-cazione del procedimento di autorizzazione paesistica. Infatti, per i beni individuati conprovvedimenti specifici, sarà necessario fare riferimento alle motivazioni che hanno de-terminato l’apposizione del vincolo. Per quanto riguarda i beni assoggettati a tutela diret-tamente dalla legge, qualora il piano non definisca espressamente le caratteristiche e lemodalità di intervento in tali ambiti, la valutazione può essere ricondotta a quegli elementiche, nel loro insieme, definiscono, per qualunque tipologia di bene, il suo carattere preci-puo. Tali elementi, che possono essere considerati aspetti salienti attraverso i quali va-lutare gli effetti di trasformazioni, sono riconducibili alla forma del bene in questione, allafunzione da questo espressa (ecologica, economica, testimoniale), al significato storico,culturale o naturale da esso rappresentato, e, infine, al valore intrinseco del bene ovveroal valore che esso assume a causa della relazione con altri oggetti dello stesso tipo o delcontesto in cui esso si trova inserito.
Un ulteriore contributo all’esercizio di tale valutazione può essere ricercato nei princi-pi contenuti dalla L.R. 15 luglio 2002, n. 16, recante "Norme per il recupero degli edificistorico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio",ed in particolare nella definizione di cui all'art. 10 della medesima legge, relativo alle co-siddette "opere incongrue". In base alla norma, infatti, si definiscono tali “le costruzioni egli esiti di interventi di trasformazione del territorio che per impatto visivo, per dimensioniplanivolumetriche o per caratteristiche tipologiche e funzionali, alterano in modo perma-nente l’identità storica, culturale o paesaggistica dei luoghi”.
Qualora l’intervento proposto presentasse elementi che potrebbero determinare neiconfronti del valore riconosciuto, impatti di non rilevante importanza nell’economia delprogetto, la sua congruità con i valori del luogo può essere ottenuta anche attraverso laprevisione di specifiche azioni finalizzate alla mitigazione o alla compensazione dell'im-patto dell'opera sul paesaggio, che in alcuni casi potrebbero anche configurarsi comeattività di recupero e riqualificazione, in particolare nei territori che abbiano subìto pro-cessi di disgregazione dei caratteri morfologici, tipologici e funzionali, mediante la crea-zione di nuovi valori e nuove identità paesaggistiche, come sollecitato dalla Convenzioneeuropea e dall’Accordo Ministro-Regioni del 19 aprile 2001.
In relazione alla verifica di inserimento paesaggistico dell'intervento proposto di cui alprecedente punto 4, esplicitamente richiesta dall'art. 3 della L.R. 31/2002, è opportunosottolinearne l'importanza fondamentale. Non è sufficiente, infatti, certificare i caratteridell’opera proposta e la sua interferenza diretta o indiretta con i valori paesaggistici-ambientali riscontrabili nell'area o nelle sue immediate vicinanze, ma occorre verificare lacoerenza del suo inserimento nel più ampio contesto paesaggistico di riferimento; con-frontarlo, cioè, con il complesso dei caratteri, delle tipologie, dei valori, degli equilibri,delle invarianti strutturali, delle identità culturali, delle testimonianze e di ogni altro ele-mento connotante quello che possiamo definire come il "sistema locale di paesaggio".
A questo proposito, un riferimento essenziale è costituito dalle Unità di paesaggio

192 – Roma, 9 ottobre 2003
(U.d.p.), di cui all’art. 6 delle norme del piano paesistico regionale, rinvenibili sia nelPTPR, sia nei PTCP, oltre che negli strumenti di pianificazione comunale adeguati alledisposizioni dello stesso piano regionale.
Il compito loro assegnato dal PTPR, e successivamente dai PTCP e dagli strumenticomunali, è infatti quello di riconoscere, in modo il più possibile oggettivo ma qualitativo,la diversità dei paesaggi regionali, i cui elementi, incrociandosi e interrelandosi tra loro,esercitino determinate funzioni realizzando forme conseguenti e riconoscibili; la descri-zione dei caratteri tipici e delle invarianti dei piani favoriscono inoltre un utile riferimentoper la valutazione della compatibilità delle scelte progettuali, in quanto implicano unanetta cognizione delle conseguenze che tali scelte comportano, in termini di coerenza odi perdita di indentità dell'ambito paesaggistico-ambientale.
Esito della valutazione paesaggistico-ambientale
L'esito della valutazione dei progetti proposti, svolta in base alle fasi sopra descritte,può determinare tre possibili esiti:- il progetto viene valutato positivamente, con pieno riconoscimento della sua idoneità
paesistica, in quanto riconosciuto compatibile con il contesto paesistico esistente;
- il progetto presenta lacune in parti non essenziali sotto il profilo localizzativo, dellasoluzione progettuale adottata, degli interventi di integrazione o compensazioneprevisti. In tali casi la valutazione potrà avere esito positivo, pur inducendol’amministrazione a dettare le prescrizioni necessarie a ricondurre il progetto propo-sto alla necessaria compatibilità paesaggistica, che potranno comprendere anche leeventuali modalità di inserimento paesaggistico al fine di minimizzare l'impatto am-bientale;
- il progetto incide in modo negativo direttamente e irreversibilmente sui caratteri, ivalori e le invarianti che caratterizzano l'area di intervento o il contesto paesaggisti-co-ambientale. In questi casi il progetto dovrà essere rigettato, affinché venga rifor-mulato sulla base delle osservazioni della Commissione per la qualità architettonicae il paesaggio.
Documentazione da allegare al progetto
È necessario mettere in risalto innanzitutto la specialità dei contenuti richiesti ad unprogetto che si confronti con i valori di un determinato contesto paesaggistico-ambientale, in quanto essi hanno lo scopo di dimostrare la compatibilità degli interventiproposti con gli aspetti oggetto di valutazione da parte della Commissione per la qualitàarchitettonica e il paesaggio. In più, è opportuno in questa sede rammentare che laCommissione fonda il proprio parere esclusivamente sulla base della documentazioneprodotta a corredo della richiesta di autorizzazione, e che tale valutazione diventa parteintegrante della motivazione che sta a fondamento del rilascio o del diniego del nulla ostapaesaggistico, assieme alla verifica di conformità agli strumenti di pianificazione effet-tuata dallo Sportello unico.
Alla luce di ciò, si ritiene opportuno definire l’elenco dei documenti da allegare al-l'istanza di autorizzazione paesaggistica, che sia condiviso dagli Enti preposti alla verificadelle trasformazioni del paesaggio, così da evitare la necessità di integrazioni a posteriorie ottenendo, al contempo, l’applicazione corretta ed omogenea della procedura nelle di-verse realtà comunali. Non deve infatti sfuggire che la qualità del progetto sarà tanto più

Accordo MiBAC, RER, Autonomie locali - 193
elevata quanto maggiore risulti l'analisi e la conoscenza dei luoghi in cui si intende inter-venire. Tale conoscenza, infatti, è fondamentale non solo per qualificare gli aspetti com-positivi e architettonici dell'intervento, ma anche per contestualizzarlo correttamente inuno specifico ambito paesistico-ambientale.
Pertanto, la proposta deve essere corredata dagli elementi analitici che permettano lavalutazione della compatibilità e che trovino collocazione in una specifica relazione pae-saggistica-ambientale.
Relazione paesaggistica ambientale
La relazione paesaggistica-ambientale deve indicare:- l'esatta ubicazione dell'opera su base CTR alla medesima scala delle tavole di PRG,
in quanto funzionale alla verifica di conformità dell'intervento alle previsioni dellapianificazione territoriale, paesistica ed urbanistica vigente. A tale scopo, risulta ne-cessario produrre lo stralcio delle corrispondenti tavole del PTPR/PTCP e delPRG/PSC, corredato dalle relative norme prescrittive ed attuative inerenti all’area incui si intende individuare l’intervento;
- la descrizione dell'intervento, con l’evidenziazione dei caratteri tipologici, estetici efunzionali delle opere proposte;
- la descrizione dello stato dei luoghi, dei valori e del contesto paesaggistico interes-sato dall’intervento;
- la descrizione dello stato di progetto dell’area in cui si colloca l’intervento, corredatoda piante, sezioni, prospetti e planivolumetrici dell’opera stessa, con l’indicazionedei materiali e dei cromatismi che si intendono utilizzare;
- la descrizione dei caratteri e i valori del più esteso contesto paesaggisticoambientalein cui si inserisce l'intervento, riconoscibili a partire dagli elaborati cartografici del-l'uso del suolo che individuino le preesistenze naturali, culturali, storiche e paesag-gistiche rinvenibili in un ambito significativo di riferimento. Un supporto a tale neces-saria descrizione è fornito dalla individuazione delle unità di paesaggio in cui ricadel'intervento proposto, rinvenibile nel PTPR ovvero nei PTCP inerenti. Necessariocompletamento alla descrizione del contesto paesaggistico, sarà la ricognizione fo-tografica, da diverse prospettive, dell'area di intervento e degli aspetti più significativie caratterizzanti l’ambito territoriale di riferimento;
- la descrizione degli aspetti di compatibilità dell'opera con le caratteristiche ed il gra-do di tutela operante nell'area considerata e la sua coerenza in relazione ai caratteritipologici, funzionali e estetici del contesto paesistico-ambientale;
- la valutazione dell'entità delle trasformazioni indotte da parte delle opere proposte,comprensive di strutture accessorie e di servizio (strada di accesso, parcheggi, mo-vimentazioni del terreno, ecc.); nei casi più complessi o rilevanti sotto il profilo del-l'entità delle trasformazioni indotte, infine, l'inserimento della opera proposta nelcontesto paesaggistico, urbanistico e ambientale dovrà essere evidenziata da schiz-zi, disegni, fotomontaggi, simulazioni al computer;
- la descrizione delle opere di integrazione e di inserimento paesaggistico eventual-mente previste ;
- la descrizione degli eventuali interventi di compensazione, di riqualificazione e dirafforzamento dell'immagine, dei valori e dell'identità del contesto paesaggistico diriferimento;

194 – Roma, 9 ottobre 2003
- le motivazioni che hanno portato alle scelte progettuali proposte, eventualmente an-che in relazione alle possibili alternative analizzate.
È evidente che l'approfondimento e le caratteristiche della documentazione da pre-sentare a corredo dell'istanza di autorizzazione paesaggistica deve essere rapportata allacomplessità dell'intervento proposto e all'entità dell'eventuale impatto delle trasformazioniipotizzabili sul paesaggio.
Conseguentemente la documentazione sopra richiamata potrà essere sintetizzata informa di scheda progettuale per quanto riguarda le opere di modesto rilievo e di bassoimpatto paesaggistico, ferma restando la necessità che le stesse siano definite puntual-mente all'interno del RUE ovvero in un apposito documento realizzato dalla Commissioneper la qualità architettonica e il paesaggio ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. c), della L. r.n. 31/02.
Si rammenta infine che l'autorizzazione rilasciata, ai fini della compatibilità paesisticacostituisce provvedimento separato e preliminare al rilascio della concessione edilizia.
Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 29 dicembre 200, n. 441, l’autorizzazione paesaggisti-ca rilasciata al termine delle predette valutazioni, e corredata dalla documentazione inbase alla quale il Comune l’ha emanata, deve essere inviata alla Soprintendenza di setto-re competente in materia, per l’esercizio del potere di esame di cui all’art. 151, comma 4,del Testo unico n. 490/99.

Codice dei beni culturali e del paesaggio - 195
Codice dei beni culturali e del paesaggioDecreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42
SOMMARIO
PARTE PRIMA Disposizioni generali
Articolo 1 PrincipiArticolo 2 Patrimonio culturaleArticolo 3 Tutela del patrimonio culturaleArticolo 4 Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturaleArticolo 5 Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in mate-ria di tutela del patrimonio culturaleArticolo 6 Valorizzazione del patrimonio culturaleArticolo 7 Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturaleArticolo 8 Regioni e province ad autonomia specialeArticolo 9 Beni culturali di interesse religioso
PARTE SECONDA Beni culturali
TITOLO I TutelaCapo I Oggetto della tutelaArticolo 10 Beni culturaliArticolo 11 Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutelaArticolo 12 Verifica dell’interesse culturaleArticolo 13 Dichiarazione dell’interesse culturaleArticolo 14 Procedimento di dichiarazioneArticolo 15 Notifica della dichiarazioneArticolo 16 Ricorso amministrativo avverso la dichiarazioneArticolo 17 Catalogazione
Capo II Vigilanza e ispezioneArticolo 18 VigilanzaArticolo 19 Ispezione
Capo III Protezione e conservazioneSezione I Misure di protezioneArticolo 20 Interventi vietatiArticolo 21 Interventi soggetti ad autorizzazioneArticolo 22 Procedimento di autorizzazione per interventi di ediliziaArticolo 23 Procedure edilizie semplificateArticolo 24 Interventi su beni pubbliciArticolo 25 Conferenza di serviziArticolo 26 Valutazione di impatto ambientaleArticolo 27 Situazioni di urgenzaArticolo 28 Misure cautelari e preventive

196 - Decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42
Sezione II Misure di conservazioneArticolo 29 ConservazioneArticolo 30 Obblighi conservativiArticolo 31 Interventi conservativi volontariArticolo 32 Interventi conservativi impostiArticolo 33 Procedura di esecuzione degli interventi conservativi impostiArticolo 34 Oneri per gli interventi conservativi impostiArticolo 35 Intervento finanziario del MinisteroArticolo 36 Erogazione del contributoArticolo 37 Contributo in conto interessiArticolo 38 Apertura al pubblico degli immobili oggetto di interventi conservativiArticolo 39 Interventi conservativi su beni dello StatoArticolo 40 Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti pubbliciterritorialiArticolo 41 Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservatidalle amministrazioni stataliArticolo 42 Conservazione degli archivi storici di organi costituzionaliArticolo 43 Custodia coattivaArticolo 44 Comodato e deposito di beni culturali
Sezione III Altre forme di protezioneArticolo 45 Prescrizioni di tutela indirettaArticolo 46 Procedimento per la tutela indirettaArticolo 47 Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativoArticolo 48 Autorizzazione per mostre ed esposizioniArticolo 49 Manifesti e cartelli pubblicitariArticolo 50 Distacco di beni culturaliArticolo 51 Studi d’artistaArticolo 52 Esercizio del commercio in aree di valore culturale
Capo IV Circolazione in ambito nazionaleSezione I Alienazione e altri modi di trasmissioneArticolo 53 Beni del demanio culturaleArticolo 54 Beni inalienabiliArticolo 55 Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturaleArticolo 56 Altre alienazioni soggette ad autorizzazioneArticolo 57 Regime dell’autorizzazione ad alienareArticolo 58 Autorizzazione alla permutaArticolo 59 Denuncia di trasferimento
Sezione II PrelazioneArticolo 60 Acquisto in via di prelazioneArticolo 61 Condizioni della prelazioneArticolo 62 Procedimento per la prelazione
Sezione III CommercioArticolo 63 Obbligo di denuncia dell’attività commerciale e di tenuta del registro.Obbligo di denuncia della vendita o dell’acquisto di documenti

Codice dei beni culturali e del paesaggio - 197
Articolo 64 Attestati di autenticità e di provenienza
Capo V Circolazione in ambito internazionaleSezione I Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionaleArticolo 65 Uscita definitivaArticolo 66 Uscita temporanea per manifestazioniArticolo 67 Altri casi di uscita temporaneaArticolo 68 Attestato di libera circolazioneArticolo 69 Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestatoArticolo 70 Acquisto coattivoArticolo 71 Attestato di circolazione temporaneaArticolo 72 Ingresso nel territorio nazionale
Sezione II Esportazione dal territorio dell’Unione europeaArticolo 73 DenominazioniArticolo 74 Esportazione di beni culturali dal territorio dell’Unione europea
Sezione III Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di unoStato membro dell’Unione europeaArticolo 75 RestituzioneArticolo 76 Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell’UnioneeuropeaArticolo 77 Azione di restituzioneArticolo 78 Termini di decadenza e di prescrizione dell’azioneArticolo 79 IndennizzoArticolo 80 Pagamento dell’indennizzoArticolo 81 Oneri per l’assistenza e la collaborazioneArticolo 82 Azione di restituzione a favore dell’ItaliaArticolo 83 Destinazione del bene restituitoArticolo 84 Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionaleArticolo 85 Banca dati dei beni culturali illecitamente sottrattiArticolo 86 Accordi con gli altri Stati membri dell’Unione europea
Sezione IV Convenzione UNIDROITArticolo 87 Beni culturali rubati o illecitamente esportati
Capo VI Ritrovamenti e scoperteSezione I Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell’ambito del territorio nazionale Arti-colo 88 Attività di ricercaArticolo 89 Concessione di ricercaArticolo 90 Scoperte fortuiteArticolo 91 Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovateArticolo 92 Premio per i ritrovamentiArticolo 93 Determinazione del premio
Sezione II Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territorialeArticolo 94 Convenzione UNESCO

198 - Decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42
Capo VII Espropriazione Articolo 95 Espropriazione di beni culturaliArticolo 96 Espropriazione per fini strumentaliArticolo 97 Espropriazione per interesse archeologicoArticolo 98 Dichiarazione di pubblica utilitàArticolo 99 Indennità di esproprio per i beni culturaliArticolo 100 Rinvio a norme generaliTITOLO II Fruizione e valorizzazioneCapo I Fruizione dei beni culturaliSezione I Principi generaliArticolo 101 Istituti e luoghi della culturaArticolo 102 Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pub-blicaArticolo 103 Accesso agli istituti ed ai luoghi della culturaArticolo 104 Fruizione di beni culturali di proprietà privataArticolo 105 Diritti di uso e godimento pubblico
Sezione II Uso dei beni culturaliArticolo 106 Uso individuale di beni culturaliArticolo 107 Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturaliArticolo 108 Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzioneArticolo 109 Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturaliArticolo 110 Incasso e riparto di proventi
Capo II Principi della valorizzazione dei beni culturali …Articolo 111 Attività di valorizzazioneArticolo 112 Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblicaArticolo 113 Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privataArticolo 114 Livelli di qualità della valorizzazioneArticolo 115 Forme di gestioneArticolo 116 Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in usoArticolo 117 Servizi aggiuntiviArticolo 118 Promozione di attività di studio e ricercaArticolo 119 Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuoleArticolo 120 Sponsorizzazione di beni culturaliArticolo 121 Accordi con le fondazioni bancarie
Capo III Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza Arti-colo 122 Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei do-cumentiArticolo 123 Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità deidocumenti riservatiArticolo 124 Consultabilità a scopi storici degli archivi correntiArticolo 125 Declaratoria di riservatezzaArticolo 126 Protezione di dati personaliArticolo 127 Consultabilità degli archivi privati
TITOLO III Norme transitorie e finaliArticolo 128 Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente

Codice dei beni culturali e del paesaggio - 199
Articolo 129 Provvedimenti legislativi particolariArticolo 130 Disposizioni regolamentari precedenti
PARTE TERZA Beni paesaggistici
TITOLO I Tutela e valorizzazioneCapo I Disposizioni generaliArticolo 131 Salvaguardia dei valori del paesaggioArticolo 132 Cooperazione tra amministrazioni pubblicheArticolo 133 Convenzioni internazionaliArticolo 134 Beni paesaggisticiArticolo 135 Pianificazione paesaggistica
Capo II Individuazione dei beni paesaggisticiArticolo 136 Immobili ed aree di notevole interesse pubblicoArticolo 137 Commissioni provincialiArticolo 138 Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblicoArticolo 139 Partecipazione al procedimento di dichiarazione di notevole interes-se pubblicoArticolo 140 Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di co-noscenzaArticolo 141 Provvedimenti ministerialiArticolo 142 Aree tutelate per legge
Capo III Pianificazione paesaggisticaArticolo 143 Piano paesaggisticoArticolo 144 Pubblicità e partecipazioneArticolo 145 Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumentidi pianificazione
Capo IV Controllo e gestione dei beni soggetti a tutelaArticolo 146 AutorizzazioneArticolo 147 Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni sta-taliArticolo 149 Interventi non soggetti ad autorizzazioneArticolo 150 Inibizione o sospensione dei lavoriArticolo 151 Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavoriArticolo 152 Interventi soggetti a particolari prescrizioniArticolo 153 Cartelli pubblicitariArticolo 154 Colore delle facciate dei fabbricatiArticolo 155 Vigilanza
Capo V Disposizioni di prima applicazione e transitorieArticolo 156 Verifica e adeguamento dei piani paesaggisticiArticolo 157 Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi aisensi della normativa previgenteArticolo 158 Disposizioni regionali di attuazione

200 - Decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42
Articolo 159 Procedimento di autorizzazione in via transitoria
PARTE QUARTA Sanzioni
TITOLO I Sanzioni amministrativeCapo I Sanzioni relative alla Parte secondaArticolo 160 Ordine di reintegrazioneArticolo 161 Danno a cose ritrovateArticolo 162 Violazioni in materia di affissioneArticolo 163 Perdita di beni culturaliArticolo 164 Violazioni in atti giuridiciArticolo 165 Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionaleArticolo 166 Omessa restituzione di documenti per l’esportazione
Capo II Sanzioni relative alla Parte terzaArticolo 167 Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecu-niariaArticolo 168 Violazione in materia di affissione
TITOLO II Sanzioni penaliCapo I Sanzioni relative alla Parte secondaArticolo 169 Opere illeciteArticolo 170 Uso illecitoArticolo 171 Collocazione e rimozione illecitaArticolo 172 Inosservanza delle prescrizioni di tutela indirettaArticolo 173 Violazioni in materia di alienazioneArticolo 174 Uscita o esportazione illeciteArticolo 175 Violazioni in materia di ricerche archeologicheArticolo 176 Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo StatoArticolo 177 Collaborazione per il recupero di beni culturaliArticolo 178 Contraffazione di opere d’arteArticolo 179 Casi di non punibilitàArticolo 180 Inosservanza dei provvedimenti amministrativi
Capo II Sanzioni relative alla Parte terzaArticolo 181 Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa
PARTE QUINTA Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata invigoreArticolo 182 Disposizioni transitorieArticolo 183 Disposizioni finaliArticolo 184 Norme abrogate

Codice dei beni culturali e del paesaggio - 201
DECRETO LEGISLATIVO recante il “CODICE DEI BENI CULTURALIE DEL PAESAGGIO”, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002,n. 137.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVISTI gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per ibeni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, esuccessive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante Testo unico delle disposizio-ni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8ottobre 1997, n. 352;
VISTO l’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del29 settembre 2003;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo28 agosto 1997, n. 281;
ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e dellaCamera dei deputati;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio2004;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro pergli affari regionali;
EMANAil seguente decreto legislativo:
Art. 1.1. E’ approvato l’unito codice dei beni culturali e del paesaggio, composto di 184 articoli edell’allegato A, vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficialedegli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osser-varlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì …

202 - Decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42
PARTE PRIMA Disposizioni generali
Articolo 1Principi
1. In attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patri-monio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all’articolo 117 della Costituzione esecondo le disposizioni del presente codice.2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la me-moria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultu-ra.3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sosten-gono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e lavalorizzazione.4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conserva-zione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturalesono tenuti a garantirne la conservazione.6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonioculturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.
Articolo 2Patrimonio culturale
1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, pre-sentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e biblio-grafico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianzeaventi valore di civiltà.3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all’articolo 134, costituentiespressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e glialtri beni individuati dalla legge o in base alla legge.4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizionedella collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non viostino ragioni di tutela.
Articolo 3Tutela del patrimonio culturale
1. La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette,sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonioculturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.2. L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti aconformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

Codice dei beni culturali e del paesaggio - 203
Articolo 4Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale
1. Al fine di garantire l’esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell’articolo 118della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attivitàculturali, di seguito denominato «Ministero», che le esercita direttamente o ne può confe-rire l’esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell’articolo 5,commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi dei commi 2 e6 del medesimo articolo 5.2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale an-che se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.
Articolo 5Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali
in materia di tutela del patrimonio culturale
1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati«altri enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell’esercizio delle funzioni ditutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codi-ce.2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti,autografi, carteggi, documenti, incunaboli, raccolte librarie non appartenenti allo Stato onon sottoposte alla tutela statale, nonché libri, stampe e incisioni non appartenenti alloStato, sono esercitate dalle regioni.3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di se-guito denominata «Conferenza Stato-regioni», le regioni possono esercitare le funzioni ditutela anche su raccolte librarie private, nonché su carte geografiche, spartiti musicali,fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non ap-partenenti allo Stato.4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed ade-guatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutelacon le regioni che ne facciano richiesta.5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altrienti pubblici territoriali.6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono conferite alle regionisecondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice.7. Relativamente alle funzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le pote-stà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadem-pienza.
Articolo 6 Valorizzazione del patrimonio culturale
1. La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attivitàdirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le miglioricondizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprendeanche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio cultu-rale.2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarnele esigenze.

204 - Decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o as-sociati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.
Articolo 7 Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale
1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimo-nio culturale. Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano la propria potestà legislativa.2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento,l’armonizzazione e l’integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.
Articolo 8 Regioni e province ad autonomia speciale
1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alleregioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti edalle relative norme di attuazione.
Articolo 9 Beni culturali di interesse religioso
1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesacattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le re-gioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d’accordo con le rispettive autori-tà.2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell’articolo12 dell’Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984,ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanatesulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, aisensi dell’articolo 8, comma 3, della Costituzione.
PARTE SECONDABeni culturali
TITOLO ITutela
Capo IOggetto della tutela
Articolo 10Beni culturali
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, aglialtri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giu-ridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologi-co o etnoantropologico.2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delleregioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

Codice dei beni culturali e del paesaggio - 205
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubbliciterritoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubbli-ci territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico.3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologicoo etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelliindicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse sto-rico particolarmente importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse
particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare,della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identitàe della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, famae particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interes-se artistico o storico.4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; b) le cose di interesse numismatico; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le
incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio; d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio; e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i
supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio; f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o
storico;h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
l) le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologicoquali testimonianze dell’economia rurale tradizionale.5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del pre-sente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano operadi autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
Articolo 11 Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela
1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 10, qualora ne ricorrano presupposti e condizio-ni, sono beni culturali, in quanto oggetto di specifiche disposizioni del presente Titolo:
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri or-namenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all’articolo 50, comma 1;
b) gli studi d’artista, di cui all’articolo 51;c) le aree pubbliche di cui all’articolo 52;d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vi-
vente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, di cui agli articoli 64 e 65;e) le opere dell’architettura contemporanea di particolare valore artistico, di cui

206 - Decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42
all’articolo 37;f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografi-
che, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manife-stazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venti-cinque anni, di cui all’articolo 65;
g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, di cui agli articoli 65 e 67,comma 2;
h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventipiù di cinquanta anni, di cui all’articolo 65;
i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimoniostorico della Prima guerra mondiale, di cui all’articolo 50, comma 2.
Articolo 12 Verifica dell’interesse culturale
1. Le cose immobili e mobili indicate all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autorenon più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alledisposizioni del presente Titolo fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui alcomma 2.2. I competenti organi del Ministero, d’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui lecose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenzadell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al com-ma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine diassicurare uniformità di valutazione.3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi deibeni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le mo-dalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sonostabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l’Agenzia del demanio e, per ibeni immobili in uso all’amministrazione della difesa, anche con il concerto della compe-tente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, icriteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, edella relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l’interesse di cui alcomma 2, le cose medesime sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del pre-sente Titolo.5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato,delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è tra-smessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione qualora, se-condo le valutazioni dell’amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubbli-co interesse.6. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4 per le quali si sia proceduto allasdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.7. L’accertamento dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, ef-fettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione aisensi dell’articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall’articolo15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Tito-lo.8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esitopositivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio in-formatico accessibile al Ministero e all’Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggiodel patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive

Codice dei beni culturali e del paesaggio - 207
competenze istituzionali.9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anchequalora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridi-ca.10. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 27, commi 8, 10, 12, 13 e 13-bis, del de-creto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 no-vembre 2003, n. 226.
Articolo 13 Dichiarazione dell’interesse culturale
1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto,dell’interesse richiesto dall’articolo 10, comma 3.2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all’articolo 10, comma 2. Tali benirimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino inqualunque modo la loro natura giuridica.
Articolo 14 Procedimento di dichiarazione
1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale,anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dan-done comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosache ne forma oggetto.2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosarisultanti dalle prime indagini, l’indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonchél’indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione dieventuali osservazioni.3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche alcomune o alla città metropolitana.4. La comunicazione comporta l’applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previstedal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento didichiarazione, che il Ministero stabilisce a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 7agosto 1990, n. 241.6. La dichiarazione dell’interesse culturale è adottata dal Ministero.
Articolo 15 Notifica della dichiarazione
1. La dichiarazione prevista dall’articolo 13 è notificata al proprietario, possessore o de-tentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o amezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento didichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha effica-cia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

208 - Decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42
Articolo 16Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione
1. Avverso la dichiarazione di cui all’articolo 13 è ammesso ricorso al Ministero, per mo-tivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione.2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimentoimpugnato. Rimane ferma l’applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dalCapo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.3. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il terminedi novanta giorni dalla presentazione dello stesso.4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l’atto impugnato.5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre1971, n. 1199.
Articolo 17Catalogazione
1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura lacatalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività.2. Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. Atal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comu-ni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integra-zione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle università, concorrono alladefinizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema dimetodologie di catalogazione e inventariazione.4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, con le modalità di cui al decretoministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione dei beni culturali loro apparte-nenti e, previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali.5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali.6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai sensi dell’articolo 13è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.
Capo IIVigilanza e ispezione
Articolo 18Vigilanza
1. La vigilanza sui beni culturali compete al Ministero.2. La vigilanza sulle cose indicate all’articolo 12, comma 1, di appartenenza statale, dachiunque siano tenute in uso o in consegna, è esercitata direttamente dal Ministero. Perl’esercizio dei poteri di vigilanza sulle cose indicate all’articolo 12, comma 1, appartenentialle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero procede anche mediante formedi intesa e di coordinamento con le regioni.
Articolo 19Ispezione
1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cin-

Codice dei beni culturali e del paesaggio - 209
que giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l’esistenzae lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali.
Capo IIIProtezione e conservazione
Sezione IMisure di protezione
Articolo 20Interventi vietati
1. I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibilicon il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conserva-zione.2. Gli archivi non possono essere smembrati.
Articolo 21Interventi soggetti ad autorizzazione
1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:a) la demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche con successiva ricosti-
tuzione;b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali, salvo quanto previsto ai
commi 2 e 3;c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia
intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’articolo 13;e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazio-
ne di archivi pubblici, nonché di archivi di soggetti giuridici privati.2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede deldetentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dalricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subi-scano danno dal trasporto.3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non èsoggetto ad autorizzazione.4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l’esecuzione di opere e lavori di qualunquegenere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente.5. L’autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnicadell’intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni.
Articolo 22Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l’autorizzazione prevista dall’articolo 21,comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro iltermine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza.2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termi-ne indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta.3. Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva

210 - Decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42
comunicazione al richiedente, il termine indicato al comma 1 è sospeso finoall’acquisizione delle risultanze degli accertamenti d’ufficio e comunque per non più ditrenta giorni.4. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può diffidarel’amministrazione a provvedere. La richiesta di autorizzazione si intende accolta ovel’amministrazione non provveda nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida.
Articolo 23Procedure edilizie semplificate
1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell’articolo 21 necessitino anche di titolo abi-litativo in materia edilizia, è possibile il ricorso alla denuncia di inizio attività, nei casi pre-visti dalla legge. A tal fine l’interessato, all’atto della denuncia, trasmette al comunel’autorizzazione conseguita, corredata dal relativo progetto.
Articolo 24Interventi su beni pubblici
1. Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazionidello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed isti-tuto pubblico, l’autorizzazione necessaria ai sensi dell’articolo 21 può essere espressanell’ambito di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato.
Articolo 25Conferenza di servizi
1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra allaconferenza di servizi, l’autorizzazione necessaria ai sensi dell’articolo 21 è rilasciata inquella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita alverbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizza-zione del progetto.2. Qualora l’organo ministeriale esprima motivato dissenso, l’amministrazione procedentepuò richiedere la determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Con-siglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.3. Il destinatario della determinazione conclusiva favorevole adottata in conferenza diservizi informa il Ministero dell’avvenuto adempimento delle prescrizioni da quest’ultimoimpartite.
Articolo 26Valutazione di impatto ambientale
1. Per i progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale,l’autorizzazione prevista dall’articolo 21 è espressa dal Ministero in sede di concerto perla pronuncia sulla compatibilità ambientale, sulla base del progetto definitivo da pre-sentarsi ai fini della valutazione medesima.2. Qualora dall’esame del progetto effettuato a norma del comma 1 risulti che l’opera nonè in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali essaè destinata ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazioneal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. In tal caso, la procedura di valuta-zione di impatto ambientale si considera conclusa negativamente.

Codice dei beni culturali e del paesaggio - 211
3. Se nel corso dei lavori risultano comportamenti contrastanti con l’autorizzazioneespressa nelle forme di cui al comma 1, tali da porre in pericolo l’integrità dei beni cultu-rali soggetti a tutela, il soprintendente ordina la sospensione dei lavori.
Articolo 27Situazioni di urgenza
1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indi-spensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazio-ne alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventidefinitivi per la necessaria autorizzazione.
Articolo 28Misure cautelari e preventive
1. Il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il dispostodegli articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero condotti in difformità dall’autorizzazione.2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l’inibizione o la sospensione diinterventi relativi alle cose indicate nell’articolo 10, anche quando per esse non siano an-cora intervenute la verifica di cui all’articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cuiall’articolo 13.3. L’ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione delmedesimo, non è comunicato, a cura del soprintendente, l’avvio del procedimento di veri-fica o di dichiarazione.4. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico,anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all’articolo 12, comma 2, ola dichiarazione di cui all’articolo 13, il soprintendente può richiedere l’esecuzione di sag-gi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente dell’opera pubbli-ca.
Sezione IIMisure di conservazione
Articolo 29 Conservazione
1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coor-dinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni dirischio connesse al bene culturale nel suo contesto.3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati alcontrollo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell’integrità,dell’efficienza funzionale e dell’identità del bene e delle sue parti.4. Per restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di opera-zioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezioneed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zonedichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprendel’intervento di miglioramento strutturale.5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delleuniversità e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri emodelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.

212 - Decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione diopere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturalimobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloroche sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività com-plementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle su-perfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato aisensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d’intesa con la Con-ferenza Stato-regioni.8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400del 1988 di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previoparere della Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si ade-gua l’insegnamento del restauro.9. L’insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studioistituite ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché daicentri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato.Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400del 1988 di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previoparere della Conferenza Stato-regioni, sono individuati le modalità di accreditamento, irequisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, lemodalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell’esame finale, cuipartecipa almeno un rappresentante del Ministero, nonché le caratteristiche del corpodocente.10. La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al re-stauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensidella normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti conaccordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo28 agosto 1997, n. 281.11. Mediante appositi accordi o intese il Ministero e le regioni, anche con il concorsodelle università e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente cen-tri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività diricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conserva-zione e restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centri possonoessere altresì istituite, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l’insegnamentodel restauro.
Articolo 30Obblighi conservativi
1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istitutopubblico hanno l’obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali diloro appartenenza.2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro fissanoi beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di lorodestinazione nel modo indicato dal soprintendente.3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne laconservazione.4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l’obbligo di conservare i propri archivi nella loroorganicità e di ordinarli, nonché di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai docu-menti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni. Allo stesso obbligo sono assog-gettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia

Codice dei beni culturali e del paesaggio - 213
intervenuta la dichiarazione di cui all’articolo 13.
Articolo 31Interventi conservativi volontari
1. Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario,possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell’articolo 21.2. In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell’interessato,sull’ammissibilità dell’intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certificaeventualmente il carattere necessario dell’intervento stesso ai fini della concessione delleagevolazioni tributarie previste dalla legge.
Articolo 32Interventi conservativi imposti
1. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli in-terventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervidirettamente.2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli obblighi di cui all’articolo 30,comma 4.
Articolo 33Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti
1. Ai fini dell’articolo 32 il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la ne-cessità degli interventi da eseguire.2. La relazione tecnica è inviata, insieme alla comunicazione di avvio del procedimento,al proprietario, possessore o detentore del bene, che può far pervenire le sue osserva-zioni entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l’esecuzione diretta degli interventi, asse-gna al proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del progettoesecutivo delle opere da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.4. Il progetto presentato è approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni econ la fissazione del termine per l’inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto presen-tato è trasmesso dalla soprintendenza al comune o alla città metropolitana, che possonoesprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all’obbligo di pre-sentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del soprin-tendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto è respinto, si procede conl’esecuzione diretta.6. In caso di urgenza, il soprintendente può adottare immediatamente le misure conser-vative necessarie.
Articolo 34Oneri per gli interventi conservativi imposti
1. Gli oneri per gli interventi su beni culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministeroai sensi dell’articolo 32, sono a carico del proprietario, possessore o detentore. Tuttavia,se gli interventi sono di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o godi-mento pubblico, il Ministero può concorrere in tutto o in parte alla relativa spesa. In tal

214 - Decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42
caso, determina l’ammontare dell’onere che intende sostenere e ne dà comunicazioneall’interessato.2. Se le spese degli interventi sono sostenute dal proprietario, possessore o detentore, ilMinistero provvede al loro rimborso, anche mediante l’erogazione di acconti ai sensidell’articolo 36, commi 2 e 3, nei limiti dell’ammontare determinato ai sensi del comma 1.3. Per le spese degli interventi sostenute direttamente, il Ministero determina la sommada porre a carico del proprietario, possessore o detentore, e ne cura il recupero nelleforme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimonialidello Stato.
Articolo 35Intervento finanziario del Ministero
1. Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore odetentore del bene culturale per l’esecuzione degli interventi previsti dall’articolo 31,comma 1, per un ammontare non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sonodi particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero puòconcorrere alla spesa fino al suo intero ammontare.2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi sugli archivi storici previ-sti dall’articolo 30, comma 4.3. Per la determinazione della percentuale del contributo di cui al comma 1 si tiene contodi altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano statiottenuti benefici fiscali.
Articolo 36Erogazione del contributo
1. Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effetti-vamente sostenuta dal beneficiario.2. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori rego-larmente certificati.3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sonostati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti. Per il recupero delle relative somme siprovvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle en-trate patrimoniali dello Stato.
Articolo 37 Contributo in conto interessi
1. Il Ministero può concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti dicredito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali immobili perla realizzazione degli interventi conservativi autorizzati.2. Il contributo è concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolatiad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato a titolo di mutuo.3. Il contributo è corrisposto direttamente dal Ministero all’istituto di credito secondo mo-dalità da stabilire con convenzioni.4. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso anche per interventi conservativisu opere di architettura contemporanea di cui il soprintendente abbia riconosciuto, su ri-chiesta del proprietario, il particolare valore artistico.

Codice dei beni culturali e del paesaggio - 215
Articolo 38Apertura al pubblico degli immobili oggetto di interventi conservativi
1. Gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totaleo parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto in-teressi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da ap-positi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all’atto dellaassunzione dell’onere della spesa ai sensi dell’articolo 34 o della concessione del contri-buto ai sensi dell’articolo 35.2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell’obbligo di apertura alpubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degliimmobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del so-printendente, al comune o alla città metropolitana nel cui territorio si trovano gli immobili.
Articolo 39Interventi conservativi su beni dello Stato
1. Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei beni culturali di appartenenzastatale, anche se in consegna o in uso ad amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sen-titi i medesimi.2. Salvo che non sia diversamente concordato, la progettazione e l’esecuzione degli in-terventi di cui al comma 1, relativi a beni immobili, sono assunte dall’amministrazione odal soggetto medesimi, ferma restando la competenza del Ministero al rilasciodell’autorizzazione sul progetto ed alla vigilanza sui lavori.3. Per l’esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a beni immobili, il Ministerotrasmette il progetto e comunica l’inizio dei lavori al comune o alla città metropolitana.
Articolo 40Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali
1. Per i beni culturali appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, le misurepreviste dall’articolo 32 sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordicon l’ente interessato.2. Gli accordi possono riguardare anche i contenuti delle prescrizioni di cui all’articolo30, comma 2.3. Gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono lo Stato, le regioni e glialtri enti pubblici territoriali nonché altri soggetti pubblici e privati, sono ordinariamenteoggetto di preventivi accordi programmatici.
Articolo 41Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti
conservati dalle amministrazioni statali
1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all’archivio centrale delloStato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant’anni,unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estra-zione sono versate settant’anni dopo l’anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gliarchivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l’esercizio profes-sionale anteriormente all’ultimo centennio.2. Il soprintendente all’archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato pos-

216 - Decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42
sono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersioneo di danneggiamento.3. Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni discarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versatiall’archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda ne-cessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni, delle quali fannoparte rappresentanti del Ministero e del Ministero dell’interno, con il compito di vigilaresulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione deicriteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti dicui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di naturariservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati condecreto adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministrodell’interno, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gliscarti sono autorizzati dal Ministero.6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero per gli affari esteri;non si applicano altresì agli stati maggiori dell’esercito, della marina e dell’aeronautica perquanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo.
Articolo 42Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali
1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico,secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica con proprio decreto,su proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stessodecreto sono stabilite le modalità di consultazione e di accesso agli atti conservati pressol’archivio storico della Presidenza della Repubblica.2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso ilproprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza.3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondole disposizioni stabilite con regolamento adottato ai sensi della vigente normativa in mate-ria di costituzione e funzionamento della Corte medesima.
Articolo 43Custodia coattiva
1. Il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istitutii beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione aisensi dell’articolo 29.
Articolo 44Comodato e deposito di beni culturali
1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o in deposito rac-colte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono riceverein comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo ministeriale,beni culturali mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della collettività, qualora sitratti di beni di particolare importanza o che rappresentino significative integrazioni dellecollezioni pubbliche e purché la loro custodia presso i pubblici istituti non risulti partico-larmente onerosa.

Codice dei beni culturali e del paesaggio - 217
2. Il comodato non può avere durata inferiore a cinque anni e si intende prorogato taci-tamente per un periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti nonabbia comunicato all’altra la disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine.Anche prima della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato.3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione dei beni ricevuti incomodato, dandone comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico delMinistero.4. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico del Ministero.5. I direttori possono ricevere altresì in deposito, previo assenso del competente organoministeriale, beni culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e cu-stodia specificamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti.6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposi-zioni in materia di comodato e di deposito.
Sezione IIIAltre forme di protezione
Articolo 45Prescrizioni di tutela indiretta
1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette adevitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiatala prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47,sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono leprescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.
Articolo 46Procedimento per la tutela indiretta
1. Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su motivata ri-chiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, dandone comunicazioneal proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile cui le prescrizioni siriferiscono. Se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile orisulta particolarmente gravosa, il soprintendente comunica l’avvio del procedimento me-diante idonee forme di pubblicità.2. La comunicazione di avvio del procedimento individua l’immobile in relazione al qualesi intendono adottare le prescrizioni di tutela indiretta e indica i contenuti essenziali di taliprescrizioni.3. Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune o allacittà metropolitana.4. La comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea immodificabilitàdell’immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nellacomunicazione stessa.5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del relativo procedi-mento, stabilito dal Ministero ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990,n. 241.

218 - Decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42
Articolo 47Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo
1. Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è notificato al proprieta-rio, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo co-munale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.2. Il provvedimento è trascritto nei registri immobiliari e hanno efficacia nei confronti diogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili cuile prescrizioni stesse si riferiscono.3. Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è ammesso ricor-so amministrativo ai sensi dell’articolo 16. La proposizione del ricorso, tuttavia, non com-porta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
Articolo 48Autorizzazione per mostre ed esposizioni
1. E’ soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni:a) delle cose mobili indicate nell’articolo 12, comma 1;b) dei beni mobili indicati nell’articolo 10, comma 1;c) dei beni mobili indicati all’articolo 10, comma 3, lettere a), ed e);d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all’articolo 10, comma
2, lettera a), delle raccolte librarie indicate all’articolo 10, commi 2, lettera c), e3, lettera c), nonché degli archivi e dei singoli documenti indicati all’articolo 10,commi 2, lettera b), e 3, lettera b).
2. Qualora l’autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti atutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell’iniziodella manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.3. L’autorizzazione è rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e,per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa è su-bordinata all’adozione delle misure necessarie per garantirne l’integrità. I criteri, le proce-dure e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione medesima sono stabiliti con decretoministeriale.4. Il rilascio dell’autorizzazione è inoltre subordinato all’assicurazione delle cose e deibeni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica dellasua congruità da parte del Ministero.5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, conla partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l’assicurazione prevista al comma 4può essere sostituita dall’assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanziastatale è rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con de-creto ministeriale, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze. Ai corrispondenti one-ri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell’ambito del fondo di riser-va per le spese obbligatorie e d’ordine istituito nello stato di previsione della spesa delMinistero dell’economia e delle finanze.6. Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a richiesta dell’interessato, il rilevante interesseculturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa acarattere culturale, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fi-scale.

Codice dei beni culturali e del paesaggio - 219
Articolo 49Manifesti e cartelli pubblicitari
1. E’ vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nellearee tutelati come beni culturali. Il soprintendente può, tuttavia, autorizzare il colloca-mento o l’affissione quando non ne derivi danno all’aspetto, al decoro e alla pubblica frui-zione di detti edifici ed aree. L’autorizzazione è trasmessa al comune ai fini dell’eventualerilascio del provvedimento autorizzativo di competenza.2. Lungo le strade site nell’ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietatocollocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dellanormativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, pre-vio parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o dellatipologia del mezzo di pubblicità con l’aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei benitutelati.3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilitàcon il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l’assenso per l’utilizzoa fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l’esecuzione degli interventidi conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richie-sta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori mede-simi.
Articolo 50Distacco di beni culturali
1. E’ vietato, senza l’autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distaccodi affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti, esposti o nonalla pubblica vista.2. E’ vietato, senza l’autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distaccodi stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti,costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.

220 - Decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42
Articolo 51Studi d’artista
1. E’ vietato modificare la destinazione d’uso degli studi d’artista nonché rimuoverne ilcontenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nelsuo insieme ed in relazione al contesto in cui è inserito, sia dichiarato di interesse parti-colarmente importante per il suo valore storico, ai sensi dell’articolo 13.2. E’ altresì vietato modificare la destinazione d’uso degli studi d’artista rispondenti allatradizionale tipologia a lucernario e adibiti a tale funzione da almeno vent’anni.
Articolo 52Esercizio del commercio in aree di valore culturale
1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina rela-tiva al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pub-bliche aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali vietare o sot-toporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio.
Capo IVCircolazione in ambito nazionale
Sezione IAlienazione e altri modi di trasmissione
Articolo 53Beni del demanio culturale
1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali cherientrino nelle tipologie indicate all’articolo 822 del codice civile costituiscono il demanioculturale.2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di dirittia favore di terzi, se non nei modi previsti dal presente codice.
Articolo 54Beni inalienabili
1. Sono inalienabili i beni culturali demaniali di seguito indicati:a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;b) gli immobili riconosciuti monumenti nazionali con atti aventi forza di legge;c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;d) gli archivi.
2. Sono altresì inalienabili:a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati all’articolo 10,
comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione ri-salga ad oltre cinquanta anni, fino a quando non sia intervenuta, ove neces-sario, la sdemanializzazione a seguito del procedimento di verifica previstodall’articolo 12;
b) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non ri-salga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggettidi cui all’articolo 53;

Codice dei beni culturali e del paesaggio - 221
c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all’articolo 53, nonché gliarchivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicatial medesimo articolo 53;
d) le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all’articolo 53 dichiarate diinteresse particolarmente importante quali testimonianze dell’identità e dellastoria delle istituzioni pubbliche, collettive, religiose, ai sensi dell’articolo 10,comma 3, lettera d).
3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra loStato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali.4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente se-condo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.
Articolo 55Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale
1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quellielencati nell’articolo 54, commi 1 e 2, non possono essere alienati senza l’autorizzazionedel Ministero.2. L’autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata a condizione che:
a) l’alienazione assicuri la tutela e la valorizzazione dei beni, e comunque non nepregiudichi il pubblico godimento;
b) nel provvedimento di autorizzazione siano indicate destinazioni d’uso compati-bili con il carattere storico ed artistico degli immobili e tali da non recare dannoalla loro conservazione.
3. L’autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione dei beni culturali cui essasi riferisce. Tali beni restano sottoposti a tutela ai sensi dell’articolo 12, comma 6.
Articolo 56Altre alienazioni soggette ad autorizzazione
1. E’ altresì soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero:a) l’alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti
pubblici territoriali, e diversi da quelli indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55,comma 1.
b) l’alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelliindicati alla lettera a) o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ad ec-cezione delle cose e dei beni indicati all’articolo 54, comma 2, lettere a) e c).
2. L’autorizzazione è richiesta anche nel caso di vendita parziale, da parte dei soggettidi cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librarie.3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e dipegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l’alienazione dei beni culturali iviindicati.4. Gli atti che comportano l’alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi compresele cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.
Articolo 57Regime dell’autorizzazione ad alienare
1. La richiesta di autorizzazione ad alienare è presentata dall’ente cui i beni appartengo-no ed è corredata dalla indicazione della destinazione d’uso in atto e dal programma de-gli interventi conservativi necessari.

222 - Decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42
2. Relativamente ai beni di cui all’articolo 55, comma 1, l’autorizzazione può essere rila-sciata dal Ministero su proposta delle soprintendenze, sentita la regione e, per suo tra-mite, gli altri enti pubblici territoriali interessati, alle condizioni stabilite al comma 2 delmedesimo articolo 55. Le prescrizioni e le condizioni contenute nel provvedimento di au-torizzazione sono riportate nell’atto di alienazione.3. Il bene alienato non può essere assoggettato ad interventi di alcun genere senza cheil relativo progetto sia stato preventivamente autorizzato ai sensi dell’articolo 21, comma4.4. Relativamente ai beni di cui all’articolo 56, comma 1, lettera a), e ai beni degli enti edistituti pubblici di cui all’articolo 56, comma 1, lettera b) e comma 2, l’autorizzazione puòessere rilasciata qualora i beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubblichee dall’alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato ilpubblico godimento.5. Relativamente ai beni di cui all’articolo 56, comma 1, lettera b) e comma 2, di proprietàdi persone giuridiche private senza fine di lucro, l’autorizzazione può essere rilasciataqualora dalla alienazione non derivi un grave danno alla conservazione o al pubblico go-dimento dei beni medesimi.
Articolo 58Autorizzazione alla permuta
1. Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni indicati agli articoli 55 e 56 nonché disingoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti eprivati, anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonioculturale nazionale ovvero l’arricchimento delle pubbliche raccolte.
Articolo 59Denuncia di trasferimento
1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la deten-zione di beni culturali sono denunciati al Ministero.2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:
a) dall’alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso ogratuito o di trasferimento della detenzione;
b) dall’acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell’ambito di procedure di ven-dita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di uncontratto di alienazione non concluso;
c) dall’erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l’erede, iltermine decorre dall’accettazione dell’eredità o dalla presentazione della dichiara-zione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dall’aperturadella successione, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.
3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano ibeni.4. La denuncia contiene:
a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappre-sentanti legali;
b) i dati identificativi dei beni ;c) l’indicazione del luogo ove si trovano i beni;d) l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento;e) l’indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni
previste dal presente Titolo.

Codice dei beni culturali e del paesaggio - 223
5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 ocon indicazioni incomplete o imprecise.
Sezione IIPrelazione
Articolo 60 Acquisto in via di prelazione
1. Il Ministero o, nel caso previsto dall’articolo 62, comma 3, la regione o l’altro ente pub-blico territoriale interessato, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturalialienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione.2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza pre-visione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico èdeterminato d’ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma 1.3. Ove l’alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata ai sensi del com-ma 2, il valore economico della cosa è stabilito da un terzo, designato concordementedall’alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano perla nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia onon possa accettare l’incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dalpresidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. Le spese relativesono anticipate dall’alienante.4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.5. La prelazione può essere esercitata anche quando il bene sia a qualunque titolo datoin pagamento.
Articolo 61Condizioni della prelazione
1. La prelazione è esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione delladenuncia prevista dall’articolo 59.2. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risultiincompleta, la prelazione è esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cuiil Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi co-stitutivi della stessa ai sensi dell’articolo 59, comma 4.3. Entro i termini indicati dai commi 1 e 2 il provvedimento di prelazione è notificatoall’alienante ed all’acquirente. La proprietà passa allo Stato dalla data dell’ultima notifica.4. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l’atto di alienazione rimane condizio-nato sospensivamente all’esercizio della prelazione e all’alienante è vietato effettuare laconsegna della cosa.5. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.6. Nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate,l’acquirente ha facoltà di recedere dal contratto.
Articolo 62Procedimento per la prelazione
1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà imme-diata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trovail bene. Trattandosi di bene mobile, la regione ne dà notizia sul proprio Bollettino Ufficialeed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale, con la de-scrizione dell’opera e l’indicazione del prezzo.

224 - Decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42
2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di trenta giorni dalla denuncia,formulano al Ministero la proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione dell’organocompetente che predisponga, a valere sul bilancio dell’ente, la necessaria copertura fi-nanziaria della spesa.3. Il Ministero, qualora non intenda esercitare la prelazione, ne dà comunicazione, entroquaranta giorni dalla ricezione della denuncia, all’ente interessato. Detto ente assume ilrelativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all’alienanteed all’acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima. La proprietàdel bene passa all’ente che ha esercitato la prelazione dalla data dell’ultima notifica. 4. Nei casi di cui all’articolo 61, comma 2, i termini indicati al comma 2 ed al comma 3,primo e secondo periodo, sono, rispettivamente, di novanta, centoventi e centottantagiorni dalla denuncia tardiva o dalla data di acquisizione degli elementi costitutivi delladenuncia medesima.
Sezione IIICommercio
Articolo 63Obbligo di denuncia dell’attività commerciale e di tenuta del registro.
Obbligo di denuncia della vendita o dell’acquisto di documenti
1. L’autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in materia, aricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate,trasmette al soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima, presen-tata da chi esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera Adell’Allegato A del presente decreto legislativo.2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornal-mente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblicasicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. Con decreto adottato dalMinistro di concerto con il Ministro dell’interno sono definiti i limiti di valore al di sopra deiquali è obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni com-merciali.3. Il soprintendente verifica l’adempimento dell’obbligo di cui al secondo periodo delcomma 2 con ispezioni periodiche, anche a mezzo di funzionari da lui delegati. La verificaè svolta da funzionari della regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi dell’articolo 5,commi 2, 3 e 4. Il verbale dell’ispezione è notificato all’interessato ed alla locale autoritàdi pubblica sicurezza.4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di vendita, nonchéi pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l’obbligo di comunicare al soprin-tendente l’elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligosono soggetti i privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi cheacquisiscano documenti aventi il medesimo interesse, entro novanta giornidall’acquisizione. Entro novanta giorni dalla comunicazione il soprintendente può avviareil procedimento di cui all’articolo 13.5. Il soprintendente può comunque accertare d’ufficio l’esistenza di archivi o di singolidocumenti dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati edi cui sia presumibile l’interesse storico particolarmente importante.

Codice dei beni culturali e del paesaggio - 225
Articolo 64Attestati di autenticità e di provenienza
1. Chiunque esercita l’attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio odi intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovverodi oggetti d’antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmentevende le opere o gli oggetti medesimi, ha l’obbligo di consegnare all’acquirente la docu-mentazione attestante l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza;ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative eregolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recantetutte le informazioni disponibili sull’autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza.Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell’opera o dell’oggetto, è ap-posta su copia fotografica degli stessi.
Capo VCircolazione in ambito internazionale
Sezione IUscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale
Articolo 65Uscita definitiva
1. E’ vietata l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indi-cati nell’articolo 10, commi 1, 2 e 3.2. E’ vietata altresì l’uscita:
a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all’articolo 10, comma1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalgaad oltre cinquanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verificaprevista dall’articolo 12.
b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicateall’articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organoconsultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporalidefiniti, abbia escluso dall’uscita, perché dannosa per il patrimonio cultu-rale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza oall’appartenenza dei beni medesimi.
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le mo-dalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l’uscita definitivadal territorio della Repubblica:
a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, sia-no opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cin-quanta anni;
b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentinointeresse culturale;
c) dei beni rientranti nelle categorie di cui all’articolo 11, comma 1, lettere f), g)ed h), a chiunque appartengano.
4. Non è soggetta ad autorizzazione l’uscita delle cose di cui all’articolo 11, comma 1,lettera d). L’interessato ha tuttavia l’onere di comprovare al competente ufficio di esporta-zione che le cose da trasferire all’estero sono opera di autore vivente o la cui esecuzionenon risalga ad oltre cinquanta anni, secondo le procedure e con le modalità stabilite con

226 - Decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42
decreto ministeriale.
Articolo 66Uscita temporanea per manifestazioni
1. Può essere autorizzata l’uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose edei beni culturali indicati nell’articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3, per manifestazioni,mostre o esposizioni d’arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantitel’integrità e la sicurezza.2. Non possono comunque uscire:
a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioniambientali sfavorevoli;
b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezionedi un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bi-bliografica.
Articolo 67Altri casi di uscita temporanea
1. Le cose e i beni culturali indicati nell’articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3 possonoessere autorizzati ad uscire temporaneamente anche quando:
a) costituiscano mobilio privato dei cittadini italiani che ricoprono, presso sedi diplo-matiche o consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche checomportano il trasferimento all’estero degli interessati, per un periodo non superiore alladurata del loro mandato;
b) costituiscano l’arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all’estero;c) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione da
eseguire necessariamente all’estero;d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali
straniere, in regime di reciprocità e per la durata stabilita negli accordi medesimi, che nonpuò essere, comunque, superiore a quattro anni.2. Non è soggetta ad autorizzazione l’uscita temporanea dal territorio della Repubblicadei mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni per la partecipazione a mostre eraduni internazionali, salvo che sia per essi intervenuta la dichiarazione ai sensidell’articolo 13.
Articolo 68Attestato di libera circolazione
1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose e i beni in-dicati nell’articolo 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio diesportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale, al finedi ottenere l’attestato di libera circolazione.2. L’ufficio di esportazione, entro tre giorni dall’avvenuta presentazione della cosa o delbene, ne dà notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i suc-cessivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati perl’uscita definitiva.3. L’ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega conmotivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l’attestato di libera circo-lazione, dandone comunicazione all’interessato entro quaranta giorni dalla presentazionedella cosa o del bene.

Codice dei beni culturali e del paesaggio - 227
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato di libera circolazione gli uffici diesportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito ilcompetente organo consultivo.5. L’attestato di libera circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre originali, unodei quali è depositato agli atti d’ufficio; un secondo è consegnato all’interessato e deveaccompagnare la circolazione dell’oggetto; un terzo è trasmesso al Ministero per la for-mazione del registro ufficiale degli attestati.6. Il diniego comporta l’avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell’articolo 14. Atal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all’interessato gli elementi di cuiall’articolo 14, comma 2, e le cose o i beni sono sottoposti alla disposizione di cui alcomma 4 del medesimo articolo.7. Per le cose o i beni di proprietà di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l’ufficio diesportazione acquisisce il parere della regione, che è reso nel termine perentorio ditrenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante.
Articolo 69Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato
1. Avverso il diniego dell’attestato è ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso alMinistero, per motivi di legittimità e di merito.2. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il terminedi novanta giorni dalla presentazione dello stesso.3. Dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e fino alla scadenza del terminedi cui al comma 2, il procedimento di dichiarazione è sospeso, ma i beni rimangono as-soggettati alla disposizione di cui all’articolo 14, comma 4.4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli atti all’ufficio di esportazione, cheprovvede in conformità nei successivi venti giorni.5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre1971, n. 1199.
Articolo 70Acquisto coattivo
1. Entro il termine indicato all’articolo 68, comma 3, l’ufficio di esportazione può proporreal Ministero l’acquisto coattivo della cosa o del bene per i quali è richiesto l’attestato dilibera circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e all’interessato, alquale dichiara altresì che l’oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in custodiapresso l’ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso iltermine per il rilascio dell’attestato è prorogato di sessanta giorni.2. Il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa o il bene per il valore indicato nella de-nuncia. Il provvedimento di acquisto è notificato all’interessato entro il termine perentoriodi novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del prov-vedimento di acquisto, l’interessato può rinunciare all’uscita dell’oggetto e provvedere alritiro del medesimo.3. Qualora il Ministero non intenda procedere all’acquisto, ne dà comunicazione, entrosessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova l’ufficio di esportazio-ne proponente. La regione ha facoltà di acquistare la cosa o il bene nel rispetto di quantostabilito all’articolo 62, commi 2 e 3, in materia di copertura finanziaria della spesa e as-sunzione del relativo impegno. Il relativo provvedimento è notificato all’interessato entro iltermine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.

228 - Decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42
Articolo 71Attestato di circolazione temporanea
1. Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio della Repubblica, ai sensi degliarticoli 66 e 67, le cose e i beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al compe-tente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valorevenale e il responsabile della sua custodia all’estero, al fine di ottenere l’attestato di cir-colazione temporanea.2. L’ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, conmotivato giudizio, l’attestato di circolazione temporanea, dettando le prescrizioni neces-sarie e dandone comunicazione all’interessato entro quaranta giorni dalla presentazionedella cosa o del bene. Avverso il provvedimento di diniego di uscita temporanea è am-messo ricorso amministrativo nei modi previsti dall’articolo 69.3. Qualora la cosa o il bene presentati per l’uscita temporanea rivestano l’interesse ri-chiesto dall’articolo 10, contestualmente alla pronuncia positiva o negativa sono comuni-cati all’interessato, ai fini dell’avvio del procedimento di dichiarazione, gli elementi indicatiall’articolo 14, comma 2, e l’oggetto è sottoposto alle misure di cui all’articolo 14, comma4.4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato, gli uffici di esportazione si at-tengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente or-gano consultivo. Per i casi di uscita temporanea disciplinati dall’articolo 66 e dall’articolo67, comma 1, lettere b) e c), il rilascio dell’attestato è subordinato all’autorizzazione di cuiall’articolo 48.5. L’attestato indica anche il termine per il rientro delle cose o dei beni, che è prorogabilesu richiesta dell’interessato, ma non può essere comunque superiore a diciotto mesi dallaloro uscita dal territorio nazionale, salvo quanto disposto dal comma 8.6. Il rilascio dell’attestato è sempre subordinato all’assicurazione dei beni da partedell’interessato per il valore indicato nella domanda. Per le mostre e le manifestazionipromosse all’estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagliistituti italiani di cultura all’estero o da organismi sovranazionali, l’assicurazione può esse-re sostituita dall’assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell’articolo 48,comma 5.7. Per i beni culturali di cui all’articolo 65, comma 1, nonché per le cose o i beni di cui alcomma 3, l’uscita temporanea è garantita mediante cauzione, costituita anche da polizzafideiussoria, emessa da un istituto bancario o da una società di assicurazione, per un im-porto superiore del dieci per cento al valore del bene o della cosa, come accertato in se-de di rilascio dell’attestato. La cauzione è incamerata dall’amministrazione ove gli oggettiammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel terminestabilito. La cauzione non è richiesta per i beni appartenenti allo Stato e alle amministra-zioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall’obbligo della cauzione istituzioni di parti-colare importanza culturale.8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano ai casi di uscita temporanea pre-visti dall’articolo 67, comma 1.
Articolo 72Ingresso nel territorio nazionale
1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell’Unione europea o l’importazione daun Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell’articolo 65, comma 3, sono certificati, adomanda, dall’ufficio di esportazione.2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono rilasciati sulla base

Codice dei beni culturali e del paesaggio - 229
di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenien-za dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimisono stati, rispettivamente, spediti o importati.3. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione hanno validità quin-quennale e possono essere prorogati su richiesta dell’interessato.4. Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalità e procedure peril rilascio e la proroga dei certificati, con particolare riguardo all’accertamento della prove-nienza della cosa o del bene spediti o importati.
Sezione IIEsportazione dal territorio dell’Unione europea
Articolo 73Denominazioni
1. Nella presente sezione e nella sezione III di questo Capo si intendono:a) per «regolamento CEE», il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicem-bre 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicem-bre 1996 e dal regolamento (CE) n. 974/01 del Consiglio, del 14 maggio 2001;b) per «direttiva CEE», la direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, comemodificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 feb-braio 1997 e dalla direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5giugno 2001;c) per «Stato richiedente», lo Stato membro dell’Unione europea che promuove l’azionedi restituzione a norma della sezione III.
Articolo 74Esportazione di beni culturali dal territorio dell’Unione europea
1. L’esportazione al di fuori del territorio dell’Unione europea dei beni culturali indicatinell’allegato A del presente codice è disciplinata dal regolamento CEE e dal presentearticolo.2. La licenza di esportazione prevista dall’articolo 2 del regolamento CEE è rilasciatadall’ufficio di esportazione contestualmente all’attestato di libera circolazione, ovvero nonoltre trenta mesi dal rilascio di quest’ultimo da parte del medesimo ufficio. La licenza èvalida sei mesi.3. Nel caso di esportazione temporanea di un bene elencato nell’allegato A del presentecodice, l’ufficio di esportazione rilascia la licenza di esportazione temporanea alle condi-zioni e secondo le modalità stabilite dagli articoli 66, 67 e 71.4. Le disposizioni della sezione I del presente Capo non si applicano ai beni culturali en-trati nel territorio dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membrodell’Unione europea a norma dell’articolo 2 del regolamento CEE, per la durata di validitàdella licenza medesima.5. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità com-petenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali. Il Ministero ne forma econserva l’elenco, comunicando alla Commissione delle Comunità europee eventuali ag-giornamenti entro due mesi dalla loro effettuazione.

230 - Decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42
Sezione IIIRestituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio
di uno Stato membro dell’Unione europea
Articolo 75Restituzione
1. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dell’Unione euro-pea dopo il 31 dicembre 1992 sono restituiti ai sensi delle disposizioni della presente se-zione.2. Sono considerati beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territoriodello Stato richiedente, in base alle norme ivi vigenti, come appartenenti al patrimonioculturale nazionale, secondo quanto stabilito dall’articolo 30 del Trattato istitutivo dellaComunità economica europea, sostituito dall’articolo 6 del Trattato di Amsterdam, e dallerelative norme di ratifica ed esecuzione.3. La restituzione è ammessa per i beni culturali ricompresi in una delle seguenti catego-rie: a) beni indicati nell’allegato A; b) beni facenti parte di collezioni pubbliche, inventariate in musei, archivi e fondi di con-servazione di biblioteche. Si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato,delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e di ogni altro ente ed istituto pubblico, non-ché le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato, dalle regioni o dagli altri entipubblici territoriali;
c) beni inclusi in inventari ecclesiastici.4. È illecita l’uscita dei beni culturali avvenuta in violazione del regolamento CEE o dellalegislazione dello Stato richiedente in materia di protezione del patrimonio culturale na-zionale, ovvero determinata dal mancato rientro alla scadenza del termine di uscita o diesportazione temporanee.5. Si considerano illecitamente usciti i beni dei quali sia stata autorizzata l’uscita ol’esportazione temporanee qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedi-mento previsto nell’articolo 71, comma 2.6. La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono almomento della proposizione della domanda.
Articolo 76Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell’Unione europea
1. L’autorità centrale prevista dall’articolo 3 della direttiva CEE è, per l’Italia, il Ministero.Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici,nonché della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni edegli altri enti pubblici territoriali.2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altroStato membro dell’Unione europea, il Ministero: a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri; b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche volte alla localizzazione del bene culturalee alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga. Le ricerche sono dispostesu domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili per age-volare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene; c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un beneculturale la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi econcordanti;

Codice dei beni culturali e del paesaggio - 231
d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue per verificare, in ordi-ne al bene oggetto della notifica di cui alla lettera c), la sussistenza dei presupposti edelle condizioni indicati all’articolo 75, purché tali operazioni vengano effettuate entro duemesi dalla notifica stessa. Qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine,non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e); e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la sua temporanea custodia pressoistituti pubblici nonché ogni altra misura necessaria per assicurarne la conservazione edimpedirne la sottrazione alla procedura di restituzione; f) favorisce l’amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore aqualsiasi titolo del bene culturale, di ogni controversia concernente la restituzione. A talfine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può pro-porre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della con-troversia mediante arbitrato, da svolgersi secondo la legislazione italiana, e raccogliere,per l’effetto, il formale accordo di entrambe le parti.
Articolo 77Azione di restituzione
1. Per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio, gli Stati membri dell’Unioneeuropea possono esercitare l’azione di restituzione davanti all’autorità giudiziaria ordina-ria, secondo quanto previsto dall’articolo 75.2. L’azione è proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova.3. Oltre ai requisiti previsti nell’articolo 163 del codice di procedura civile, l’atto di citazio-ne deve contenere: a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la qualità di bene cultu-rale; b) la dichiarazione delle autorità competenti dello Stato richiedente relativa all’uscitaillecita del bene dal territorio nazionale.4. L’atto di citazione è notificato, oltre che al possessore o al detentore a qualsiasi titolodel bene, anche al Ministero per essere annotato nello speciale registro di trascrizionedelle domande giudiziali di restituzione.5. Il Ministero notifica immediatamente l’avvenuta trascrizione alle autorità centrali deglialtri Stati membri.
Articolo 78Termini di decadenza e di prescrizione dell’azione
1. L’azione di restituzione è promossa nel termine perentorio di un anno a decorrere dalgiorno in cui lo Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente sitrova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore a qualsiasititolo.2. L’azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dalgiorno dell’uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente.3. L’azione di restituzione non si prescrive per i beni indicati nell’articolo 75, comma 3,lettere b) e c).
Articolo 79Indennizzo
1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, può, su domanda della parte interes-sata, liquidare un indennizzo determinato in base a criteri equitativi.

232 - Decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42
2. Per ottenere l’indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto interessato è tenuto a di-mostrare di aver usato, all’atto dell’acquisizione, la diligenza necessaria a seconda dellecircostanze.3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione, eredità o legatonon può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del proprio dante causa.4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell’indennizzo può rivalersi neiconfronti del soggetto responsabile dell’illecita circolazione residente in Italia.
Articolo 80Pagamento dell’indennizzo
1. L’indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla re-stituzione del bene.2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto processo verbale a cura di unnotaio, di un ufficiale giudiziario o di funzionari all’uopo designati dal Ministero, al quale èrimessa copia del processo verbale medesimo.3. Il processo verbale costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione delladomanda giudiziale.
Articolo 81Oneri per l’assistenza e la collaborazione
1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custo-dia temporanea del bene da restituire, le altre comunque conseguenti all’applicazionedell’articolo 76, nonché quelle inerenti all’esecuzione della sentenza che dispone la re-stituzione.
Articolo 82Azione di restituzione a favore dell’Italia
1. L’azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano èesercitata dal Ministero, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice delloStato membro dell’Unione europea in cui si trova il bene culturale.2. Il Ministero si avvale dell’assistenza dell’Avvocatura generale dello Stato.
Articolo 83Destinazione del bene restituito
1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero provvedealla sua custodia fino alla consegna all’avente diritto.2. La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute peril procedimento di restituzione e per la custodia del bene.3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero dànotizia del provvedimento di restituzione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale della Repubblica italiana e con altra forma di pubblicità.4. Qualora l’avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data dipubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso previsto dal comma 3, il bene è acqui-sito al demanio dello Stato. Il Ministero, sentiti il competente organo consultivo e le regio-ni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio delloStato, di una regione o di altro ente pubblico territoriale, al fine di assicurarne la miglioretutela e la pubblica fruizione nel contesto culturale più opportuno.

Codice dei beni culturali e del paesaggio - 233
Articolo 84Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale
1. Il Ministro informa la Commissione delle Comunità europee delle misure adottatedall’Italia per assicurare l’esecuzione del regolamento CEE e acquisisce le corrispondentiinformazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri.2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in allegato allo stato di previsionedella spesa del Ministero, una relazione sull’attuazione del presente Capo nonchésull’attuazione della direttiva CEE e del regolamento CEE in Italia e negli altri Stati mem-bri.3. Il Ministro, sentito il competente organo consultivo, predispone ogni tre anni la relazio-ne sull’applicazione del regolamento CEE e della direttiva CEE per la Commissione indi-cata al comma 1. La relazione è trasmessa al Parlamento.
Articolo 85Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti
1. Presso il Ministero è istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, se-condo modalità stabilite con decreto ministeriale.
Articolo 86Accordi con gli altri Stati membri dell’Unione europea
1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca, maggiore conoscenza del patrimonioculturale nonché della legislazione e dell’organizzazione di tutela dei diversi Stati membridell’Unione europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con le corrispondentiautorità degli altri Stati membri.
Sezione IVConvenzione UNIDROIT
Articolo 87Beni culturali rubati o illecitamente esportati
1. La restituzione dei beni culturali indicati nell’annesso alla Convenzione dell’UNIDROITsul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati è disciplinatadalle disposizioni della Convenzione medesima e dalle relative norme di ratifica ed ese-cuzione.

234 - Decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42
Capo VIRitrovamenti e scoperte
Sezione IRicerche e rinvenimenti fortuiti nell’ambito del territorio nazionale
Articolo 88Attività di ricerca
1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicateall’articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.2. Il Ministero può ordinare l’occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguir-si le ricerche o le opere di cui al comma 1.3. Il proprietario dell’immobile ha diritto ad un’indennità per l’occupazione, determinatasecondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione perpubblica utilità. L’indennità può essere corrisposta in denaro o, a richiesta del proprieta-rio, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino leraccolte dello Stato.
Articolo 89Concessione di ricerca
1. Il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l’esecuzione delle ri-cerche e delle opere indicate nell’articolo 88 ed emettere a favore del concessionario ildecreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.2. Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni imposte nell’atto di concessio-ne, tutte le altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di inosservanza la conces-sione è revocata.3. La concessione può essere revocata anche quando il Ministero intenda sostituirsinell’esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al concessionariole spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministero.4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l’importoè stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spesesono anticipate dal concessionario.5. La concessione prevista al comma 1 può essere rilasciata anche al proprietario degliimmobili ove devono eseguirsi i lavori.6. Il Ministero può consentire, a richiesta, che le cose rinvenute rimangano, in tutto o inparte, presso la Regione od altro ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre chel’ente disponga di una sede idonea e possa garantire la conservazione e la custodia dellecose medesime.
Articolo 90Scoperte fortuite
1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell’articolo 10 ne fa denunciaentro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all’autorità di pubblica sicu-rezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni enel luogo in cui sono state rinvenute.2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo

Codice dei beni culturali e del paesaggio - 235
scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazionesino alla visita dell’autorità competente e, ove occorra, di chiedere l’ausilio della forzapubblica.3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni de-tentore di cose scoperte fortuitamente.4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.
Articolo 91Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate
1. Le cose indicate nell’articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sotto-suolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili omobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e826 del codice civile.2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territo-riali o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, tra i materiali di ri-sulta che per contratto siano stati riservati all’impresa di demolizione non sono compresele cose rinvenienti dall’abbattimento che abbiano l’interesse di cui all’articolo 10, comma3, lettera a). E’ nullo ogni patto contrario.
Articolo 92Premio per i ritrovamenti
1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritro-vate: a) al proprietario dell’immobile dove è avvenuto il ritrovamento; b) al concessionario dell’attività di ricerca, ai sensi dell’articolo 89; c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall’articolo 90.2. Il proprietario dell’immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall’articolo 89ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valo-re delle cose ritrovate.3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondoaltrui senza il consenso del proprietario o del possessore.4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritro-vate. In luogo del premio, l’interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta dipari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Mini-stro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell’articolo 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Articolo 93Determinazione del premio
1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo ai sen-si dell’articolo 92, previa stima delle cose ritrovate.2. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo è corrisposto un acconto del premio inmisura non superiore ad un quinto del valore, determinato in via provvisoria, delle coseritrovate. L’accettazione dell’acconto non comporta acquiescenza alla stima definitiva.3. Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle coseritrovate è determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti. Se esse non siaccordano per la nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo nomi-nato non voglia o non possa accettare l’incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di

236 - Decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42
una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate.Le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio.4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.
Sezione IIRicerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territoriale
Articolo 94Convenzione UNESCO
1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodicimiglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle“Regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo” allegate alla Conven-zione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2novembre 2001.
Capo VIIEspropriazione
Articolo 95Espropriazione di beni culturali
1. I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causadi pubblica utilità, quando l’espropriazione risponda ad un importante interesse a miglio-rare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.2. Il Ministero può autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali non-ché ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare l’espropriazione di cui al comma 1. Intal caso dichiara la pubblica utilità ai fini dell’esproprio e rimette gli atti all’ente interessatoper la prosecuzione del procedimento.3. Il Ministero può anche disporre l’espropriazione a favore di persone giuridiche privatesenza fine di lucro, curando direttamente il relativo procedimento.
Articolo 96Espropriazione per fini strumentali
1. Possono essere espropriati per causa di pubblica utilità edifici ed aree quando ciò sianecessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, ga-rantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l’accesso.
Articolo 97Espropriazione per interesse archeologico
1. Il Ministero può procedere all’espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi diinteresse archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose indicate nell’articolo 10.
Articolo 98Dichiarazione di pubblica utilità
1. La pubblica utilità è dichiarata con decreto ministeriale o, nel caso dell’articolo 96, an-che con provvedimento della regione comunicato al Ministero.

Codice dei beni culturali e del paesaggio - 237
2. Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli 96 e 97 l’approvazione del progettoequivale a dichiarazione di pubblica utilità.
Articolo 99Indennità di esproprio per i beni culturali
1. Nel caso di espropriazione previsto dall’articolo 95 l’indennità consiste nel giusto prez-zo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all’interno delloStato.2. Il pagamento dell’indennità è effettuato secondo le modalità stabilite dalle disposizionigenerali in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Articolo 100Rinvio a norme generali
1. Nei casi di espropriazione disciplinati dagli articoli 96 e 97 si applicano, in quantocompatibili, le disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.
TITOLO II Fruizione e valorizzazione
Capo IFruizione dei beni culturali
Sezione IPrincipi generali
Articolo 101Istituti e luoghi della cultura
1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gliarchivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.2. Si intende per:
a) «museo», una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed esponebeni culturali per finalità di educazione e di studio;
b) «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme or-ganizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque sup-porto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva docu-menti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e diricerca.
d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossileo di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
e) «parco archeologico», un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenzearcheologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzatocome museo all’aperto;
f) «complesso monumentale», un insieme formato da una pluralità di fabbricati edifi-cati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una auto-noma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono de-

238 - Decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42
stinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che ap-partengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato diutilità sociale.
Articolo 102Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica
1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubbli-co, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all’articolo101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina lafruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti alloStato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigen-te.3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cuiall’articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmentecon lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti edai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regionie gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell’ambito e con le proceduredell’articolo 112. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire lafruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero può altresì trasferire alle regioni eagli altri enti pubblici territoriali, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione edadeguatezza, la disponibilità di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurareun’adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti.
Articolo 103Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura
1. L’accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura può essere gratuito o a paga-mento. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese percoordinare l’accesso ad essi.2. L’accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalità di lettura, studio e ricercaè gratuito.3. Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territorialideterminano:
a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo. Il prezzo
del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste allalettera c);
c) le modalità di emissione, distribuzione e vendita del biglietto d’ingresso e di ri-scossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici eprivati. Per la gestione dei biglietti d’ingresso possono essere impiegate nuovetecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita presso terzi con-venzionati.
d) l’eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all’Ente nazionale diassistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori dramma-tici.
4. Eventuali agevolazioni per l’accesso devono essere regolate in modo da non creare

Codice dei beni culturali e del paesaggio - 239
discriminazioni ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unioneeuropea.
Articolo 104 Fruizione di beni culturali di proprietà privata
1. Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali:a) i beni culturali immobili indicati all’articolo 10, comma 3, lettere a) e d), che rivesto-
no interesse eccezionale;b) le collezioni dichiarate ai sensi dell’articolo 13.
2. L’interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1, lettera a), è dichiarato conatto del Ministero, sentito il proprietario.3. Le modalità di visita sono concordate tra il proprietario e il soprintendente, che ne dàcomunicazione al comune o alla città metropolitana nel cui territorio si trovano i beni.4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 38.
Articolo 105Diritti di uso e godimento pubblico
1. Il Ministero e le regioni vigilano, nell’ambito delle rispettive competenze, affinché sianorispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose e i beni sog-getti alle disposizioni della presente Parte.
Sezione IIUso dei beni culturali
Articolo 106 Uso individuale di beni culturali
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l’uso deibeni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazioneculturale, a singoli richiedenti.2. Per i beni in consegna al Ministero, il soprintendente determina il canone dovuto eadotta il relativo provvedimento.
Articolo 107Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riprodu-zione nonché l’uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna,fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d’autore.2. E’ di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi daglioriginali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni sianofatti. Sono ordinariamente consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi dacopie degli originali già esistenti. Le modalità per la realizzazione dei calchi sono discipli-nate con decreto ministeriale.

240 - Decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42
Articolo 108Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione
1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sonodeterminati dall’autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto: a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d’uso; b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni; c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni; d) dell’uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che nederivano al richiedente.2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o permotivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. I richiedenti sonocomunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione concedente.4. Nei casi in cui dall’attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni cultura-li, l’autorità che ha in consegna i beni determina l’importo della cauzione, costituita anchemediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovutaanche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.5. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non han-no subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l’uso e la riproduzione dei beni sonofissati con provvedimento dell’amministrazione concedente.
Articolo 109Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali
1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini diraccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento con-cessorio prescrive:
a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;b) la restituzione, dopo l’uso, del fotocolor originale con relativo codice.
Articolo 110Incasso e riparto di proventi
1. Nei casi previsti dall’articolo 115, comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei bi-glietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione edai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cuigli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità allerispettive disposizioni di contabilità pubblica.2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi dicui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche me-diante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sulconto corrente bancario aperto da ciascun responsabile di istituto o luogo della culturapresso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l’istituto bancario provvede, non oltrecinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesore-ria provinciale dello Stato. Il Ministro dell’economia e delle finanze riassegna le sommeincassate alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesadel Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo.3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso agli istituti ed ai luoghi apparte-nenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurez-

Codice dei beni culturali e del paesaggio - 241
za e la conservazione dei luoghi medesimi, ai sensi dell’articolo 29, nonchéall’espropriazione e all’acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazio-ne.4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso agli istituti ed ai luoghi apparte-nenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all’incremento ed alla valoriz-zazione del patrimonio culturale.
Capo IIPrincipi della valorizzazione dei beni culturali
Articolo 111Attività di valorizzazione
1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organiz-zazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competen-ze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed alperseguimento delle finalità indicate all’articolo 6. A tali attività possono concorrere, co-operare o partecipare soggetti privati.2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata.3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipa-zione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità etrasparenza della gestione.4. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta lafinalità di solidarietà sociale.
Articolo 112Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica
1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei benipresenti negli istituti e nei luoghi indicati all’articolo 101, nel rispetto dei principi fonda-mentali fissati dal presente codice.2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina lavalorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenentiallo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativavigente.3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cuiall’articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmentecon lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare le attività di valorizzazione dei beni delpatrimonio culturale di appartenenza pubblica, lo Stato, per il tramite del Ministero, le re-gioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi su base regionale, al fine di definiregli obbiettivi e fissarne i tempi e le modalità di attuazione. Con gli accordi medesimi sonoindividuate le adeguate forme di gestione, ai sensi dell’articolo 115.5. Qualora, entro i tempi stabiliti, gli accordi di cui al comma 4 non siano raggiunti tra icompetenti organi, la loro definizione è rimessa alla decisione congiunta del Ministro, delpresidente della Regione, del presidente della Provincia e dei sindaci dei comuni interes-sati. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizza-zione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.6. Lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali posso-no definire, in sede di Conferenza unificata, indirizzi generali e procedure per uniformare,sul territorio nazionale, gli accordi indicati al comma 4.

242 - Decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42
7. Agli accordi di cui al comma 4 possono partecipare anche soggetti privati e, previoconsenso dei soggetti interessati, gli accordi medesimi possono riguardare beni di pro-prietà privata.8. I soggetti pubblici interessati possono altresì stipulare apposite convenzioni con le as-sociazioni culturali o di volontariato che svolgono attività di promozione e diffusione dellaconoscenza dei beni culturali.
Articolo 113Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata
1. Le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di pro-prietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regio-ni e degli altri enti pubblici territoriali.2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali aiquali si riferiscono.3. Le modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il pro-prietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno.4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizza-zione dei beni di cui all’articolo 104, comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti alcomma 3.
Articolo 114Livelli di qualità della valorizzazione
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle uni-versità, fissano i livelli uniformi di qualità della valorizzazione e ne curano l’aggiornamentoperiodico.2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede diConferenza unificata.3. I soggetti che, ai sensi dell’articolo 115, hanno la gestione delle attività di valorizzazio-ne sono tenuti ad assicurare il rispetto dei livelli adottati.

Codice dei beni culturali e del paesaggio - 243
Articolo 115Forme di gestione
1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali ad iniziativa pubblica sono gestite in for-ma diretta o indiretta.2. La gestione in forma diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alleamministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria econtabile, e provviste di idoneo personale tecnico.3. La gestione in forma indiretta è attuata tramite:
a) affidamento diretto a istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi, società di ca-pitali o altri soggetti, costituiti o partecipati, in misura prevalente, dall’amministrazionepubblica cui i beni pertengono;
b) concessione a terzi, in base ai criteri indicati ai commi 4 e 5.4. Lo Stato e le regioni ricorrono alla gestione in forma indiretta al fine di assicurare unadeguato livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestioneindicate alle lettere a) e b) del comma 3 è attuata previa valutazione comparativa, in ter-mini di efficienza ed efficacia, degli obiettivi che si intendono perseguire e dei relativimezzi, metodi e tempi.5. Qualora, a seguito della comparazione di cui al comma 4, risulti preferibile ricorrere allaconcessione a terzi, alla stessa si provvede mediante procedure ad evidenza pubblica,sulla base di valutazione comparativa dei progetti presentati.6. Gli altri enti pubblici territoriali ordinariamente ricorrono alla gestione in forma indirettadi cui al comma 3, lettera a), salvo che, per le modeste dimensioni o per le caratteristichedell’attività di valorizzazione, non risulti conveniente od opportuna la gestione in formadiretta.7. Previo accordo tra i titolari delle attività di valorizzazione, l’affidamento o la concessio-ne previsti al comma 3 possono essere disposti in modo congiunto ed integrato.8. Il rapporto tra il titolare dell’attività e l’affidatario od il concessionario è regolato concontratto di servizio, nel quale sono specificati, tra l’altro, i livelli qualitativi di erogazionedel servizio e di professionalità degli addetti nonché i poteri di indirizzo e controllo spet-tanti al titolare dell’attività o del servizio.9. Il titolare dell’attività può partecipare al patrimonio o al capitale dei soggetti di cui alcomma 3, lettera a), anche con il conferimento in uso del bene culturale oggetto di valo-rizzazione. Gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi dicessazione totale dalla partecipazione da parte del titolare dell’attività o del servizio, diestinzione del soggetto partecipato ovvero di cessazione, per qualunque causa,dell’affidamento dell’attività o del servizio. I beni conferiti in uso non sono soggetti a ga-ranzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.10. All’affidamento o alla concessione di cui al comma 3 può essere collegata la conces-sione in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione. La concessione perde efficacia,senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione dell’affidamento o della concessionedel servizio o dell’attività.
Articolo 116Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso
1. I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai sensi dell’articolo 115,commi 9 e 10, restano a tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. Lefunzioni di tutela sono esercitate dal Ministero, che provvede anche su richiesta ovveronei confronti del soggetto conferitario o concessionario dell’uso dei beni medesimi.

244 - Decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42
Articolo 117Servizi aggiuntivi
1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all’articolo 101 possono essere istituitiservizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:
a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, au-diovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni cul-turali;
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il reca-pito del prestito bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;d) la gestione dei punti vendita e l’utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei be-
ni;e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per
l’infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incon-tro;
f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;g) l’organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozio-
nali.3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi dipulizia, di vigilanza e di biglietteria.4. La gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall’articolo 115.5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell’articolo 110.
Articolo 118Promozione di attività di studio e ricerca
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle uni-versità e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anchecongiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonioculturale.2. Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei risultati degli studi, dellericerche e delle altre attività di cui al comma 1, ivi compresa la catalogazione, il Ministeroe le regioni possono stipulare accordi per istituire, a livello regionale o interregionale,centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale, prevedendo ilconcorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati.
Articolo 119Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole
1. Il Ministero, il Ministero per l’istruzione, l’università e la ricerca, le regioni e gli altri entipubblici territoriali interessati possono concludere accordi per diffondere la conoscenza efavorire la fruizione del patrimonio culturale da parte degli studenti.2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghidella cultura di cui all’articolo 101 possono stipulare con le scuole di ogni ordine e grado,appartenenti al sistema nazionale di istruzione, apposite convenzioni per la elaborazionedi percorsi didattici, la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, nonché per laformazione e l’aggiornamento dei docenti. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto

Codice dei beni culturali e del paesaggio - 245
della specificità della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinatedalla presenza di alunni disabili.
Articolo 120Sponsorizzazione di beni culturali
1. E’ sponsorizzazione di beni culturali ogni forma di contributo in beni o servizi da partedi soggetti privati alla progettazione o all’attuazione di iniziative del Ministero, delle regio-ni e degli altri enti pubblici territoriali, ovvero di soggetti privati, nel campo della tutela evalorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio,l’immagine, l’attività o il prodotto dell’attività dei soggetti medesimi.2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l’associazione del nome, delmarchio, dell’immagine, dell’attività o del prodotto all’iniziativa oggetto del contributo, informe compatibili con il carattere artistico o storico, l’aspetto e il decoro del bene culturaleda tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione.3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione delcontributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizza-zione dell’iniziativa cui il contributo si riferisce.
Articolo 121Accordi con le fondazioni bancarie
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito,possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni conferentidi cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, chestatutariamente perseguano scopi di utilità sociale nel settore dell’arte e delle attività ebeni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturalee, in tale contesto, garantire l’equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a dispo-sizione. La parte pubblica può concorrere, con proprie risorse finanziarie, per garantire ilperseguimento degli obiettivi dei protocolli di intesa.
Capo IIIConsultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza
Articolo 122Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti
1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, deglialtri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamenteconsultabili, ad eccezione: a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell’articolo 125, relativi alla politi-ca estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la lorodata;
b) di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di naturapenale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati persona-li, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta annise i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipofamiliare.2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i documenti restano acces-sibili ai sensi della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi. Sull’istanza di ac-cesso provvede l’amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del

246 - Decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42
deposito.3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di pro-prietà privata depositati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, oagli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato. I depositanti e coloroche donano o vendono o lasciano in eredità o legato i documenti possono anche stabilirela condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell’ultimo settan-tennio. Tale limitazione, così come quella generale stabilita dal comma 1, non opera neiriguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi de-signata; detta limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dai deposi-tanti, donanti e venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, aiquali essi siano interessati per il titolo di acquisto.
Articolo 123Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti
riservati
1. Il Ministro dell’interno, previo parere del direttore dell’Archivio di Stato competente eudita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riser-vati, istituita presso il Ministero dell’interno, può autorizzare la consultazione per scopistorici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi di Stato anche primadella scadenza dei termini indicati nell’articolo 122, comma 1. L’autorizzazione è rilascia-ta, a parità di condizioni, ad ogni richiedente.2. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi del comma 1 conservanoil loro carattere riservato e non possono essere diffusi.3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 è assoggettata anche la consultazione per scopi sto-rici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi storici delle regioni, deglialtri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico. Il parere di cui alcomma 1 è reso dal soprintendente archivistico.
Articolo 124Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti
1. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti della pub-blica amministrazione, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano laconsultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito.2. La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi correnti e di deposito degli altri entied istituti pubblici, è regolata dagli enti ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi generalistabiliti dal Ministero.
Articolo 125Declaratoria di riservatezza
1. L’accertamento dell’esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabiliindicati agli articoli 122 e 127 è effettuato dal Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministe-ro.
Articolo 126Protezione di dati personali
1. Qualora il titolare di dati personali abbia esercitato i diritti a lui riconosciuti dalla norma-tiva che ne disciplina il trattamento, i documenti degli archivi storici sono conservati e

Codice dei beni culturali e del paesaggio - 247
consultabili unitamente alla documentazione relativa all’esercizio degli stessi diritti.2. Su richiesta del titolare medesimo, può essere disposto il blocco dei dati personali chenon siano di rilevante interesse pubblico, qualora il loro trattamento comporti un concretopericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell’identità personaledell’interessato.3. La consultazione per scopi storici dei documenti contenenti dati personali è assogget-tata anche alle disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta previsto dallanormativa in materia di trattamento dei dati personali.
Articolo 127Consultabilità degli archivi privati
1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi o di singoli do-cumenti dichiarati ai sensi dell’articolo 13 hanno l’obbligo di permettere agli studiosi, chene facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione deidocumenti secondo modalità concordate tra i privati stessi e il soprintendente. Le relativespese sono a carico dello studioso.2. Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati di carattere riservato aisensi dell’articolo 125. Possono essere esclusi dalla consultazione anche i documenti peri quali sia stata posta la condizione di non consultabilità ai sensi dell’articolo 122, comma3.3. Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non dichiarati a normadell’articolo 13, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 123, comma 3, e 126, com-ma 3.
TITOLO IIINorme transitorie e finali
Articolo 128Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente
1. I beni culturali di cui all’articolo 10, comma 3, per i quali non sono state rinnovate e tra-scritte le notifiche effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno1922, n. 778, sono sottoposti al procedimento di cui all’articolo 14. Fino alla conclusionedel procedimento medesimo, dette notifiche restano comunque valide agli effetti di questaParte.2. Conservano altresì efficacia le notifiche effettuate a norma degli articoli 2, 3, 5 e 21della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate e notificate a normadell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 edegli articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti onon valutati, il Ministero può rinnovare, d’ufficio o a richiesta del proprietario, possessoreo detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggettodelle notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la perdurante sussistenza dei pre-supposti per l’assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela.4. Avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del procedimento di dichia-razione, prodotta ai sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione conclusiva delprocedimento medesimo, anche quando esso sia stato avviato d’ufficio, è ammesso ri-corso amministrativo ai sensi dell’articolo 16.

248 - Decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42
Articolo 129Provvedimenti legislativi particolari
1. Sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto singole città o parti di esse, complessi ar-chitettonici, monumenti nazionali, siti od aree di interesse storico, artistico od archeologi-co.2. Restano altresì salve le disposizioni relative alle raccolte artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n.1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31.
Articolo 130Disposizioni regolamentari precedenti
1. Fino all’emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente codice, resta-no in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regi de-creti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363, e ogni altra disposizione regola-mentare attinente alle norme contenute in questa Parte.
PARTE TERZABeni paesaggistici
TITOLO ITutela e valorizzazione
Capo IDisposizioni generali
Articolo 131Salvaguardia dei valori del paesaggio
1. Ai fini del presente codice per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio icui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni.2. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprimequali manifestazioni identitarie percepibili.
Articolo 132Cooperazione tra amministrazioni pubbliche
1. Le amministrazioni pubbliche cooperano per la definizione di indirizzi e criteri riguar-danti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione delpaesaggio e di gestione dei relativi interventi.2. Gli indirizzi e i criteri perseguono gli obiettivi della salvaguardia e della reintegrazionedei valori del paesaggio anche nella prospettiva dello sviluppo sostenibile.3. Al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio le amministrazionipubbliche intraprendono attività di formazione e di educazione.4. Il Ministero e le regioni definiscono le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggiotenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall’Osservatorionazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Os-servatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità.

Codice dei beni culturali e del paesaggio - 249
Articolo 133Convenzioni internazionali
1. Le attività di tutela e di valorizzazione del paesaggio si conformano agli obblighi e aiprincipi di cooperazione tra gli Stati derivanti dalle convenzioni internazionali.
Articolo 134Beni paesaggistici
1. Sono beni paesaggistici:a) gli immobili e le aree indicati all’articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da
138 a 141;b) le aree indicate all’articolo 142;c) gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti
dagli articoli 143 e 156.
Articolo 135Pianificazione paesaggistica
1. Le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato. A talfine sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio, approvando piani paesaggisticiovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici,concernenti l’intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati «piani paesaggi-stici».2. Il piano paesaggistico definisce, con particolare riferimento ai beni di cui all’articolo134, le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riquali-ficazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, nonché gli interventi di valorizza-zione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile.
Capo IIIndividuazione dei beni paesaggistici
Articolo 136Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità
geologica;b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del
presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente
valore estetico e tradizionale;d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o
di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Articolo 137Commissioni provinciali
1. Con atto regionale è istituita per ciascuna provincia una commissione con il compito diformulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indi-cati alle lettere a) e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) dell’articolo 136;

250 - Decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42
2. Della commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per ibeni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici compe-tenti per territorio. I restanti membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dallaregione tra soggetti con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nella tuteladel paesaggio. La commissione procede all’audizione dei sindaci dei comuni interessati epuò consultare esperti.
Articolo 138Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico
1. Su iniziativa del direttore regionale, della regione o degli altri enti pubblici territorialiinteressati, la commissione indicata all’articolo 137, acquisisce le necessarie informazioniattraverso le soprintendenze e gli uffici regionali e provinciali, valuta la sussistenza delnotevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all’articolo 136, e propone ladichiarazione di notevole interesse pubblico. La proposta è motivata con riferimento allecaratteristiche storiche, culturali, naturali, morfologiche ed estetiche proprie degli immobilio delle aree che abbiano significato e valore identitario del territorio in cui ricadono o chesiano percepite come tali dalle popolazioni e contiene le prescrizioni, le misure ed i criteridi gestione indicati all’articolo 143, comma 3.2. Le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono dirette a stabilire unaspecifica disciplina di tutela e valorizzazione, che sia maggiormente rispondente aglielementi peculiari e al valore degli specifici ambiti paesaggistici e costituisca parte inte-grante di quella prevista dal piano paesaggistico.
Articolo 139Partecipazione al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico
1. La proposta della commissione per la dichiarazione di notevole interesse pubblico diimmobili ed aree, corredata dalla relativa planimetria redatta in scala idonea alla loroidentificazione, é pubblicata per novanta giorni all’albo pretorio e depositata a disposizio-ne del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.2. Dell’avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su almenodue quotidiani diffusi nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano adiffusione nazionale e, ove istituiti, sui siti informatici della regione e degli altri enti pubbli-ci territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela.3. Entro i sessanta giorni successivi all’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio della pro-posta della commissione, i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioniportatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349 e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni alla regione, che haaltresì facoltà di indire un’inchiesta pubblica.4. Successivamente agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 la regione, per gli immobiliindicati alle lettere a) e b) dell’articolo 136, comunica l’avvio del procedimento di dichiara-zione al proprietario, possessore o detentore del bene, nonché alla città metropolitana oal comune interessato.5. La comunicazione di cui al comma 4 ha per oggetto gli elementi, anche catastali, iden-tificativi dell’immobile, la proposta formulata dalla commissione, nonché l’indicazione deiconseguenti obblighi a carico del proprietario, possessore o detentore.6. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 4, ilproprietario, possessore o detentore dell’immobile può presentare osservazioni alla re-gione.

Codice dei beni culturali e del paesaggio - 251
Articolo 140Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza
1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminate le osservazioni etenuto conto dell’esito dell’eventuale inchiesta pubblica, emana il provvedimento di di-chiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) e dellearee indicate alle lettere c) e d) dell’articolo 136.2. Il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicatialle lettere a) e b) dell’articolo 136 è altresì notificato al proprietario, possessore o deten-tore, depositato presso il comune, nonché trascritto a cura della regione nei registri im-mobiliari.3. I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono pubblicati nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione.4. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all’albo pretorio di tutti i co-muni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata adisposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.
Articolo 141Provvedimenti ministeriali
1. Qualora la commissione non proceda alle proprie valutazioni entro il termine di ses-santa giorni dalla richiesta formulata ai sensi dell’articolo 138, ovvero laddove il provve-dimento regionale di dichiarazione di notevole interesse pubblico non venga comunqueemanato entro il termine di un anno dalla predetta richiesta, il direttore regionale puòchiedere al Ministero di provvedere in via sostitutiva.2. Il competente organo ministeriale, ricevuta copia della documentazione eventualmenteacquisita dalla commissione provinciale, effettua l’istruttoria ai fini della formulazione dellaproposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.3. Il Ministero invia la proposta ai comuni interessati affinché provvedano agli adempi-menti indicati all’articolo 139, comma 1, e provvede direttamente agli adempimenti indi-cati all’articolo 139, commi 2, 4 e 5.4. Il Ministero valuta le osservazioni presentate ai sensi dell’articolo 139, commi 3 e 6, eprovvede con decreto. Il decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico è notifi-cato, depositato, trascritto e pubblicato nelle forme previste dall’articolo 140, commi 2, 3 e4.5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle proposte di integra-zione, con riferimento ai contenuti indicati all’articolo 143, comma 3, lettere e) ed f), deiprovvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico esistenti.
Articolo 142Aree tutelate per legge
1. Fino all’approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell’articolo 156, sono comun-que sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dallalinea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unicodelle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato conregio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi de-

252 - Decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42
gli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la
catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninicae per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione
esterna dei parchi;g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definitidall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.227;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 1976, n. 448,l) i vulcani;m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore
del presente codice.2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano
delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei co-muni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati aisensi dell’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, intutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in appositoelenco redatto e reso pubblico dalla regione competente. Il Ministero, con provvedimentoadottato con le procedure previste dall’articolo 141, può tuttavia confermare la rilevanzapaesaggistica dei suddetti beni.4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicatiall’articolo 157.
Capo IIIPianificazione paesaggistica
Articolo 143Piano paesaggistico
1. In base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza eintegrità dei valori paesaggistici, il piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, da quellidi elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o degradati.2. In funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti, il piano attribuisce aciascun ambito corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica. Gli obiettivi di qualitàpaesaggistica prevedono in particolare:
a) il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfo-logie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecni-che e dei materiali costruttivi;
b) la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i di-versi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggisti-co del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti

Codice dei beni culturali e del paesaggio - 253
nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO e delle aree agricole;c) il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela
compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero direalizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli.
3. Il piano paesaggistico ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo. La sua elabo-razione si articola nelle seguenti fasi:
a) ricognizione dell’intero territorio, attraverso l’analisi delle caratteristiche stori-che, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizionedei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;
b) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraversol’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesag-gio, la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e didifesa del suolo;
c) individuazione degli ambiti paesaggistici e dei relativi obiettivi di qualità pae-saggistica;
d) definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l’uso del territo-rio compreso negli ambiti individuati;
e) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi dellearee tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli inter-venti di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati dinotevole interesse pubblico;
f) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significa-tivamente compromesse o degradate;
g) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi ditrasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono rife-rirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree in-teressate;
h) individuazione, ai sensi dell’articolo 134, lettera c), di eventuali categorie di im-mobili o di aree, diverse da quelle indicate agli articoli 136 e 142, da sottoporrea specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.
4. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi ditrasformazione del territorio, individua distintamente le aree nelle quali la loro realizzazio-ne è consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e deicriteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 3, lettere d), e), f) eg), e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche parametri vincolanti per lespecifiche previsioni da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione edi adeguamento ai sensi dell’articolo 145.5. Il piano può altresì individuare:
a) le aree, tutelate ai sensi dell’articolo 142, nelle quali la realizzazione delle ope-re e degli interventi consentiti, in considerazione del livello di eccellenza deivalori paesaggistici o della opportunità di valutare gli impatti su scala proget-tuale, richiede comunque il previo rilascio dell’autorizzazione di cui agli articoli146, 147 e 159;
b) le aree, non oggetto di atti e provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 138,140, 141 e 157, nelle quali, invece, la realizzazione di opere ed interventi puòavvenire sulla base della verifica della conformità alle previsioni del piano pae-saggistico e dello strumento urbanistico, effettuata nell’ambito del procedi-mento inerente al titolo edilizio e con le modalità previste dalla relativa discipli-na, e non richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e159;
c) le aree significativamente compromesse o degradate nelle quali la realizzazio-

254 - Decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42
ne degli interventi di recupero e riqualificazione non richiede il rilasciodell’autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159.
6. L’entrata in vigore delle disposizioni previste dal comma 5, lettera b), è subordinataall’approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico ai sensidell’articolo 145. Dalla medesima consegue la modifica degli effetti derivanti dai provve-dimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141, nonché dall’inclusione dell’area nelle categorieelencate all’articolo 142.7. Il piano può subordinare l’entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realiz-zazione di opere ed interventi ai sensi del comma 5, lettera b), all’esito positivo di un pe-riodo di monitoraggio che verifichi l’effettiva conformità alle previsioni vigenti delle tra-sformazioni del territorio realizzate.8. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui all’articolo 5, lettera b), siano effettuaticontrolli a campione sulle opere ed interventi realizzati e che l’accertamento di un signifi-cativo grado di violazione delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell’obbligodell’autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159, relativamente ai comuni nei quali sisono rilevate le violazioni.9. Il piano paesaggistico individua anche progetti prioritari per la conservazione, il recupe-ro, la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del paesaggio regionale indicandonegli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.10. Le regioni, il Ministero e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio possonostipulare accordi per l’elaborazione d’intesa dei piani paesaggistici. Nell’accordo è stabi-lito il termine entro il quale è completata l’elaborazione d’intesa, nonché il termine entro ilquale la regione approva il piano. Qualora all’elaborazione d’intesa del piano non conse-gua il provvedimento regionale, il piano è approvato in via sostitutiva con decreto del Mi-nistro, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio.11. L’accordo di cui al comma 10 stabilisce altresì presupposti, modalità e tempi per larevisione periodica del piano, con particolare riferimento alla eventuale sopravvenienza diprovvedimenti emanati ai sensi degli articoli 140 e 141.12. Qualora l’accordo di cui al comma 10 non venga stipulato, ovvero ad esso non segual’elaborazione congiunta del piano, non trova applicazione quanto previsto dai commi 5,6, 7 e 8.
Articolo 144Pubblicità e partecipazione
1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concerta-zione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni costituiteper la tutela degli interessi diffusi, individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio1986, n. 349 e ampie forme di pubblicità.2. Qualora dall’applicazione dell’articolo 143, commi 3, 4 e 5 derivi una modificazione de-gli effetti degli atti e dei provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141, l’entrata in vigoredelle relative disposizioni del piano paesaggistico è subordinata all’espletamento delleforme di pubblicità indicate all’articolo 140, commi 3 e 4.
Articolo 145Coordinamento della pianificazione paesaggistica
con altri strumenti di pianificazione
1. Il Ministero individua ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 le linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tuteladel paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione.

Codice dei beni culturali e del paesaggio - 255
2. I piani paesaggistici prevedono misure di coordinamento con gli strumenti di pianifica-zione territoriale e di settore, nonché con gli strumenti nazionali e regionali di sviluppoeconomico.3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 sono cogenti per glistrumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono imme-diatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumentiurbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento de-gli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quantoattiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunqueprevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione.4. Entro il termine stabilito nel piano paesaggistico e comunque non oltre due anni dallasua approvazione, i comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle areenaturali protette conformano e adeguano gli strumenti di pianificazione territoriale e urba-nistica alle previsioni dei piani paesaggistici, introducendo, ove necessario, le ulterioriprevisioni conformative che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultinoutili ad assicurare l’ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dai piani. Ilimiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli stru-menti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la parteci-pazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.
Capo IVControllo e gestione dei beni soggetti a tutela
Articolo 146Autorizzazione
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli attie dei provvedimenti elencati all’articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degliarticoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell’articolo 142, ovvero sottoposti a tutela dalle dispo-sizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni cherechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, han-no l’obbligo di sottoporre alla regione o all’ente locale al quale la regione ha affidato larelativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della docu-mentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, è indivi-duata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli in-terventi proposti.4. La domanda di autorizzazione dell’intervento indica lo stato attuale del bene interes-sato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasfor-mazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.5. L’amministrazione competente, nell’esaminare la domanda di autorizzazione, verificala conformità dell’intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne ac-certa:
a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;b) la congruità con i criteri di gestione dell’immobile o dell’area;c) la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

256 - Decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42
6. L’amministrazione, accertata la compatibilità paesaggistica dell’intervento ed acquisitoil parere della commissione per il paesaggio, entro il termine di quaranta giorni dalla rice-zione dell’istanza, trasmette la proposta di autorizzazione, corredata dal progetto e dallarelativa documentazione, alla competente soprintendenza, dandone notizia agli interes-sati. Tale ultima comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, aisensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l’amministrazione verifi-chi che la documentazione allegata non corrisponde a quella prevista al comma 3, chiedele necessarie integrazioni; in tal caso, il predetto termine è sospeso dalla data della ri-chiesta fino a quella di ricezione della documentazione. Qualora l’amministrazione ritenganecessario acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella prevista al comma 3, ov-vero effettuare accertamenti, il termine è sospeso, per una sola volta, dalla data della ri-chiesta fino a quella di ricezione della documentazione, ovvero dalla data di comunica-zione della necessità di accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi, per unperiodo comunque non superiore a trenta giorni.7. La soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giornidalla ricezione della proposta di cui al comma 6. Decorso inutilmente il termine perl’acquisizione del parere, l’amministrazione assume comunque le determinazioni in meritoalla domanda di autorizzazione.8. L’autorizzazione è rilasciata o negata dall’amministrazione competente entro il terminedi venti giorni dalla ricezione del parere della soprintendenza e costituisce atto distinto epresupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l’intervento edilizio. I lavorinon possono essere iniziati in difetto di essa.9. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 8, è data facoltà agli interessati dirichiedere l’autorizzazione alla regione, che provvede anche mediante un commissario adacta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualoravenga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, iltermine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione ri-chiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Laddove la regione nonabbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica,la richiesta di rilascio in via sostitutiva è presentata alla competente soprintendenza.10. L’autorizzazione paesaggistica:
a) diventa efficace dopo il decorso di venti giorni dalla sua emanazione;b) è trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che ha emesso il parere
nel corso del procedimento, nonché, unitamente al parere, alla regione ed alla provinciae, ove esistenti, alla comunità montana e all’ente parco nel cui territorio si trova l’immobileo l’area sottoposti al vincolo;
c) non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, ancheparziale, degli interventi.11. L’autorizzazione paesaggistica è impugnabile con ricorso al tribunale amministrativoregionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioniambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8luglio 1986, n. 349 e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse.Il ricorso è deciso anche se, dopo la sua proposizione ovvero in grado di appello, il ricor-rente dichiari di rinunciare o di non avervi più interesse. Le sentenze e le ordinanze delTribunale amministrativo regionale possono essere impugnate da chi sia legittimato aricorrere avverso l’autorizzazione paesaggistica, anche se non abbia proposto il ricorso diprimo grado.12. Presso ogni comune è istituito un elenco, aggiornato almeno ogni sette giorni e libe-ramente consultabile, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione pae-saggistica, con la annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se essasia stata rilasciata in difformità dal parere della soprintendenza. Copia dell’elenco è tra-smessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell’esercizio delle fun-

Codice dei beni culturali e del paesaggio - 257
zioni di vigilanza di cui all’articolo 155.13. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle istanze concernenti leattività minerarie di ricerca ed estrazione.14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle autorizzazioni per le attivitàdi coltivazione di cave e torbiere. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio ai sensi della normativa in materia, che sonoesercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesag-gistici, dalla competente soprintendenza.
Articolo 147Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali
1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall’articolo 143 riguardi opere da ese-guirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personalemilitare, l’autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi ai sensi de-gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e inte-grazioni.2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a normadell’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da eseguirsi da parte di amministrazionistatali, l’autorizzazione prescritta dal comma 1 è rilasciata secondo le procedure previsteall’articolo 26.3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Pre-sidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero, d’intesa con il Ministero delladifesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalità divalutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionaleche incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica.
Articolo 148Commissione per il paesaggio
1. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente codice le regioni promuovonol’istituzione della commissione per il paesaggio presso gli enti locali ai quali sono attri-buite le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica.2. La commissione è composta da soggetti con particolare e qualificata esperienza nellatutela del paesaggio.3. La commissione esprime il parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazionipreviste dagli articoli 146,147 e 159.4. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi che prevedano le modalità di parte-cipazione del Ministero alle attività della commissione per il paesaggio. In tal caso, il pa-rere di cui all’articolo 146, comma 7, è espresso in quella sede secondo le modalità stabi-lite nell’accordo, ferma restando l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 146, commi10, 11 e 12.
Articolo 149Interventi non soggetti ad autorizzazione
1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 143, comma 5, lettera b) e dell’articolo 156,comma 4, non è comunque richiesta l’autorizzazione prescritta dall’articolo 146,dall’articolo 147 e dall’articolo 159:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento stati-co e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli

258 - Decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42
edifici;b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non com-
portino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre ope-re civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologicodel territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antin-cendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142,comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
Articolo 150
Inibizione o sospensione dei lavori
1. Indipendentemente dall’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio prevista dagli articoli139 e 141, ovvero dall’avvenuta comunicazione prescritta dall’articolo 139, comma 4, laregione o il Ministero ha facoltà di:
a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di pregiu-dicare il bene;
b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), lasospensione di lavori iniziati.2. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su immobili od areenon ancora dichiarati di notevole interesse pubblico cessa di avere efficacia se entro iltermine di novanta giorni non sia stata effettuata la pubblicazione all’albo pretorio dellaproposta della commissione di cui all’articolo 138 o della proposta dell’organo ministerialeprevista all’articolo 141, ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la comunicazioneprevista dall’articolo 139, comma 4.3. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su di un bene paesag-gistico per il quale la pianificazione paesaggistica preveda misure di recupero o di riquali-ficazione cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni la regione non ab-bia comunicato agli interessati le prescrizioni alle quali attenersi, nella esecuzione deilavori, per non compromettere l’attuazione della pianificazione.4. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono comunicati anche al comune interes-sato.
Articolo 151Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori
1. Per lavori su beni paesaggistici che non siano già stati oggetto dei provvedimenti di cuiagli articoli 138 e 141, o che non siano stati precedentemente dichiarati di notevole inte-resse pubblico, e dei quali sia stata ordinata la sospensione senza che fosse stata inti-mata la preventiva diffida di cui all’articolo 150, comma 1, l’interessato può ottenere ilrimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le operegià eseguite sono demolite a spese dell’autorità che ha disposto la sospensione.
Articolo 152Interventi soggetti a particolari prescrizioni
1. Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali edi palificazione nell’ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) dell’articolo136, ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) dello stesso articolo, laregione ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corsod’esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l’utilità economica delle opere già realiz-

Codice dei beni culturali e del paesaggio - 259
zate, valgano ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo. La medesima facoltàspetta al Ministero, che la esercita previa consultazione della regione.2. Per le zone di interesse archeologico elencate all’articolo 136, lettera c), o all’articolo142, comma 1, lettera m), la Regione consulta preventivamente le competenti soprinten-denze.
Articolo 153 Cartelli pubblicitari
1. Nell’ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell’articolo 134 è vietato col-locare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell’amministrazionecompetente individuata dalla regione. 2. Lungo le strade site nell’ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietatocollocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensidell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive mo-dificazioni, previo parere favorevole della amministrazione competente individuata dallaregione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario coni valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.
Articolo 154Colore delle facciate dei fabbricati
1. L’amministrazione competente individuata dalla regione può ordinare che, nelle areecontemplate dalle lettere c) e d) dell’articolo 136, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cuicolore rechi disturbo alla bellezza dell’insieme, un diverso colore che con quella armoniz-zi.2. La disposizione del comma 1 non si applica nei confronti degli immobili di cuiall’articolo 10, comma 3, lettere a) e d), dichiarati ai sensi dell’articolo 13.3. Per i fabbricati ricadenti nelle zone di interesse archeologico elencate all’articolo 136,lettera c), o all’articolo 139, comma 1, lettera m), l’amministrazione consulta preventiva-mente le competenti soprintendenze.4. In caso di inadempienza dei proprietari, possessori o detentori dei fabbricati,l’amministrazione provvede all’esecuzione d’ufficio.
Articolo 155Vigilanza
1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da questo Titolo sono esercitatedal Ministero e dalle regioni.2. Le regioni vigilano sull’ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente decretolegislativo da parte delle amministrazioni da loro individuate per l’esercizio delle compe-tenze in materia di paesaggio. L’inottemperanza o la persistente inerzia nell’esercizio ditali competenze comporta l’attivazione dei poteri sostitutivi.
Capo VDisposizioni di prima applicazione e transitorie
Articolo 156Verifica e adeguamento dei piani paesaggistici
1. Entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, le regioni che

260 - Decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42
hanno redatto i piani previsti dall’articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490 verificano la conformità tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell’articolo143 e, in difetto, provvedono ai necessari adeguamenti.2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente codice, il Ministero, d’intesacon la Conferenza Stato-regioni, predispone uno schema generale di convenzione con leregioni in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, cen-simento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tec-niche per la loro rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare lainteroperabilità dei sistemi informativi.3. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi per disciplinare lo svolgimentod’intesa delle attività volte alla verifica e all’adeguamento dei piani paesaggistici, sullabase dello schema generale di convenzione di cui al comma 2. Nell’accordo è stabilito iltermine entro il quale sono completate le attività, nonché il termine entro il quale la regio-ne approva il piano adeguato. Qualora al completamento delle attività non consegua ilprovvedimento regionale il piano è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro.4. Se dalla verifica e dall’adeguamento, in applicazione dell’articolo 143, commi 3, 4 e 5,deriva una modificazione degli effetti degli atti e dei provvedimenti di cui agli articoli 157,140 e 141, l’entrata in vigore delle relative disposizioni del piano paesaggistico è subordi-nata all’espletamento delle forme di pubblicità indicate all’articolo 140, commi 3 e 4.5. Qualora l’accordo di cui al comma 3 non venga stipulato, ovvero ad esso non seguanola verifica e l’adeguamento congiunti del piano, non trova applicazione quanto previstodai commi 5, 6, 7 e 8 dell’articolo 143.
Articolo 157Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della
normativa previgente
1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 143, comma 6, dell’articolo 144, comma 2 edell’articolo 156, comma 4, conservano efficacia a tutti gli effetti:a) le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche,eseguite in base alla legge 11 giugno 1922, n. 776;b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;c) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensidella legge 29 giugno 1939, n. 1497;d) i provvedimenti di riconoscimento della zone di interesse archeologico emessi aisensi dell’articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24luglio 1977, n. 616, aggiunto dall’articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312,convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431;e) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi deldecreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;f) i provvedimenti di riconoscimento della zone di interesse archeologico emessi aisensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
2. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli immobili ed alle aree inordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata laproposta ovvero definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole interessepubblico o del riconoscimento quali zone di interesse archeologico.
Articolo 158Disposizioni regionali di attuazione
1. Fino all’emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice

Codice dei beni culturali e del paesaggio - 261
restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con re-gio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
Articolo 159Procedimento di autorizzazione in via transitoria
1. Fino all’approvazione dei piani paesaggistici, ai sensi dell’articolo 156 ovvero ai sensidell’articolo 143, ed al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensidell’articolo 145, l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione previstadall’articolo 146, comma 2, dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle auto-rizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall’interessato nonché lerisultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata conte-stualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensie per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.2. L’amministrazione competente può produrre una relazione illustrativa degli accerta-menti indicati dall’articolo 146, comma 5. L’autorizzazione è rilasciata o negata entro iltermine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque attodistinto e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l’interventoedilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di inte-grazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alladata di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione de-gli accertamenti. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6-bis del decreto ministe-riale 13 giugno 1994, n. 495.3. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l’autorizzazioneentro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione.4. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 2 è data facoltà agli interessati di ri-chiedere l’autorizzazione alla competente soprintendenza, che si pronuncia entro il termi-ne di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L’istanza, corredata dalladocumentazione prescritta, è presentata alla competente soprintendenza e ne è datacomunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione do-cumentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di rice-zione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accerta-menti.5. Per i beni che alla data di entrata in vigore del presente codice siano oggetto di prov-vedimenti adottati ai sensi dell’articolo 1-quinquies del decreto legge 27 giugno 1985, n.312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431 e pubblicati nellaGazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l’autorizzazione prevista dalcomma 1 e dagli articoli 146 e 147 può essere concessa solo dopo l’approvazione deipiani paesaggistici.

262 - Decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42
PARTE QUARTASanzioni
TITOLO ISanzioni amministrative
Capo ISanzioni relative alla Parte seconda
Articolo 160Ordine di reintegrazione
1. Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabilitidalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce undanno, il Ministero ordina al responsabile l’esecuzione a sue spese delle opere necessa-rie alla reintegrazione.2. Qualora le opere da disporre ai sensi del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-ediliziol’avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche alla città metro-politana o al comune interessati.3. In caso di inottemperanza all’ordine impartito ai sensi del comma 1, il Ministero prov-vede all’esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato. Al recupero delle somme relative siprovvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle en-trate patrimoniali dello Stato.4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondereallo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subitadalla cosa.5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è accettata dall’obbligato,la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nomi-narsi uno dal Ministero, uno dall’obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spe-se relative sono anticipate dall’obbligato.
Articolo 161Danno a cose ritrovate
1. Le misure previste nell’articolo 160 si applicano anche a chi cagiona un danno allecose di cui all’articolo 91, trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 89 e 90.
Articolo 162Violazioni in materia di affissione
1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cuiall’articolo 49 è punito con le sanzioni previste dall’articolo 23 del decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 163Perdita di beni culturali
1. Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle disposizioni della sezione Idel Capo IV e della sezione I del Capo V, il bene culturale non sia più rintracciabile o ri-

Codice dei beni culturali e del paesaggio - 263
sulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato unasomma pari al valore del bene.2. Se il fatto è imputabile a più persone queste sono tenute in solido al pagamento dellasomma.3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non è accettata dall’obbligato, lasomma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsiuno dal Ministero, uno dall’obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese re-lative sono anticipate dall’obbligato.4. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifestainiquità.
Articolo 164Violazioni in atti giuridici
1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti sta-biliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l’osservanza delle condi-zioni e modalità da esse prescritte, sono nulli.2. Resta salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell’articolo 61,comma 2.
Articolo 165Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale
1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall’articolo 123, comma 1, del decretolegislativo 29 ottobre 1999, n. 490, chiunque trasferisce all’estero le cose o i beni indicatinell’articolo 10, in violazione delle disposizioni di cui alle sezioni I e II del Capo V del Ti-tolo I della Parte seconda, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di unasomma da euro 77, 50 a euro 465.
Articolo 166Omessa restituzione di documenti per l’esportazione
1. Chi, effettuata l’esportazione di un bene culturale al di fuori del territorio dell’Unioneeuropea ai sensi del regolamento CEE, non rende al competente ufficio di esportazionel’esemplare n. 3 del formulario previsto dal regolamento (CEE) n. 752/93, della Commis-sione, del 30 marzo 1993, attuativo del regolamento CEE, è punito con la sanzione am-ministrativa del pagamento di una somma da euro 103, 50 a euro 620.
Capo IISanzioni relative alla Parte terza
Articolo 167Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria
1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, iltrasgressore è tenuto, secondo che l’autorità amministrativa preposta alla tutela paesag-gistica ritenga più opportuno nell’interesse della protezione dei beni indicati nell’articolo134, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equiva-lente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la tra-sgressione. La somma è determinata previa perizia di stima.

264 - Decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42
2. Con l’ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine perprovvedere.3. In caso di inottemperanza, l’autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggisticaprovvede d’ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese.4. Le somme riscosse per effetto dell’applicazione del comma 1 sono utilizzate per fina-lità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione dellearee degradate.
Articolo 168Violazione in materia di affissione
1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cuiall’articolo 153 è punito con le sanzioni previste dall’articolo 23 del decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO IISanzioni penali
Capo ISanzioni relative alla Parte seconda
Articolo 169Opere illecite
1. E’ punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro38.734, 50:
a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero ese-gue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell’articolo 10;
b) chiunque, senza l’autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affre-schi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti onon alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione previstadall’articolo 13;
c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili perevitare danni notevoli ai beni indicati nell’articolo 10, senza darne immediatacomunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, iprogetti dei lavori definitivi per l’autorizzazione.
2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell’ordine disospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell’articolo 28.
Articolo 170Uso illecito
1. E’ punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro38.734, 50 chiunque destina i beni culturali indicati nell’articolo 10 ad uso incompatibilecon il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o inte-grità.

Codice dei beni culturali e del paesaggio - 265
Articolo 171Collocazione e rimozione illecita
1. E’ punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro38.734, 50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dalsoprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui all’articolo 10, comma 1.2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente so-printendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora,ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesiminon subiscano danno dal trasporto.
Articolo 172 Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta
1. E’ punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro38.734, 50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell’articolo45, comma 1.2. L’inosservanza delle misure cautelari contenute nell’atto di cui all’articolo 46, comma4, è punita ai sensi dell’articolo 180.
Articolo 173Violazioni in materia di alienazione
1. E’ punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro77.469:
a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli ar-ticoli 55 e 56;
b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all’articolo 59,comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzionedi beni culturali;
c) l’alienante di un bene culturale soggetto a diritto di prelazione che effettua la con-segna della cosa in pendenza del termine previsto dall’articolo 61, comma 1.
Articolo 174Uscita o esportazione illecite
1. Chiunque trasferisce all’estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, et-noantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicateall’articolo 11, comma 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenzadi esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro258 a euro 5.165.2. La pena prevista al comma 1 si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rien-trare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stataautorizzata l’uscita o l’esportazione temporanee.3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a personaestranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganalerelative alle cose oggetto di contrabbando.4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione afine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna conseguel’interdizione ai sensi dell’articolo 30 del codice penale.

266 - Decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42
Articolo 175Violazioni in materia di ricerche archeologiche
1. E’ punito con l’arresto fino ad un anno e l’ammenda da euro 310 a euro 3.099: a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento dicose indicate all’articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni datedall’amministrazione; b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall’articolo 90,comma 1, le cose indicate nell’articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loroconservazione temporanea.
Articolo 176Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato
1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell’articolo 10 appartenenti allo Statoai sensi dell’articolo 91 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31a euro 516, 50.2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca previstadall’articolo 89.
Articolo 177Collaborazione per il recupero di beni culturali
1. La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 174 e 176 è ridotta da uno a dueterzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevolerilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all’estero.
Articolo 178Contraffazione di opere d’arte
1. E’ punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 aeuro 3.099: a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un’opera di pittura,scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico; b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzio-ne, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel ter-ritorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffat-ti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di og-getti di interesse storico od archeologico; c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) eb), contraffatti, alterati o riprodotti; d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri odetichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscen-done la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alte-rati o riprodotti.2. Se i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività commerciale la pena è aumentatae alla sentenza di condanna consegue l’interdizione a norma dell’articolo 30 del codicepenale.3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre quoti-

Codice dei beni culturali e del paesaggio - 267
diani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si appli-ca l’articolo 36, comma 3, del codice penale.4. E’ sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delleopere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a per-sone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la venditanelle aste dei corpi di reato.
Articolo 179Casi di non punibilità
1. Le disposizioni dell’articolo 178 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in ven-dita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie odimitazione di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, dichiarate espres-samente non autentiche all’atto della esposizione o della vendita, mediante annotazionescritta sull’opera o sull’oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimen-sioni della copia o dell’imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all’atto della esposi-zione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano rico-struito in modo determinante l’opera originale.
Articolo 180Inosservanza dei provvedimenti amministrativi
1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad un ordi-ne impartito dall’autorità preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del presenteTitolo è punito con le pene previste dall’articolo 650 del codice penale.
Capo IISanzioni relative alla Parte terza
Articolo 181Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa
1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori diqualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall’articolo 20 dellalegge 28 febbraio 1985, n. 47.2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato deiluoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla regione ed al co-mune nel cui territorio è stata commessa la violazione.

268 - Decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42
PARTE QUINTADisposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore
Articolo 182Disposizioni transitorie
1. L’articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come sostituitodall’articolo 3 del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, continua ad applicarsi li-mitatamente a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultanoiscritti ai corsi di diploma di laurea statale ovvero di scuola di restauro statale ivi previsti.2. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 2, lettere a), b) e c), del de-creto n. 294 del 2000, come sostituito dall’articolo 3 del decreto n. 420 del 2001. Le di-sposizioni di cui all’articolo 7, comma 2, lettere a) e c), del decreto n. 294 del 2000, comesostituito dall’articolo 3 del decreto n. 420 del 2001, si applicano anche a coloro i quali,alla data di entrata in vigore di tale ultimo decreto, ancorché non ancora in possesso deldiploma, erano iscritti ad una scuola di restauro statale o regionale ivi prevista finoall’anno accademico 2002-2003.3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri entipubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione dicui all’articolo 103, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitu-tiva, ai sensi dell’articolo 117, quinto comma, della Costituzione.
Articolo 183Disposizioni finali
1. I provvedimenti di cui agli articoli 13, 45, 141, 143, comma 10, e 156, comma 3, nonsono soggetti a controllo preventivo ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 14 gen-naio 1994, n. 20.2. Dall’attuazione degli articoli 5 e 44 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica.3. La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice si intende a titologratuito e comunque da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica.4. Gli oneri derivanti dall’esercizio da parte del Ministero delle facoltà previste agli articoli34, 35 e 37 sono assunti nei limiti degli stanziamenti di bilancio relativi agli appositi capi-toli di spesa.5. Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione dell’articolo 48, comma 5, sono elencatein allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensidell’articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. In caso di escussione di dette garanzieil Ministero trasmette al Parlamento apposita relazione.6. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai princìpi del presente de-creto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.7. Il presente codice entra in vigore il giorno 1 maggio 2004.
Articolo 184Norme abrogate
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:- legge 1 giugno 1939, n. 1089, articolo 40, nel testo da ultimo sostituito dall’articolo 9

Codice dei beni culturali e del paesaggio - 269
della legge 12 luglio 1999, n. 237;- decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente:all’articolo 21, commi 1 e 3, e comma 2, nel testo, rispettivamente, modificato e sostituitodall’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281; agli articoli 21-bis e 22, com-ma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto e modificato dall’articolo 9 del medesimo de-creto legislativo;- decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, limitatamente all’articolo9;- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente all’articolo 23, comma 3 e primoperiodo del comma 13-ter, aggiunto dall’articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472;- legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all’articolo 12, comma 5, nel testo modifi-cato dall’articolo 19, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; e comma 6, primoperiodo;- legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente all’articolo 7, come modificato dagli articoli 3e 4 della legge 12 luglio 1999, n. 237 e dall’articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n.513;- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente agli articoli 148, 150, 152 e153;- legge 12 luglio 1999, n. 237, limitatamente all’articolo 9;- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, limitatamente agli articoli 8, comma 2, e 9;- decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e successive modificazioni e integrazioni;- decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283;- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente all’articolo 179, comma 4;- legge 8 luglio 2003, n. 172, limitatamente all’articolo 7.

270 - Decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42
Allegato A(Previsto dagli artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3; 75, comma 3, lettera a)
A. Categorie di beni:
1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da: a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine; b) siti archeologici; c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e prove-nienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente amano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qual-siasi materiale (1) e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifestioriginali (1).
7. Opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultorea e copie ottenute con il medesimoprocedimento dell’originale (1), diverse da quelle della categoria 1.
8. Fotografie, film e relativi negativi (1).
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati oin collezione (1).
10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.
11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquantaanni.
13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia,anatomia. b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.
14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più dicinquanta anni.
I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da questo Testo Unicosoltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori indicati alla lettera B.

Codice dei beni culturali e del paesaggio - 271
B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro):
1) qualunque ne sia il valore 1. Reperti archeologici 2. Smembramento di monumenti 9. Incunaboli e manoscritti 12. Archivi
2) 13.979,50 5. Mosaici e disegni 6. Incisioni 8. Fotografie 11. Carte geografiche stampate
3) 27.959,00
4. Acquerelli, guazzi e pastelli
4) 46.598,00 7. Arte statuaria 10. Libri 13. Collezioni 14. Mezzi di trasporto 15. Altri oggetti
5) 139.794,00
3. Quadri
Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della pre-sentazione della domanda di restituzione.
(1) Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all’autore.


Documento della Conferenza dei Presidenti delle Regioni - 273
Documento della Conferenza dei Presidenti delleRegioni e delle Province autonomeRoma, 3 marzo 2005
SOMMARIO
1. Nota introduttiva2. Il problema da affrontare: il patrimonio culturale e le responsabilità dei pubblici poteri;un sistema di governo pluralista e integrato è una necessità3. La situazione determinatasi a seguito del Codice: un’incertezza da risolvererapidamente4. Protagonisti, strumenti e modi: a) premesse generali5. Segue: b) principi e modelli per l’intervento pubblico6. Segue: c) accordi, intese, convenzioni, forme di cooperazione6. 1. Partecipazione dei poteri regionali e locali alle attività di tutela6.2. Funzioni conoscitive: catalogo e sistemi informativi6.3. Fruizione, valorizzazione, gestione7. Nota finale: un programma di lavoro
1. Nota introduttiva.
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d. lgs. n. 42/2004) è un testo a cuipossono essere addebitati o accreditati molti difetti o molti pregi. In ogni caso, è unevento che coinvolge per intero la responsabilità di governo delle istituzioni pubblicheterritoriali e che le costringe a riconsiderare il loro ruolo ed a definire le prospettive ed iprogrammi di intervento.
Le regioni, in applicazione del principio di leale collaborazione, intendonomanifestare una prima ed impegnativa posizione di disponibilità propositiva nei confrontidello stato e degli altri enti. A questo fine, ritengono più produttivo soffermarsi sulleesigenze di fondo poste oggi ai pubblici poteri dal patrimonio culturale e sulle linee che, inpositivo, possono incardinare, ordinare ed avviare un processo di concludentecollaborazione.
2. Il problema da affrontare e le responsabilità dei pubblici poteri; un sistema digoverno pluralista ed integrato è una necessità.
La rilevanza del patrimonio culturale (oggi contemplato dall’art. 2, c. 1, del Codice)nasce e si sviluppa in un primo arco di tempo,come noto, in riferimento a due beni (ilbene oggi “culturale,”, art. 2, c. 2; e quello oggi “paesaggistico”, art. 2, c. 3) consideratiseparatamente (dalle due leggi – senza andare troppo indietro – n. 1089 e n. 1497 del1939) ed identificati attraverso una funzione (un’esigenza di pubblico interesse) in séomogenea, ma parziale (la tutela come mera individuazione-conservazione), a sua voltaisolata da altri bisogni e da altri interessi pubblici pur presenti nel contesto in cui il benesi colloca o di cui è palese forma espressiva: si pensi al paesaggio. Nel contempol’accentramento politico ed amministrativo dell’assetto del pubblico potere, riassunto edorganizzato nello Stato, è ad un tempo causa ed effetto di quelle concezioni e delle lorotraduzioni istituzionali.

274 - Roma, 3 marzo 2005
Con la Costituzione del 1948 (art. 9, sui beni paesaggistici e culturali come valoriaffidati alla Repubblica; art. 5 sulle autonomie locali, e artt. 114 e seguenti); con leesperienze maturate attraverso le prassi istituzionali e le politiche di intervento, ai varilivelli, centrale e locale; con l’evoluzione delle scienze, delle tecniche, dei canoni storicie sociali di immaginazione, percezione ed individuazione del bene e del patrimonioculturale; con la moltiplicazione degli interessi, dei bisogni e delle opportunità sociali; conla continua emersione dei loro reciproci intrecci e condizionamenti; e infine con la riformadel Titolo V, si innesca e progredisce un processo circolare che muove in sensoopposto. La struttura pluralista dei poteri pubblici e la crescita civile e socialecontribuiscono a scoprire ed a valorizzare la intrinseca dimensione “locale” comecomplemento essenziale del patrimonio culturale. A sua volta, l’accrescimento degliaspetti di rilevanza del bene (non solo la tutela, ma la valorizzazione, la fruizione, ecc.)legittima la pretesa ad una conformazione effettivamente pluralista dell’assetto (non piùdel potere pubblico, ma) dei pubblici poteri.
Di tutto questo vi sono, sul piano soggettivo, una diffusa consapevolezza e, sulpiano oggettivo, un’evidente riprova. La fase di emersione delle ragioni dellacomplessità e dei suoi aspetti si può sostanzialmente ritenere, almeno per un suo ciclo,conclusa. Il patrimonio culturale si è rivelato come un oggetto di (potenzialmente)illimitata consistenza e ricchezza e propone un altrettanto illimitato bisogno diconoscenza, di classificazione, di catalogazione. Ma non vi è istituzione alcuna chepossa pensare di farvi fronte da sola. Il pluralismo, dunque, non è più un’opzionepolitica o giuridica, è, innanzitutto e comunque, una necessità. Da qui si deve ripartire.Stato, regioni, enti locali, hanno - oggi - il compito di prenderne definitivamente atto e diprogettare e di praticare un livello ulteriore, delineando un’architettura che sappiasollecitare, promuovere ed ordinare l’iniziativa e l’inventiva dei tanti protagonisti. E’ ilmomento, per i pubblici poteri, di creare un sistema di governo e di amministrazionefondato sull’integrazione delle diversità, come già segnalato nel documento approvato invista della formazione del Codice (Conferenza dei Presidenti delle regioni e delleprovince autonome, 8 maggio 2003), e dunque di trovare misure di unità non amputandoma valorizzando e portando a compimento i vari aspetti di rilevanza del patrimonioculturale alla luce della sua intrinseca ed unitaria “missione”: la realizzazione dell’usopubblico, nelle sue anch’esse molteplici e differenti forme.
3. La situazione determinatasi a seguito del Codice: un’incertezza da risolvererapidamente.
Il Codice prende atto dell’esigenza di provvedere alla ricomposizione dei vari aspettidella rilevanza del bene. La conferma è nell’introduzione della categoria di genere (il“patrimonio culturale”), nella previsione di principi ad essa relativi, nella precisazionedelle funzioni concernenti il bene culturale e delle loro connessioni.
Diversa è la situazione per quanto riguarda l’assetto dei pubblici poteri e ladistribuzione delle funzioni e delle competenze. Il Codice contiene importantiprescrizioni, che, in termini generali, si fanno carico della presenza delle regioni e deglialtri enti territoriali, a cominciare dall’art. 1. Ma vi è anche la conferma di uno schema,teorico ed operativo, che consolida una duplice preliminare separazione: la separazioneconcernente la tutela dei beni culturali, attraverso la prevalente intestazione allo stato, equella concernente la valorizzazione, quando si tratta di beni statali. A queste riserve, siaggiungono, a fini di bilanciamento, numerose previsioni che aprono a forme di accordo,di intesa, di cooperazione fra stato, regioni, altri enti territoriali (in specie gli artt. 4 e 5,per la tutela e gli art. 102 e 112 per la fruizione e la valorizzazione).
Il punto non risulta univocamente interpretabile, ma è centrale, perché incide o puòincidere sull’intero sistema. Ne può derivare una linea tale da far arretrare il faticosopercorso volto a cogliere la dimensione unitaria del bene culturale come oggetto di cura

Documento della Conferenza dei Presidenti delle Regioni - 275
dei pubblici poteri e da determinare una tensione contraddittoria all’interno dello stessoCodice, che, in relazione all’altra specie di beni inquadrata nel patrimonio culturale,quella paesaggistica, presenta un impianto ben diverso. Oppure si possono elaborare esviluppare quegli elementi che consentono di fare limitati ma essenziali passi avantiverso un sistema realmente pluralista e perciò anche efficiente.
Peraltro, la direzione da imboccare già discende da quanto osservato (§ 1) e daquanto suggeriscono ulteriori specifici dati costituzionali. La Costituzione stessa, infatti,registra la possibile inadeguatezza dello schema di ripartizione in via generale da essamedesima prescritto (l’esclusiva statale sulla tutela) dove prevede la possibilità di formespeciali di autonomia (art. 116, c.3) ed in particolare dove espressamente indica “forme diintesa e di coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” (art. 118, c. 3). Inrealtà, dunque, i pubblici poteri sono tenuti ad adottare una prospettiva capace dicostruire un sistema pluralista ed integrato.
4. Protagonisti, strumenti e modi: a) premesse generali
I protagonisti naturali non possono che essere regioni ed enti locali. I soggettiportatori delle istanze di autonomia, per forza di cose (di coerenza e di credibilità), hannol’onere di promuovere e di attivare l’attività volta alla costruzione della trama di cui vi èbisogno.
Quanto a strumenti e modi, dinanzi alle possibili non univoche versioni del sistemadesumibile dal Codice (sopra § 2) e dinanzi ai rischi presenti pur nella positiva novitàdella varie figure di accordi (su cui subito sotto), vengono in evidenza due esigenze.
La prima comporta la definizione di alcuni principi generali e di alcune invariantidell’iniziativa regionale, per dare un primo contenuto alle linee con cui le regioniinterpretano, in modo comune e coordinato, l’intero sistema ed il loro ruolo: una sorta diagile ma significativo codice di comportamento, pubblico ed impegnativo. Su questo econ questo saranno chiamate a confrontarsi le altre istituzioni ed in specie lo stato, che,in applicazione del principio di leale collaborazione, dovrà essere sollecitato, in modocostante e propositivo, a fare quanto di sua spettanza per completare il quadro dellecondizioni istituzionali, normative e materiali che occorrono per una attuazione correttadell’intervento pubblico.
Una seconda esigenza riguarda l’utilizzazione delle forme convenzionali e dicooperazione. Accordi e intese hanno ormai da tempo cittadinanza in generale (si ricordil’art. 15 legge n. 241/1990). Nel settore in esame finiscono per avere un ruolo essenzialeper integrare, ricomporre, coordinare le funzioni ed il loro esercizio al di là della loroastratta ripartizione fra gli enti, come in più punti previsto dal Codice (oltre alle norme giàricordate, si possono vedere gli artt. 17, 18, 29, 40, 103, 118, 119, 121). Accordi, intese,forme di cooperazione, però, di per sé, automaticamente, non garantiscono ilconseguimento di ciò che si vuole ottenere; possono anche prendere una direzioneopposta e trasformarsi in fattori di ulteriore frantumazione dell’intervento pubblico inmisure contingenti, solitarie, meccaniche, prive di respiro e di strategie, e perciò piùfacilmente esposte a pressioni particolaristiche. E’ un esito da evitare. Il mezzo è lacreazione di un contesto, di una rete, in cui inserire ed a cui agganciare gli accordi.Questa condizione è in parte certamente realizzata attraverso la individuazione econdivisione dei principi comuni di cui subito sopra, ma, per un’altra (e conseguente)parte, necessita di appositi criteri concernenti il ricorso alle forme consensuali ed i lorocontenuti.

276 - Roma, 3 marzo 2005
5. Segue: b) principi e modelli per l’intervento pubblico
Adeguati principi generali comuni a cui dovrebbero ispirarsi la strutturazione ed icontenuti dell’intervento pubblico, a seconda delle varie competenze, sono sicuramente iseguenti:a) integrazione del quadro istituzionale, attraverso una maggiore ricomposizione delle
funzioni: per quanto possibile, l’esercizio delle funzioni e delle attività deve esserericomposto in testa alle strutture più adeguate, per ragioni istituzionali, territoriali,tecniche, ecc.;
b) consapevolezza del carattere di “situità” del bene del patrimonio culturale e dunquevalorizzazione della dimensione territoriale come ambito di riferimento dei progetti edi partecipazione alla definizione e realizzazione degli stessi, nonché di integrazionedelle competenze;
c) essenzialità della funzione conoscitiva, in termini di individuazione dei dati rilevantidal punto di vista della dimensione unitaria del bene culturale e del patrimonioculturale;
d) costituzione di forme di raccordo sistematico con le Università e con le istituzioni diricerca;
e) idoneità tecnica del personale e delle strutture organizzative, quale che sia il tipo difunzione (tutela, valorizzazione, gestione, ecc.): il patrimonio culturale è da semprestato oggetto di un intervento pubblico organizzato attraverso strutturespecialistiche, che anzi sono un contrassegno determinante del modello; laprofessionalità e l’autonomia tecnico-scientifica del personale addetto e dei tipiorganizzativi con cui esso è strutturato (come già segnalato nel citato documentoella Conferenza dei Presidenti) costituiscono dunque un elemento che condiziona(nella realtà, prima ancora che dal punto di vista giuridico) sia il recupero delladimensione unitaria del bene culturale sia ogni possibilità di intervento; si dovràdunque procedere lungo la strada indicata dall’art. 115, c. 2, a proposito dellagestione diretta, ed anzi trarne motivo per elaborare principi e regole di assicurare laqualità tecnico-scientifica dell’intervento pubblico in ogni suo segmento
f) congruità fra i livelli di governo e di amministrazione ed il contenuto della funzionee dell’interesse rappresentato: si deve evitare di concentrare nella medesimaistituzione o nella medesima entità organizzativa compiti fra loro intrinsecamenteconfliggenti;
g) costruzione e programmazione dell’intervento, specie per quanto riguarda lagestione, su basi territoriali e tecnico-materiali adeguate;
h) valorizzazione dell’apporto dei privati, singoli e associati, il che significa ancheelaborazione di regole e di strumenti in grado di conoscere e di verificare un sistemadi intervento che assume la normalità di una presenza privata;
i) determinazione delle garanzie di qualità dei soggetti che aspirano ad essereprotagonisti della gestione indiretta: è un compito di particolare rilievo per illegislatore regionale, anche per coerenza con quanto enunciato sopra sub h);
l) trasparenza e verificabilità: il tema riguarda le modalità di programmazione e diimpiego delle risorse e la promozione di sistemi e di strumenti volti a favorire laconoscibilità, ad opera dell’opinione pubblica, dell’effettivo funzionamento delsistema, compresa la parte eventualmente impersonata dai privati, singoli oassociati.

Documento della Conferenza dei Presidenti delle Regioni - 277
6. Segue: c) accordi, intese, convenzioni, ecc.
6. 1. Partecipazione dei poteri regionali e locali alle attività di tutela
Per soddisfare le esigenze in precedenza enunciate (n. 1 e n. 2) l’esercizio di alcunefunzioni in tema di tutela deve essere conferito alle regioni. Lo spazio ed il rilievoattribuiti dal Codice alla tutela tendono a condizionare fortemente gli altri aspetti dirilevanza del bene culturale. Dunque, ulteriori spostamenti verso l’amministrazioneregionale sono una condizione essenziale per impedire che, nei fatti, torni ad esseretotalizzante una (pur nei principi rifiutata) logica della separazione-estraneità dellecompetenze e degli interessi pubblici. Occorre dunque passare all’applicazione di quantodisposto dagli articoli 4 e 5 del Codice. In particolare, si dovrà provvedere ad una specificazione:a) dei possibili contenuti degli accordi e delle forme di coordinamento, anche con
specifico riferimento alla vigilanza (art. 18) ed alle ipotesi di intervento regionale;b) degli elementi di collegamento con i profili e con le linee di intervento previste dal
Codice in relazione ai beni paesistici;c) della partecipazione delle regioni e degli enti locali, con risorse proprie e con risorse
dell’Unione europea, all’attività di conservazione e della loro conseguentelegittimazione alla verifica dell’interesse dei beni culturali oggetto degli interventiconservativi; e ciò anche in riferimento all’art. 29 Cod.;
d) delle modalità attraverso cui sono chiamati a cooperare gli enti locali;e) del trasferimento di personale e di risorse finanziarie;f) di clausole tipo in ordine alle possibilità di recesso, ai meccanismi (sanzionatori e
procedurali) in funzione di reciproca garanzia, ai tempi di esecuzione;g) di criteri e regole tali da agevolare una tempestiva ed organica conoscibilità delle
forme consensuali e, ancor prima, delle procedure e dei contatti a tal fine avviati.
6.2. Funzioni conoscitive: catalogo e sistemi informativi.
La funzione conoscitiva è non solo fondamentale (come detto), ma ancheindivisibile. Essa non sopporta frantumazioni, omissioni o separazioni né in ragione deimolteplici aspetti di rilevanza del bene culturale né in ragione del pluralismo delleistituzioni. Le attività di catalogazione ed il catalogo, inteso come il luogo nel qualeconfluiscono le informazioni acquisite mediante l’attività di ricerca sui beni culturali e dovequeste informazioni sono costantemente aggiornate ed elaborate, presuppongono perciòun contesto ed un sistema unitario, quale che sia la loro (maggiore o minore) incidenzain materia di tutela, di valorizzazione, di fruizione, ecc., e debbono essere concepite epredisposte come un indispensabile servizio (il “quadro conoscitivo”) per ilcoordinamento e l’integrazione degli interventi statali, regionali e locali, oltre che comeun elemento di rilievo per la stessa iniziativa dei privati e per la definizione in concretodei rapporti fra attività pubbliche ed attività private.
Oltre alle previsioni di cui all’art.17 del D.Lgs. 42/2004, la necessità dell’interventoregionale è espressamente prevista in materia di beni paesaggistici dall’art. 132 Cod.(Osservatorio nazionale ed osservatori regionali per la qualità del paesaggio), ma ciò èda considerare anche come riconoscimento di un’esigenza concernente tutto ilpatrimonio culturale, a ulteriore riprova della sua unitarietà.
L’obiettivo di un sistema nazionale del catalogo fondato su cataloghi regionali, giàindicato dall’accordo Stato-Regioni del 2001, deve essere dunque confermato ed attuato,utilizzando anche le nuove disposizioni del Codice, e ponendo attenzione alla necessitàdi uno strumento conoscitivo per l’insieme del patrimonio culturale.

278 - Roma, 3 marzo 2005
6.3. Fruizione, valorizzazione, gestione.
Fruizione e valorizzazione sono attribuite alla competenza statale e regionale. Lavalorizzazione, peraltro, segue anch’essa, per una parte, il principio della separazione, inlinea con gli enunciati della corte Costituzionale (sent. n. 26/2004).
E’ evidente la necessità di forme di ricomposizione e di integrazione, da realizzareattraverso accordi e intese che il Codice stesso, in specie agli artt. 102 e 112, provvedead indicare, anzi a rendere in qualche modo sostanzialmente doverose (art. 112, c. 5).
Di questi accordi possono essere parti lo stato, le regioni, gli altri enti territoriali, edanche i privati, cosicché vengono ancor più in luce i rischi e le esigenze segnalate alprecedente § 6.1. In particolare, si debbono perciò:a) preliminarmente definire i criteri generali e le procedure previste dal c. 6 dell’art. 112,
il che consentirà di predeterminare modi e forme di integrazione con i privati, inapplicazione di uno dei più generali principi in precedenza elencati (§ 5);
b) progettare, programmare e specificare, mediante apposite previsioni ed anche congraduazione temporale, quei trasferimenti che, ai sensi dell’art. 102, in relazione allecondizioni reali di singoli “istituti e luoghi di cultura”, consentano integrazioniproficue dal punto di vista della funzione essenziale ed unitaria del bene culturale,che è la sua destinazione all’uso pubblico.
Separata attenzione meritano gli accordi in punto di gestione, di cui all’art. 115, c. 7,anch’essi da considerare nel complesso del quadro di collaborazione con lo Stato.
7. Nota finale: un programma di lavoro.
In ragione di quanto sopra esposto, le regioni chiedono al Ministero l’apertura di untavolo di lavoro, sul modello di quello a suo tempo attivato per la definizione deglistandard per i musei ai sensi del comma 6 dell’Art. 150 del Dlgs. 112/98, al fine didefinire regole e standard condivisi fra lo Stato e le Autonomie, in materia di tutela deibeni culturali, di catalogazione, ai quali improntare l’esercizio delle funzionieventualmente assegnate, tramite accordi o intese, al sistema delle Autonomie. E’ugualmente urgente avviare un confronto sull’attuazione delle previsioni di cui all’Art. 102del D.lgs 42/2004, relativo al trasferimento della disponibilità di istituti e luoghi dellacultura, dallo Stato al sistema degli enti locali
Il confronto fra Stato e regioni in sede centrale non potrà tuttavia prescindere,laddove possibile e opportuno, dalla sperimentazione, nelle singole realtà regionali, diconcreti percorsi operativi in ambito regionale. Le regioni sono infatti, in relazione alleloro competenze ed al ruolo ad esse complessivamente spettante, il soggetto istituzionalein grado di garantire da un lato la promozione ed il coordinamento delle iniziative e,dall’altro, effettive misure di indirizzo e di governo, capaci di evitare la frammentazione ela sterilità delle singole esperienze. E’ questa la strada da percorrere per perseguirel’obiettivo della costruzione di un sistema nazionale di governo dei beni e del patrimonioculturale, costituito da sistemi regionali.
Roma, 3 marzo 2005


Finito di stampare a BolognaMarzo 2005
Stamperia della Regione Emilia-Romagna