APPARTENERE A CRISTO: UN INCONTRO CHE DÀ SAPORE...
Transcript of APPARTENERE A CRISTO: UN INCONTRO CHE DÀ SAPORE...
2
APPARTENERE A CRISTO:
UN INCONTRO CHE DÀ SAPORE ALLA VITA
AMEDEO CENCINI
n prete romano, mi pare, gliel’ha anche detto… papale papale: «Ma
lei, papa Francesco, ce l’ha proprio coi preti. Ogni volta che parla di
loro ha sempre da rimproverarli!». Molti hanno proprio questa impres-
sione, perché, in effetti, so-
no molti gl’interventi di
papa Bergoglio in cui il to-
no è piuttosto deciso e sa di
richiamo, e non in generale,
ma sempre facendo riferi-
mento a modi di essere
molto precisi e da parte di
chi in realtà mostra di voler molto bene alla categoria.
La cosa, per altro, ha una sua logica e si spiega molto facilmente. Papa
Francesco vuole portare avanti una riforma della Chiesa, e sa bene che
una riforma della Chiesa parte dalla riforma del clero; non sarebbe pensa-
bile e possibile alcun cambiamento nella Chiesa senza un cambiamento
dei suoi preti. Molto probabilmente è proprio l’aver intuito questo, o
l’aver capito che il punto nevralgico o d’arrivo della riforma bergogliana è
esattamente questo, ciò che crea qualche maldipancia clericale.
U
3
Proprio per questo all’incontro del Papa con la CEI del maggio scorso,
all’apertura della 69.ma Assemblea generale, dedicata proprio al rinno-
vamento del clero, molti si aspettavano chissà quale tirata d’orecchie. In-
vece papa Francesco ha proposto una riflessione molto pacata e propositi-
va, da parte di chi conosce molto bene la situazione, le fatiche, i dubbi, la
complessità dell’esser preti oggi, non pretende risolvere sbrigativamente
il problema, ma dà un’indicazione precisa per il cammino da fare.
Più precisamente, il Papa parte da tre domande: cosa rende saporita la
vita del prete? Per chi e per che cosa impegna il suo servizio? Qual è la ra-
gione ultima del suo donarsi?
A queste tre domande risponde con un termine preciso e strategico: ap-
partenenza, declinato in tre direzioni, al Signore, alla Chiesa, al Regno. Come
bene ha intuito chi ha formulato il titolo di questa riflessione. Che vorrei
proprio commentare spiegando il senso dei termini, così evocativi. Divi-
derò dunque in tre sezioni tale explicatio terminorum: appartenenza, appar-
tenenza a Cristo, incontro che dà sapore alla vita. E metterò tali termini in
corrispondenza con le tre fasi pedagogiche dell’adesione a un valore: co-
noscenza, esperienza, sapienza. Ma tenendo sullo sfondo l’icona biblica
usata dal Papa nell’indirizzo ai vescovi: Mosè e il roveto ardente.
1. Appartenere: la conoscenza (di sé) che apre alla relazione
Il sacerdote è «uno che non s’appartiene», classica frase fatta, che noi
normalmente carichiamo di senso morale-spirituale, persino un po’ ecces-
sivo al limite dell’improbabile. In realtà, ogni persona normale e che ha
raggiunto un buon livello d’identità non s’appartiene. Appartiene a un al-
4
tro, come può essere la moglie; ma può appartenere anche a un ideale, a
un progetto diventato come una passione. L’uomo è fatto per appartenere
a un altro, a chi e come lo decide lui, ma in ogni caso non può esimersi dal
farlo.
Cosa vuol dire appartenere?
1.1. Consegnarsi, fidarsi…
Vuol dire consegnarsi, fidarsi e abbandonarsi (a un altro), esser parte
di… (un progetto comune, un amore…). È il contrario di «si tiene la vita
stretta tra le proprie mani», o non si fida abbastanza dell’altro, o calcola
bene a chi far credito e seleziona con accuratezza le relazioni. Potremmo
forse sintetizzare la differenza dicendo che chi appartiene normalmente
vive una forte relazione o conosce un grande amore, sa innamorarsi; chi
non appartiene a niente e a nessuno di solito non conosce nemmeno
l’esperienza d’un grande amore cui consegnarsi. È un po’ narciso, il Nar-
ciso disperato del mito greco che non si fida di chi lo ama e finisce per in-
namorarsi della sua immagine riflessa sulle acque del lago, immagine che
tenta disperatamente di abbracciare, finendo annegato dentro la sua ac-
qua, dentro questo falso innamoramento. Davvero un’identità liquida la
sua… Immagine diventata incredibilmente di moda in una società liquida
come la nostra.
Cosa c’è all’origine dell’appartenenza, da dove viene?
5
1.2. Dall’identità all’appartenenza
Fondamentalmente l’appartenenza suppone una buona identità, solo la
persona che ha acquisito la certezza d’una radicale e stabile positività per-
sonale può permettersi il lusso, e la libertà, di aprirsi all’altro, a lui conse-
gnandosi. Narciso, invece (don Narciso), non s’apre all’altro perché si
vergogna di sé (il contrario della stima), non crede d’essere amato proprio
perché non si sente amabile, non s’imbarca in una relazione d’amore per-
ché teme di non avere i nu-
meri per sostenerla. E finisce
per far l’amore con se stesso,
operazione che – come sap-
piamo − conduce alla morte
per soffocamento.
All’origine, dunque, c’è il
problema della positività
dell’io. Che è un’esigenza
fondamentale nella vita
d’ogni persona. E pure nella
vita del prete e del suo senso d’identità.
Ma che non ha l’attenzione che meriterebbe nella prima formazione, o
ce l’ha solo dal punto di vista dei contenuti (teologici) o del ruolo (pasto-
rale), come fosse automatico il passaggio dal teologico al pastorale, dallo
spirituale allo psicologico. Qui non possiamo affrontare il problema per
esteso, ma faremo solo un veloce accenno, partendo dal rilievo di papa
Francesco nel testo che stiamo considerando circa il presbitero «che si è
6
avvicinato al fuoco (del roveto) e ha lasciato che le fiamme bruciassero le
sue ambizioni di carriera e potere»; o il prete, ancora, che «non è un buro-
crate o un anonimo funzionario dell’istituzione […] e non cerca assicura-
zioni terrene o titoli onorifici». Sappiamo, per altro, quante volte risuoni
nei discorsi di Francesco questo invito a liberarsi dal virus del carrierismo
clericale, vero e proprio demone dal potere psicologicamente devastante.
La cui origine va ricercata esattamente in un difetto di positività della propria
identità.
Sabbia
Dove trova la radice della propria identità un presbitero? Non certo nel
primo livello, quello fisiologico, legato al proprio corpo e alla pretesa che
esso sia sempre sano-bello-forte-giovanile, né all’apparenza esteriore, an-
che se vi possono essere residui di questo tipo di identificazione in un cer-
to eccesso di attenzione al proprio look (il prete «bello»), alla propria salu-
te (il don salutista), al proprio abbigliamento (il prete elegante), a quel cer-
to discreto fascino del reverendo (il prete figo). Né l’identità del prete può
trovare il suo fondamento ultimo nelle doti e qualità che egli possiede (sa-
rebbe il livello psicologico), perché questo lo renderebbe pericolosamente
dipendente da tutta una serie di realtà: dai risultati delle proprie prestazio-
ni, dalla stima degli altri, dal consenso della folla…, al punto di non saper
accettare insuccessi né riconoscere i propri limiti…; lo renderebbe invidioso
come un preadolescente di chi ha di più (la famosa «invidia clericalis»,
spreco immondo di energie preziose) e competitivo nelle relazioni (fino a
godere degl’insuccessi altrui), compiacente coi superiori e cinico coi pari o
7
con gl’inferiori; lo porterebbe a identificarsi col ruolo (il prete «arruolato»
che non accetta di essere sostituito e vorrebbe non lasciare mai), magari
persino arrabbiato con la vita perché non avrebbe abbastanza, e pauroso di
rischiare e tentare avventure inedite (fingendosi umile laddove è solo in-
sicuro di fare bella figura), e in particolare creerebbe questa insana esigen-
za di emergere, diventare qualcuno, raggiungere titoli (di studio o comunque
di prestigio), fare carriera, vincere sugli altri, interpretando il suo ruolo
come una continua esibizione di sé (ovvero abusandone, vedi i vari esibi-
zionismi liturgici)… Non è su-
perbia se il superbo è uno che
si pensa (o si sforza di pensar-
si) chissà chi; è semmai la di-
sperazione di chi non ha trovato
un punto stabile e definitivo, che
in modo stabile e definitivo gli
dia la certezza della propria
positività, senza bisogno di ricorrere a compensazioni che mai gli risolve-
ranno il problema, e che al contrario non faranno che aumentare in lui una
sete insana e incolmabile, con inevitabili ricadute sul piano pastorale.
Quanti preti si sono persi o hanno perso la loro pace lasciandosi sedurre
da questo livello, tipico della fase adolescenziale, e che assieme al primo
livello (più infantile) sarebbe come la sabbia su cui è impossibile costruire
una solida abitazione (cf. Mt 7,21.24-27)! O quanti preti, con scarsa stima
di sé (e povero senso della loro amabilità) si sono ritrovati proprio per
questo in una situazione di vulnerabilità emotivo-affettiva, che li ha resi
8
eccessivamente sensibili rispetto al minimo segnale positivo di attenzione
affettiva (o affettivo-sessuale) nei loro confronti, illudendosi così di poter
risolvere il loro problema («se una mi ama vuol dire che sono amabile»), e
finendo spesso per divenire dipendenti dalla relazione, dalla persona in
questione, da gesti e segni vari d’affetto...! Quante crisi affettivo-sessuali
di preti o ex-preti sono nate non nell’area affettivo-sessuale, ma nell’area
della identità (non abbastanza positiva)! O quanti preti hanno ritenuto di
poter cambiare la propria identità vocazionale, specie quando questa s’è
rivelata meno gratificante rispetto alle attese, come fosse un abito nel
momento in cui questa non gli dava più un positivo ritorno d’immagine!
Roccia
Il livello ulteriore è quello autentico, adulto, roccioso, che non inganna:
il livello ontologico, ove la persona s’identifica per quello che è e per quello
che è chiamata a essere. Non più per quello che ha. Dunque per quello che è
già, anzitutto, per quello che ha ricevuto, per la vita, per l’amore, per gli
altri, per il dono della fede e per tutto quello che continua a ricevere, che è
sempre infinitamente di più del limite o del negativo che pure fa parte
della vita stessa. Ma che apre subito il suo spirito a riconoscere la fonte di
tutto ciò, quella volontà buona che s’è innamorata della mia immagine e
mi ha preferito alla non esistenza. È l’incontro con il roveto ardente, che
mette Mosè di fronte al mistero, quello di Dio – fuoco che arde e non
s’estingue −, e il mistero di se stesso, in particolare di quel che vuole e de-
ve realizzare, della sua vocazione; il mistero di Dio lento all’ira e misericor-
dioso, che ha ascoltato il gemito del suo popolo, e quello dell’uomo, chia-
9
mato a manifestare la tenerezza e volontà di salvezza di questo Dio. In
modo assolutamente inedito e imprevisto. Da un lato, tale fuoco brucia
ogni pretesa di autosufficienza dell’uomo (l’invito a non avvicinarsi trop-
po, a togliersi i sandali), dall’altro gli svela il futuro, quello che è chiamato
a essere.
È l’esperienza che dovrebbe essere strutturale per l’uomo-prete, proprio
nel senso che dà una struttura e un contenuto stabili alla sua identità, lo
definisce e lo rassicura nella sua positività, come qualcosa che ha già e che
pure gli sta davanti, e
che nulla più potrà
offuscare. Come una
teofania quotidiana.
Che l’uomo s’ap-
presta a celebrare
«scalzo» (come sotto-
linea papa France-
sco): senza la pretesa
d’esser lui a definire se stesso, la sua identità è «terra santa», luogo che
appartiene a Dio, e lui solo, il Creatore, può svelarti a te stesso. E ti svela
che la tua identità è contenuta-nascosta in quella di Dio, proprio perché
sei stato creato a sua immagine e somiglianza, e la potrai scoprire nella
misura in cui entri nel mistero di Dio, o ti avvicini ogni giorno alle soglie
di questo mistero, di questo roveto ardente. Qualcosa che «arde», non una
considerazione teorica, ma esperienza profonda e intensa, che «marchia a
fuoco l’esistenza, la conquista e la conforma a quella di Gesù Cristo», le dà
10
luce e calore, che ti coinvolge e cambia dentro. E allora tale esperienza ti
rende anche scalzo, sempre più scalzo, ovvero, nelle parole di Francesco,
quelle fiamme hanno bruciato «le sue ambizioni di carriera e potere», per
cui non ha bisogno di «assicurazioni terrene o titoli onorifici». Nel roveto
ardente dell’amore dell’Eterno gli è dato di trovare sempre di nuovo ciò
che dà sostanza e pienezza di significato alla propria persona, al punto
che non avrebbe senso cercare altrove, o lasciarsi illudere dalle luci ingan-
nevoli della carriera e della fama. Il suo bene è Dio, e quella parola che e-
sce dalla sua bocca. C’è una singolare espressione nel discorso del Papa,
quando dice che il prete che ha «accettato di non disporre di sé, non ha
un’agenda da difendere», che va inteso non solo come cose da fare e pro-
getti da realizzare, ma soprattutto come rinuncia a sentirsi artefice di se
stesso, ad autogestirsi la vita in autonomia, a decidere lui cos’è importante
fare, a lasciare che sia la Parola ogni giorno (la Parola-del-giorno) a stabili-
re priorità e urgenze.
In tal senso davvero chi ogni giorno vive questo rapporto con Dio «ro-
veto ardente» può dire che ha costruito la propria vita sulla roccia, e la sua
identità-positività è stabile: può anche vivere situazioni dolorose e negati-
ve, che sembreranno contraddire quella positività radicale, come
l’esperienza della propria fragilità o di tutto ciò che lo indurrà a riconosce-
re il proprio peccato (è un «paralitico guarito», dice Francesco, o «ladrone
graziato»); potrà affrontare insuccessi e fallimenti, soffrire l’eventuale po-
ca considerazione degli altri nei suoi confronti… senza deprimersi troppo,
senza cercare squallide compensazioni. Come purtroppo sovente succede
nella vita di troppi preti.
11
1.3. Appartenenza come
L’identità umana nell’identità divina
L’identità è un concetto individuale, si riferisce al singolo e al suo modo
di sentirsi. In realtà l’identità, quand’è correttamente definita, apre all’altro
e alla relazione. Ovvero, come abbiamo accennato più sopra, chi coglie la
propria positività in modo definitivo e stabile coglie, particolarmente nel
caso del credente, di non esser solo, anzi, di essere stato anticipato nel suo
pensarsi e provvedere a e stesso, scopre questa Volontà buona che l’ha
pensato da sempre al punto da volerlo esistente e riempirlo di beni e doni.
A questa Volontà buona egli si consegna, perché si fida di essa. Ma pure
ancor più profondamente perché si sente parte d’essa in qualche modo,
l’identità del credente nasce da quella di Dio secondo una logica di corri-
spondenza di significati, per cui se Dio è l’Amore, la creatura è l’amata; se
Dio è il Padre, io sono suo figlio; se lui è l’acqua viva io mi posso dissetare
solo bevendo di quest’acqua; se il Signore è il Bel Pastore io sono la sua
pecora…
Esser parte del dramma della salvezza
E non solo, l’appartenenza che nasce dall’identità significa che il cre-
dente e tanto più il presbitero è parte d’un progetto divino, che nasce con
la creazione e si compie con la redenzione. Ovvero l’identità vocazionale
presbiterale significa prender parte in modo attivo e responsabile al
dramma della salvezza o, detto diversamente, significa esser salvato (= io
attuale, come processo già compiuto grazie al sangue di Cristo) al punto di
esser chiamato a farsi carico della salvezza dell’altro (= io ideale, salvezza
12
in atto, della quale sono responsabile), «partecipe e responsabile del suo
destino». E dunque è un’appartenenza tutt’altro che solo spirituale e mi-
stica, pacifica e scontata, ma che carica di responsabilità drammatica. E, al
tempo stesso, conferma oltre ogni prospettiva solo umana la positività e
dignità dell’essere umano.
Dalla solidità-positività dell’identità al senso forte d’appartenenza
Infine, c’è un’appartenenza, che nasce dall’identità, nei confronti di co-
loro coi quali l’individuo condivide un certo progetto vocazionale, dun-
que l’identità. È così che il marito appartiene alla moglie (e viceversa); è
così che il presbitero appartiene al presbiterio e, più concretamente, ai
presbiteri che ne fanno parte, che solo in quel momento (ovvero a partire
da una solida identità) gli diventano fratelli; è sempre così che nasce la
comunità consacrata, in cui si condivide la medesima identità (senza che
questo porti al livellamento, visto che ognuno lo vive secondo la propria
originalità o secondo il proprio unico-singolo-irripetibile io attuale). Tale
appartenenza è tanto più forte quanto più positiva è l’identità, e indica in con-
creto condivisione, responsabilità reciproca, consegna di sé pure reciproca,
gusto di stare insieme, «obbedienza fraterna»…. Ma c’è anche un risvolto
negativo: molti problemi relazionali derivano da una debole identità, o da una
bassa stima di sé che produce rifiuto di sé, e dunque anche disagio con gli
altri, o proiezione negli altri dei propri conflitti personali irrisolti. Avere
una buona identità (e dunque stima di sé stabile e radicale) è un’esigenza
insopprimibile dell’essere umano. Quando uno non risponde in modo a-
13
deguato a quest’attesa la vita diventa una sfida continua e il soggetto un
problema per quei poveretti che gli vivono attorno.
2. Appartenere a Cristo: l’esperienza d’un incontro
Il presbitero appartiene a Dio in forza d’una relazione del tutto partico-
lare che lo rende conforme a Cristo. Proprio come dice il Papa riferendosi
al roveto ardente, che marchia a fuoco, conquista e conforma l’esistenza
del prete a quella di Gesù, «verità definitiva della sua vita».
Dalla fase della conoscenza passiamo ora a quella della esperienza. Come
dire che da un approccio soprattutto di tipo riflessivo-mentale occorre
passare a un approccio più globale, che coinvolge interamente il soggetto,
tutta la sua persona, tutto il suo mondo interiore soprattutto.
2.1. Sensibilità presbiterale, il luogo della formazione (permanente)
E qui c’imbattiamo in un termine che non ci suona nuovo, certamente,
ma che forse non è preso abbastanza sul serio dai nostri progetti formativi
o riformativi, e che invece è d’importanza assolutamente strategica nella
vita d’ogni essere umano. Basti pensare all’invito di Paolo ai Filippesi
(2,5): «Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù», lad-
dove l’originale fronein sarebbe meglio tradotto con sensibilità, visto che i
sentimenti sono solo una parte di quel tutto che è il nostro mondo interio-
re chiamato sensibilità. È già importante affermare questo: il prete deve
avere la stessa sensibilità di Gesù, non solo i suoi comportamenti. Poiché
la sensibilità – da un lato − è espressione immediata dell’identità,
14
dall’altro ognuno dovrebbe formarsi una sensibilità in linea con il proprio
io ideale, con quello che è chiamato a diventare.
In realtà questo è il vero obiettivo della vita del prete, che non può ac-
contentarsi di avere un certo comportamento, da devoto, dice il Papa, o da
corretto esecutore dei suoi doveri, rischiando di diventare «un burocrate o
un anonimo funzionario dell’istituzione», ma deve cambiare il cuore, per-
sino le emozioni, i sentimenti, gli affetti… Dobbiamo riconoscere che an-
cora non è sparita del tutto la tendenza ad accontentarsi nella formazione
iniziale d’una attenzione al versante comportamentale del soggetto, dan-
do pochissima attenzione a quel che avviene dentro, magari a insaputa dello stes-
so. È proprio per questo che sovente si giunge al termine del cammino
formativo (?), e si constata con soddisfazione che la persona ha imparato
molte cose e nozioni, ha superato tutti gli esami e anche qualche prova, ha
mostrato buona volontà e non ha dubbi sulla sua vocazione, ma se uno
spinge lo sguardo oltre la condotta visibile e cerca di guardare «dentro»,
scopre che la sensibilità è rimasta quella di prima, è stata quasi per nulla
sfiorata da tutti i contenuti teologici o dalle operazioni pedagogiche dei
lunghi anni di formazione. A cosa è servita questa formazione? Formazio-
ne che molto probabilmente si fermerà qui, perché ormai lo costatiamo
sempre più, fa formazione permanente solo chi ha intrapreso un cammino
di conversione profonda, che coinvolge la sensibilità, fin dalla prima for-
mazione. Chi non ha inteso e vissuto così la formazione iniziale è molto
difficile che entri nella logica della FP.
15
Grande risorsa
La sensibilità è quell’orientamento emotivo, e non solo emotivo, impresso al
nostro mondo interiore dalle esperienze passate e dalle scelte che abbiamo fatto e
continuiamo a fare, in diversi ambiti di vita, orientamento che ci attrae in una di-
rezione precisa. La sensibilità è una realtà complessa, formata dai sensi (e-
sterni e interni), sensazioni (reazioni di tipo fisico all’ambiente), emozioni
(reazioni psicologiche), sentimenti (sensazioni messe abitualmente in at-
to), desideri, gusti, affetti, criteri decisionali, passioni… E in diversi ambi-
ti: esiste infatti la sensibilità relazionale, penitenziale, morale (= la coscien-
za), credente, orante, intellettuale, estetica, vocazionale, pasquale, presbi-
terale, pastorale… È a causa della sensibilità che proviamo simpatie e an-
tipatie, o che un comportamento ci appare corretto o meno, o che «sen-
tiamo» una cosa come moralmente buona o cattiva, o che avvertiamo gu-
sto e attrazione nel vivere in un certo modo, o che siamo capaci di piange-
re. Tutti siamo più sensibili a qualcosa e meno a qualcos’altro, ma tutti
siamo sensibili, non esiste il tipo insensibile a tutto.
Ma da dove viene la sensibilità?
Grande responsabilità
Di solito si pensa che la sensibilità sia un dato pressoché istintivo, che
faccia parte del carattere, da accettare e basta. Niente di più sciocco. La
sensibilità all’inizio della vita è frutto dell’interazione con l’ambiente cir-
costante, ma poi diventa sempre più come il frutto delle scelte della persona, pic-
cole e grandi, poiché ogni scelta sposta energia in una direzione o in un’altra, e
dunque determina una progressiva tendenza: nella mente che giudica una
16
cosa come normale e lecita, nel cuore che avverte una sensazione positiva
in quella stessa direzione, nella volontà che si sentirà sempre più spinta ad
agire in quella maniera. Ma è importante dunque ricordare che la sensibili-
tà è la conseguenza dei comportamenti della persona, e può e deve esser oggetto di
formazione; ognuno ne è responsabile, o ha la sensibilità che si merita e che si è
costruito piano piano.
Se dunque il presbitero è chiamato ad avere in sé la sensibilità di Cristo,
deve partire dai sensi (esterni e interni), e poi dare attenzione alle proprie
sensazioni ed emozioni, verificare i propri sentimenti, discernere pensieri
e affetti, gusti e desideri,
interrogarsi sui criteri
decisionali coi quali sce-
glie, riconoscere gli affetti
che agitano il suo cuore,
specie quelli più inten-
si… Con pazienza e co-
stanza. Passando dalla
sincerità che consente di
dare un nome a ciò che uno prova, alla verità, che costringe a chiedersi da
dove venga, come mai sto provando quel sentimento, cosa dice di me
questa emozione. Solo chi compie tale passaggio evita la dittatura dei sen-
timenti e sperimenta libertà.
Celebrazione Eucaristica con S.E. Mons. Domenico Sorrentino
17
2.2. Odore delle pecore o mondanità spirituale
Sono entrambe espressioni di papa Francesco. Che indicano le due di-
rezioni opposte che può prendere il mondo interiore, o la sensibilità, del
pastore: o l’odore delle pecore o la mondanità spirituale.
Torniamo all’icona-madre della visione di Francesco proposta a tutti
noi: il roveto ardente che – ripetiamo questi tre verbi così efficaci − mar-
chia a fuoco e conquista l’esistenza del prete per conformarla a quella di
Cristo. Ne viene un cammino formativo formidabile, che non può non
impegnare la persona per tutta la vita, per esser attenta a ogni vibrazione
del cuore, ma anche all’uso dei sensi, per imparare a discernere pensieri e
sensazioni, e a cogliere quel peccato che è «accovacciato alle porte del
cuore», per esser reso simile in tutto alla sensibilità del Figlio obbediente,
del Servo sofferente, dell’Agnello innocente.
Papa Francesco ha sintetizzato il tutto con quella felice espressione di-
venuta emblematica: l’odore delle pecore, a dire un cammino davvero for-
mativo che cambia così radicalmente il modo di sentire del pastore fino a
cambiargli i sensi e rendergli familiare l’odore delle pecore (con tutte le
implicanze più o meno… maleodoranti). Espressione, dunque, che diven-
ta particolarmente efficace all’interno di questa nostra sottolineatura circa
la sensibilità.
Il contrario sarebbe la «mondanità spirituale che corrompe», come qual-
cosa che s’introduce lentamente nello spirito del prete, cammino lento e
lungo un piano che è inclinato, che di solito parte da concessioni veniali e
leggere a certe pretese istintuali, gratificazioni così piccole che il soggetto
non teme di ripeterle, ma che proprio la ripetizione fa lentamente diventare
18
abitudini, condizionando piano piano, come abbiamo detto prima, la mente
che dà il suo assenso, il cuore che se ne sente sempre più attratto, la volontà
progressivamente condizionata da qualcosa che s’impone in modo viepiù
automatico. L’individuo è così sempre meno libero e sempre più condizionato
da un atteggiamento interiore che lo attrae verso il basso: a volte verso esi-
ti comportamentali d’una certa gravità (vedi scandali sessuali e dintorni),
nella maggioranza dei casi verso quello spirito mondano, o sensibilità, che
prende il posto della sensibilità cristiana ed evangelica. Mondanità come
mediocrità; mediocrità come già perversione, ma perversione accettata senza
grandi turbamenti e sensi di colpa, senza lacrime né coscienza di conver-
sione, senza chieder perdono a nessuno né capire il male fatto. Ovvero,
esattamente come insensibilità.1
3. Incontro che dà sapore e sapienza alla vita
Il cammino di adesione a un valore culmina nella sapienza. Spesso pen-
siamo che l’esperienza sia il punto finale, e insistiamo perché vi sia un
rapporto esperienziale con il valore in questione che sarebbe il massimo
(ad es. esperienza di Dio). In realtà molte volte le esperienze rappresenta-
no nella nostra vita un evento passeggero, bello in sé, ma che lascia poche
o punte tracce (quante esperienze cosiddette spirituali hanno fatto questa
fine!). E invece no, c’è un altro gradino oltre l’esperienza, è la sapienza.
Vediamo di coglierne le caratteristiche principali.
1 Ho tracciato il percorso che conduce all’insensibilità in A.CENCINI, È cambiato qualcosa? La Chiesa dopo gli scandali sessuali, Bologna 2014, pp.67-93.
19
3.1. Definitività
Sapienza è accesso a una verità non solo con una conoscenza intellettua-
le, ma grazie a una esperienza di vita o a un rapporto intenso che segna in
modo definitivo e stabile identità e verità della persona. Il sapere di cui par-
liamo significa qualcosa che ormai è entrato nel modo di essere e di sen-
tirsi individuale, di pensarsi e leggersi, di giudicare il proprio vissuto,
d’intenderne correttezza e autenticità, di scegliere e riscegliere il proprio
progetto vocazionale, motivandolo e rimotivandolo in continuazione. È
proprio la sapienza, intesa come opzione definitiva della propria identità
(attuale e ideale) che consente non solo di non cambiare il proprio proget-
to di vita, ma di passare dalla perseveranza alla fedeltà. Ovvero dalla per-
manenza nello stato vocazionale solo o soprattutto materiale e fisica, a un
restare che è desiderato e scelto; da un permanere che è passivo e ripetitivo,
a una decisione rinnovata che s’avvale di motivazioni nuove e rende creativa
la fedeltà; da una permanenza che il soggetto decide dentro di sé e davanti
a sé, come davanti a uno specchio, a una decisione maturata dinanzi a un
Altro e alla sua fedeltà, la fedeltà è relazionale.
3.2. Sapore
Sapienza − come ben sappiamo − deriva dal latino sàpere, che significa
qualcosa di più del semplice sapere intellettuale o solo spirituale, e che
segnala invece la sensazione intensa del sapore, dell’assaporare la relazione
con il Signore Gesù, del gustare d’esser suoi discepoli, del provare l’Evangelii
gaudium, dell’imparare a godere della gioia delle Beatitudini, del soffrire il pro-
prio peccato. Sapienza psicologico-spirituale vuol dire tale capacità e liber-
20
tà, come una nuova sensibilità, che arricchisce enormemente la vita d’una
persona, ma ancor prima − sul piano del contenuto − significa la saggezza
del lasciarsi attrarre dal sapore della verità e la raffinatezza del palato che
ha imparato a gustare ciò che è in sé bello e buono, piacevole e desiderabi-
le, distinguendolo immediatamente da ciò che è cattivo e sgradevole. La
potremmo chiamare sensibilità o coscienza sapienziale.2
Ecco perché la vita spirituale che nasce dall’incontro con Cristo nel suo
significato più profondo è anche sguardo poetico, elaborazione creativa,
esperienza mistica, passaggio dal «fare esperienza» all’«essere esperien-
za», o «esperienza che trascende l’esperienza».
3 Ed ecco perché, come dice
Lonergan, «nelle cose della religione l’amore precede la conoscenza», e la
fede è la conoscenza che nasce dall’amore.4
3.3. Relazione
Infine la sapienza, afferma Giacomo nella sua lettera, è «pura, poi paci-
fica, mite e arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, senza par-
zialità e senza ipocrisia» (Gc 3,17). È curioso che in questa descrizione bi-
blica della sapienza5
2 Cf A.CENCINI-A.MANENTI, Psicologia e Teologia, Bologna 2015, p.289.
non vi sia alcun riferimento all’aspetto intellettuale di
questo atteggiamento virtuoso, come verrebbe spontaneo, cui vengono
invece attribuite qualità relazionali: pace, mitezza, arrendevolezza, miseri-
cordia, imparzialità… Si direbbe che la sapienza è relazionale, non solo
3 T. MERTON, Semi di contemplazione, Milano 1955, pp.181; 138. 4 B. LONERGAN, Il metodo in teologia, Brescia 1985, p.156. 5 Cf. in tal senso anche Sap 9,1-6.
21
razionale, crea rapporti e li purifica, fa vivere la qualità delle relazioni
perché giungano alla verità.
Se traduciamo tutto ciò in termini di sensibilità presbiterale-pastorale
vorrei indicare solo un aspetto, che troviamo sottolineato da papa France-
sco nel testo rivolto ai vescovi italiani. Un aspetto che mi sembra partico-
larmente necessario nel prete oggi.
3.4. Com-passione
È la capacità di provare compassione, compassione nel senso di patire
assieme, dunque come espressione ancora d’una certa sensibilità. E che
naturalmente ritroviamo in Gesù, che tutti riconoscevano in lui. Perché la
gente sentiva Gesù come uno che aveva autorità? Così diverso da scribi e
farisei, da quel sacerdote di cui Gesù stesso parla come esempio negativo
nella parabola del buon samaritano?
La risposta è interessante. La gente umile e semplice riconosceva
l’autorità di Gesù non necessariamente perché ne aveva teologicamente
colto l’origine dal Padre, ma perché si sente da lui compresa, e si sente da
lui compresa perché Gesù prende parte al suo dolore, piange di fronte al
feretro del figlio unico di madre vedova come alla notizia della morte di
Lazzaro, si accorge che la folla che lo segue è senza cibo, si commuove di-
nanzi all’ufficiale romano che gli chiede la guarigione del servo, espres-
sione di quel Padre che vede il suo popolo oppresso e soffre per lui e con
lui. Ecco la fonte dell’autorità. Forse ci appare insolita e singolare, eppure
22
continua a esser vero anche oggi. È la compassione la fonte autentica
dell’autorità del prete.6
L’autorità non è un tabù, un prete la deve saper esercitare. Ma stando
bene attento da dove nasce e da dove dovrebbe nascere. Se non c’è com-
passione nel suo cuore, lì si apre la strada verso le sciagurate e variegate
deformazioni del potere, che è l’interpretazione diabolica dell’autorità, o
la compensazione psicologica di
chi non è libero di provare com-
passione (e dunque non sarà
nemmeno autorevole e riconosciu-
to come tale).
Se invece c’è compassione allora
lì c’è vera autorità, quella che dav-
vero fa crescere l’altro (significato
etimologico), e dunque cambia to-
talmente il modo di relazionarsi
del prete, specie con chi è nel do-
lore e nella prova, e si apre con lui
e glielo racconta.
In concreto sacerdote capace di compassione è uomo di Dio capace di
ascolto umano, d’un ascolto il più possibile empatico, che non si ferma a ciò
che l’altro dice o magari di cui il penitente s’accusa, ma che cerca – per
quanto possibile − di capire ciò che c’è dietro, il contesto, il punto di vista 6 In fondo la compassione è ancora espressione di identità positiva e stabile, poiché indica una persona così sicura della propria positività da esser libera di accogliere il dolore (=la negatività) altrui senza il timore di perdere la propria positività.
23
in cui si pone il penitente stesso, soprattutto se dietro si percepisce una
certa sofferenza. Dobbiamo abituarci, dice Bonhoeffer, a valutare le per-
sone più per quello che soffrono, che non per quello che fanno.
Compassione significa un’altra cosa che a noi preti non viene sempre
facile, ovvero la sospensione del nostro giudizio morale. Se ascolti ascolta
davvero, non giudicare immediatamente, altrimenti il giudizio blocche-
rebbe la comunicazione. Il tempo della valutazione morale viene dopo,
prima devi capire.
Compassione è sentirsi allo stesso livello dell’altro. In altre parole, soprat-
tutto se si tratta di rapporto penitente-confessore, non puoi dimenticare
nemmeno un istante che sei anche tu penitente, né più né meno come chi
ora ti sta confessando i propri peccati. Anzi, a volte ti dà anche un certo
esempio di pazienza, fedeltà, forza d’animo, comprensione… Non è com-
passionevole chi si sente superiore all’altro. Il giusto è cordialmente pre-
gato di non fare il confessore!
Infine, compassione è libertà di patire assieme, di ospitare nel proprio cuore
almeno un po’ del dolore dell’altro. Che è una cosa prodigiosa, come una sor-
ta di travaso di sofferenza. Avere un cuore libero, come dovrebbe essere
un cuore sacerdotale, significa consentire a chi soffre e ti racconta la pro-
pria sofferenza di consegnarla almeno in parte a te. Anche per questo ci
consacriamo nella verginità del cuore, perché il cuore sia libero di ospitare
la pena altrui. In quel caso l’altro se ne va in qualche modo alleggerito e il
tuo celibato ha un senso. È un piccolo grande miracolo!
Sarebbe un test formidabile per noi preti. Quante volte ascoltiamo
drammi e disperazioni! Spesso ascoltiamo con professionale competenza,
24
sappiamo pure dire parole che ci sembrano consolatorie, ma poi la perso-
na se ne va e noi torniamo al nostro lavoro come se nulla fosse successo, a
volte persino dimenticandoci della persona e della sua pena. Il test sareb-
be semplice e infallibile: quando uno mi racconta il suo dolore io ci sto
male? Soffro con lui e per lui? Mi sento dentro in qualche modo quella
sofferenza? La riporto nella preghiera, la consegno al Signore?
Allora e solo allora saremmo preti che hanno autorità, l’autorità del Dio
ricco di misericordia e tenerezza. Autorità come sensibilità!
AMEDEO CENCINI, FDCC
25
Appartenere alla Chiesa:
un grembo che continuamente rigenera
LUCIANO MANICARDI
1. Presbitero e tempo
i è stato chiesto di commentare in particolare la seconda parte del
discorso di papa Francesco alla CEI del 16 maggio 2016, la parte
posta da papa Francesco sotto
il titolo: «Per chi impegna il
servizio il nostro presbitero?»
Una parte in cui le parole
chiave sono «comunità»,
«appartenenza», «partecipa-
zione», «relazione», «con-
divisione», ma soprattutto
«comunione». E per poter rispondere alla domande sull’impegno del
presbitero e sulla sua comunione con il Signore, con gli altri preti, con i
parrocchiani o i membri di un’associazione, occorre interrogarsi sulle
possibilità stesse di tale impegno e di tale comunione. Occorre cioè
chiedersi che cosa richieda un «impegno» e che cosa sia preliminarmente
necessario la comunione con «il Signore e con altre persone». Altrimenti il
nostro parlare cade nel vuoto e nella retorica. Dobbiamo cioè affrontare il
problema spinoso del rapporto tra il presbitero e il tempo.
M
26
Impegnarsi significa impegnare il tempo. La sua radice ha in sé l’idea di
dare in pegno, di obbligarsi, di promettere: e promettere è sempre
impegnare il futuro. Il presbitero che ha promesso la sua vita al Signore
nel servizio a una comunità ha impegnato la sua vita, ovvero il tempo del
suo vivere con perseveranza fino alla morte. Impegnarsi per qualcuno è
anzitutto impegnare il proprio tempo. Impegnarsi per qualcuno, come
dice papa Francesco, implica il dare ascolto, il dare parola, il dare
presenza, ma tutto questo significa «dare tempo». Il presbitero nutre
dunque la coscienza di fede che seguire il Signore e perdere la propria vita
nella sequela è semplicemente, e anzitutto, donare il concreto tempo della
vita. Possiamo dirlo così: senza comunione con il tempo, senza un
rapporto pacificato con il tempo, non ci sarà nessuna comunione con il
Signore e con le altre persone.
Ritengo che questo sia il problema decisivo che sottostà a molti
malesseri contemporanei e che rappresenti un’urgenza antropologica e
culturale che potrebbe costituire un tema di riflessione e elaborazione
nelle vostre associazioni. Diciamo di essere in un tempo di crisi, ma
stiamo vivendo una grave crisi del tempo, cioè delle modalità con cui
viviamo la dimensione temporale. Accanto alla dimensione ecologica
applicata allo spazio occorre inventare una ecologia del tempo, perché la
casa (oikos, questo significa la parola eco di ecologia) non è solo spazio,
ma anche tempo, tempo di abitare, di coltivare relazioni, di creare la
dimensione umana domestica, la fratellanza. Un’etica dell’ecologia esige
questa attenzione al tempo: non a caso il vocabolo greco êthos (ἦθος), da
cui proviene il termine «etica», ha anche il senso di «dimora»,
27
«abitazione». Ma il tempo, oggi, spesso anche per il presbitero non evoca
l’immagine della quiete domestica, ma dell’affanno della corsa. Spesso
anche il presbitero «non ha tempo»: sovraccarico di lavoro pastorale,
carenza di preti e pesi pastorali che gravano sempre più sulle spalle di
pochi, causano un ritmo di vita del presbitero spesso non umano, con
rischi di ricadute gravi a livello di qualità umana e spirituale della vita, di
conseguenze psicologiche, perfino di abbandoni. Per potersi impegnare
con serenità e dedizione al servizio delle persone e della comunità occorre
guardarsi dallo strutturare il proprio tempo in modo mondano, come
piccoli manager. Le
patologie del tempo oggi più
diffuse e che patisce anche il
presbitero sono: la
velocizzazione e l’accele-
razione (non si sopporta
l’attesa, la lentezza, il tempo
vuoto), la produttività e l’efficacia (il tempo non perso è quello in cui si
agisce efficacemente e si produce; si pensi all’iperattivismo pastorale);
l’atomizzazione e la frammentazione (non esiste più il tempo, ma solo i
tempi, segmentati, incalzanti, successivi, determinati da ciò che si fa: una
riunione, una catechesi, una eucaristia, un funerale, ...), l’episodicità e la
momentaneità (l’assolutizzazione del presente e il prevalere
dell’immediato sulle altre dimensioni temporali del passato e del futuro).
C’è chi parla di cronofagia per definire il nostro rapporto con il tempo.
28
Ribaltando il mito di Crono che divora i suoi figli, siamo noi umani che
divoriamo il tempo, e così ne abbiamo sempre meno.
Pongo ora alcune questioni sul rapporto presbitero e tempo che
potremo sviluppare e approfondire in sede di discussione.
2. Tempo e salute psicofisica
Se il tempo è vissuto in modo angosciato come nemico, per cui si deve
correre in continuazione, si devono fare azioni pastorali, sacramentali,
catechetiche, a volte devozionali, e tali che il presbitero stesso vi aderisce
poco, e questo ingenera dei modi di essere fondati sul risentimento e
sull’insoddisfazione che si esprimono con stress e rabbia, nervosismo e
frustrazione. E con ricerca di compensazioni. Il rischio dell’esaurimento,
del burnout è in agguato nelle relazioni di aiuto e nel ministero
presbiterale e proprio quando è vissuto con dedizione, con generosità,
senza risparmio. Se si vive il ministero sotto l’egida del dovere, si rischia
lo sfiancamento. Occorre trovare tempi e modalità di respiro. Il filosofo
Byung-Chul Han ha scritto: «In un mondo colpito da una sindrome
generale di dispnea» occorre ritrovare spazi di respiro perché solo così si
potrà ritrovare anche uno spirito: giocando sul doppio senso della parola
greca pneuma (respiro/soffio e spirito) il filosofo afferma che «chi perde il
soffio perde anche lo spirito».
Tempo e vita spirituale
Si abbia il coraggio di riscoprire la lentezza, il soffermarsi sulla cose, il
pensare e il riflettere. Si ritroverà la capacità di stupore che stiamo
29
perdendo, la capacità contemplativa, il godere delle cose, di un paesaggio,
di un fiore, di un volto. L’antica virtù dell’otium, il lavoro interiore, il dare
fondamenta spirituali all’agire umano e pastorale, il dare tempo alla
lettura e al pensare, è essenziale. Si tratta di accordare più importanza alla
qualità che alla quantità. Ma questo implica la creazione di un ordine e
l’assunzione di una disciplina degli impegni e degli orari, richiede il
coraggio di fare delle scelte nella propria giornata e di non subire la
tirannia delle tecnologie e dei mezzi di informazione, della televisione e di
Internet, dello
smartphone e
dei social che,
oltre a essere
strumenti di
grande utilità,
sono anche for-
midabili mezzi
per perdere tem-
po e dissipare se stessi. Otium, in un’ottica cristiana, significa anche
coltivare la preghiera, la vita spirituale.
Già Carlo Borromeo avvertiva i presbiteri: «Eserciti la cura d’anime?
Non trascurare per questo la cura di te stesso e non darti agli altri fino al
punto che non rimanga nulla di te a te stesso. Devi certo avere presente il
ricordo delle anime di cui sei pastore, ma non dimenticarti di te stesso». Si
stia attenti a non cadere nella nevrosi pastorale e si abbia il coraggio di
imparare a «dire di no». Avere tempo per sé, se non è vissuto come lusso e
30
privilegio, è fondamentale per dare profondità e qualità alla propria
persona e dunque autorevolezza al proprio ministero. In questo mi
permetto di ricordare due strumenti basilari di autoformazione del
presbitero su cui può fare affidamento per una trasformazione del proprio
cuore. La solitudine della propria camera e la Parola di Dio contenuta
nella Bibbia. La Bibbia è uno specchio che ci legge nelle nostre lacune e nei
nostri peccati e che ci offre l’immagine a cui conformarci: Gesù. Leggere la
Bibbia è farsi leggere da essa. Scrive Gregorio Magno: «La Sacra Scrittura
si presenta agli occhi della nostra anima come uno specchio, in cui
possiamo conoscere ciò che in noi c’è di bello e di brutto, possiamo
verificare il nostro progresso e quanto siamo lontani dalla meta».7
Per i
monaci la cella è specchio del monaco. Lo spazio materiale della cella e lo
spazio spirituale della solitudine divengono luogo di trasformazione e di
crescita spirituale per il presbitero. Dal riflesso si passa alla riflessione,
alla vita interiore. In tempi in cui la solitudine è radicalmente mutata e
rischia di scomparire perché anche in condizioni di solitudine fisica si è
sempre connessi con tante persone e presenze, è compito di chiunque
abbia a cuore l’educazione e la trasmissione di un sapere spirituale, il
coltivarla, esercitarsi in essa e mostrarne la fecondità.
Liturgia e tempo
La liturgia chiede lentezza, non nel senso di lungaggini o di pigrizia, ma
di gravitas, di coscienza della serietà del mistero che si sta celebrando.
Dunque non nel senso di ritualismo o di affettata religiosità, ma nel senso 7 GREGORIO MAGNO, Commento a Giobbe, 2,1,1.
31
che per il presbitero si tratta di essere totalmente e interamente in ciò che
si sta celebrando, immerso in esso, sicché mentre «fa la liturgia», il
presbitero è trasformato dalla liturgia. Ecco dunque che i gesti del
celebrante, il suo incedere, il proclamare l’evangelo, deve avere il giusto
tempo rifuggendo ogni frettolosità sicché appaia che il celebrante celebra
con tutto se stesso, corpo e spirito. Chiediamoci: che significa per il
comune partecipante all’eucaristia ascoltare e pronunciare parole come
«nei secoli dei secoli», «Regno eterno», «in quel tempo», «eternità», «per
sempre», ecc.?
3. Durata e perseveranza
La vita presbiterale richiede perseveranza e fedeltà e si snoda su una
durata. Occorre assumere la responsabilità della propria vita di fede e del
proprio ministero. Allora anche contraddizioni e amarezze, cadute,
sbandate affettive o disordini sessuali, potranno non divenire motivo di
abbandono, ma di re-inizio mettendo fiducia nella misericordia del
Signore. Occorre pazienza, che è la capacità di vivere l’incompiuto e
l’inadeguato in sé, negli altri e nella vita; la capacità di ricominciare
credendo di più alla misericordia di Dio e alla potenza della sua Parola
che all’evidenza della propria debolezza; la volontà di conversione, cioè il
concepire il ministero come la forma della propria sequela Christi e
dunque della mai finita conversione; l’assiduità alla preghiera: solo la
preghiera fa della fede una concreta e quotidiana relazione con il Signore.
Smarrire la preghiera è spesso l’anticamera dell’abbandono del ministero.
32
I passaggi critici della vita
Vi sono momenti della vita, tappe, età, che sono più critici, in cui siamo
più feribili e più fragili. La crisi del superamento della metà della vita − i
fatidici quarant’anni − in cui la coscienza che la morte entra nella nostra
vita perché ciò che ci resta da vivere è meno di ciò che abbiamo già
vissuto, in cui facciamo i conti e ci ritroviamo in rosso, in cui vediamo che
una quantità di possibilità sono chiuse e non più praticabili, è uno di
questi ed è molto destabilizzante. Occorre essere aiutati e accompagnati in
una relazione di paternità spirituale.
Alla radice dell’appartenenza e della comunione ecclesiale
Per chi impegna il servizio il presbitero? Si chiede papa Francesco e
prosegue: «Parti, innanzitutto, non perché hai una missione, ma perché
strutturalmente tu sei un missionario». Potremmo specificare la domanda,
per chi impegna il servizio il presbitero, con la più appropriata, «di chi si
fa servo il presbitero?». Non basta fare dei servizi, ma occorre essere servi.
La differenza è enorme. Si possono compiere molti e buoni servizi nella
Chiesa senza avere alcuna qualità di santità. E chi è il servo? Biblicamente
il servo è reso tale dall’ascolto della parola del Signore. Il servo del
Signore di cui parla Isaia è colui che dice: «Ogni mattina il Signore apre il
mio orecchio affinché io ascolti come i discepoli» (Is 50,4). E Maria è colei
che è resa serva del Signore dalla sua disponibilità radicale all’accoglienza
della parola di Dio in sé: «Ecco la serva del Signore, avvenga di me
secondo la tua parola» (Lc 1,38). Paolo, che più volte si proclama servo di
Cristo, afferma di essersi fatto «servo di tutti» (1Cor 9,19), «servo vostro»
33
(2Cor 4,5), egli cioè ha seguito l’esempio di colui che si piegò a lavare i
piedi ai suoi discepoli facendosi servo di tutti. Ora, alla radice della
comunione ecclesiale vi è l’appartenenza a Cristo attraverso l’ascolto
obbediente della parola del Signore. Attraverso l’impegno della propria
libertà a servizio della parola e della volontà di Dio. E questo è anzitutto
la postura della Chiesa nei confronti del suo Signore. Si deve qui ricordare
che al Concilio Vaticano II
si prese la decisione di
intronizzare l’evangelo
all’inizio di ogni seduta
affinché apparisse che il
Cristo stesso presiedeva il
Concilio e che l’intero
Concilio si poneva sotto
l’autorità della parola di Dio e che questa era la postura della Chiesa nel
suo insieme. Il Proemio della Dei Verbum dice, con parole che allora
risuonavano di una novità rivoluzionaria: «Dei Verbum religiose audiens
et fidenter proclamans, Sacrosancta Synodus verbis S. Joannis obsequitur
dicentis…» («In religioso ascolto della parola di Dio e procla-mandola con
ferma fiducia, il sacro Concilio aderisce alle parole di s. Giovanni il quale
dice…»). Il Proemio presenta il Concilio che parla di se stesso, che svela la
sua autocoscienza e si pone come esempio per quel «popolo degli
ascoltanti della parola» (Karl Rahner) che sono chiamati a essere i
cristiani. La centralità – così biblica – dell’audire, dell’ascolto, che
caratterizza la postura del Concilio e dunque della Chiesa, è decisamente
Celebrazione Eucaristica con S.E. Mons. Stefano Russo
34
innovativa. Lì si afferma che la Chiesa esiste in quanto serva della Parola
di Dio, sotto la parola di Dio, nel doppio movimento di ascolto e annuncio
della parola di Dio: «è come se l’intera vita della Chiesa fosse raccolta in
questo ascolto da cui solamente può procedere ogni suo atto di parola»
(Joseph Ratzinger). Per essere Ecclesia docens, la Chiesa deve essere Ecclesia
audiens. E la citazione del prologo della Prima Lettera di Giovanni (1Gv
1,2-3) annuncia il tema centrale e la parola chiave della DV e dell’intero
Concilio: comunione. Comunione che scaturisce dalla comunicazione che
Dio, il Dio trinitario (DV 2), cioè il Dio che è comunione nel suo stesso
essere, fa della sua vita agli uomini e che si manifesta pienamente in
Cristo. Questa comunicazione non è dottrinale, ma vitale, avviene nella
storia, ha come forma e centro il Cristo, come destinatario il mondo intero
e come fine la salvezza dell’uomo. E tale comunicazione è accolta
mediante l’ascolto, che è luogo di conversione del cuore, di
trasformazione della persona umana e di relazione con Dio e con gli
uomini. L’ascolto sempre rinnovato della Parola di Dio nelle varie epoche
e luoghi, nelle diverse contingenze storiche ed ecclesiali, nelle diverse
stagioni teologiche, è ciò che anima e rende vivo il cammino della
tradizione nella storia impedendo alla tradizione stessa di fossilizzarsi. Il
Proemio ha una struttura teologica significativa in quanto si apre e si
chiude sulla dimensione kerygmatica, e solo all’interno di essa viene
situata la dimensione dottrinale. Ciò che è essenziale è ciò che la Chiesa
ascolta e annuncia (dimensione kerygmatica): la dottrina non esiste scissa
dal kerygma della Chiesa. L’ascolto, attitudine decisiva per la Chiesa, è
all’inizio e alla fine del proemio, chiudendolo come in uno scrigno
35
(audiens … audiendo). Il card. Kasper, commentando questo testo di DV
ha scritto: «Non può esservi migliore espressione per dire il primato della
parola di Dio su tutte le parole e azioni del popolo di Dio».
4. Il presbitero, uomo di comunione perché uomo di ascolto
Se la Chiesa, l’ekklesía, nasce dall’ascolto della Parola di Dio che la
chiama (il verbo kaléo «chiamare» è presente nella radice del vocabolo ek-
klesía) a uscire (ek-) e ad andare verso l’umanità, il presbitero, dice papa
Francesco «è tale nella misura in cui si sente partecipe della Chiesa, di una
comunità concreta di cui condivide il cammino. Il popolo fedele di Dio
rimane il grembo da cui egli è tratto, la famiglia in cui è coinvolto, la casa
a cui è inviato. Ogni vocazione è sempre ricevuta all’interno della Chiesa e
rende appartenenti alla Chiesa, anche quando questa vocazione chiamasse
a una marginalità nei confronti della Chiesa stessa come appare nella
vocazione monastica. Nella Vita di Antonio, il padre dei monaci, Atanasio
racconta la sua vocazione: un giovane Antonio entra in una chiesa in cui si
sta leggendo Matteo 19, là dove si dice «se vuoi essere perfetto, va’, vendi
quello che possiedi, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi» (Mt 19,21).
Antonio ascolta quella parola, che significativamente è proclamata nella
liturgia, nella Chiesa, a significare che la vocazione è sempre debitrice
della Chiesa, luogo sacramentale dove avviene la trasmissione della
parola di Dio, e la sente rivolta a sé, in modo personalissimo. Antonio
prende sul serio quella parola ricevuta nel grembo della Chiesa ed inizia
una vita di radicalità cristiana mettendo in pratica ciò che aveva ascoltato
nel Vangelo. E che lo condurrà a vivere la sua fedeltà alla Chiesa nella
36
marginalità del deserto e della vita anacoretica. Il presbitero è uomo di
comunione a misura che si lascia plasmare dall’ascolto e dalla
realizzazione della Parola di Dio. Egli è affidato alla Parola di Dio, come
dice Paolo in At 20,32: non la Parola è affidata a lui in una visione
funzionalistica del ministero, ma il presbitero è lui stesso affidato alla
Parola che ha il potere di custodirlo nella comunione con il Signore, di
dargli forza preservandolo dalla divisione interiore che affatica e
scoraggia. Essere affidati a questa Parola significa da parte dei presbiteri
accettare che essa eserciti la sua signoria su di loro, che le loro vite
facciano perno su di essa. Ora, i presbiteri sono affidati alla Parola
attraverso l’ascolto assiduo della Parola e attraverso la messa in pratica
della Parola stessa. Dovere primario del presbitero è quello di accogliere,
custodire e realizzare la Parola: solo così sarà abilitato a comunicarla a
coloro ai quali è inviato dal Signore e potrà realizzare l’impegno e il
servizio a cui è consacrato. La Parola egli la comprende non in maniera
individualistica o intellettuale, ma collocandosi vitalmente nel grembo
generante di una concreta comunità cristiana. Scrive Gregorio Magno a
proposito del suo leggere la Scrittura per gli altri e con gli altri: «Molte
cose nella Santa Scrittura che da solo non sono riuscito a capire, le ho
capite mettendomi di fronte ai miei fratelli (coram fratribus meis positus
intellexi) … Mi sono reso conto che l’intelligenza mi era concessa per
mezzo loro … Grazie a voi imparo ciò che a voi insegno; infatti, con voi
ascolto ciò che a voi dico (cf. Omelie su Ezechiele, II,2,1). L’ascolto della
Parola deve diventare sua realizzazione obbediente. Gesù ha delineato il
processo della Parola che, seminata in abbondanza, può non venire
37
accolta da quegli ascoltatori da lui identificati nel terreno calpestato,
sassoso, spinoso (cf. Mc 4,1-20). Quella parabola dice che l’ascolto consta
dei momenti della interiorizzazione, della perseveranza e della lotta
spirituale: altrimenti il seme della Parola non porta frutto. Ascoltare è un
lavoro, un’ascesi. Il presbitero come uomo di comunione viene plasmato
lì, quotidianamente. La Parola viene ascoltata nella misura in cui viene
realizzata: se non c’è realizzazione, non c’è nemmeno ascolto. Se non c’è
ascolto, non c’è trasformazione, cambiamento, conversione. Il primato
dell’ascolto nella Scrittura sugli altri sensi è legato, per la Bibbia, al fatto
che esso è il senso della conversione: »Ascoltate, e la vostra vita rinascerà«
(Is 55,3). Un ascolto scisso dall’obbedienza, dalla pratica, crea personalità
spiritualmente scisse. E questo è un rischio purtroppo frequente, anche tra
presbiteri e religiosi. C’è il rischio di una schizofrenia tra il dire e il fare,
tra l’annunciare e il realizzare nella propria vita. È impossibile che non ci
sia uno scarto, perché noi uomini non siamo mai capaci di realizzare
pienamente il vangelo e non cadere in peccato, ma occorre da parte nostra
una tensione affinché quello che annunciamo risuoni sempre come
giudizio per noi stessi: se ciò non avviene, la schizofrenia che viviamo
diventa progressivamente una patologia con cui ci abituiamo a convivere,
e le conseguenze inevitabili sono forme patologiche e di doppiezza nella
vita spirituale e nel comportamento. Gesù ha avuto parole severe contro
quelli che «seduti in cattedra … dicono e non fanno«(cf. Mt 23,3). Ma il
magistero quotidiano della Parola rende il presbitero uomo capace di
creare comunione tra le persone a cui è inviato facendosi ministro di
ascolto. È lì che si verifica il movimento virtuoso di cui parla papa
38
Francesco per cui il presbitero si lascia evangelizzare dal Pastore buono,
dalla Parola del Signore, ma anche dal «popolo fedele», «dalla fede
semplice del popolo santo di Dio, con il quale opera e nel cui cuore vive».
Ma questo implica che per «costruire comunità» il presbitero diventi un
asceta dell’ascolto dei fratelli e delle sorelle in umanità. E lì si verifica −
come già detto − che il
presbitero è convertito non
solo dall’ascolto della Parola
di Dio ma anche dall’ascolto
del popolo. Ha detto papa
Francesco nel novembre del
2015 ai presbiteri: «Sapere e
ricordare di essere “costituiti
per il popolo” − popolo santo, popolo di Dio −, aiuta i preti a non pensare
a sé, ad essere autorevoli e non autoritari, fermi ma non duri, gioiosi ma
non superficiali, insomma, pastori, non funzionari [...] Io vi dico
sinceramente, io ho paura a irrigidire, ho paura. Ai preti rigidi …
Lontano! Ti mordono! [...] Il ministro senza il Signore diviene rigido e
questo è un pericolo per il popolo di Dio».
5. La comunione presbiterale
Un intero paragrafo è dedicato da papa Francesco al presbiterio. Ma
credo che ciò che dirò e che riguarda in prima battuta esattamente il
presbiterio si possa applicare anche alla costruzione di comunione
all’interno della comunità con laici e con l’insieme del popolo di Dio.
39
Resistenze alla fraternità presbiterale
«I sacerdoti sono uniti in una fraternità sacramentale, pertanto la prima
forma di evangelizzazione è la testimonianza di fraternità e di comunione
tra loro e con il Vescovo». Così papa Francesco nel discorso del 3 ottobre
2014 alla plenaria della Congregazione per il clero. Se il vescovo e il
presbitero sono servi della comunione ecclesiale, essi non possono
certamente esserli chiudendosi in un dorato isolamento o in atteggiamenti
ieratici o cedendo alla mondanità dell’individualismo imperante. Essi
sono chiamati a vivere la comunione anzitutto tra di loro, tra di loro
presbiteri, e tra presbiteri e vescovo, pena, la smentita del loro ministero,
la loro non-credibilità. La loro concreta comunione, il loro amore
reciproco è la loro prima testimonianza e forma di evangelizzazione.
Prima di ogni preoccupazione pastorale, di ogni attività organizzativa,
anche di ogni celebrazione cultuale, il ministero presbiterale si
caratterizza per questa comunione. Secondo il vangelo di Marco, Gesù,
dopo aver stabilito i Dodici «perché stessero con lui e per inviarli a
predicare» (Mc 3,14), li inviò «a due a due» (Mc 6,7; cf. anche Lc 10,1).
Perché la prima e fondamentale testimonianza a Cristo e al vangelo passa
attraverso la concreta carità vissuta reciprocamente. «Da questo tutti
conosceranno che siete miei discepoli: se avrete amore gli uni per gli
altri». Certo, questa comunione incontra in realtà numerose resistenze nel
vissuto personale dei presbiteri. Perché?
40
Il prevalere del ruolo
Anzitutto, c’è il rischio del prevalere del ruolo: un rischio è divenire
funzionari, magari efficienti, iperattivi (e il peso delle cose da fare è a volte
davvero eccessivo), dimen-
ticando la cosa più importante,
ovvero, la costruzione della
propria umanità, l’attenzione
alle virtù umane, alla relazione
con gli altri. In verità, tendere
concretamente a vivere il
proprio presbiterato insieme,
con gli altri presbiteri, ovvero,
nel corpo presbiterale di una
diocesi, è molto più
impegnativo e faticoso che fare
le cose da soli, senza gli altri, realizzando di fatto la figura di un piccolo
manager piuttosto che di un servo della comunione, e configurando la
comunità ecclesiale come macchina o azienda piuttosto che come corpo.
Ma questo è cedere alla tentazione dell’individualismo dominante. È fare
come fanno tutti. Le parole di Gesù ai Dodici nell’ultima cena secondo il
vangelo di Luca portano un’indicazione molto importante che regola il
ministero apostolico nei confronti della mondanità: «Voi però non così»
(Vos autem non sic: Lc 22,26). L’avversativa dice che c’è una lotta da fare.
41
La fatica di amare chi non si è scelto
L’attenzione alla comunione presbiterale implica un’attenzione agli altri
e un lavoro su di sé. Perché prima che presbiteri siete uomini chiamati ad
amare. E amare è un lavoro, una fatica esigente. Per giungere a relazioni
improntate a rispetto e amore, o almeno a fraternità e carità nel presbiterio,
occorre esercitarsi all’arte di amare chi non si è scelto. Se nel matrimonio i
partner si scelgono in base all’attrazione e all’amore, ai sentimenti, nel
presbiterio si è chiamati a cercare di amare chi ci è dato come co-
presbitero. Si tratta di andare al di là di simpatie e antipatie per mettere in
atto l’amore intelligente secondo il vangelo. Un amore nell’obbedienza.
Un amore che è obbedienza. Un amore che è effettivo ancor prima che
affettivo e si nutre di disponibilità alla collaborazione e anche di
attenzione all’altro, ai suoi momenti di difficoltà, alle sue solitudini.
La resistenza al cambiamento e alla conversione
Se quanto detto è vero, la resistenza alla comunione, che diviene poi
difficoltà a un lavoro insieme, alla sinodalità, è resistenza a quel concreto
cambiamento di sé in cui consiste la conversione. Chiediamo agli altri la
conversione con la predicazione, ma noi siamo disposti a cambiare?
Accettiamo il lavoro trasformativo su di noi che viene grazie alla relazione
attiva e concreta con gli altri, i membri della concreta comunità cristiana, e
anzitutto con gli altri presbiteri? Tertulliano scriveva che unus christianus,
nullus christianus, ovvero, che il cristiano esiste sempre in un corpo, in un
insieme, in una relazione, non da solo, quanto più questo vale per il
presbitero che è a servizio della comunione del corpo ecclesiale. Quel
42
corpo che è anzitutto il presbiterio, nella comunione tra presbiteri tra di
loro e tra presbiteri e vescovo.
Chiamati alla sinodalità
Papa Francesco afferma che «il nostro primo compito è quello di
costruire comunità». Il ministero ricevuto pone il presbitero a servizio
della comunione della comunità cristiana. Egli, dice il Concilio Vaticano II
«è stato consacrato per predicare il vangelo, pascere i fedeli e celebrare il
culto divino» (LG 28). Questo compito egli lo svolge nella coscienza di
essere in mezzo a un popolo di consacrati, cioè di uomini e donne «unti»
(il NT usa il verbo chríein), «santificati» (il NT usa il verbo haghiàzein)
mediante il battesimo, un popolo di «messianici», potremmo dire, perché
discepoli di Gesù il Messia. Il compito del vescovo e del presbitero è
quello di porsi a servizio del camminare insieme della comunità nella
comunione e nella diversità dei carismi. Ora, fin dall’epoca
neotestamentaria la sinodalità è la pratica ecclesiale della comunione. È la
via e la maniera di costruire la comunità e di edificarla nella comunione.
La logica di partecipazione a cui fa riferimento papa Francesco nel
discorso alla CEI trova il suo nome proprio nella sinodalità.
Se il cristianesimo viene chiamato «la via» (hodòs: At 9,2; 18,25-26; ecc.),
la modalità di viverlo è il sýn-odos, «il cammino fatto insieme». Nella
Chiesa, che è corpo del Signore nella storia, un’unica linfa vitale scorre
nelle varie membra sicché costitutivo della pratica ecclesiale è il fare le
cose insieme (sýn) e nella reciprocità, gli uni per gli altri (allélon).
43
Anzitutto, insieme: Paolo parla di collaborare (Fil 1,27; 4,3), di con-soffrire
(1Cor 12,26), di con-gioire (Fil 2,17), di con-riposare (Rm 15,32), di con-
vivere (2Cor 7,3), ecc. Paolo crea neologismi in greco per accentuare
questa dimensione comunionale che deve divenire pratica quotidiana
nella vita ecclesiale. Poi Paolo parla di reciprocità: si tratta di pregare gli
uni per gli altri (Gc 5,16), di perdonarsi gli uni gli altri (Ef 4,32), di
correggersi gli uni gli altri (Rm 15,14), di consolarsi a vicenda (1Ts 4,18;
5,11), di sopportarsi gli uni gli altri (Col 3,13), di accogliersi gli uni gli altri
(Rm 15,7), in una parola, di amarsi gli uni gli altri (cf. Gv 13,34). È invece
una contro-testimonianza quando nella Chiesa si vedono gruppi,
associazioni e movimenti che fanno le cose all’insaputa gli uni degli altri,
o in contrapposizione reciproca, gli uni senza gli altri. Nel discorso di
Paolo in 1Cor 12 sulla Chiesa come corpo formato di molte e diverse
membra, l’apostolo afferma che come nel corpo nessun membro può dire
all’altro «io non ho bisogno di te» (1Cor 12,21), così nella Chiesa nessuna
componente ecclesiale può fare le cose senza o contro le altre né al di
sopra o all’insaputa delle altre. La Chiesa è il luogo della povertà
condivisa: la comunione nasce non dall’accumulo delle forze e
competenze dell’uno e dell’altro, ma dalla condivisione delle povertà di
ciascuno. Questa la «condivisione virtuosa» di cui parla papa Francesco
nel nostro testo.
Il NT presenta la prassi sinodale all’opera in alcuni momenti decisivi
della vita ecclesiale e non la presenta mai nella forma di una democrazia
diretta, ma nell’articolazione tra «tutti», «alcuni» e «uno solo». Gesù,
durante la sua vita, fra tutti i discepoli ne ha scelti alcuni (i Dodici) e tra
44
questi ha distinto Pietro (uno solo). Al momento di completare il collegio
dei Dodici (alcuni) menomato per la defezione di Giuda, Pietro (uno solo)
si rivolge all’assemblea plenaria dei fratelli (tutti) che propone due nomi.
Dopo aver pregato, viene tirata la sorte e scelto Mattia (At 1,15-26). Questa
logica partecipativa è all’opera anche al momento di risolvere una
tensione sorta fra cristiani di origine palestinese e cristiani ellenisti circa il
sostentamento da assicurare alle rispettive vedove: non si agisce di
autorità, ma i Dodici formulano una proposta che, approvata da tutta
l’assemblea, porta alla decisione (At 6,1-7). Il cosiddetto Concilio di
Gerusalemme (At 15), in realtà un incontro in cui si è pervenuti a un
accordo tra Chiese che erano in contrasto su un punto preciso,
l’obbligatorietà o meno della circoncisione e dell’osservanza della Legge
mosaica da parte dei cristiani provenienti dal mondo pagano, mostra bene
lo stile sinodale presentando interventi di autorità delle chiese, riunioni
ristrette e infine riunioni assembleari, in plenaria, diremmo noi.
Ora, il principio sinodale, ovvero la strutturazione a piramide
rovesciata «tutti-alcuni-uno», si accompagna al principio di strutturazione
della comunione per cui vi è un primato. Nella Chiesa non si dà sinodalità
senza primato, né primato senza sinodalità. E la comunità ecclesiale vede i
presbiteri costituire insieme al loro vescovo un unico presbiterio. Se il
vescovo è chiamato ad assumere e ad esercitare una concreta paternità nei
confronti dei suoi preti, rendendosi disponibile ad incontrarli,
interessandosi della loro vita, della loro salute, delle condizioni in cui
vivono, così i preti sono chiamati ad entrare con il loro vescovo in un
rapporto leale, onesto, schietto, rispettoso, collaborativo. Un rapporto non
45
di adulazione, ma di rispetto, non di ribellione e di maldicenza, ma di
parresía. Io non intendo soffermarmi sui fondamenti teologici della
comunione tra presbiteri e tra presbiteri e vescovo, sulla necessità che il
presbiterio, come dice Ignazio di Antiochia, sia «armonicamente unito al
vescovo come le corde sono unite alla cetra» (Agli Efesini 4,1), ma voglio
solo ricordare alcuni atteggiamenti esistenziali e spirituali che possono
rendere possibile nel concreto la comunione presbiterale, tra preti e
vescovo e tra preti e laici. Atteggiamenti da porre in atto certamente nelle
riunioni, nelle assemblee, nelle giornate di aggiornamento e nei vari
consigli, per esempio nel consiglio presbiterale, dunque nelle istituzioni
sinodali, nei consigli pastorali, ma che, più in generale, devono reggere la
relazione quotidiana tra presbiteri, tra presbiteri e vescovo, tra presbiteri e
comunità.
6. La prassi della sinodalità e della collaborazione nel presbiterio
Anzitutto è importante che il vescovo vigili perché ci sia una buona
informazione di tutti i presbiteri circa la vita diocesana. Una dimensione
della sinodalità è l’informazione. L’informazione tende all’edificazione del
corpo ecclesiale. È importante che i presbiteri conoscano con chiarezza le
linee di governo del vescovo, conoscano motivazioni e finalità dell’agire
pastorale che viene loro richiesto, altrimenti, presto o tardi, ci si troverà di
fronte a un rifiuto inconscio o anche aperto della decisione. Ci si troverà di
fronte a una demotivazione, a un divorzio se non dal ministero, almeno
dalla volontà di impegnarsi.
46
Da parte dei presbiteri occorre la volontà di essere presenti alle
occasioni di incontro e di fraternità e di non cedere troppo facilmente alla
tentazione di dire «non servono a nulla», «sono inutili», «tanto non
cambia mai niente».
Occorre accettare di
essere scomodati. E
combattere la pigrizia, il
cinismo e la sfiducia.
Perché la fraternità
divenga responsabilità e
corresponsabilità tra
presbiteri e tra presbiteri e vescovo occorre mettere in atto diversi
atteggiamenti relazionali che comportano un impegnativo lavoro su di sé
e la disponibilità a sempre ricominciare. E ciò che ora elenco è però
essenziale non solo nei rapporti interni al presbiterio, ma in genere nella
conduzione della comunità cristiana, nella collaborazione con i laici, nella
condivisione di responsabilità con i membri della concreta comunità.
Serietà. Si tratta di prendere sul serio ciò che si fa: il proprio e l’altrui
ministero, la propria vita di fede e di preghiera, le relazioni con gli altri, ...
In particolare, si tratta di prendere sul serio le occasioni sinodali e i
momenti assembleari disponendosi a una partecipazione convinta e attiva.
Rispetto. Mi riferisco al rispetto dei preti tra di loro e del prete verso il
vescovo e viceversa. Ma è anche rispetto delle opinioni diverse dalla
propria, rispetto delle differenze, delle debolezze dell’altro. Rispetto è
47
anche capacità di vedere (re-spicere) i propri limiti, le proprie debolezze,
per non travalicare, per non peccare di hybris, per non cadere
nell’arroganza, nella prepotenza, nel disprezzo.
Fiducia. Un vescovo è il primo responsabile della creazione di un
clima di fiducia reciproca nel presbiterio. La sua disponibilità all’ascolto e
all’incontro dei suoi preti, il suo prendersi cura delle situazioni che gli
vengono presentate, nella coscienza che la sollecitudine per i presbiteri è il
suo primo compito, il suo essere «di parola», il suo ricordarsi delle
situazioni di ciascuno, tutto questo favorisce un clima di fiducia e fa
sentire come affidabile il vescovo stesso. Ovvio che questa apertura di
fiducia deve vigere anche nei presbiteri e tra di loro. Senza fiducia non vi
è alcuna possibilità di comunione e di fraternità. Non si abbia paura di far
fiducia!
Lealtà. Sulla fiducia si costruisce la lealtà, che è legame di alleanza con
gli altri, accordo per costruire insieme e camminare insieme. La lealtà è
impegno della volontà che si orienta verso un fine comune, un obiettivo
non individualistico, ma comune.
Sincerità. La sincerità accompagna la lealtà e impedisce di nascondere,
celare, mentire, dire verità parziali. Uno dei significati etimologici del
termine «sincerità» rinvia a «senza cera», in riferimento agli scultori che
non facevano ricorso alla cera per mascherare i difetti delle loro opere.
L’idea sarebbe quella di «genuino», «autentico», «senza finzione».
Sincerità rinvia anche a quella parresía che è libertà di parola e che deve
contraddistinguere ogni riunione sinodale e ogni rapporto intraecclesiale
48
autentico. Sincerità si deve accompagnare a chiarezza di comunicazione,
perché caritas è anche claritas.
Responsabilità. La responsabilità mi situa in rapporto vitale con Dio e
con gli altri e mi spinge a rispondere di me, di ciò che faccio, del ministero
che ho ricevuto, della mia vita di fronte al Signore, di fronte alla mia
coscienza, di fronte alla comunità. E anche, per il presbitero, di fronte al
vescovo e di fronte alla comunità. Della responsabilità fa parte costitutiva,
anche etimologicamente, la parola, la risposta. Una piena responsabilità
non può essere muta o non comunicativa.
Discrezione. Va infine ricordata la necessaria, anzi vitale, discrezione.
Discrezione da parte del vescovo che si trova a conoscere dettagli di
situazioni ecclesiali e personali di presbiteri che richiedono di non essere
divulgati, discrezione da parte di ogni presbitero per non cadere in quella
tentazione così spesso stigmatizzata da papa Francesco della chiacchiera,
della mormorazione, del parlar male degli altri, del vescovo o di altri
presbiteri.
6. Luoghi di costruzione dell’umanità del presbitero e della comunione
nella comunità
Individuo ora tre ambiti, tre punti cruciali su cui si costruiscono la nella
Chiesa: l’ascolto, la parola, l’affettività. Le tre cose rientrano in
quell’attenzione di cui parla papa Francesco affermando che «l’attitudine
alla relazione» è elemento a cui si deve prestare grande attenzione nel
discernimento vocazionale.
49
6.1 L’ascolto
L’ascolto è un atto intenzionale. A differenza del sentire che è meccanico,
l’ascolto esige una decisione, una volontà. Esso richiede concentrazione,
rientrare in sé, rispettare ciò che si ascolta senza manipolare, senza
forzare, senza interpretare arbitrariamente. L’ascolto tende a far emergere
ciò che l’altro dice e sente per far emergere chi l’altro è. Ascoltare è
impegno di tutta la persona, è un essere presenti all’altro senza riserve,
senza distrazioni, con piena attenzione, con coinvolgimento. Un ascolto
distaccato, asettico, non coinvolto, fallisce l’incontro a cui l’ascolto vuole
condurre. L’ascolto è atto che tende all’accoglienza dentro di sé dell’altro
(cum-prehendere). La fraternità presbiterale e l’amore pastorale nascono
dalla volontà di ascolto. Lì, inizia la condivisione di cui parla papa
Francesco.
L’ascolto non ascolta solamente le parole e le frasi ma anche il corpo. Anche il
corpo parla, anzi normalmente il corpo non mente a differenza delle
parole che mascherano o mentono apertamente. Ascoltare è anche
osservare, fare attenzione, cogliere i tic verbali e i movimenti del corpo
che si accompagnano alle parole dette, notare i riflessi emotivi che
sottolineano certi passaggi del parlare dell’altro. Nella comunicazione
umana sappiamo che i gesti, il tono della voce, i lineamenti del volto, le
posture del corpo, gli sguardi, comunicano molto di più del contenuto
delle parole. Ascoltare l’atteggiamento del confratello presbitero che vedo
preoccupato, teso, e che, forse, attende solo qualcuno che gli offra la
possibilità di dire ciò che lo sta facendo soffrire. Certi abbandoni della vita
presbiterale forse si sarebbero potuti evitare se il prete avesse avuto
50
l’occasione (certo, anche il coraggio) di dire ciò gli gravava sul cuore, la
crisi che stava vivendo. L’ascolto suppone che si rompa con i pregiudizi
sull’altro. Precomprensioni, etichette e pregiudizi sono un impedimento
all’ascolto. Ascoltare significa operare una purificazione delle idee che
avevamo sull’altro. Occorre essere aperti alle smentite e alla novità
quando ci si dispone all’ascolto. Il rischio è quello di proiettare sull’altro le
cose che sappiamo di lui o quelle che crediamo di sapere. L’altro non è
una categoria, ma una
persona, un volto, una
unicità irripetibile. E questo
io lo riconosco solo con
l’ascolto.
Ascoltare significa dare
tempo all’altro. La fretta è
nemica di un buon ascolto.
Occorre rimettersi ai tempi
dell’altro, non forzargli la
mano, ma acconsentire ai
suoi tempi perché arrivi a dire ciò che vuole dire. Ascoltare è dire di sì
all’altro e apprestargli uno spazio di rinascita. L’ascolto crea fiducia, che è
la matrice della vita. Ma su questo dare tempo ci siamo già soffermati.
Ascoltare è ospitare. L’ascolto è atto di ospitalità verso l’altro. Occorre
pertanto sgombrare il proprio io da pensieri, distrazioni, rumori,
immagini che riempono e non lasciano spazio all’altro di trovare dimora.
Se il nostro cuore trabocca di preoccupazioni, sofferenze, pensieri
51
autocentrati, non si rende libero per ascoltare e chiude all’altro la porta e
la possibilità di entrare in sé. L’ospitalità dell’ascolto si deve
accompagnare al pudore e alla discrezione. L’altro ci fa fiducia
consegnandoci timori, problemi, paure, parole delicate, angosce,
situazioni inerenti la sfera sessuale o morale: questo esige pudore, non
intrusività, non curiosità fuori luogo o morbosa, perché allora l’ascolto
diventerebbe violenza e abuso, pretesa e prevaricazione.
Ascoltare implica anche il fare silenzio. Non solo il tacere, ma il fare
silenzio, il fare del silenzio un’attività interiore. Il silenzio interiore è
silenzio delle conversazioni interiori, dei litigi interiori, delle voci e dei
rumori, delle immagini che ci attraversano e ci disturbano. L’ascolto esige
l’ascesi mentale, il dominio della facoltà dell’immaginazione. Solo così ciò
che l’altro ci dice e ci comunica ci può raggiungere in modo limpido.
Ascoltare è discernere. L’ascolto opera una cernita, un discernimento, una
scelta tra gli elementi che compongono il messaggio dell’altro. L’ascolto è
atto intelligente, selettivo: legge dentro, fra, negli interstizi del detto e del
non-detto, tra parole e gesti, nota le parole chiave e rivelatrici dell’altro.
Tante parole dette non sono essenziali al fine della conoscenza dell’altro,
ma spesso per comunicare qualcosa di importante si avvolge il messaggio
con parole che costituiscono un cuscinetto protettivo che attutisce il colpo
della rivelazione che sta a cuore. Ascoltare implica anche il vedere e
nominare le paure che possiamo avere nell’ascolto. Le resistenze
all’ascolto: ho il fastidio di chi è noioso, di chi è lento, di chi per dire una
cosa che ho già capito quale sarà, percorre un giro interminabile per
arrivarci, ho il terrore delle persone confuse e poco capaci di esprimersi
52
con chiarezza. L’ascolto diviene così anche svelamento delle nostre
miserie, delle nostre debolezze, delle nostre fragilità. Comprendiamo così
che l’ascolto dell’altro è anche, inscindibilmente, ascolto di sé. E, tra i
frutti che porta, non c’è solo la conoscenza dell’altro, ma anche di se stessi.
E, dunque, la conoscenza del Signore che è in noi, come è nel fratello.
Dunque, un presbiterio diviene realmente tale quando si crea in esso un
clima di ascolto reciproco.
6.2. La parola
La comunione è costruita (o distrutta) anzitutto dalle parole. La maggior
parte dei testi biblici riguardanti il prossimo verte sul parlare: «Dite
ciascuno la verità al proprio prossimo» (Ef 4,25); «Non pronunciare falsa
testimonianza contro il tuo prossimo» (Es 20,16; Pr 25,18); «Colui che
adula il prossimo gli tende una rete» (Pr 29,5); «Con la bocca l’empio
rovina il suo prossimo» (Pr 11,9), ecc. La costruzione della comunione
esige un’etica della parola, una responsabilità della parola. In particolare,
nello spazio della sinodalità, nella vita di un presbiterio e nella vita di una
comunità cristiana, occorre assumere la discussione come metodo
spirituale. La ricerca che si fa attraverso dibattito e discussione, magari
anche accesa, in cui si scontrano opinioni diverse, è la forma spirituale,
cioè mossa dallo Spirito Santo, di ricerca di forme e modalità comunionali.
Altre forme che potrebbero sembrare più spirituali, sono solo devozionali
o magiche. Tommaso d’Aquino si oppone a coloro che aprivano a caso la
Bibbia per risolvere le controversie riconoscendo che una simile pratica è
un’offesa allo Spirito Santo, mentre i cristiani hanno come metodo quello
53
di dibattere e discutere in assemblea: «Invece di cercare l’accordo con gli
altri si fa ingiuria allo Spirito Santo che noi crediamo fermamente essere
presente nella chiesa e nelle assemblee» (Quodlibet XII,36). Né si deve
aver paura della diversità di opinione, di esprimere un parere difforme da
ciò che altri o la maggioranza hanno espresso. «La vera concordia è
intrecciata con la diversità, è intessuta con essa», dice Nicola da Cusa nel
suo De concordantia catholica (CC II,32,233).
Negli incontri come nelle relazioni quotidiane è bene che non ci siano
toni categorici, scatti d’ira, mancanze di rispetto, insulti o ingiurie. La
parola è lo strumento elaborato dagli umani per creare spazi alternativi
alla violenza. Per evitare la violenza occorre che la parola lasci sempre
spazio all’altro. La sinodalità è dunque il metodo di ricerca insieme della
verità e di costruzione comune di un senso attraverso il dialogo, lo
scambio della parola. Metodo che accorda importanza essenziale
all’interlocutore come soggetto e non lo considera mero terminale della
propria parola e della propria volontà (questo sarebbe ricadere nella
violenza). Se è vero che, nello spazio cristiano, ogni istituzione sinodale è
preceduta e nasce dall’evento fondante della comunione, così ogni
istituzione, ogni riunione sinodale deve condurre alla comunione, creare
comunione, avere la comunione come obiettivo ultimo. Comunione che si
edifica per la via faticosa del comune ascolto, della comune discussione,
della comune consultazione, della comune deliberazione.
54
Il processo sinodale può essere sintetizzato in queste quattro tappe:
1) ascolto reciproco
2) dibattito, discussione e confronto di posizioni
3) discernimento
4) decisione
In tutto questo non deve essere temuto nemmeno il conflitto. Il sinodo
sulla famiglia ha portato allo scoperto posizioni non solo diverse, ma
anche opposte e inconciliabili: solo dando voce al conflitto, esso può
essere affrontato e elaborato. Il conflitto è rivelativo di ciò che
normalmente resta celato e nascosto. Del resto, la dimensione conflittuale
è presente nella vita delle chiese fin dai più antichi tempi neotestamentari,
ne fa parte. Noi siamo in un contesto culturale che ha relegato spesso il
conflitto nello spazio del negativo, quando invece il conflitto è parte della
vita, e non è scandaloso che abiti anche il vivere ecclesiale e comunitario.
Una realtà senza conflitti non è solo una realtà senza passioni e senza
convinzioni, ma più in profondità, è una realtà senza vita.
Nella Chiesa abbiamo bisogno di un’ascesi della parola, per giungere a
una disciplina della comunicazione. Non si dimentichi mai che ogni
parola è un gesto, che può fare del bene o del male. E ogni parola ha una
valenza etica: essa esige il rispetto di colui a cui parlo, di me che parlo (il
menzognero offende la propria dignità di persona) e della parola stessa
che non sopporta di essere manipolata, travisata, violentata. E si stia
attenti alle parole che giudicano, che etichettano, che deridono il
confratello, si stia attenti al gossip ecclesiastico. Strumento decisivo di una
comunione autentica e non solo di facciata nella Chiesa è la correzione
55
fraterna. Nella comunità cristiana la correzione del fratello, del presbitero,
che cade nell’errore è una responsabilità connessa all’essere tutti membra
dello stesso corpo. «Io sono custode di mio fratello», dice colui che assume
la responsabilità della correzione fraterna e così si sottrae al rischio di
divenire, come Caino, l’uccisore del fratello (cf. Gen 4,9). La correzione, la
parresía, su cui tanto insiste papa Francesco, il coraggio della parola che
svela il male al fratello per curarlo, è un atto di autentica fraternità, di
amore. Sì, l’amore autenticamente spirituale è capace di correggere e
ammonire l’amato. Il rischio è infatti di tacere il peccato per amore del
peccatore, divenendone così complici.
6.3. L’affettività
Esiste la possibilità di un celibato presbiterale sterile e infecondo. E di
una vita umana del presbitero che può immiserirsi, divenire meschina.
Vivere rapporti di autentica comunione richiede un’umanità salda e sana.
Anche per un presbitero che vive il celibato è importante e vitale la
dimensione dell’amore. Anch’egli deve porsi la domanda, soprattutto, nel
passare degli anni: Chi mi ama? Chi io amo? Questo non pone in
discussione la condizione del celibato sacerdotale, ma interroga la
modalità di vivere l’affettività di ogni presbitero. Maturità affettiva
implica la rottura del cordone ombelicale e l’uscita da una maniera
infantile e adolescenziale di vivere gli affetti. Implica la responsabilità di
farsi educatore e di troncare con la tentazione di farsi seduttore. Implica il
vivere in maniera adulta e responsabile le relazioni con gli altri preti e con
le persone che collaborano in parrocchia. Implica la rinuncia alle relazioni
56
impulsive e il lavoro di integrare il celibato nella propria personalità.
Anche il presbitero non deve dimenticare che è anzitutto un uomo e un
cristiano. Dunque una persona chiamata a umanizzarsi e a coltivare e
nutrire la propria fede. Non si dimentichi mai che, nel cristianesimo, in
cui l’umanità di Gesù di Nazaret narra pienamente Dio, ciò che è
autenticamente umano è anche autenticamente spirituale, e ciò che è
autenticamente spirituale è anche autenticamente umano. Guai se
l’esercizio del ministero diviene paravento per nascondere identità deboli
e immaturità umane o affettive che purtroppo prima o poi si
manifesteranno creando sofferenze se non scandali. Una sana e equilibrata
cura di sé è essenziale per una vita umanamente buona. Molto più che da
difetti di teologia del ministero o da carenze e incertezze della spiritualità
presbiterale, molti problemi dei presbiteri oggi nascono dalla schizofrenia
tra ministero e umanità, nascono da un rapporto non armonico tra
ministero e vita umana, tra ministero e relazioni interpersonali. Da una
carenza di comunione interiore, da una frantumazione interiore, che si
manifesta come doppiezza, come instabilità, come incapacità di fedeltà. Se
il presbitero si situa sulla scia della missione di Gesù stesso, egli è
chiamato anche a seguire Gesù nella pratica della sua umanità, senza mai
dimenticare che lo straordinario di Gesù si situa sul piano umano, non su
quello religioso. Gesù ha rivelato Dio, ha mostrato il volto di Dio nella sua
umanità e nel modo in cui ha vissuto la sua umanità. Oggi che
l’autorevolezza di un presbitero non è più connessa a segni esteriori o a
un ruolo, essa emerge dalla sua qualità umana, dalla qualità delle
relazioni che vive, dalla profondità delle parole che pronuncia e della vita
57
interiore che nutre. È dunque vitale ripetere l’invito apostolico alla
vigilanza. Paolo dice ai presbiteri di Efeso: «Vegliate su voi stessi» (At
20,28). Analogo avvertimento è rivolto a Timoteo: «Vigila su te stesso»
(1Tm 4,16). Sì, vigilare su se stessi, sul proprio corpo, sul vestito, sul cibo,
sulla casa in cui si abita, sui beni della parrocchia, sul denaro, sul
ministero, sulle parole e sui silenzi, sulle relazioni e sui gesti che le
accompagnano. La vigilanza è richiesta a tutti, ma essa assume connotati
particolari in cui vive la condizione del celibato e deve dunque dotarsi di
una struttura dialogica interiore che si misura con la propria coscienza e
con le esigenze del vangelo. Essa è essenziale perché il presbitero diventi
uomo di relazioni mature, capace di comunione, che evangelizza già con il
suo essere, con la sua umanità e con la qualità delle sue relazioni.
LUCIANO MANICARDI, monaco di Bose
59
APPARTENERE AL REGNO:
IN UNA «COMPAGNIA» DA CONDIVIDERE
ANTONIO MASTANTUONO
Fedeltà e rischio, tempio e strada,
contemplazione e lotta
non sono termini contraddittori
ma modi diversi e ineludibili
di vivere il proprio mistero di risorti.
(T.Bello)
1. Da «custodi del santuario» a preti sulle strade dell’uomo
ella tradizione religiosa di tutti i popoli la vita di un uomo che cerca
Dio è semplice. Sa che fare, dove andare. Dio lo si incontra sulle
«alture», nei recinti sacri, nel culto, nei
libri sacri, separandosi dal mondo,
andando nel deserto, digiunando, nelle
lunghe penitenze, in pellegrinaggi di
espiazione, estraniandosi da tutto ciò
che è carne e sangue, concretezza della
vita, povere distrazioni in questa valle
di lacrime. L’»uomo di Dio» è il primo
a frequentare questi spazi, è il «tecnico» (per così dire) di questo percorso,
colui che dà direttive, spinge i peccatori a convertirsi e a pensare alla loro
anima. Nessuno può essere insieme «uomo di Dio» e «uomo del mondo».
N
60
C’è stato un tempo (lungo secoli) che, anche nella tradizione «vulgata»
dell’ebraismo e del cristianesimo, le cose andavano così. Sacerdoti, leviti,
preti, monaci, gente «separata», indicavano l’essenziale all’uomo del loro
tempo: fai spazio a Dio nella tua vita, almeno un giorno alla settimana,
almeno in alcune occasioni festose, sapendo che sei destinato a lasciare
questo mondo e che perdi tutto se perdi l’eternità beata di Dio.
Accanto a questa esistenza «religiosa», c’era ovviamente la vita
concreta, «profana», fatta di lavoro, di bisogni da soddisfare. Sapersi
districare tra questi due mondi rimaneva un’arte difficile. E l’uomo di
Dio aggiungeva: «Certamente nella vita mondana farai sbagli, offenderai
la legge divina, ma in questo caso una preghiera in più, una penitenza
supplementare, metterà le cose a posto. E se hai dei dubbi sulla strada da
percorrere, segui me – aggiungeva ancora – calca le mie orme».
Probabilmente si può così delineare il sottofondo mentale di tanti
credenti e praticanti nostrani. Forse anche di tanti preti e di quella figura
che alcuni chiamano il «cattolico medio», senza lasciarci capire per altro,
se quell’essere in mezzo, avvicini quel battezzato a una specie di anima-
sandwich o a un cattolico mediocre.
Oggi nutriamo seri dubbi se un simile «uomo di Dio» possa qualificarsi
come sacerdote cristiano. L’aggettivo «cristiano» fa la differenza, la
specificità, se è vero che il Dio di cui ci ha parlato Gesù di Nazaret è così
distante dalle tradizioni religiose dell’umanità. Proprio Gesù non ci ha
annunciato che Dio lo si incontra non separandoci dalla vita concreta ma
immergendoci in essa? Proprio da lui viene questo «cattivo» esempio: per
salvare l’uomo, non ha atteso che questi salisse fino in cielo separandosi
61
dalla terra, ma piuttosto lo ha inseguito facendosi terra, di terra, humilis,
carne e storia umana.
1.1. Intermezzo: la storia ci dice…
Una simile chiarezza sulla identità del seguace di Cristo e del vangelo
non ha sempre accompagnato il cammino della Chiesa. A volte si è
eclissata o imbarbarita dando luogo a due opposti atteggiamenti. Si è
andati dalla fede del tutto disincarnata a una intromissione tale nelle cose
del mondo da trasformare i ministri ordinati in tutt’altro che «uomini di
Dio», fino a fare della fonte una fonte blasfema di guadagno e,
soprattutto, di potere personale degli stessi uomini di chiesa.
Il Vaticano II ha preso posizione su questi «opposti estremismi». In
particolare la Gaudium et spes ha fatto entrare la storia e la concretezza
umana nella teologia, collocando però l’interesse per il mondo nella
prospettiva della salvezza di «tutto l’uomo», del riscatto, nella liberazione
da ogni idolo. Pace, guerra, acqua, petrolio, lavoro, giustizia, educazione,
salute, casa, tutela dei deboli, equità sociale, diritti umani, sono luoghi
teologici dove Dio ha una parola da dire indicando in che direzione
bisogna trovare la soluzione dei problemi, se si vuole procurare il bene
dell’uomo e non di pochi prepotenti privilegiati.
Da quel momento la vita di un prete comincia ad essere davvero
complicata. Non perché è chiamato a soccorrere i poveri (questo si è
sempre fatto) ma perché non è abituato a vedere concretamente la
sacralità della persona umana nella sua inscindibile unità, e meno che mai
a vedere che nulla è profano, nulla è estraneo a Dio se tocca l’uomo.
62
Dobbiamo aggiungere che il Vaticano II scalzò oltre un millennio di
storia ecclesiastica perché di cose di mondo, di realtà terrestri, per una
prevalente affermazione di potere del papato e dell’alto clero, in un’ottica
che di cristiano aveva solo la copertura, la chiesa si era occupata fin
troppo.
Leggiamo con un certo imbarazzo oggi il Dictatus papae di Gregorio VII,
le affermazione di Innocenzo III sul suo diritto a esercitare potere anche
temporale sui principi terreni, l’Unam sanctam di Bonifacio VIII, gli
anatemi e le audaci affermazioni apodittiche di Gregorio XVI. Papa Borgia
credeva di avere il diritto di stabilire come dividere il Nuovo mondo tra
Spagna e Portogallo. Ed ai tempi di Giulio II si poteva scrivere che «ormai
i sacerdoti seguono perfino le armate, i vescovi le comandano,
abbandonando le chiese per gli affari. Ormai la guerra produce
addirittura sacerdoti, prelati, cardinali, ai quali il titolo di legato al campo
sembra onorifico e degno dei successori degli apostoli».
Certamente il ministro ordinato del secolo scorso, anche prima del
Vaticano II, aveva abbandonato da tempo quelle tristi contaminazioni, ma
lo stesso si trovò impreparato anche culturalmente ad accogliere le
prospettive conciliari. Sapeva di teologia e di liturgia, ma di economia, di
storia delle dottrine politiche che conosceva? Che cosa di politica
internazionale o di filosofia moderna? Che ne sapeva della sofferenza
delle persone vicine e di intere popolazioni lontane? E poi che poteva farci
lui?
63
2. Verso una spiritualità di incarnazione
Nonostante l’insegnamento magisteriale lo abbia indicato con
chiarezza, tarda a farsi strada una spiritualità di incarnazione. Se a livello
di linguaggio parliamo ormai di uomini e di donne, nella prassi pensiamo
che nostro compito sia quello di dedicarci alle «anime» e ci sembra
plausibile, per quanto riguarda i «corpi», fidarci di «galantuomini»
addetti ai lavori, dei politici che per questo vengono pagati dalla
collettività. A loro volta, questi specialisti della politica preferiscono avere
amica la Chiesa gerarchica, piuttosto che nemica. La blandiscono, e
pagano lieti un qualche tributo per questo ricevendone il vantaggio di
poter decidere, in piena autonomia, secondo criteri anche molto
discutibili, le sorti del pianeta e dell’umanità.
Ecco il tributo pagato ai cristiani: assicurare vie preferenziali per la
pratica della religione cattolica, la libertà di culto, le facilitazioni fiscali,
l’impegno (anche solo teorico) per sostenere nella legislazione i cosiddetti
«valori non negoziabili». Dal lato opposto il tributo pagato dai credenti è
il «voto cattolico», il cauto silenzio, l’astensione dalle critiche «al
guidatore», la contestualizzazione di possibili scivolamenti etici dei
politici. Insomma, niente «conflitti di interessi».
Questa strada ha condotto lontano l’uomo integrale di cui Dio ha cura,
e che la Chiesa deve accompagnare verso il Regno. «L’umanità vive come
un tornante della propria storia, considerati i progressi registrati nei vari
ambiti. Tuttavia va riconosciuto che la maggior parte degli uomini e delle
donne del nostro tempo continuano a vivere in una precarietà quotidiana
con conseguenze funeste. La paura, la disperazione, prendono i cuori di
64
numerose persone anche nei Paesi cosiddetti ricchi; la gioia di vivere va
diminuendo, l’indecenza e la violenza sono in aumento, si deve lottare per
vivere, e spesso per vivere in modo non dignitoso. Abbiamo creato nuovi
idoli. L’adorazione dell’antico vitello d’oro ha trovato una nuova spietata
immagine nella dittatura dell’economia senza volto né scopo realmente
umano» (papa Francesco 2013).
Ne segue che è urgente prendere in mano diversamente il destino
dell’uomo, il problema della sua «salvezza». Che non si può delegare ai
politici il senso da dare alla vita umana, il futuro della stessa vita sulla
terra, la determinazione di ciò che è bene o male, la centralità o la
situazione periferica dell’uomo nel governo del mondo o di una piccola
comunità.
È necessario riaffermare con forza il punto basilare della cultura e della
nostra fede che l’uomo non è un «io» isolato il cui destino è strettamente
personale. L’uomo è un «noi», una radicale relazione con altri, anzi
un’intima comunione con tutta la creazione che lo circonda. Non si salva
da solo e non si perde da solo. E se è vero che il prete è inviato all’uomo,
ad essere compagno di un cammino verso quella pienezza di umanità che
noi chiamiamo «salvezza» dell’uomo integrale, allora è anche inviato alla
realtà sociale. Non può ignorare ciò che in qualsiasi modo tocca la
collettività.
Il nostro interessamento per la realtà sociale intanto ha un suo valore in
quanto procede dalla fede e serve l’uomo. Ai politici e a quanti sono
interessati della nostra comune convivenza sulla terra, noi abbiamo solo
da trasmettere una lieta notizia, un Vangelo, che è tale per tutti. Mai
65
possiamo appoggiare un’economia, una teoria di «sicurezza nazionale»,
una difesa dei nostri confini territoriali o del nostro standard di vita, se ciò
oltraggia la dignità di altri uomini, e richiede, in forma sempre nuove,
l’instaurazione di una «società sacrificale». «È meglio che uno solo
perisca invece della nazione tutta» è la logica di Caifa, inammissibile per
un cristiano, ma ovvia per il neoliberismo imperante. Per un presunto
bene di tutto il corpo sociale, non si può mettere in preventivo la morte o
la sofferenza di altre creature umane che condanniamo all’insignificanza e
alla disperazione. Se questo indirizzo continua a prevalere ancora oggi,
significa che il mondo attende ancora la salvezza, ce non ha ascoltato
Cristo.
Il non possumus dei cristiani al sistema vigente nasce dalla tipicità del
messaggio evangelico che fa della sofferenza umana un vero «luogo
teologico». Dio, prima ancora che nel tempio lo si incontra nelle urla dei
sofferenti, degli Abele inermi di fronte alla prepotenza. Parola di Dio,
assieme alla Scrittura, è l’urlo che sale dalle generazioni sacrificate, dagli
innocenti condannati, dagli affamati venuti al mondo per morire
anzitempo.
Non vogliamo che la Chiesa sia serva e strumento dello stato, e neppure
che lo stato sia al servizio di alti prelati ambiziosi. La distinzione degli
ambiti è salutare che rimanga, pur riservandoci come credenti, di
annunziare la nostra visione del destino ultimo dell’uomo, del senso della
sua vita sulla terra, della dignità dell’uomo, della destinazione dei beni,
della giustizia, della salvaguardia del creato, della famiglia, del diritto e
della pace.
66
L’Evangelii gaudium – testo programmatico del pontificato di papa
Francesco − propone quattro principi (cf. nn.221-237) che «orientano
specificamente lo sviluppo della convivenza sociale e la costruzione di un
popolo in cui le differenze si armonizzino all’interno di un progetto
comune». Lo fa nella convinzione che la loro applicazione possa
rappresentare un’autentica via verso il bene comune e la pace sociale, di
cui ciascuna nazione e cultura hanno bisogno per crescere e per
svilupparsi, e nella consapevolezza della necessità che voci profetiche si
alzino a difesa della promozione della giustizia e della fraternità. Questi
principi riguardano anche noi preti, e non possono mancare nella
formazione di futuri ministri di Dio, se ancora crediamo che il Regno di
Dio è possibile.
Si tratta del gusto del domani, della fede che le segrete potenzialità
degli uomini possano svilupparsi nel tempo avviando processi di
cambiamento che conducano la realtà opaca verso una maggiore luce.
Niente «tutto e subito», ma scelta di una strategia di piccoli passi che
portino alla pienezza umana nella libertà e nella consapevolezza. Si tratta
di non ignorare i conflitti che ogni convivenza genera, la complessità dei
problemi, ma puntare più sul desiderio della soluzione che sulla
esasperazione ideologica delle parti, quasi che in sé la vittoria di uno
schieramento e l’annullamento del nemico siano automaticamente un
passo verso l’umano. In fondo se siamo un «noi» aspiriamo a un mondo
di pace. Certamente non è nostro ambiente la «guerra infinita» fra nazioni
o religioni, che recentemente ha preso il posto della guerra di classe. Tutto
ciò – sembra dire il papa – significa che i «fatti» sono nostri amici non le
67
ideologie che costringono la realtà dentro i nostri preconcetti. Realtà è il
conflitto, ma realtà è anche il desiderio di un cammino verso una vita che
sia più degna dell’uomo. Realtà è la piccola vittoria, il passo titubante la
nascita di un dubbio sulla bontà del cammino di ieri, se tutto questo apre
a una prospettiva più ampia.
3. Non siamo tranquilli custodi di un ovile
Nella concretezza tutto questo si traduce in un atteggiamento ben
preciso del prete che si occupa del «noi»: guardare questo mondo, mai
passarci distrattamente accanto, farsi un’idea di ciò che accade, conoscere
ciò che opprime o libera l’uomo, le sue
attese, le sue frustrazioni. Sembra che
Gesù abbia una sua idea ben precisa
delle dinamiche del mondo quando lo
paragona «a un uomo lasciato mezzo
morto sulla strada dai ladroni». E
profeticamente avverte che non basta
accorgersi di quello strano intralcio
alla nostra serenità che è il sangue
sulla strada. Bisogna guardare da vicino, scendere da cavallo, interessarsi.
Non si deve imitare l’uomo del Tempio – sacerdote o levita che sia − che
ritiene non gli si addica fare il soccorritore. Pregherà certo per il
malcapitato, ma di più non può.
Guardare significa cercare di capire e interpretare i fenomeni sociali in
atto, farli oggetto di studio, ben consapevoli che da quei fenomeni
68
dipende la vita e la morte di centinaia di milioni di persone. Non basta
ancorarsi ad una conoscenza accademica della Dottrina sociale della
chiesa. Questa è certamente utile, preziosa, ma non conduce lontano da
sola, perché rimane astratta se non si coglie la specificità del nuovo che
appare sotto i nostri occhi. Al di fuori di questo profondo guardare è
impossibile guardare la realtà a cui siamo mandati, assurdo capire l’uomo
del nostro tempo, aiutarlo a pensare e a pensarsi.
Siamo preti per essere mandati nel mondo reale della gente. Siamo
mandati «nella realtà» di quei cuori umani che Dio ha eletto a suo
santuario. Dove si piange e si spera, dove si attende e ci si dispera, dove si
è vittime, e con una gran voglia di diventare carnefici per non
soccombere. Siamo mandati all’uomo del nostro tempo che Dio ama. E
per quest’uomo, anzi per queste «persone concrete» abbiamo una buona
notizia: Dio è interessato al vostro orario di lavoro, alla vivibilità delle
vostre città, alle difficoltà incontrate in famiglia. Lui non vi aspetta solo in
chiesa. Il suo appuntamento è nella vita, in quella concreta vita in cui
spendete o sperperate il meglio di voi stessi.
Si tratta allora di essere :
preti che hanno l’intuito di prevenire,
così come Dio previene, cioè di
arrivare prima, che ha questa dimensione profetica che non tiene la coda
alla storia, ma è avanti.
preti che non stanno al balcone, ma che vivono tra la gente, partecipi
delle gioie e delle sofferenze. Quel prete con l’odore delle pecore di cui
69
parla papa Francesco, perché è così che anche le pecore possono prendere
il respiro di Cristo che già hanno ottenuto con il Battesimo.
Preti che accompagnano,
Preti che cercano di dare frutti,
non che danno le direttive e indicazioni del
percorso, ma che camminano, che si fanno pellegrini con gli altri. E
quando uno cammina con gli altri sa quando deve accelerare il passo e
quando deve fermarsi per aspettare o rallentare il passo per mettersi in
sintonia con chi cammina.
che sanno essere generativi,
Preti capaci di rendere una testimonianza non muta, una testimonianza
palpabile, una testimonianza che, nella coerenza tra parola ed azione,
sappia essere veramente credibile. È attraverso questa testimonianza di
vita che oggi, forse molto più che in altri tempi, siamo chiamati a
rispondere all’invito rivoltoci dalla Prima Lettera di Pietro: essere
«sempre pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della
speranza che è in voi» (1Pt 3, 15).
cioè che
sanno attivare dei processi da cui nascono cose nuove.
Esiste, quindi, una via all’impegno sociale del prete in quanto tale.
Non si tratta di seguire una moda, uniformarsi ad un comportamento che
fa tendenza, quello del prete socialmente impegnato - tra l’altro, in questo
particolare momento, l’impegno sociale sta passando di moda. Non è
questione di giocare a fare i sindacalisti o di occupare spazi che
riguardano i laici. L’impegno sociale del prete non è l’ultima spiaggia a
cui alcuni approdano perché sentono in crisi la loro identità sacerdotale.
La motivazione autenticamente cristiana e sacerdotale sta nel servizio
70
concreto al fratello sul modello di Gesù Cristo che ci ha insegnato,
facendolo per primo, a lavare i piedi ai nostri fratelli.
Preti capaci di vivere il dovere della denuncia di tutte quelle situazioni
che umiliano gli esseri umani e Gesù Cristo in essi. Come i profeti
dell’Antico Testamento dobbiamo levare la nostra voce, senza paura delle
conseguenze che ce ne potranno derivare, senza calcolare, animati dalla
forza dello Spirito. Vi invito a riprendere il testo di Amos e a meditarlo in
questa ottica, al di fuori del contesto liturgico che a volte stempera la forza
d’urto della Parola di Dio: Am 5, 21-24; Am 6, 1.4-7; Am 8,4-7.
E, ancora come i profeti, denunciare con il gesto oltre che con la parola,
sapendo che il nostro modo di fare potrà risultare non accetto a molti, che
ci sarà chi cercherà di screditarci e di metterci in ridicolo, recuperando
quella virtù dei martiri che va sotto il nome di parrhesia, sfrontatezza agli
occhi del mondo, franchezza del testimone agli occhi di Dio.
Per essere preti così è importante «promuovere e curare una formazione
qualificata che crei «persone capaci di scendere nella notte senza essere
invase dal buio e perdersi; di ascoltare l’illusione di tanti, senza lasciarsi
sedurre; di accogliere le delusioni, senza disperarsi e precipitare
nell’amarezza; di toccare la disintegrazione altrui, senza lasciarsi
sciogliere e scomporsi nella propria identità. Serve una solidità umana,
culturale, affettiva, spirituale, dottrinale» per essere capaci di predicare il
Vangelo anche quando è controcorrente rispetto al pensare comune»
(papa Francesco).
71
Ci rimane una perplessità. Ci sono voluti più di 1700 anni per giungere
a respirare in modo corale l’aria evangelica del Vaticano II. Più di 50 anni
per trovare il coraggio di
ascoltare un Concilio ed
equilibrare una visione
dottrinale astratta della
fede con un annunzio di
salvezza nella realtà storica.
Stiamo vivendo oggi un
incredibile kairos: Dio ci
salva perché si fa nostra carne, quel Signore che ci attende in cielo vuole
abitare oggi nei nostri cuori di carne e nelle nostre città perché diventino
pezzetti del suo Regno. Conti-nueremo noi Chiesa su questa strada?
Non abbiamo che una sola risposta. È già una grazia aver iniziato. Per il
resto, mons. Romero diceva: «Noi piantiamo semi, che un giorno
nasceranno, noi innaffiamo semi già piantati, sapendo che altri li
custodiranno. Siamo profeti un futuro non nostro».
ANTONIO MASTANTUONO, vice assistente generale di AC
Celebrazione Eucaristica con S.E. Mons. Paolo Giulietti
73
Conclusioni
A CURA DEL COLLEGIO DEGLI ASSISTENTI CENTRALI
Introduzione
a fatica nel tener insieme una molteplicità di impegni che spesso
accompagnano il servizio di assistente nelle diocesi e nelle comunità
parrocchiali ed il pericolo sperimentata che tutto ciò potesse condurre ad
un mistero vissuto a compartimenti stagno sono state le ragioni che ci
hanno spinto a mettere a tema del nostro convegno l’unità di vita del
presbitero-assistente.
Le tre relazioni ci hanno aiutato comporre (o ricomporre) l’identità
sacerdotale attorno al trinomio io-tu-noi (uno-pochi-molti). La vita
sacerdotale innanzitutto una tessitura della relazione quotidiana con il
Signore che non chiude ma apre ad autentiche relazioni con la comunità e,
al suo interno, noi con i membri delle nostre associazioni ed infine con la
realtà più vasta di cui siamo chiamati ad essere, vincendo le tentazioni
della fuga mundi e dell’insignificanza, attori e non spettatori.
Una attenta lettura delle relazioni darà la possibilità di cogliere la
ricchezza delle riflessioni e potrebbero anche diventare, se lo si riterrà
opportuno, occasione di approfondimento negli incontri collegiali.
È sembrato a noi opportuno più che tentare una sintesi di ciò che è stato
detto, riconsegnare alcune delle sottolineature emerse dal lavoro, intenso
L
74
e partecipato dei gruppi, come sentieri su cui continuare a riflettere
insieme.
1. Il collegio assistenti
La diminuzione del numero dei presbiteri ( o forse anche la
diminuzione della disponibilità di alcuni a mettersi a servizio dell’AC),
l’aumento del numero dei servizi pastorali richiesti ad uno solo rendono
ancora più significativa l’esperienza del collegio assistenti.
E’ un’esperienza,
purtroppo, poco
diffusa; vi sono già
tante riunioni
(consigli di presidenza
e di settore….) per cui
mettiamo da parte
l’incontrarsi come
assistenti.
Eppure non sfugge l’importanza di vivere momenti comuni;
potranno essere:
occasione per ripensare ruoli e servizi dell’assistente all’interno del
proprio contesto diocesano;
momenti di condivisione e di riflessione sulla vita delle associazioni
locali;
momento per trovare e indicare strategie perché i vari settori
camminino insieme;
Il Collegio degli Assistenti centrali di AC
75
momento per trovare e indicare strategie perché i vari settori
camminino insieme;
esperienze di fraternità sacerdotale come segno all’interno di tutto il
presbitero diocesano
luogo per accompagnare e avvicinare all’esperienza associativa altri
presbiteri;
strumento di aiuto per assistenti di diocesi vicine che vivono «in
solitudine» il proprio servizio associativo.
2. La vita spirituale
«L’Azione cattolica non ha grandi pretese.
Essa vuole essere come l’asinello
che porta Gesù dentro alla città»
(Mansueto Bianchi, 3 maggio 2014)
L’esigenza e la richiesta di una solida vita spirituale per il prete
assistente, nonché il compito di educare alla vita spirituale, è stata
sottolineata nelle tre relazioni ascoltate, soprattutto in quella di Luciano
Manicardi e nel ricco dibattito di martedì mattina e nelle sintesi dei
gruppi. Questo è uno degli obiettivi dell’assemblea associativa del 2014
che la Presidenza ha cercato di portare avanti con un lavoro di esperienza
e ricerca laboratoriale concentrato nel luogo simbolo: Casa San Girolamo.
76
«Un ascolto dal basso del vissuto delle persone e un ascolto privilegiato
della Parola, devono diventare tratto qualificante e prioritario del servizio
degli assistenti associativi, proprio per crescere nell’arte delle relazioni di
comunione».
La vita spirituale non sta in alto perchè non la possiamo raggiungere,
non è una parte della vita nella quale ci possiamo rifugiare ogni tanto
(«Questa Parola non è in cielo … non è di là dal mare. Invece questa
Parola è molto vicino a te; è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu
possa metterla in pratica» cf. Dt 30,12-14). La vita spirituale è dentro,
unifica, compagina e corrobora tutta l’esistenza del prete e del laico.
Essa non funziona come gli ideali morali o i concetti della mente: essi
vengono dall’alto e si applicano alla realtà. La vita spirituale procede
secondo la dinamica dell’incarnazione del Signore nostro Gesù Cristo: si
spoglia e cerca l’essenziale, va in basso alla ricerca dell’umano. È un
cammino di umanizzazione secondo l’esempio dell’umanità di Cristo.
La vita spirituale, come umanizzazione del cristiano, ha degli
ingredienti fondamentali: la vita umana, la Parola di Dio, l’esperienza di
Casa San Girolamo - Spello
77
chiesa. Una solida esperienza associativa non può non radicarsi
nell’intreccio della vita con la Parola.
La vita spirituale dell’assistente e del laico di AC guarda alla vita con
uno sguardo contemplativo: sa intravvedere le tracce della presenza del
Signore. Tracce e orme rese più chiare dalla luce della parola del Vangelo.
Per questo parliamo del Primato della Vita. Poiché non solo il Vangelo
illumina e dà senso alla vita; ma anche e soprattutto la vita umana è
l’alfabeto con cui interpreto e capisco le storie raccontate nella Scrittura.
Solo con l’esperienza dell’incontro con il Signore nella loro vita
quotidiana i laici possono dire una parola autorevole alla chiesa: portano
il mondo dentro la chiesa, evangelizzano la chiesa. L’assistente vive in sé
stesso questa dinamica spirituale; poi la condivide nel collegio assistenti e
nella Presidenza. Solo così potrà prendersi cura della vita spirituale dei
laici della sua associazione. Un’AC che non voglia ridursi ad
organizzazione pastorale che prende e spreme i suoi responsabili in un
impegno estenuante, deve offrire prima di tutto una vita bella, una
attrattiva che si diffonde da sé senza bisogno di molte promozioni. Una
vita spirituale solida e caratterizzata dalla positività e dalla gioia sarà il
cuore di associazioni robuste dentro le nostre comunità cristiane.
3. Il discernimento
Parlare di discernimento significa affrontare un processo eminentemen-
te spirituale. Per un credente, infatti, non si tratta di fare valutazioni e
scelte dettate da criteri «mondani» ma di mettersi in ascolto della Parola e
dello Spirito perché siano essi a guidare le azioni.
78
Come preti assistenti possiamo sentirci coinvolti in questo processo su
due fronti: personale e comunitario.
Da un punto di vista più personale, il discernimento prende la forma
dell’accompagnamento spirituale. Esso rappresenta anzitutto un’esperienza
che siamo chiamati a fare, a cercare; ciascuno di noi ha bisogno di essere
accompagnato, di poter fare riferimento ad una figura alla quale dona fi-
ducia e che reputa capace di consiglio.
L’accompagnamento è pure un servizio che siamo chiamati ad offrire in
quanto presbiteri. Come assistenti di Azione Cattolica, crediamo che sia
importante dare spazio e tempo alla cura dell’accompagnamento dei respon-
sabili dell’associazione, almeno nel corso del loro mandato. In questo c’è
uno dei tratti qualificanti del ministero del sacerdote-assistente.
Inoltre, in questo anno di cammino assembleare, sarà preziosa l’opera di
discernimento legata al rinnovo delle cariche associative: un confronto sereno,
capace di partire dalle condizioni di vita reali delle persone, potrà favorire
l’individuazione di persone capaci di assumere un compito oggi e
interiormente attrezzate per portarlo avanti domani. Un discernimento
superficiale e distratto, al contrario, rischia di farci convivere con
continue fatiche, resistenze e ripensamenti. Anche in questo percorso il
ruolo dell’assistente può trovare uno spazio privilegiato di azione e di
accompagnamento.
79
Vi è poi una dimensione comunitaria del discernimento. Il prete-
assistente accompagna i gruppi a viverlo anzitutto maturando e favorendo
un duplice ascolto: della Parola, anzitutto e pure della vita, attraverso quello
sguardo contemplativo che ricerca, al di là della cronaca, il significato de-
gli eventi. Il discernimento comunitario vuole essere un modo per evitare
derive efficientiste o per non rischiare di essere completamente assorbiti
dalla dimensione organizzativa. L’ascolto (della Parola e della vita) è esat-
tamente quell’esercizio che ci obbliga a guardare «oltre noi stessi», sia in
termini di spazio che di tempo; che ci permette di immaginare il futuro e
di orientare verso di esso le nostre scelte attuali.
Il discernimento, infatti, può dirsi autentico quando sfocia nella decisione.
Se non c’è decisione, allo-
ra si rimane nella sfera
dell’analisi.
In questo senso, un ul-
teriore servizio che pos-
siamo rendere
all’associazione nei pros-
simi mesi sarà quello di
accogliere con attenzione le proposte del documento che prepara le as-
semblee. Non è un testo descrittivo, ma un invito alla conoscenza della re-
altà per elaborare a partire da essa e dai bisogni che manifesta una propo-
sta di vita associativa capace davvero di «uscire» e di farsi prossima alle
persone e ai territori.
Celebrazione Eucaristica con S.E. Mons. Nunzio Galantino
80
Una buona programmazione (fatta di studio e di azione, di preghiera e,
appunto, di discernimento comunitario) potrà essere occasione per un ri-
trovato slancio della proposta associativa nei prossimi anni.
4. La leadership dell’assistente di AC
Uno dei temi emersi, in positivo e in negativo, all’interno dei gruppi di
studio è stato quello della leadership. Esso, tra l’altro, è stato messo in
relazione con il tema del rapporto tra sacerdozio battesimale e sacerdozio
ordinato. Sono emerse difatti le seguenti osservazioni:
Questa forte esperienza di ecclesialità (che é l’Azione Cattolica) è
messa a rischio da associazioni che pensano di autogestirci o da assistenti
che non rinunciano alla leadership, credendo di rendere un servizio alla
Chiesa modellando l’associazione a propria immagine.
La rinuncia alla leadership (dell’assistente di Azione Cattolica) apre
alla corresponsabilità, anche e soprattutto nelle situazioni problematiche
della pastorale, come anche nelle divisioni all’interno della comunità e tra
i singoli membri.
Il sacerdote che si lascia formare alla sensibilità della
corresponsabilità laicale spesso è incompreso dai confratelli, perché
giudicato incapace di un ruolo sacerdotale di leadership.
I laici in Azione Cattolica aiutano il prete a riscoprire la vocazione
battesimale, e di conseguenza lo specifico della vocazione ministeriale.
81
Da queste osservazioni ricaviamo alcune domande:
È proprio vero che fare l’assistente di Azione Cattolica vuol dire
rinunciare alla leadership?
Potrebbe esserci una leadership da esercitare all’interno del servizio
di assistenti di Azione Cattolica? Se sì, quale tipo di leadership?
Ancora una volta viene messo in questione il rapporto tra vocazione
battesimale e specifico ministeriale.
Dalle sollecitazioni emerse dai relatori del convegno raccogliamo le
seguenti sollecitazioni:
A cappello di queste nostre considerazioni dobbiamo ridirci qualcosa
di cui siamo convinti tutti. La convinzione cioè che se da una parte
svolgere il servizio di assistenti non è una diminuzione ma una
esaltazione di quella che è la nostra identità sacerdotale; nello stesso
tempo il servizio di assistenti di Azione Cattolica non ci chiede di
rinunciare all’esercizio della nostra leadership ma di reinterpretarla
cercando di ripensarla secondo modelli innovativo.
A proposito della nostra identità sacerdotale non possiamo non
ricordarci che il ministero ordinato è sempre a servizio del sacerdozio
battesimale e che il secondo si specifica a partire dal primo e non il
contrario (cf. PO 1-2). Ma soprattutto ripensiamo a quello «stare in mez-
zo» del pastore nei confronti del suo gregge, richiamato da L. Manicardi
mutuandolo da papa Francesco, non solo dal punto di vista spaziale ma
anche dal punto di vista sostanziale. Esso si configura come la possibilità
82
che ci diamo di vivere con i fratelli relazioni autentiche, mature e
soprattutto alla pari. Questo ci allontana dalla tentazione di percepisci
come «direttori» degli altri, ma come «accompagnatori» di cammini che si
incrociano con i nostri. Tutto questo diventa sostanziale quando arriviamo
a dire parafrasando le parole di sant’Agostino: «Per voi sono sacerdote
con voi sono cristiano«, con tutto quello che questo significa.
Si avverte inoltre la necessità di passare da una leadership autoritaria
a una leadership autorevole (cf. omelia di mons. Galantino), dove non
sono io evidentemente, in quanto presbitero, a essere il termine ultimo
della dinamica
decisionale; ma proprio
perché assistente un
punto di riferimento
importante non solo in
termini di esemplarità ma
anche per un vero
discernimento nello Spirito sulle questioni. Tra l’altro, gli studi
contemporanei sulla leadership ci consegnano diversi modelli per
rileggere il tema della leadership. Tra questi richiamiamo l’attenzione su
quello che ci sembra uno dei modelli più interessanti e più vicini
all’esperienza associativa, ovvero la leadership partecipativa o partecipata.
Una delle possibili definizioni di questo modello potrebbe essere la
seguente: «Il leader partecipativo è infatti una guida perfettamente
integrata nel gruppo che incoraggia ed assiste il gruppo nelle discussioni e
decisioni collettive, suggerendo eventuali strategie e consigliando i suoi
83
collaboratori, così da arrivare a risultati condivisi. Lascia libertà di scelta
nella gestione del lavoro, nella divisione dei compiti e nella selezione dei
compagni di lavoro, creando tuttavia consenso e spronando ognuno a
dare il proprio contributo per il bene del gruppo». Crediamo che la
leadership intesa in questa modo possa essere preziosa per esercitare il
proprio servizio di assistenti nelle nostre associazioni parrocchiali e
diocesane.
5. La sinodalità
Significative in questo senso le parole del Papa a Firenze: «Vi
raccomando anche, in maniera speciale, la capacità di dialogo e di incontro.
Dialogare non è negoziare. Negoziare è cercare di ricavare la propria «fetta» della
torta comune. Non è questo che intendo. Ma è cercare il bene comune per tutti.
Discutere insieme, oserei dire arrabbiarsi insieme, pensare alle soluzioni migliori
per tutti. Molte volte l’incontro si trova coinvolto nel conflitto. Nel dialogo si dà
il conflitto: è logico e prevedibile che così sia. E non dobbiamo temerlo né
ignorarlo ma accettarlo. «Accettare di sopportare il conflitto, risolverlo e
trasformarlo in un anello di collegamento di un nuovo processo»» (Evangelii
gaudium, 227). Quindi, «la sinodalità si fa e non si dice»
Vorremmo donarvi soltanto alcuni atteggiamenti che, secondo noi,
potrebbero aiutarci a fare sinodalità.
Saper stare: la presenza alla presidenza e far sentire la presenza.
Stare tra/dentro non trovare motivi di lontananze.
Aver voglia di contaminare i pensieri.
84
Per fare sinodalità è necessario ri-formarsi e cambiare la mentalità del
direttore.
Sinodalità è spendere tempo, dar parola, significa aver pazienza.
La sinodalità è sedersi con altri.
La sinodalità è fare fatica.
Ancora il papa a Firenze: «Ricordatevi inoltre che il modo migliore per
dialogare non è quello di parlare e discutere, il modo migliore, ma quello di fare
qualcosa insieme, di costruire insieme, di fare progetti: non da soli, tra cattolici,
ma insieme a tutti coloro che hanno buona volontà».

























































































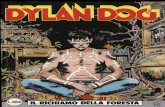





![[MindbendeR] Il Richiamo Di Cthulhu - Cthulhu Netbook](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/55cf96d8550346d0338e262a/mindbender-il-richiamo-di-cthulhu-cthulhu-netbook-5681830dec108.jpg)







