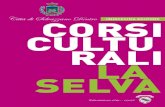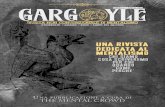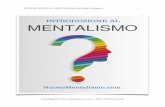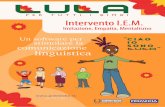Anno 1 numero 5 15 Aprile 2012 Le Idi di… aprile · i primi la Virginia), ... mentalismo islamico...
Transcript of Anno 1 numero 5 15 Aprile 2012 Le Idi di… aprile · i primi la Virginia), ... mentalismo islamico...
ai redditi, costituiscono una sorta di stabilizzatore
fra gli stati e confluiscono in un unico bilancio fe-
derale, da cui vengono poi redistribuite per aiutare
gli stati in difficoltà. Solo dopo la formazione di
un debito comune, quindi, gli Stati Uniti adottaro-
no una moneta unica e crearono una banca centra-
le.
L’area dell’euro ha invece seguito un percorso in-
verso. Se infatti esistono una moneta unica e la
BCE (Banca Centrale Europea), non si può dire lo
stesso del debito comune. Questo, inevitabilmente,
ci rende meno credibili agli occhi dei mercati fi-
nanziari di altri paesi: abbiamo, infatti, una politica
monetaria comune, ma le questioni di bilancio re-
stano di competenza dei singoli stati. Il fatto quin-
di che manchi un governo federale in grado di
provvedere ad una politica economica unitaria,
come negli Stati Uniti, produce soprattutto due
effetti. Primo, inevitabilmente, si vanno ampliando
i divari di competitività fra i singoli stati, questo
determina che le economie più forti sempre più
difficilmente accettino di adeguarsi alle economie
degli “ultimi della classe”; ne è un chiaro esempio
la Germania. Secondo, in tempi di crisi, i paesi
finanziariamente più deboli hanno enormi difficol-
tà a rispettare i vincoli di pareggio di bilancio im-
posti, dal momento che non possono contare su
una spesa federale di sostegno, come avvenuto in-
vece negli Stati Uniti.
Arrivati alla situazione attuale, quindi, per uscire
veramente dalla crisi, e non trovarsi nuovamente in
una condizione simile, molti osservatori sostengo-
no l’assoluta necessità per l’area dell’euro di do-
tarsi di un debito unico e di una politica di bilancio
comunitaria. Il problema è che la Germania (a tor-
to o a ragione) non sembra disposta ad accettare di
farsi carico dei debiti dei paesi più in difficoltà.
Cosimo Inzerillo II F
Stiamo attraversando ormai da alcuni anni la più
grave crisi economica dalla Grande Depressione
del 1929. Questo fenomeno è nato negli Stati Uniti
nel 2007 in seguito alla crisi del mercato immobi-
liare, che si è allargata ai mercati finanziari, con il
fallimento di alcune grandi compagnie come la
Lehman Brothers, provocando una pesante reces-
sione nelle maggiori economie. In Europa la crisi
ha assunto dimensioni ben più drammatiche rispet-
to agli Stati Uniti, con pesanti ripercussioni sociali
(fra queste la disoccupazione giovanile in aumen-
to); sta quindi mettendo a rischio il sistema finan-
ziario dell’area dell’euro e perfino la stessa esi-
stenza della moneta unica, per via delle difficoltà di
alcuni paesi, tra i quali Grecia e Spagna (l’Italia
sembra essersene tirata fuori), a far fronte al rim-
borso del proprio debito.
Per comprendere meglio questo punto, facciamo un
salto indietro nel tempo, agli anni compresi fra il
1788 e il 1796, in quelli che sarebbero divenuti in
seguito gli Stati Uniti d’America. I singoli stati era-
no usciti dalla guerra di indipendenza indebitati, chi
più chi meno, con altri stati o con finanzieri privati:
mentre alcuni avevano già saldato i loro debiti (fra
i primi la Virginia), altri versavano invece in gra-
vissime difficoltà finanziarie e nella sostanziale im-
possibilità di restituire quanto avevano ricevuto. Il
Ministro del Tesoro dell’epoca, Alexander Hamil-
ton, comprese che il futuro stato, per godere di suf-
ficiente credibilità verso l’esterno, doveva necessa-
riamente dimostrare di avere il pieno controllo sui
debiti dei singoli stati. Hamilton si adoperò quindi,
mediante concessioni agli stati non in difficoltà (la
Virginia ottenne lo spostamento della capitale a
Washington), perché il nuovo governo nazionale
assumesse su di sé i debiti dei singoli stati. L’eco-
nomia statunitense si basa ancora oggi su questo
sistema: le imposte, infatti, in quanto proporzionali
IL MODELLO AMERICANO CONTRO LA CRISI
15 Aprile 2012 Anno 1 numero 5
Le Idi di… aprile
Mohamed Merah, il killer francese di origine
algerina che ha fatto tremare la Francia, riposerà
per sempre nel settore musulmano del cimitero
di Tolosa, in una tomba senza nome. Sulla vi-
cenda del giovane francese che ha preferito il
fondamentalismo islamico alla laicità francese
abbiamo letto molte analisi, ma non ci è parso di
aver letto le domande più importanti: come è
potuto succedere che un giovane francese di ori-
gine nordafricana abbia preferito il credo di “al-
Quaida” alla cultura democratica europea? Co-
me è possibile che abbia preferito impegnarsi in
modo militante nell'organizzazione e abbia ese-
guito azioni violentemente ostili nei confronti
del suo Paese? Perché ha preferito tale scelta
all’integrazione nella società europea? Perché la
cultura francese è stata per lui meno affascinante
del fondamentalismo islamico? Nessuno ha vo-
luto affrontare il problema principale che la vi-
cenda pone: la scelta di Mohamed Merah rap-
presenta una sconfitta culturale dell’Occidente
laico. Infatti Mohamed Merah non era cresciuto
ubbidendo ciecamente al Corano. I suoi amici
dicono che egli non fosse nemmeno praticante
anche perché, diciamocelo, quale musulmano
praticante andrebbe mai a guardare gli spettacoli
della “nana”, una famosa pornostar affetta da
nanismo? Mohamed Merah ha compiuto un atto
scellerato e folle pur essendo sano di mente. Ha
preferito il fondamentalismo islamico, con le
sue false certezze, la sua violenza innata, per un
semplice motivo: il modello di vita propostogli
dal capitalismo occidentale lo aveva nauseato.
T o l o s a : l a s c o n f i t t a d e l l ’ O c c i d e n t e
P a g i n a 2 L e I d i d i …
a p r i l e
Mohamed Merah non riusciva più a vivere in
un Occidente che ha abdicato alla ricerca della
verità e ha scelto il nichilismo. Difatti oggi-
giorno la maggior parte dei giovani occidentali
sono affascinati da relativismo e nichilismo.
Queste due filosofie di vita hanno raggiunto un
numero incredibile di “adepti” e solo poche
fiaccole di pensiero negano queste correnti di
pensiero cercando di pervenire da una realtà
ultima. Mohamed Merah, vissuto in una socie-
tà che afferma unicamente il non senso di ogni
cosa quando ha incontrato il fondamentalismo
islamico ne è rimasto accecato. Per la prima
volta nella sua vita ha visto dinanzi a se un'i-
deologia forte. Non si è accorto che questa
ideologia fosse falsa, l'ha seguita e l'ha ritenuta
la sua unica ragione di vita. Ma come può
l'Occidente laico e democratico evitare che in
un futuro non troppo lontano ci sia un altro
Mohamed Merah? Non basteranno le polizie e
il lavoro dei servizi segreti a fermare il terrori-
smo islamico. L’Occidente batterà il fonda-
mentalismo islamico solo se lo batterà cultu-
ralmente e, per batterlo, i laici hanno una sola
strada: offrire un’alternativa laica e reale ai
giovani europei di qualsiasi religione, cultura,
razza. Basterebbe tornare alla Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo e alla questio-
ne del diritto naturale negando una volta per
tutta il relativismo e il nichilismo offertoci dai
maestri della retorica.
Giuseppe della Corte I D
L a v i g n e t t a — d i E l e n a B u r a l i
I l m e c c a n i c i s t a d e l l a
l i b e r t à
P a g i n a 3 A n n o 1 n u m e r o 5
«In Italia viene applicata la condanna a morte quotidianamente. La peggiore delle condanne a morte,
consumata sotto la luce del sole, davanti agli occhi di centinaia di persone». Ascolto in silenzio le pa-
role di Luigi Miggiani, progettista meccanico e ex-presidente di un’associazione di imprenditori, oggi
seduto di fronte a me, in giacca e cravatta, a un tavolo della Mensa Caritas di via Marsala.
Luigi, nato a Napoli, torinese d’adozione, aveva tutto (lavoro, casa, famiglia), e perse tutto, dall’oggi al
domani. Così decise di far ritorno nella sua terra nativa e di fondarvi un’Associazione “contro la crisi”
finalizzata a creare, col sostegno dato a giovani imprenditori, nuove occasioni di lavoro anche nel Sud.
Un progetto ambizioso. E infatti l’associazione non è mai decollata, e Luigi, come riporta un articolo
di giornale che ha con sé, si dedicò alla lotta contro l’usura, trovandosi costretto in pochi anni a cam-
biare più di dieci domicili. Non spiega come mai oggi si trovi a dormire in una macchina, ma è dal
1998, dopo essere stato isolato dal contesto sociale, professionale, legale e assistenziale (con una car-
diomiopatia ostruttiva e altre patologie non ha diritto a una pensione di invalidità), che, a Roma, Luigi
ha iniziato quella che lui non chiama protesta, ma missione.
Con un cartellone e un tavolino di legno, in via delle Fornaci, a due passi da San Pietro, ha cercato di
far sentire la sua voce, battendosi «perché l’uomo venga rispettato, chiunque egli sia», e lottando con-
tro l’«indegna indifferenza» degli uomini, che rifiutano, per volontà e per ignoranza, di prendere atto
della realtà che vive ai bordi del marciapiede.
E’ per questo che sta scrivendo un libro-denuncia che contiene la sua storia e quella di Fortunato, il
vecchietto lì con lui che tiene le sue penne e si definisce suo “compagno di vita”. «Perché noi ci siamo,
ci siamo sul marciapiede, viviamo sul marciapiede, e la gente non sa che quello che cerchiamo, spesso,
è solo una parola, un po’ di calore umano» mi dice, mentre penso che “la gente” siamo noi e sono io.
Oggi la sua missione continua in giro per l’Italia. Ogni giorno sale su un treno diverso insieme a Fortu-
nato per dire ad altre persone quello che ha detto a me, e «per sfatare la voce che vivere isolati, spor-
chi, ghettizzati, sia una scelta».
Al momento di andar via, Luigi mi lascia il titolo di una canzone che vuole che io ascolti. E’ di Fabio
Concato e fa:
“Serve immaginare per comprendere,
però senza nessuna velleità,
c’è solo della gente da difendere,
è tutto qua...”
Chiara Abbasciano II F
Luigi Miggiani sul suo tavolino in via delle Fornaci
La storia della letteratura sembra insegnarci che poeti, prosatori, filosofi e
tutti gli individui di questa risma sono sempre stati più innamorati dell’uo-
mo che della donna. Tanto per fare qualche esempio, possiamo chiamare
in causa l’eroe omerico, il cavaliere medievale, l’eroe romantico. Tempo
fa la filosofia ha partorito, tra le altre invenzioni, il concetto di Superuo-
mo; e nessuno s’è curato di dar vita alla Superdonna. A dir la verità, a met-
ter le toppe a questa incompletezza qualcuno ha pensato, nientemeno che
un premio Nobel: George Bernard Shaw, irlandese ma ben presto natura-
lizzato inglese, vissuto fino a tutta la prima metà del secolo scorso, sociali-
sta, wagneriano, insomma quanto di più rivoluzionario c’era per l’epoca.
Dopo aver abbracciato con ardore la filosofia di Nietzsche in tutti i suoi
aspetti (Superuomo compreso) si permise, nel corso della sua lunghissima
attività di drammaturgo (in totale circa sessanta commedie, senza contare
romanzi e saggi sparsi), di introdurre anche delle novità nel pensiero del
Maestro. Come il concetto che io oserei chiamare di “Superdonna”. Cer-
cherò di darvene un’idea parlandovi di due tra le migliori commedie di Shaw: Candida e La Miliardaria
(la prima sicuramente reperibile nella biblioteca della scuola). Immaginiamoci una serena famiglia bor-
ghese del 1898, composta da padre (Rev. Giacomo Morell), madre (Candida), figli vari e intruso (Eugenio
Marchbanks). Quest’ultimo è un diciottenne preso da estri lirici il quale, ospitato in casa del Reverendo,
inizia a minare la serenità della famigliola, innamorato com’è della dolce, materna Candida. Eugenio è
uno squattrinato, un carattere sognante fino all’eccesso, caricatura del Romanticismo più esasperato, ma è
pur sempre poeta; invece Morell è in realtà un bambinone, gongolante e felice della realtà in cui vive, sen-
za sospettare che il credito di cui gode, il clima d’affetto che regna in casa sua non sono farina del suo
sacco, bensì opera della moglie. La situazione precipita: nell’ultima scena i due uomini, ormai rivali in
amore, chiedono esplicitamente a Candida di “scegliere” quale dei due amare. Ella si promette a chi dei
due ha realmente bisogno di lei: Marchbanks capisce e se ne va via per sempre, chiudendo nel suo cuore
“il suo segreto di poeta” che rimarrà ignoto ai due coniugi di nuovo pacificati. Penso che già da questa
commedia si possa evincere il significato di “Superdonna”. L’individuo di sesso maschile, per Shaw, è
universalmente riconducibile al modello “Morell”: senza la donna, un bambino sperso nel buio. Questa
assurge ad un ruolo mai visto prima nella letteratura. Non più la Musa ispiratrice o “la gran donna dietro
al grande uomo” ma l’anima vera dell’uomo, non solo la sua parte complementare, ma addirittura domi-
nante. Quel che è più splendido è che questa teoria di Shaw, di per sé poeticissima, è espressa in comme-
die con una verve delle più frizzanti. Ma cosa succede quando la “Superdonna” è troppo grande e sopraffà
l’uomo, o peggio, tutti gli uomini che incontra? È questo il tema della seconda commedia, la Miliardaria.
Protagonista è Epifània Ognisanti di Parerga (già il nome è una garanzia!): donna ricca, ricchissima, non
solo per censo avito, ma soprattutto per la propria spregiudicata attività di finanziera nella Londra affarista
del 1935, si vede preferire dal marito una donnucola apparentemente da due soldi, Polly (sprezzantemente
da Epifània chiamata “Calzerotte”), che gli sa dare il clima di dolce confidenza di cui egli abbisogna (un
nuovo Morell!). Sin dalla sua apparizione in scena, nell’ufficio del suo avvocato, nelle vesti della tragica
signora tradita dal marito, pronta al suicidio e subito dopo, nei confronti del consorte sopraggiunto con
l’amante, dotata della più pronta, crudele e scoppiettante ironia, ci sentiamo irretiti da questo personaggio.
Già dopo il secondo atto, invece, capiamo perché sia il marito che l’amante, nel corso della commedia,
l’abbiano scaricata entrambi. Questa donna sprigiona un’energia tanto grande da non lasciarsi avvicinare
se non da uomini aventi la sua stessa carica: il che, per Shaw, equivale all’impossibile. Nella commedia la
Superdonna forse non è lei: essa ne è una deformazione abnorme. La vera Superdonna è la povera Polly
che con la sua dolcezza e la sua nascosta ma profonda intelligenza ha saputo trovare il vero amore. Lei è
la vera Candida di questa commedia. E questo è forse uno degli insegnamenti più sottili e poetici che
Shaw ci abbia lasciato: a volte, nella vita, anzi quasi sempre, si può essere Super anche se si è persone
normali. Anche con le calze rotte.
Alessandro Giardini II F
I l t a r l o l e t t e r a r i o P a g i n a 4 L e I d i d i …
a p r i l e
L a B a m b o l a d e l D i a v o l o
P a g i n a 5 A n n o 1 n u m e r o 5
“Un uomo è minimamente probabile che diventi grande tan-
to più è dominato dalla ragione: pochi possono realizzare la
grandezza - e nessuno nell'arte - se non sono dominati dall'il-
lusione”. Sono queste le parole di Mr. Doctor, comparse co-
me annuncio su un giornale nel 1987, per reclutare i musici-
sti necessari al suo progetto. Così inizia la storia dei Devil
Doll, una band rock sperimentale italo-slovena tra le più
interessanti nel panorama italiano, considerata tra le migliori
in assoluto, ancora oggi ignorata e sottovalutata. Il loro ge-
nere musicale è una sorta di unione tra musica classica, tea-
tralità, rock progressivo ed elementi metal. Violino, violon-
cello, contrabbasso, chitarra, basso, batteria, pianoforte, ta-
stiere, organo, tutto insieme... Il gruppo realizza qualcosa
che, prima della loro comparsa sulla scena musicale, non era
mai esistito. La figura del fondatore è avvolta in un alone di
mistero: è italiano e si cela sotto lo pseudonimo di Mr. Doc-
tor. È lui a comporre la musica e i testi, a creare le copertine
dei cd, a dirigere tutta la band. Storica è la sua profonda misantropia, forse solo apparente, che lo ha portato
a rilasciare solo tre interviste e a pubblicare sei cd, di cui uno mai messo in commercio. A rendere ancora
più incredibili le atmosfere uniche dei suoi album, sono i deliri vocali dello stesso artista: uno schizofrenico
cantato che alterna balbettii e bisbigli, a dure parti a voce spiegata. Proprio questa interpretazione ,così sof-
ferta e violenta dei testi che definire geniali è estremamente riduttivo, trascina l’ascoltatore in una dimen-
sione onirica e inquietante, a metà fra angoscia e attimi di pura tensione portata all’estremo dai potenti ar-
chi. In Dies Irae si aggiungono anche un soprano e una seconda voce maschile. Proprio quest’ album è defi-
nito il loro “Testamento musicale”. Ultimo dei loro lavori, uscito nel 1996, sfiora la perfezione con la sua
struttura imprevedibile. Quarantacinque minuti e cinquantatre secondi di emozioni, stati d’animo, sensazio-
ni, tormenti, racchiusi in un pentagramma. La forza del mondo di Mr. Doctor infatti è proprio questa: riu-
scire ad esprimere concetti non descrivibili con le parole, trasformandoli in note. “ Il mio faro è (ed è sem-
pre stato) il fascino e lo stupore che provo davanti ad una grande opera d’Arte, il tremito del mio corpo
quando è riempito dai germi di ispirazione di qualcuno, e l’emozione, la sfida di creare, di tirare fuori di me
l’Ignoto. L’Arte è la più grande avventura che ci è concesso sperimentare nella breve apparizione sul palco-
scenico della vita”. Ormai sono trascorsi sedici anni dall’uscita di Dies Irae... e il fenomeno Devil Doll con-
tinua a far parlare di sé. Infatti in Italia la band non è conosciuta se non da pochi ma, nel resto del mondo, i
loro cd sono venduti per centinaia di dollari, perché introvabili e ricercatissimi. Se si ascolta un loro album,
il perché di questa fama risulta subito chiaro: pochi artisti sono riusciti a creare dal nulla atmosfere così
evocative e surreali. Tanto ci sarebbe da dire anche per quanto riguarda l’incendio dei Tivoli Studio, le esi-
bizioni a sorpresa del gruppo e l’eclettismo di Mr. Doctor ma qui lasciamo lo spazio all’indagine e alla cu-
riosità del lettore...
Guida all’ascolto:
- Dies Irae;
- The Sacrilege of Fatal Arm;
- Sacrilegium;
- Eliogabalus;
- The Girl who Was… Death.
Elena Burali II F, Ludovico Luzzi I E
Gringoire) degli attori protagonisti, che quindi so-
no facilmente riconoscibili dallo spattatore. Altret-
tanto strabiliante è la scenografia, composta da
una parete di pietre che fuoriescono dallo sfondo,
quasi a voler prendere vita (rifacendosi probabil-
mente a queste parole tratte dal brano Il tempo
delle cattedrali: “E questo è il tempo delle catte-
drali, la pietra si fa: statua, musica e poesia, e tutto
sale su verso le stelle, su mura e vetrate: la scrittu-
ra è architettura”); da colonne sormontate dalle
statue dei mostri di Notre Dame, che vengono por-
tate in scena per mezzo di carrelli, e da campane e
travi che scendono pos-
senti dall’alto tra la me-
raviglia e lo stupore,
rendendo assai semplice
l’immedesimazione
all’interno di quella cat-
tedrale così scura e fred-
da. Ciò che indubbia-
mente contraddistingue
quest’opera però sono le
coreografie eseguite da
alcuni tra i più rinomati
ballerini e acrobati di
tutto il mondo: fanno
acrobazie di ogni tipo,
volteggiando in aria,
arrampicandosi sulle pareti, dondolandosi sulle
campane, eseguono, leggiadri, balletti veloci,
spesso a canone, perfettamente sincronizzati e a
tempo, con un’eccellente qualità tecnica e un
grandissimo pathos espressivo che coinvolge il
pubblico a tal punto da farlo rabbrividire. Qui un
ruolo importantissimo è dato alle luci, che non
solo rispecchiano in modo sublime i sentimenti e
le situazioni cantate, ma riescono a tenere il ritmo
incalzante delle note, coniugando l’udito e la vista
in un unico nucleo, che ogni piccolo particolare
sul palco collabora a formare.
Anche a distanza di dieci anni la maestosità
nell’opera si va sempre più confermando, grazie
alle emozioni forti e al susseguirsi veloce delle
vicende e delle musiche, che penetrano gli animi
degli spettatori lasciandoli sbalorditi e ammaliati
da uno spettacolo così… spettacolare!
Flaminia Benincampi II E
N o t r e D a m e d e P a r i s Q u a n d o l o s p e t t a c o l o d i v e n t a …
s p e t t a c o l a r e
P a g i n a 6 L e I d i d i …
a p r i l e
Emozioni, passioni, brividi… Questo è ciò che si
prova durante le due ore e mezza seduti sulla pla-
tea del Gran Teatro di Roma. A dieci anni esatti
dal debutto della versione italiana di Notre Dame
de Paris, a grande richiesta del pubblico e dei
fans, torna nuovamente sul palco, dal 14 marzo al
primo aprile, l’incredibile opera in due atti tratta
dall’omonimo romanzo di Victor Hugo. Le tra-
volgenti e impetuose musiche di Riccardo Coc-
ciante inondano il teatro; i testi ricchi di signifi-
cato sono magistralmente interpretati dalle grandi
voci di Lola Ponce, Giò di Tonno, Vittorio Mat-
teucci, Marco Guerzoni,
Matteo Setti, Graziano
Galatone e Claudia D’Ot-
tavi. Essi prestano il vol-
to rispettivamente ai per-
sonaggi di Esmeralda, la
bella e misteriosa gitana,
Quasimodo, il campanaro
gobbo della cattedrale di
Notre Dame, Frollo, l’ar-
cidiacono della cattedra-
le, Clopin, amico e pro-
tettore della zingara,
Gringoire, il poeta, Febo,
il bel capitano delle guar-
die del Re, e Fiordaliso,
la giovane e ricca borghese fidanzata di Fe-
bo.Questi attori di altissimo livello raccontano, o
meglio, cantano la storia di un amore condannato
dall’ingiustizia e dall’ipocrisia, dalla vendetta e
dal tormento, dai fraintendimenti e dagli inganni
che porterà la povera Esmeralda all’impiccagione
e con essa alla morte dello stesso Quasimodo,
lacerato dal dolore. Ma la magnificenza di questo
musical non si deve solo alle musiche e agli attori
protagonisti; tutto è infatti curatissimo nei minimi
dettagli: il trucco è impeccabile e ben visibile an-
che da lontano e di forte impatto è la nitida con-
trapposizione fra gli abiti minimalisti (pantaloni
larghi per gli uomini e top e pantaloncini per le
donne) un po’ stracciati e di colori molto chiari
del corpo di ballo e i gli abiti dalle tinte decise e
scure (come il nero della tonaca dell’arcidiacono
Frollo) o dalle più varie sfumature ( come la tuta
appariscente e coloratissima indossata dal poeta
La nuova Biancaneve
P a g i n a 7 A n n o 1 n u m e r o 5
Torna sul grande schermo Biancaneve, adatta-
mento della celebre fiaba dei fratelli Grimm edita
per la prima volta nel 1812. Abituati come siamo
alla versione animata del 1937 è difficile lasciarsi
convincere ma, il regista indiano Tarsem Singh,
dedito di solito a tutt’altro genere, dimostra di
essersi impegnato; anche troppo. La fiaba rivisi-
tata in chiave moderna propone temi attuali come
l’ossessione della regina per mantenere intatta la
propria bellezza; il popolo vessato di tasse per
finanziare suntuose feste regali e i nani esclusi
dalla società civile in quanto “diversi”.
La trama vede la perfida regina rinchiudere in
un’ala del castello la figliastra che cresce così
completamente ignara degli eventi che sconvol-
gono il regno. Il giorno del suo diciottesimo com-
pleanno però la protagonista, interpretata da Lily
Collins, prende coscienza di sé e del proprio ruo-
lo decidendo così di uscire dalla reggia e finendo
per incontrare i sette banditi nani e un ricco prin-
cipe straniero.
Proprio quest’ultimo sarà oggetto di contesa tra la
regina cattiva, interpretata dal premio Oscar Julia
Roberts, e la bella principessa che verrà spedita
nel bosco per essere eliminata dalla “bestia”; ma
qualcosa non va secondo i piani e Biancaneve è
costretta a convivere con i nani e ad addestrarsi
per sottrarre il regno all’inarrestabile matrigna
che nel frattempo cerca di conquistare le attenzio-
ni del principe. Il lieto fine è così lieto che la pro-
tagonista ritrova perfino il padre creduto morto.
Julia Roberts è senz’altro l’interprete più divertita
e divertente, dedita a cure di bellezza poco orto-
dosse, quali impacchi di escrementi di canarini e
gonfiaggio di labbra mediante punture d’api.
Vanno sottolineati però l’assenza degli animali
del bosco; il lato tenero e indifeso della personali-
tà dei sette nani; la spavalderia del principe e la
malvagità della strega cattiva. Al contrario il regi-
sta calca troppo la mano nei costumi e soprattutto
nei colori che assieme alla canzone finale “Love”
rendono il film di stampo prettamente bollywoo-
diano e simile all'Alice in wonderland burtoniano,
sebbene con toni molto più squillanti.
Di grande impatto visivo sono invece le scene in
cui la regina si immerge nello specchio per ritro-
varsi in una realtà parallela e quella in cui la per-
sonificazione di esso governa i burattini atti a di-
struggere Biancaneve.
Irene Convenevole III H
In questi tempi di crisi anche le fashion vic-
tims devono adeguarsi e tenere d’occhio il
portafoglio, cosa difficile, certo, ma non im-
possibile. Come fare a tenere comunque il
proprio guardaroba sempre aggiornato? Per
riuscirci c’è bisogno soltanto di un po’ di fan-
tasia e voglia di provare cose nuove.
Per prima cosa non bisogna sottovalutare i
marchi low cost, spesso ritenuti poco affidabi-
li e non di qualità, ma che ultimamente si
stanno innovando presentando collezioni
all’ultima moda a prezzi più che convenienti.
Un’altra divertente soluzione sono i mercatini,
dove “originalità” è la parola d’ordine. Giran-
do tra i banchetti di questi divertenti luoghi si
trova di tutto: deliziosi gioielli fatti a mano,
magliette stampate e pezzi unici, capi e acces-
sori vintage, sempre di tendenza e perfetti se
si vuole essere notati. Armati di tempo e pa-
zienza si riesce a fare grandissimi affari e tor-
P a g i n a 8 L e I d i d i …
a p r i l e
Direttore: Alessandra Marino III F
Caporedattore: Alessandro Giardini II F
Professore referente: Giuseppe Mesolella
Potete rileggere Le Idi di… sulla home del sito del Liceo Giulio Cesare
LE IDI DI...
nare a casa felici e liberi da sensi di colpa. Se
invece di pazienza non ne avete, ma siete do-
tati di madri e nonne alla moda non abbiate
paura di dare un’occhiata nei loro armadi: po-
treste trovare non solo ispirazione, ma anche
vestiti retrò che, abbinati nel modo giusto, po-
trebbero avere un grande effetto. Nel caso ab-
biano bisogno di qualche modifica prendete in
mano ago e filo (oppure chiedete aiuto proprio
alle vostre madri e nonne) e modernizzateli a
vostro piacimento. Sarete sicure di avere un
look unico. Quando poi la pigrizia prende il
sopravvento e non riuscite a lasciare lo scher-
mo del vostro computer, internet è una minie-
ra d'oro per le occasioni a piccoli prezzi, in
modo da dare nell'occhio senza nemmeno al-
zarsi dalla poltrona.
Gaia Petronio II E
LA MODA AI TEMPI DELLA CRISI