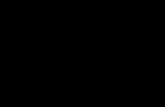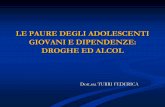Adolescenti e Psichiatria
-
Upload
marco-boeri -
Category
Documents
-
view
39 -
download
0
Transcript of Adolescenti e Psichiatria
-
Una nuova formula di collaborazione tra pubblico e privato La Asl3 Genovese porta avanti insieme Ai Ceis di Genova una efficace sperimentazione nei rapporto tra la sanit regionale e le organizzazioni no profit che lavorano nel sociale
di Angela Lidia Grondona e Rita Schenone
Nella giornata di studio che si tenuta Gioved 18 o t tobre presso l 'Auditorium dell ' Ist i tuto Nautico S. Giorgio di Genova stato possibile compiere una riflessione ed un bilancio dell'esperienza maturata
nei due anni trascorsi dalla att ivazione deila Comunit
Terapeutica per adolescenti "La Finestra sul Porto". La
giornata di studio, promossa da ASL3 Genovese e CEIS di
Genova, stata occasione per discutere e permettere un
confronto tramodell i organizzativi /gestional i e approcci
terapeutici presenti in Liguria e nelle regioni vicine.
L'esperienza della C.T. "La finestra sul por to" costituisce
un model lo innovativo di integrazione pubbl ico/pr ivato,
che si realizzato sia nella fase di progettazione che
nelle att ivi t organizzate all ' interno della Comunit.
Dopo anni di proget t i e richieste alle istituzioni nel marzo
2010 stato possibile aprire la C.T. "La Finestra sul Porto"
rivolta alla fascia di et 12-14/18 anni, per la cura dei
giovani pazienti in fase di grave scompenso emot ivo tali
da compromet tere la vita di relazione e la permanenza
in famiglia. Il proget to ha preso consistenza dopo un
lavoro preparatorio comune tra il personale del CEIS, del
Consultorio, del DSM e del SERT. La C.T. uno dei
luoghi di cura che si inserisce come tessera in un
mosaico di offerte terapeutiche, si rende necessaria
in un momento di problematicit composta da pi
fattori: l'adolescenza di per s un'epoca della
vita dove i sentimenti e i comportament i possono
raggiungere in tut te le loro manifestazioni espressioni
molto intense, la psicopatologia in et evolutiva pu
assumere forme sintomatologiche talvolta drammatiche.
Nella realt di AsI 3 le competenze legate alla salute
mentale infantile e alla riabilitazione neuropsicologica
sono collocate all' interno dell'area materno infantile
nella Struttura Complessa Assistenza Consultoriale.
A questa area di intervento afferisce nel territorio
genovese una utenza ampia: 8.744 utenti nel 2011, con
bisogni diversi e rilevanti. Di questi 1.524 sono nella fascia
di et adolescenziale.
Area neuropsicologica e riabilitazione
La psicopatologia degli adolescenti viene presa in
carico dai Neuropsichiatri e Psicologi dei Consultori
Familiari sia nelle sedi Ambulatorial i distribuite nei sei
Distretti Socio-sanitari che nei Centri Giovani dove molt i
ragazzi accedono spontaneamente, cosa che permette
di intercettare e prendersi cura di ragazzi che non
arriverebbero ai Servizi attraverso i canali istituzionali.
-
Il bisogno di residenzialit negli ultimi anni stata
abbastanza costante come si evince dallo schema
sottotante dove troviamo i numeri relativi ai ragazzi
minori inseriti in CT da ASL 3 dal 2007 ad oggi.
La comunit nata sulla spinta di una necessit fortemente
sentita dagli operatori dei servizi dell'et evolutiva, costretti
a ricoverare i ragazzi in strutture lontane dalla citt
attuando una emarginazione ambientale che aggravava
quella generata dalla malattia stessa.
In effetti da quando si dispone di C. T. in Regione
Liguria il numero dei ragazzi inseriti in CT fuori regione
passato da 17 a 3. In particolare la possibilit della
collocazione in centro citt ha permesso di pensare
ad una organizzazione che potesse comprendere il
mantenimento, quando possibile, del progetto scuola,
sport, e tempo libero gi in atto, importante per
contrastare lo sradicamento dei pazienti dal contesto
ambientale, di mantenere la cooperazione dei servizi
territoriali coinvolti , e di predisporre spazi di relazione
per i genitori anche attraverso la metodologia del gruppo.
Nella prima parte della mattinata, nelle quattro relazioni
la CT si presentata raccontando la sua complessit
di avere un "dentro" (numero dei ragazzi, sintomi e
manifestazioni della patologia, dinamiche sempre
mutevoli dei gruppi..) ma soprattutto avere un "fuori"
(frequenza della scuola, tempo libero, rapporti con
la famiglia, con i fidanzati, con gruppi esterni talvolta
devianti.., rapporti con gli altri luoghi di cura..).
Nella seconda parte della mattinata si tenuta la prima
tavola rotonda con l'apporto delle esperienze della la
Comunit Gruppo Ceis di Modena, la Comunit "Lo
scarabocchio" di Befana Brianza, La C. La Tuga 1 di
Genova, La C. di Casal Noceto, la C. di Desio Vimercate
Milano. Particolarmente interessante l'esperienza della
semiresidenzialit portata dalla C.T. di Desio, grazie alla
quale gli ingressi e le dimissioni dalla struttura possono
avvenire con gradualit, permettendo una maggiore
consapevolezza e adesione nelle scelte terapeutiche del
ragazzo e della sua famiglia. Nel pomeriggio c' stata la
tavola rotonda sulla Organizzazione dei Servizi Sanitari
per l'et evolutiva e l'adolescenza. Sono state messe a
confronto la realt Lombarda, Piemontese e Genovese.
Sono stati presentati dal dr Alberto Matricardi i risultati
di una indagine epidemiologica promossa dalla Agenzia
Regionale Sanitaria riguardante i dati degli inserimenti
in strutture residenziali dei pazienti psichiatrici minori
in carico ai Servizi Sanitari Pubblici della Regione.
Nel 2011 sono stati visti dai servizi territoriali, delle 5
ASL Liguri, per la cura della psicopatologia dell'et
evolutiva circa 13.000 minori. Un consistente numero di
questi minori risultava affetto da patologie manifestatesi
attraverso disturbi del comportamento (circa 700 casi),
situazioni che potenzialmente potrebbero afferire alle
comunit terapeutiche regionali, questa patologia era
presente in quasi la met dei ragazzi inseriti in comunit
in Liguria nel 2011. Proprio i disturbi comportamental i
necessitano di notevole attenzione da parte di tutte
le istituzioni e non solo di quelle sanitarie in quanto
al loro interno necessario distinguere i disturbi
comportamentali causati da una vera psicopatologia
da quelli che si manifestano come reazione a situazioni
ambientali contingenti, al fine di poter scegliere il luogo
-
di cura pi appropriato. La presenza del presidente del
Tribunale dei Minori, dott. Sansa, ha dato un importante
contributo nel dibattere proprio le problematiche di chi'
attraverso lo scivolamento nella devianza pu sottendere
una patologia che richiede l'intervento sanitario e chi,
pure affetto da Disturbo della Condotta (ICD-10),
pi indicato usufruisca dell'intervento psico-educativo.
Si cercato infine di immaginare, partendo dalla realt
odierna dei Servizi, un ventaglio d'i servizi che permetta
di rispondere all'urgenza e all'emergenza, pensato ed
organizzato per l'et evolutiva dove il momento acuto
richiedente il ricovero e/o una prima tempestiva risposta,
possa avvenire nelle migliori condizioni possibili e possa
costituire un momento reale di diagnosi ed impostazione
delle cure, con tempi di permanenza dettati dal bisogno.
Si sono ipotizzati quindi:- un Reparto Ospedaliero
dedicato ai pi giovani, con personale preparato in
stretta relazione con il Pronto Soccorso,- un Ospedale
Diurno (DH, Centro Crisi..), per le situazioni nelle quali la
famiglia risulta ancora in grado di contenere il giovane
paziente e dove la frequentazione diurna pu permettere
l' inquadramento diagnostico, la valutazione clinica
globale, l'inizio eventuale delle terapie farmacologiche,
l'organizzazione della rete delle cure domicil iari/
ambulatoriali ,- un Centro Diurno educativo/terapeutico.
Un'altra necessit evidenziata una C.T. per adolescenti
e giovani adulti dopo i 18 anni, per contrastare la
cronicizzazione della patologia e mantenere ancora al
centro la riabilitazione e la speranza del reinserimento
sociale. Queste idee hanno riscosso un vasto e
manifestato consenso tra i numerosi partecipanti ai
lavori e sono stati condivisi dai politici intervenuti.
Siamo fiduciosi quindi che nella nostra Regione si voglia
lavorare in modo serio e competente e con migliori
strumenti per la salute psichica dei ragazzi che molto
numerosi si rivolgono ai servizi sanitari per essere curati
e riabilitati e non per essere avviati a percorsi di cure
stigmatizzanti tendenti alla cronicizzazione. Siamo
convinti che la Comunit Terapeutica "la Finestra sul
porto" sia una prima valida risposta in questa direzione.
-
Il difficile rapporto tra Psichiatria e Adolescenza La Finestra sul Porto: H punto di vista degli operatori del Dipartimento della Salute
mentale e Dipendenze
di Sergio Calabro, Margherita Doicino, Antonietta ScibUia, Cristina Venturino
Da quasi tre anni opera Genova la comunit terapeutica per minori "La Finestra sul porto", nata dalla stretta collaborazione fra servizi pubblici della ASL 3 Genovese (Dipart imento
di Salute Mentale e delle Dipendenze e U.O. Assistenza
Consultoriale) ed il CEIS: da un tentativo, dunque, di
integrare pubbl ico e privato in un settore delicato quale
la sofferenza psichica giovanile.
Vogliamo, in questa sede, tentare un primo bilancio di
un'avventura cos impegnativa dal nostro punto di vista
-
di operatori del dipart imento della salute mentale e
dipendenze.
Il nostro contesto di r iferimento quindi quello della
presa in carico dell'adolescente all'interno dei servizi
psichiatrici, situazione resa sempre pi concreta
dalla crescente domanda di intervento ospedaliera
e territoriale a fronte del trasformarsi della fase
adolescenziale in qualcosa
di relativamente pi stabile
e che si prolunga nel
tempo.
Tradizionalmente il
rapporto tra psichiatria
e adolescenza non mai
stato facile: la psichiatria,
come disciplina e come
prassi, rischia di non riuscire
a cogliere la dimensione
evolutiva, plastica, anche
ludica di alcuni segni/
sintomi dell'adolescenza
e di cristallizzarli in uno
schema nosografico-
semeiotico-cl inico r igido
ed adulto-forme.
L'adolescenza stata
soprattut to considerata
una "fase di esordio", pi che un momento che assume in
se alcune sfide indispensabili per il processo di crescita,
di cui il bambino non aveva bisogno e che per l'adulto
non sono pi possibili.
Forse per questo si dice che l'adolescente si ammala
poco, ma muore spesso: non sono tanto i processi
morbosi a piegarlo quanto i rischi, i comportamenti ,
lo stile di vita. Il mentale si esprime attraverso il
comportamento e l'agito, che assumono la dimensione
di porta di accesso allo psichico ed al corporeo, ma
possono al tempo stesso costituirsi come un diaframma
ed una difesa da loro e soprattutto dalle loro integrazioni
ed interazioni.
L'attuale organizzazione dei Servizi psichiatrici offre
programmi, strategie di cura e assistenza che hanno
dimostrato nel tempo una efficacia per differenti
patologie e t ipologie di utenti, ma lasciano spazi
irrisolti. L'area dell'adolescenza, in quanto area di
transito, risente in modo particolare di alcune di
queste criticit, quali diff icolt a riunificare i diversi
angoli di osservazione all'interno di una elaborazione
complessiva, atteggiamenti di delega da un settore
all'altro ed un divario fra le metodologie d' intervento ed
i processi formativi. Sembra spesso difficile individuare
uno spazio d'ascolto per ci che non si adatta ai modelli,
ai tempi, all'organizzazione dei Servizi tradizionali, e per
ci che esula dalle prioritarie funzioni di contenimento
e t rat tamento a lungo
termine. Pertanto, gli
adolescenti sviluppano
un uso molto selettivo
e circoscritto dei Servizi
stessi, rendendo manifesta
la rigidit che li caratterizza
e la mancanza di strategie
d'accoglimento a loro
adeguate.
Inoltre ci sembra anche
di poter dire che, come
accade per altre fasce
di et, nuovi tipi di
richiesta si aggiungano
oggi a quella classica
che afferisce ai servizi,
di t ipo psicopatologico,
una richiesta in cui si
riversa anche la fragilit, la
precariet di un mondo attraversato da "nuove povert",
o, per usare le parole di Benasayag, da "passioni tristi".
La risposta a questo certamente difficile, ma non pu
consistere nel trasformare le storie di vita delle persone
in casi clinici, e la complessit del vivere ed essere
giovani oggi in una patologia.
Rispetto all'organizzazione dei servizi per l'adolescenza,
l'esperienza della Comunit "La finestra sul porto"
ha evidenziato in modo netto l ' importanza di poter
disporre di luoghi e persone che permettano di riaprire
"i giochi": luoghi non solo "transizionali", ma anche
transitori, svincolati dai percorsi di cura tradizionali ed
utilizzabili in modo pi vicino ai bisogni dell'adolescente.
Luoghi che offrano in primo luogo opportunit, percorsi
che non sollecitino pi del necessario la dipendenza, la
regressione e gli investimenti transferali, spazi intermedi
tra salute e malattia, tra familiare e sconosciuto, tra
aspetti regressivi e potenzialit evolutive, "pont i" tra un
"pr ima" e un "dopo" e tra un dentro ed un fuori in grado
di avviare eventuali successivi moment i di volta in volta
-
terapeutici, educativi, riabilitativi.
Sempre Benasayag sottol inea come per occuparsi
dei giovani nel contesto storico e culturale odierno sia
necessario assumere la cura come un accompagnamento,
nel corso del quale il cl inico - e le istituzioni- debbono
prendersi la responsabil i t di cercare insieme ai pazienti
una direzione capace di modi f icare la situazione
presente, e che eviti di r idurre l ' individuo alla visione
unidimensionale del suo problema. Ci vuol dire anche,
nella clinica, sostenere i legami concret i che spingono
pazienti ed operator i fuori dall ' isolamento, perch la
dove le relazioni d iventano pi "consistenti", lo diventa
anche l ' identit.
Quindi, per tornare ad una sintesi dell 'esperienza del
g ruppo di lavoro che in questi anni ha af f iancato la
Comunit "La finestra sul porto" , r i teniamo che lo
specif ico del nostro cont r ibuto abbia a che vedere
soprat tu t to con due aspett i :
1 - INTEGRARSI FATICOSO, MA POSSIBILE.
La prima considerazione riguarda il processo di
costruzione di una mental i t, di un l inguaggio, di un
pensiero comune fra persone e servizi che, in partenza,
si sentivano pro fondamente di f ferent i fra loro.
Il tavolo che, in questi t re-quat t ro anni, ha riunito a lmeno
una volta alla sett imana, nella c.t. "La finestra sul porto" ,
a parlare di concret i casi clinici operator i del Consultorio,
della Salute mentale, dei Sert, del Ceis, delle ATS del
Comune, delle varie agenzie educative, del mondo
ospedaliero e universitario, ha svi luppato, forse al di l
di quanto era lecito attendersi, una profonda riflessione
sui l imit i dell 'esperienza e del sapere di cui ognuno
portatore, e sull 'uti l it di mettere in comune conoscenze
e punt i di vista per af f rontare un compi to cos arduo
quale la gest ione del l 'adolescente problemat ico.
2 - LA FRUSTRAZIONE SEMPRE DIETRO L'ANGOLO,
IN EVIDENZA ; LA GRATIFICAZIONE VA RICERCATA
CON GRANDE PAZIENZA.
La gest ione di una comuni t terapeut ica per minor i
r ichiede di lavorare in un clima che appare sempre
dominato dall 'emergenza, dall 'urgenza, dagli actings.
Occorre tempo perch si instauri un suff ic iente
legame fra il ragazzo e gli operatori , e perch questo
legame possa essere lo s t rumento pi impor tante di
contenimento emot ivo del giovane.Succede dunque che
ci sia sempre qualche ospi te in condiz ione di profonda
instabilit, "n dentro n fuori", in parte alla ricerca
// processo di integrazione tra AsI e Servizi Privati no profit parte dal confronto e dall'elaborazione di un
linguaggio comune.
di legami famil iar i-gruppal i ma in parte rabbioso e
opposi t ivo, e che il suo malessere si propaghi come un
incendio, cos che tu t ta la comunit entri in sofferenza.
Pu sembrare,agli operatori , che non ci sia mai un ordine,
un min imo di tranquil l i t, di rout ine giornaliera, e che si
viva sempre nel caos e nella tensione.
In realt, col t empo ed il lavoro terapeut ico il s ingolo
ragazzo si stabil izza e migliora, ma all ' interno del g ruppo
c' sempre qualcuno che svolge il ruolo di "agi tatore", o
perch pi indietro nel processo di inserimento in c.t., o
perch in crisi evolutiva.
su questi temi che, come operator i della salute mentale,
ci parso che la nostra esperienza potesse essere
speci f icamente utile: nel sostegno e incoraggiamento
agli educatori , nella valorizzazione dei piccoli, a vol te
poco evidenti, progressi dei pazienti, nel l 'abitudine a
mantenere ferma la speranza in situazioni che possono
sembrare disperate, a sopportare sensazioni di
impotenza, di ingrat i tudine altrui, di opposi t iv i t a volte
estenuante da parte del paziente, dei familiari, perf ino di
colleghi.
Ci sembra quindi che questo lavoro, vol to a creare una
cornice pi ampia di contenimento, costr ibuisca alla
costruzione di quella necessaria "base sicura" che pu
permet tere alla cura di rivolgersi ad un reinvest imento
relazionale instaurato su distanze pi adeguate con
l'altro, a rendere pi ampie le possibil it di potersi
attaccare a qualcosa .di vitale, ad ampliare una gamma
di interessi spesso for temente r idotta, a riparare legami
poveri ed inconsistenti, insomma restituire senso,
identit, speranza.
-
n adolescenza si evidenziano la maggior parte
delle condizioni psicopatologiche pi gravi: disturbi
d'ansia, depressione, comportament i antisociali,
abuso di.sostanze, spettro schizofrenico e tali patologie
interessano globalmente almeno il 20% della popolazione
adolescenziale. Questo fenomeno si pu spiegare
tenendo conto delle rapide trasformazioni, psicologiche,
sociali e neurobiologiche, che determinano uno stato di
"f isiologico" disequilibrio in questa fase della vita.
I temi fondamentali che si propongono all'adolescente
sono quelli dell ' identit, delle scelte programmatiche
per la vita, della separazione dalle figure di r iferimento
infantili e dal control lo delle emozioni emergenti. I
meccanismi di programmazione e di scelta, di control lo
delle emozioni e della sessualit, di gestione della
separazione e della perdita sono fortemente stimolati
in questo periodo della vita .E' obiett ivamente difficile
per l'adolescente trovare un armonico equilibrio tra le
richieste dell 'ambiente esterno e le esigenze interiore
che via, via emergono nel corso dello sviluppo.
Lo sviluppo della personalit dell 'adolescente
condizionato sia dalle esperienze precoci della vita
relazionale, con gli effett i negativi secondari a eventi
traumatici, sia dai fattori biologici, genetici e legati alla
maturazione cerebrale. Le neuroscienze negli ultimi
20 anni hanno dimostrato che durante l'adolescenza
il cervello ancora molto immaturo e in una fragile
condizione di instabilit, con accentuata att ivazione dei
centri di stimolazione emozionale e scarsa maturazione
delle aree di controllo.
Quindi le scelte degli adolescenti r ispondono spesso
alle esigenze di eccitamento incontrollato e le loro
decisioni sono caratterizzate da un elevato rischio,
dalla incapacit di procrastinare il soddisfacimento
dei bisogni e talora dalla tendenza all'autolesionismo.
Tali fattori determinano le caratteristiche modalit
psicopatologiche e comportamental i dell'adolescente,
molto variabili, che oscillano dalla grave inibizione
all'estrema attivazione comportamentale. Oggi la
diagnosi psichiatrica pu utilizzare sia la valutazione
obiett iva dei disturbi mentali e comportamental i ,
mediante scale di classificazione come DMS IV, sia la
conoscenza "analogica", storica e interna del disagio
psichico (valutazione psicodinamica). Dall' integrazione
dei due modelli deriva una buona capacit di
r iconoscimento delle diverse condizioni di disagio
adolescenziale.
L'intervento terapeutico deve essere quindi multimodale,
privilegiando le cure psicologiche e di recupero sociale,
senza trascurare i possibili interventi farmacologici
mirati.
In questo panorama evolutivo deve essere inserito
l ' intervento in comunit; la scelta di un periodo di
t rat tamento in Comunit proponibi le nei casi in cui
lo stato psicopatologico e/o comportamentale richiede
un periodo di "separazione" dalle condizioni di vita pre-
esistenti e un trat tamento relazionale a tempo pieno.
L'esperienza della "La Finestra sul Porto" sta
dimostrando e confermando le possibilit e i limiti
dell ' intervento in diverse condizioni psicopatologiche e
sociali.
I ragazzi ospiti della nostra comunit sono stati 27, di
cui 14 femmine, con et media all'ingresso di 15 anni e 7
mesi, con permanenza media di 8 mesi (da pochi mesi a
oltre 2 anni e mezzo).
I precedenti personali sono caratterizzati
in una elevata percentuale di casi (74%) da
eventi abbandonici, abusi e stress precoci.
-
Durante il periodo di valutazione sono state definiti
specifici quadri psicopatologici: disturbi della condotta
e tendenza antisociale 52%, disturbi dello spettro
schizofrenico 22%, disturbi d'ansia e affett ivi 26%. Tali dati
confermano altre analoghe esperienze della letteratura.
I risultati ottenuti si possono ritenere pienamente positivi
in 3 casi, parzialmente positivi in 14, non significativi in 3,
mentre in 2 si evidenziata
una evoluzione verso la
tossicodipendenza e in 4
la tendenza verso l'anti-
socialit si confermata
e accentuata (quindi un
risultato positivo stato
osservato nei due terzi
dei casi). Da tale iniziale
esperienza emergono
alcuni fondamentali principi
organizzativi e gestionali.
Il trattamento in comunit
deve in ogni caso essere
integrato in un progetto
che precede e che segue
la vita in comunit; sono
quindi indispensabili una
stretta collaborazione e una
capacit di comunicazione
continua ed efficiente tra
l comunit e i servizi territoriali (Consultorio, Salute
Mentale, ATS, SERT). Le scelte dell ' inserimento iniziale
e il progetto del t rat tamento successivo richiedono un
condivisione dei principi di gestione dei ragazzi.
Inoltre emersa la necessit di poter utilizzare nella fase
pre e post-comunit una struttura semiresidenziale, per
favorire in alcuni casi l'ingresso in struttura e consentire
in altri una progressiva separazione dall 'ambiente di
cura; pu anche essere utile disporre di un servizio
ambulatoriale, finalizzato a seguire i ragazzi nelle fasi
intermedie dell'esperienza in comunit e poi nella fase
successiva alla dimissione.
Da un punto i vista generale, la nostra esperienza ha
evidenziato la necessit di individuare interventi specifici
per le diverse condizioni psichiche.
L'inserimento in comunit per i soggett i con disturbi
della condotta si deve proporre di offrire modelli
alternativi e positivi di identificazione, di fornire una
guida educativa autorevole ma flessibile, di favorire un
rinforzo positivo dei comportament i adattivi.
Per i casi con disturbi d'ansia e depressivi, alla cui
origine si ritrova una grave angoscia di separazione, la
comunit pu offrire una esperienza di al lontanamento
protet to dalle figure di r iferimento e la possibilit di uno
spostamento dell 'attaccamento verso ogget t i esterni,
capaci di stimolare l'evoluzione verso l'autonomia.
Infine per i pazienti con disturbi dello spettro
schizofrenico, la comunit costituisce l'unica possibilit
di uscire da un mondo
chiuso, dominato dalle
angosce e dalle reciproche
proiezioni negative, per
fare esperienze mult iple
di relazioni equilibrate e
maturanti.
Il principio essenziale della
nostra att ivit quindi
costituito dalla ricerca
costante di una relazione
positiva e di un proget to
condiviso con i ragazzi;
spesso diff ici le trovare
un armonico equilibrio tra
i bisogni di contenimento e
di guida (per i pazienti con
disturbi "esternalizzati") e
la necessita di st imolo e di
spinta verso l 'autonomia
(per i casi affett i da una
psicopatologia "internalizzata").
Non sempre possibile soddisfare queste esigenze
contraddittorie, ma la creazione di un ambiente
terapeutico "a tempo pieno" rappresenta lo strumento
essenziale irrinunciabile dell ' intervento comunitario.
"La Finestra sul Porto" nata dalla stretta collaborazione
della ASL 3 Genovese e il CEIS di Genova, come
esempio di una valida integrazione tra l'assistenza
pubblica e il mondo della solidariet privata "no profit".
In tale struttura sono confluite esperienze diverse e
complementari, acquisite da molti decenni in ambit i
diversi: il Consultorio Famigliare e la Salute Mentale, il
CelS, il SERT, le strutture Ospedaliere e Universitarie
di Neuropsichiatria Infantile. Dalla integrazione di tali
esperienze sta nascendo un modello di lavoro basato
sulla ricerca costante di una relazione positiva e di un
proget to condiviso con i ragazzi, li convegno dello
scorso 18 ot tobre si proposto di valutare le esperienze
acquisite dalla nostra Comunit per Adolescenti, e di
avviare un confronto con altre comunit terapeutiche in
Italia.