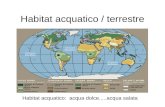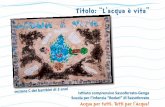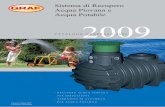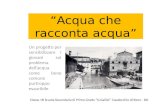Acqua
-
Upload
anna-gigoli -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
description
Transcript of Acqua
AAACCCQQQUUUAAABBBOOOOOOKKK Appunti riflessioni ed esperienze sull’acqua elaborate da
Maria Todeschini e MMaria Todeschini e MMaria Todeschini e MMaria Todeschini e Marcelloarcelloarcelloarcello Zanotto Zanotto Zanotto Zanotto
Istituto Comprensivo F. Morosini
Classe I B
Anno scolastico 2009/2010
INDICE
1. Un po’ di storia………………………………………………………………………………………………1
2. La molecola d’ acqua………………………………………………………………………….............2
3. L’acqua: densità e peso specifico………………………………………………………………3
4. L’ acqua è un solvente…………………………………………………………………………………..4
5. Il principio dei vasi comunicanti…………………………………………………………….....5
6. La capillarità………………………………………………………………………………………………….7
7. La tensione superficiale………………………………………………………………………………9
8. L’acqua e i tre stati di aggregazione………………………………………………………10
9. Il ciclo dell’acqua………………………………………………………………………………..……….11
10. L’acqua e il calore……………………………………………………………………………………...12
11. La distribuzione delle acque sulla terra…………………………………………….…13
12. Il laboratorio “ Bevi con stile”……………………………………………………………..…14
UN PO’ DI STORIA
L’ acqua nelle civiltà antiche era importante, e quasi tutte le antiche
civiltà sorgevano vicino all’ acqua: serviva per bere, coltivare i campi,
allevare gli animali e come mezzo di comunicazione. Essa era così preziosa
che la conservavano nei periodi aridi in cisterne che avevano riempito
quando pioveva.
Gli antichi filosofi greci (Aristotele,Empedocle e altri) ritenevano l’acqua
uno dei quattro elementi costituenti l’universo (acqua, aria, terra, fuoco).
I Romani non approfondirono ulteriori conoscenze teoriche ma studiarono
e progettarono le modalità per meglio utilizzarla costruendo degli
acquedotti, delle cisterne e delle terme.
Anche nel Medioevo e nel Rinascimento continuarono a tener valide le
considerazione degli antiche greci. Con Galileo nasce il metodo
sperimentale, ma solo nel 18° secolo ciò portò ad nuova conoscenza della
struttura dell’acqua. Tra il 1781 e il 1783 i fisici inglesi Cavendish,Watt e
Priestly scoprirono che l’acqua è un composto formato da idrogeno e
ossigeno. Gli esperimenti furono approfonditi dal chimico francese
Lavoisier , loro contemporaneo.
La storia della molecola d’acqua, conclusa con J.Berzelius (1779-1848)
chiarì definitivamente che una molecola d’acqua era composta da due
atomi di idrogeno e uno di ossigeno, adattando la famosa “formula” H2O.
LA MOLECOLA D’ ACQUA
La molecola d’ acqua, H2O, è formata da due atomi di idrogeno (H) e un
atomo di ossigeno (O) legati tra loro con legame covalente che è uno dei
tre modi di unione degli atomi.
E’una molecola polare perché presenta un polo positivo e un polo negativo.
Il polo positivo si trova vicino alla molecola di idrogeno.Il polo negativo è
vicino alla molecola di ossigeno.
Proprio per questo motivo è un solvente universale per molte sostanze;
per esempio l’ acqua scioglie il cloruro di sodio che è un composto ionico,
insinuandosi tra gli ioni Na+ e Cl- circondandoli, rispettivamente, con il
polo negativo e quello positivo
L’ ACQUA : PESO SPECIFICO E DENSITA’
La densità di un corpo e’ il rapporto tra la massa e il volume di un corpo
mentre il peso specifico e’ il rapporto tra il peso di un oggetto e il suo
volume. Tuttavia qui sulla terra possiamo considerare il peso e la densità
come una cosa unica, in quanto tutti i corpi sono sottoposti alla forza di
gravità.
Abbiamo allora fatto questo esperimento per ricavare il peso specifico
dell’acqua potabile
ESPERIENZA
MATERIALI =bilancia elettrica, cilindro graduato e acqua.
IPOTESI = verificare il peso specifico dell’acqua
DESCRIZIONE = pesare il cilindro vuoto = 187,9 g
Riempire con 200 ml di H2O
Pesare il cilindro più acqua = 389,7 g
Peso 3 – peso 1 = 201,8 g peso dell’ acqua
Ps H2O = P:V = 200,67:200 ml = 1,00335g/ml
CONCLUSIONI = il peso specifico dell’ acqua e’ maggiore di 1 perché
essendo potabile è ricca di sali mentre quella distillata ha un Ps =1.
SOLUBILITA’ IN ACQUA L’acqua è un solvente per moltissime sostanze. In una soluzione infatti
distinguiamo sempre un solvente, la sostanza in maggior quantità, un
soluto cioè la sostanza presente in minor quantità.
La concentrazione di una soluzione è la quantità di soluto su 100 ml di
soluzione.
La soluzione è un miscuglio omogeneo di 2 o piu’ sostanze.
ESPERIENZA
MATERIALI = vetrino da orologio, una pipetta, agitatore, becher, 3
provette, porta provette, solfato di rame, olio di semi, soluzione di blu di
metilene all’ 1%.
IPOTESI = verificare la solubilità in acqua delle tre sostanze: solfato di
rame, olio di semi e blu di metilene
DESCRIZIONE = abbiamo versato nella provetta 1 qualche piccola
quantità di solfato di rame, nella provetta 2, una soluzione di blu di
metilene all’ 1%, nella provetta 3 olio di semi ed abbiamo mescolato. Nella
provetta 1 si è formata una soluzione, nella provetta 2 abbiamo formato
una soluzione di blu di metilene, nella provetta 3 abbiamo ottenuto un
miscuglio non omogeneo perché l’ olio galleggia sull’acqua.
CONCLUSIONI = il solfato di rame e la soluzione di blu di metilene sono
solubili in acqua invece l’ olio di semi non lo è.
IL PRINCIPIO DEI VASI COMUNICANTI
Le esperienze che seguono vogliono dimostrare il principio in base al quale
l’ acqua si dispone sempre allo stesso livello in una serie di vasi
comunicanti tra loro.
ESPERIENZA 1
MATERIALI = abbiamo usato l’apparecchio dei vasi comunicanti, della
soluzione di blu di metilene, un becher, un miscelatore, un contagocce e
infine un imbuto.
IPOTESI = verificare che un liquido raggiunge lo stesso livello anche se i
vasi comunicanti hanno forme diverse.
DESCRIZIONE = abbiamo creato una soluzione di blu di metilene poi
abbiamo versato la soluzione così creata nell’ apparecchio dei vasi
comunicanti con l’uso di un imbuto. Abbiamo verificato che l’altezza
dell’acqua è la stessa in tutti e 4 i vasi indipendentemente dalla loro
forma. Abbiamo anche verificato che i liquidi prendono la forma del
recipiente.
CONCLUSIONI = è confermato il principio dei vasi comunicanti.
VASI COMUNICANTI ARTIGIANALI
MATERIALI = due bottiglie di plastica, becher, soluzione di blu di
metilene, tubo trasparente flessibile, nastro isolante, forbici.
IPOTESI = verificare il principio dei vasi comunicanti.
DESCRIZIONE = abbiamo tagliato le bottiglie all’ altezza dell’ etichetta
privandole del fondo. Abbiamo fissato le due estremità del tubo al collo di
ciascuna bottiglia con il nastro adesivo. Abbiamo versato l’acqua colorata
in una bottiglia e abbiamo verificato che essa ha raggiunto lo stesso
livello dell’ altra. Il liquido ha seguito il principio dei vasi comunicanti.
Abbiamo alzato e abbassato le bottiglie e abbiamo osservato che c’era il
fenomeno della fontanella cioè, quando una bottiglia era in alto si
svuotava mentre quella in basso si riempiva creando come una fontanella.
CONCLUSIONI = è confermato il principio de vasi comunicanti.
LA CAPILLARITA’
Il fenomeno della capillarità è il fenomeno per il quale l’acqua non rispetta
il principio dei vasi comunicanti e sale maggiormente nei vasi che hanno un
lume di tipo capillare. Ciò è dovuto alla adesività dell’acqua alle pareti del
tubicino.
ESPERIENZA 1: TRASFERIRE ACQUA SENZA VERSARLA
MATERIALI = due becher, un foglio di scottex e acqua colorata.
IPOTESI =verificare il fenomeno della capillarità sulla carta assorbente.
DESCRIZIONE = riempire il primo becher con l’acqua colorata arrotolare
la carta e disporla a ponte tra il primo e il secondo becher. Attendere
mezz’ ora. Alla fine parte dell’ acqua colorata sarà presente anche nel
secondo becher.
CONCLUSIONI = poiché le fibre della carta assorbente formano tra loro
interstizi capillari, l’ acqua a contatto con la carta si comporta come all’
interno di un vaso capillare confermandone il principio.
ESPERIENZA 2: VERIFICARE LA CAPILLARITA’
MATERIALI = apparecchio vasi capillari, imbutino, acqua e aceto.
IPOTESI = dimostrare il fenomeno della capillarità.
DESCRIZIONE = verso l’ acqua nel vaso più largo con l’aiuto dell’ imbuto e
verifico che l’ acqua si dispone ad un livello più alto mano a mano che
diminuisce il lume contro il principio dei vasi comunicanti.
Ha interferito sulla esperienza la formazione di bolle d’aria.
CONCLUSIONI = a causa delle piccole dimensioni del capillare, l’acqua
sale maggiormente nel vaso più piccolo, ciò è dovuto alla adesività
dell’acqua alle pareti del capillare
LA TENSIONE SUPERFICIALE
Se osserviamo l’ acqua che gocciola da un rubinetto chiuso male possiamo
vedere che essa rimane attaccata al rubinetto prima di cedere alla
gravità; spesso sulla superficie di uno stagno notiamo che alcuni insetti si
appoggiano senza affondare. Questi fenomeni sono gli effetti di una
particolare forza si chiama TENSIONE SUPERFICIALE che è dovuta alla
grande forza di coesione tra le varie molecole d’acqua.
ESPERIENZA:LA GRAFFETTA CHE GALLEGGIA
MATERIALI = 1 becher, forchetta, graffetta, acqua
IPOTESI = dimostrare il fenomeno per cui la graffetta può galleggiare
sull’acqua anche se è più pesante di essa per la presenza di forze sulla
superficie dell’acqua.
DESCRIZIONE = riempio il becher d’acqua e, con molta delicatezza,
adagio la graffetta sulla superficie dell’acqua. Possiamo osservare che la
graffetta galleggia. Versiamo, con il contagocce, una piccola quantità di
detersivo: la graffetta va a fondo perché l’acqua allenta la sua tensione
superficiale.
CONCLUSIONI = il detersivo ha la funzione di diminuire la forza della
tensione superficiale
GLI STATI DI AGGREGAZIONE DELL’H2O L’acqua è l’unica sostanza in natura presente contemporaneamente nei tre
stati di aggregazione:
SOLIDO: l’acqua diventa solida quando la temperatura è sotto gli 0 gradi:
la possiamo trovare nei luoghi freddi (es. in Antartide, zone di montagna
ecc.).
Anche quando la mamma mette le bottiglie d’ acqua in freezer possiamo
osservare che diventa ghiaccio e aumenta di volume, rompendo la bottiglia
o il contenitore.
LIQUIDO: l’acqua nello stato liquido si trova nei laghi,mari e fiumi.
AERIFORME: l’acqua diventa aeriforme per somministrazione di calore. Si
può notare quando l’acqua bolle in pentola, esce il vapore acqueo sotto
forma di fumo.
IL CICLO DELL’ACQUA
L’acqua della pioggia,l’acqua dei fiumi e l’acqua del mare non sono la stessa
cosa…
Eppure è sempre acqua, tutta l’acqua del pianeta partecipa ad un grande
ciclo che permette di bagnare la maggior parte del mondo.
Ogni giorno, per effetto del calore del sole, l’acqua dei laghi, dei mari e
degli oceani evapora e forma le nuvole .
Le nuvole si spostano spinte dal vento e condensano per effetto
dell’abbassamento della temperatura, lasciando cadere la pioggia L’acqua
della pioggia cade nel suolo, penetra nel terreno, nutre le piante, scorre
nei fiumi in stato liquido fino al mare o nelle falde sotterranee (piccoli
fiumi con acqua pulita), e da lì ricomincerà il ciclo.
L’ACQUA E IL CALORE
Per il fenomeno della dilatazione termica l’acqua aumenta di volume
all’aumentare la temperatura ma…essa presenta uno STRANO
COMPORTAMENTO quando dagli 0 °C passa ai 4 °C: nel processo di
fusione infatti si osserva una diminuzione di volume dell’acqua liquida
rispetto ad una stessa quantità di ghiaccio.
Ciò è dovuto alla struttura cristallina che assumono le molecole nello
strato di ghiaccio; allo stato liquido le molecole si avvicinano
maggiormente diminuendo il volume dell’acqua che è stata fusa.
Un’ importante conseguenza di questo fenomeno è il galleggiamento del
ghiaccio sull’acqua; ciò consente ai fiumi e ai laghi di ghiacciare solo in
superficie garantendo,in profondità, la sopravvivenza degli esseri viventi.
LA CONVEZIONE NELL’ACQUA Nell’acqua il calore si trasmette per convezione:si creano così movimenti
ascendenti di acqua calda e movimenti discendenti di acqua fredda che
generano, assieme a variazioni di salinità,le correnti marine.
DISTRIBUZIONI DELLE ACQUE
Circa il 97% delle acque sulla terra sono salate, solo il rimanente 3% è
acqua dolce
ACQUE SALATE
ACQUE DOLCI TOTALE
97 3 100
distribuzione delle acque
ACQUESALATE
ACQUE DOLCI
Se poi consideriamo le acque dolci, il 65% del totale è imprigionato nei
ghiacciai e quasi il 34,4% nelle acque sotterranee; fiumi e laghi sono lo
0,7% e la percentuale del vapore è quasi nulla.
GHIACCIAI FALDE FIUMI E LAGHI VAPORE TOTALE
65 34,3 0,7 0 100
05
1015202530354045505560
GHIACCIAI FALDE FIUMI E LAGHI VAPORE
ACQUE DOLCI
Serie1
LABORATORIO BEVI CON STILE
Il giorno 25 febbraio 2010 abbiamo partecipato a un laboratorio didattico
organizzato da professori e alunni dell’Istituto Vendramin Corner. Il
laboratorio riguardava alcune analisi chimiche relative all’acqua potabile.
L’acqua è potabile quando:
-non ha colore,odore, sapore;
-non contiene microrganismi patogeni;
-non contiene sostanze chimiche in concentrazione tali da risultare
nocive;
-è limpida,areata e fresca.
Per essere sicure di ciò le aziende che gestiscono l’acquedotto o che
producono acqua minerale la controllano in laboratorio.
LE NOSTRE ESPERIENZE
ESPERIENZA 1: L’INDICE DI KUBEL
IPOTESI: verificare la presenza di sostanze organiche nell’acqua.
MATERIALI: due becher, acqua minerale naturale, acqua di fosso,
permanganato di potassio(KMgO4 ), due piastre riscaldanti con calamita
incorporata.
DESCRIZIONE: riempire un becher di acqua potabile ed uno di acqua di
fosso; mettere dentro a entrambi un calamita ed il permanganato.
Aspettiamo un pò, vedremo che l’acqua potabile conserva il colore violetto
mentre l’acqua di fosso diventa arancione
CONCLUSIONI: è confermata la presenza di sostanze organiche
nell’acqua di fosso.
ESPERIENZA 2: MISURARE IL pH DELL’ ACQUA
Il pH misura il grado di acidità o basicità di una soluzione ( nel nostro
caso acqua potabile. Esso oscilla tra pH = 0 e pH = 14.
IPOTESI: verificare il pH di un campione di acqua potabile e di uno di
acqua distillata.
MATERIALI: provetta, campioni di acqua, kit di indicatori per il pH e
schedina di lettura.
DESCRIZIONE: abbiamo versato diversi campioni di acqua nelle
provettine e in ognuna abbiamo aggiunto 5 gocce di indicatore per il pH.
Abbiamo confrontato i colori delle acque e quelle della schedina del pH.
CONCLUSIONI: abbiamo accertato che il campione di acqua distillata è
più acido del campione di acqua potabile: nel primo caso, infatti, la
provetta era gialla e nel secondo azzurra.
LA DUREZZA DELL’ACQUA
La durezza di un’acqua è la misura della quantità di sali contenuti. Essa si
misura in gradi francesi.
ESPERIENZA 3:ANALISI QUALITATIVA
IPOTESI: verificare la presenza di Sali nell’acqua.
MATERIALI: due campioni di acque di cui una distillata,
due provettoni, sapone liquido e miscelatore.
DESCRIZIONE: versare le acque nei due provettoni separati. Aggiungere
cinque gocce di sapone liquido e mescolare. Se non si è ottenuta la
schiuma aggiungere altre 5 gocce, finche in tutte e due le acque non si
sarà ottenuta la schiuma.
CONCLUSIONI: l’acqua distillata, poiché priva di sali, dopo 5 gocce fa
già la schiuma, mentre l’acqua potabile, con più sali, avrà bisogno di 25-30
gocce.
ESPERIENZA 4: ANALISI QUANTITATIVA
IPOTESI = misurare la durezza di diversi campioni di acqua minerale.
MATERIALI = 100 ml di ciascuna acqua,4 becher, buretta, ammoniaca,
indicatore(colorante), EDTA.
DESCRIZIONE = versare 100 ml di ciascuna acqua in ogni becher,
mettere il becher sopra i fornelli e metterci dentro una calamita per
mescolare. Si mette una piccola quantità dell’indicatore, in modo da far
assumere all’acqua un colore viola. Riempire la buretta con 100 ml di
EDTA. Aprire il rubinetto e far uscire piano l’EDTA fino a quando l’acqua
non assume un colore azzurro. Chiudere il rubinetto. Si esegue il
procedimento con tutte le acque. Più gocce di EDTA servono, più l’acqua
è dura.
CONCLUSIONI = le acque potabili hanno durezze diverse che rivelano
una diversa quantità di sali.