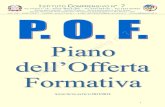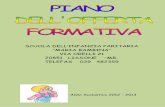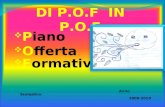5^A LICEO DELLE SCIENZE UMANE Opzione ECONOMICO … · Il Consiglio di classe ha fatto propri i...
-
Upload
dangkhuong -
Category
Documents
-
view
235 -
download
0
Transcript of 5^A LICEO DELLE SCIENZE UMANE Opzione ECONOMICO … · Il Consiglio di classe ha fatto propri i...
ESAME DI STATO a. s. 2017-2018
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
(art.5, comma 2 del D.P.R. n° 323/98 - art.6 O.M. n.43 del 11/04/2002)
CONSIGLIO DI CLASSE :
5^A LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Opzione ECONOMICO SOCIALE
PROFILO DELL’INDIRIZZO
Al termine del percorso di studi, lo studente deve:
conoscere i metodi, i concetti chiave e le categorie interpretative delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche, anche attraverso percorsi attivi e proposte didattiche pluridisciplinari articolate durante i cinque anni del corso (analisi dei bisogni e delle risposte sul territorio, marketing e comunicazione aziendale, lavoro e gestione del personale, etica e cooperazione internazionale);
comprendere i fenomeni culturali attraverso le categorie delle scienze umane, in particolare antropologica e sociologia, dell’economia e del diritto orientandosi verso la comprensione della modernità;
aver sviluppato la capacità di confrontare teoria e pratica attraverso strumenti matematici, statistici e informatici;
aver studiato le interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali usando le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche;
cogliere il legame tra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni politiche a livello nazionale, europeo e globale, sviluppando sensibilità ai problemi sociali e creatività nell’affrontarli;
acquisire nella prima lingua moderna (inglese) il livello B2 delle competenze comunicative e nella seconda lingua moderna (francese) competenze comunicative a livello B1.
2. STORIA DELLA CLASSE
2.1 INSEGNANTI
INSEGNANTI
MATERIA
3°EA 4°EA 5° EA
RELIGIONE PAU Maria Teresa PAU Maria Teresa IAVARONE Daniela
ITALIANO MOSSINO Stefano MOSSINO Stefano MOSSINO Stefano
STORIA MOSSINO Stefano MOSSINO Stefano MOSSINO Stefano
INGLESE TROMBETTA Rosanna CANNELLI Roberta CANNELLI Roberta
FRANCESE MONTICONE
Margherita
MONTICONE Margherita MONTICONE
Margherita
DIRITTO ED
EC.POLITICA
STRAMBIO Maria Laura STRAMBIO Maria Laura STRAMBIO Maria
Laura
FILOSOFIA DEMATTEIS Luca Maria FIORE Patrizia POZZO Germana
MATEMATICA SCIUTTI Rosella SCIUTTI Rosella SCIUTTI Rosella
FISICA SCIUTTI Rosella SCIUTTI Rosella SCIUTTI Rosella
SCIENZE UMANE POZZO Germana POZZO Germana POZZO Germana
STORIA DELL’ARTE DODI Anna CONTINO Sandra GRASSI Emilia
SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE
CASSULLO Aristide DOTTINO Marilisa DOTTINO Marilisa
2.2 STUDENTI
Inizio anno fine anno
STUDENTI
da classe
Da altri
Ripetenti
Totale
Promossi
Non
Ritirati
precedente Istituti o indir. A giugno A
settembr
e
promossi
3a 19 1 0 20 14 5 1 0
4a 19 0 1 20 16 3 0 1
5a 19 0 1 20 1
3. ATTIVITA’ DIDATTICHE PROGRAMMATE E REALIZZATE CON LA
CLASSE nell’a.s. _2017/2018
Gli alunni che abbiano riscontrato insufficienze nel primo quadrimestre sono stati coinvolti nelle
iniziative di recupero proposte dall’istituto secondo le modalità stabilite dal collegio docenti
3.1 ATTIVITA’ COMPLEMENTARI E/O INTEGRATIVE REALIZZATE DALLA CLASSE
Attività Durata Tipologia Partecipazione
Progetto Migranti in
collaborazione con
Fondazione Goria e Piam
8 ore Curricolare Totale
Incontro con un Avvocato
del Centro di Servizi per
l’immigrazione “ PIAM” di
Asti
2 ore Curriculare Totale
Viaggio di istruzione
Amsterdam
5 giorni Curricolare Quasi totale
Progetto Industriamoci 24 ore Extracurricolare Parziale
Corso di diritto
internazionale ISRAT
5 ore Curricolare Totale
Progetto “La costituzione
e la bellezza”
16 ore Curricolare Parziale
Progetto “ Conoscere il
servizio civile”
2 ore Curricolare Totale
3.2 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Tutti gli alunni hanno partecipato alle attività di alternanza scuola lavoro esaurendo e in molti casi superando, le 200 ore previste dalla normativa, con valutazioni apprezzabili. In preparazione all’esperienza di Alternanza hanno partecipato al corso sulla Sicurezza promosso dalla scuola e ad altri corsi di formazione. Durante l’anno scolastico 2015-16, la classe ha partecipato al progetto di simulazione d’impresa in collaborazione con JA ITALIA che ha riconosciuto a tutti gli alunni 80 ore di alternanza. Le restanti ore sono state svolte sia attraverso la partecipazione ad attività promosse dall’Istituto, sia su iniziativa personale degli studenti in settori attinenti al percorso di studio ( studi legali, commercialisti, assicurazioni, aziende, volontariato in associazioni ed enti pubblici).
3.3 TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO
DISCIPLINA Ore annuali previste
entro il 15 Maggio
Ore effettivamente svolte
entro il 15 Maggio
ITALIANO 120 105
STORIA 60 56
SCIENZE UMANE 90 82
DIRITTO 90 78
FRANCESE 90 83
INGLESE 90 86
FILOSOFIA 60 54
MATEMATICA 90 92
FISICA 60 53
STORIA DELL’ARTE 60 56
ED. MOTORIA 60 52
RELIGIONE 30 24
Totale 900 821
4. VALUTAZIONE
4.1 CRITERI ADOTTATI
Il Consiglio di classe ha fatto propri i criteri di valutazione del P.O.F. dell’Istituto “Monti”
Per le simulazioni della terza prova dell’Esame di Stato, le valutazioni in quindicesimi sono state
convertite in decimi sui registri dei docenti.
4.2 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE VERIFICHE SVOLTE DURANTE L’ANNO
PER TIPOLOGIA
MATERIA
N° VERIFICHE ORALI N° VERIFICHE
SCRITTE
TIPOLOGIE DI PROVE
PREVALENTEMENTE USATE
ITALIANO 5 5 1 3 8 9 21
STORIA 4 1 11 18
SCIENZE UMANE 5 8 1 8 9 10 11 18
DIRITTO 3 5 1 3 21 8
FRANCESE 5 6 1 4 8 11 15 18
INGLESE 4 6 1 4 8 15 18
FILOSOFIA 2 4 1 11 18 21
MATEMATICA 4 8 1 11 14 15 18
FISICA 2 4 1 11 14 15 18
STORIA DELL’ARTE 2 2 1 18 20
ED. MOTORIA 2 2 1 22
RELIGIONE 2 1 2 7
Nota: inserire nella quarta colonna il numero corrispondente alle tipologie di prova prevalentemente usate.
1. Interrogazione 7. Relazione 15. Esercizi
2. Interrogazione semistrutturata con obiettivi
predefiniti
8. Analisi di testi 16. Analisi di casi
17. Progetto 9. Saggio breve
3. Tema 10. Quesiti vero/ falso 18. Quesiti a risposta singola
4. Traduzione da lingua classica/
straniera in italiano
11. Quesiti a scelta multipla
12. Integrazioni/ completamenti
19- Riassunto
20- Riflessione parlata
5. Traduzione in lingua straniera 13. Corrispondenze 21- Trattazione sintetica di argomenti
6. Dettato 14. Problema 22- Prova pratica
4.3 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SIMULAZIONI EFFETTUATE SECONDO LE
TIPOLOGIE PREVISTE PER LA TERZA PROVA D’ESAME
SIMULAZION
E DI TERZA
PROVA
MATERIE
coinvolte
A partire da
un testo di
riferimento
Trattazione
sintetica di
argomenti
Quesiti a
risposta
singola
Quesiti a
scelta
multipla
Problemi
a soluzione
rapida
Casi
pratici e
professio-
nali
Sviluppo
di
progetti
Data 10/01 Inglese Storia Matematica Filosofia
X
X
X
X
X
X
X
X
Data 05/05 Inglese Matematica Francese Diritto ed economia
X X X
X
5. PROFILO DELLA CLASSE
La composizione della classe, 19 alunni di cui 15 femmine e 4 maschi, dopo una prima selezione
in partenza, non ha subito particolari modifiche nel triennio. Il percorso didattico fin qui seguito è
stato sostanzialmente regolare e condiviso fra consiglio di classe e studenti, il comportamento è
sempre stato positivo, sia nel corso della normale attività scolastica sia in tutte le altre occasioni,
quali viaggi d'istruzione, visite guidate, partecipazione a corsi, conferenze e iniziative del nostro
liceo o esterne; il modo di relazionarsi con gli insegnanti corretto e leale. Si segnala una frequenza
regolare, una buona partecipazione al dialogo educativo, un impegno costante, un interesse e una
partecipazione sostenuti, favoriti anche dai numeri non troppo elevati e da una buona motivazione
di partenza. Pur permanendo qualche situazione di incertezza dal punto di vista dei risultati
scolastici, la classe si presenta all’esame con un rendimento mediamente buono.
6. ALLEGATI
6.1. ALLEGATO1 : ATTIVITA’ DIDATTICHE DISCIPLINARI E PROGRAMMI ANALITICI
6.2 ALLEGATO2 : ESEMPLIFICAZIONI DI TERZA PROVA (n.2 )
6.3 ALLEGATO3 : GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE D’ESAME
Asti, 15 maggio 2018 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Prof. Giorgio MARINO )
ALLEGATO1. ATTIVITA’ DIDATTICHE DISCIPLINARI E PROGRAMMI ANALITICI
MATERIA LETTERATURA ITALIANA DOCENTE Stefano Mossino
Testi adottati: Rosa fresca aulentissima voll. 5 e 6
Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/2018: 105 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI
CONOSCENZE/ CONTENUTI La letteratura italiana dalla crisi del romanticismo agli anni ’70 del ‘900 con accenni alla situazione
storica e culturale dell’ Europa e degli Stati Uniti, confronti e rapporti di interdipendenza tra autori
italiani e stranieri,in particolare francesi,russi,mitteleuropei, anglosassoni.
CAPACITA’/ COMPETENZE Saper realizzare, secondo le indicazioni, testi corrispondenti a tutte le tipologie d’esame. Creare
colle gamenti tra la letteratura, la storia le scienze umane. Esporre in modo efficace utilizzando il
lessico adeguato. Saper cogliere aspetti particolari di un testo analizzato
RISULTATI OTTENUTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PERSEGUITI
In generale abbastanza buoni, non ci sono stati particolari problemi organizzati, le richieste in
merito alle valutazioni sono sempre state soddisfatte, alcune preparazioni risultano ancora un po’
superficiali e mnemoniche altre più approfondite e di ampia veduta.
Gli obiettivi si possono dire comunque raggiunti in buona parte
METODOLOGIE DIDATTICHE Lezione frontale, lezione dialogata, compresenza su argomenti comuni,lavoro sul testo, simulazioni
di prima prova
STRUMENTI ED AMBITI DI LAVORO Libro di testo, altre fonti lette in classe, accesso (ove possibile ) alla rete, confronti individuali sulle
tesine
MODALITA’ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE
Interrogazione, modelli di prima prova tratti dalle precedenti sessioni, test.
MATERIA STORIA DOCENTE Stefano Mossino
Testi adottati: La cittàdella storia vol 3
Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/2018: 56
PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI
CONOSCENZE/ CONTENUTI Eventi della storia mondiale dall’inizio del ‘ 900 agli anni ’80-’90 con particolare riferimento
alle
Vicende europee, senza tralasciare questioni coloniali o globali.
CAPACITA’/ COMPETENZE Interpretare correttamente i fenomeni, mett.erli in relazione fra di loro nel meccanismo causa
effetto. Approfondire determinati aspetti in relazione al corso di studi economico-sociale.
Comprendere le dinamiche politiche e ideologiche
Utilizzare un lessico adeguato anche dal punto di vista tecnico
RISULTATI OTTENUTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PERSEGUITI
In media adeguati alle aspettative, alcuni allievi utilizzano ancora un lessico un po’ generico che
non contribuisce alla comprensione e all’esposizione corretta di concetti complessi. In ogni caso
l’interesse dimostrato per la materia è buono
METODOLOGIE DIDATTICHE Lezione frontale, narrazioni, analisi di alcuni documenti (anche di storia locale) collaborazione con
l’ISRAT
STRUMENTI ED AMBITI DI LAVORO Manuale, documenti diversamente reperiti, prodotti audiovisivi, internet
MODALITA’ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE Interrogazione, test secondo il modello di terza prova
MATERIA DIRITTO ED ECONOMIA DOCENTE Maria Laura Strambio
Testo in adozione :
Una finestra sul mondo ed. Paravia /Pearson Ore di lezione effettuate nell’ a.s. 2017/2018 72
PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI
CONOSCENZE/ CONTENUTI
Conoscere il nostro sistema economico e il nostro sistema di welfare
Conoscere il funzionamento dei rapporti economici internazionali ed i rapporti monetari fra gli Stati
Conoscere i principali organi e funzioni dell’ordinamento europeo
Conoscere l’ordinamento dello Stato italiano
Conoscere i principali organismi sovranazionali
Conoscere i valori fondanti la Costituzione
CAPACITA’/ COMPETENZE
Riconoscere le caratteristiche principali di uno stato ad economia mista della globalizzazione, il ruolo delle multinazionali e della New Economy e del welfare
Riconoscere le politiche monetarie ed economiche che hanno impatto sul nostro sistema economico
Utilizzare gli strumenti acquisiti per leggere e capire un articolo in materia economica o giuridica
RISULTATI OTTENUTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PERSEGUITI
Nella classe si distinguono tre gruppi : il primo ha raggiunto un buon spirito critico rispetto al tema
da affrontare ed in diverse situazioni ha dimostrato di saper utilizzare le nozioni e gli strumenti
acquisiti in questi anni per trattare l’argomento che gli viene richiesto. Il secondo gruppo viceversa
non è brillante in tutti gli argomenti ma comunque l’esposizione sia orale che scritta risulta
mediamente discreta .
Qualche studente viceversa nel corso degli anni non ha dimostrato particolare attitudine per la
materia e ciò si riflette sui risultati acquisiti e sullo spirito con il quale affronta i quesiti richiesti :
comunque mediamente la preparazione risulta sufficiente .
METODOLOGIE DIDATTICHE Lezione frontale, discussione in classe , commento e discussione su eventi economici/ giuridici di
attualità
STRUMENTI ED AMBITI DI LAVORO Lezione in classe , computer
MODALITA’ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE E’ stata valutata l’acquisizione di contenuti, la padronanza della loro gestione, il linguaggio e la
capacità di collegare i diversi argomenti trattati, il percorso .
MATERIA: INGLESE DOCENTE: Roberta Cannelli Testi adottati: M. Spiazzi – M. Tavella – M. Layton COMPACT PERFORMER CULTURE & LITERATURE LINGUE ZANICHELLI Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/2018 N. 86 PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI CONOSCENZE/CONTENUTI: Una selezione di autori in lingua inglese dal periodo vittoriano all’età contemporanea.
• CAPACITA’/COMPETENZE: Sapersi orientare nella contestualizzazione storica del periodo letterario studiato, sapere usare termini appropriati per il linguaggio letterario, sapere riassumere un testo in modo sintetico ma comprensibile.
• RISULTATI OTTENUTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PERSEGUITI
La classe ha seguito il percorso di apprendimento con interesse ed impegno. Tutti gli studenti hanno dimostrato motivazione e serietà, anche se i risultati non sono omogenei. Un gruppo di allievi ha raggiunto un’approfondita conoscenza della materia e adeguate competenze comunicative, mentre una minoranza rivela ancora incertezze espositive e insicurezza nella comunicazione, alle quali si cerca di sopperire attraverso uno studio mnemonico. In linea generale, gli studenti riescono ad esprimere oralmente concetti sia di carattere generale che letterario in modo chiaro, seppur a volte essenziale. Nella composizione scritta si nota un uso generalmente adeguato delle strutture morfosintattiche.
• METODOLOGIE DIDATTICHE Al fine di porre gli studenti al centro del percorso di apprendimento e di consolidare le competenze espressive in lingua inglese, ho volutamente limitato la lezione frontale per dare spazio agli interventi degli alunni. Durante le spiegazioni abbiamo fatto costante riferimento al libro di testo che è stato letto e commentato. Ho sempre coinvolto la classe favorendo gli interventi diretti nella lezione attraverso domande e chiarimenti. La reazione è stata generalmente positiva e gli studenti hanno risposto partecipando attivamente alle spiegazioni. Le spiegazioni sono state supportate dall’uso di video in lingua originale. E’ stato fatto uso sporadico di fotocopie per integrare lo studio di brani e autori non presenti nel testo. Sono stati forniti inoltre schemi riassuntivi sui vari argomenti per agevolare lo studio.
• STRUMENTI ED AMBITI DI LAVORO: libro di testo, cd, fotocopie, video e audio.
• MODALITA’ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE. Tre prove scritte per quadrimestre. TIPOLOGIA: questionari, traduzione, commenti di brevi passaggi tratti dai brani antologici. Nel corso del secondo quadrimestre sono state effettuate due simulazioni di terza prova. Prove orali: due interrogazioni a quadrimestre consistenti in domande e commento dei brani. VALUTAZIONE – Nella valutazione si è tenuto conto:
• della pertinenza alle richieste • del livello di conoscenza dei contenuti • della capacità di farsi capire con un linguaggio comprensibile.
MATERIA: LINGUA FRANCESE DOCENTE: Margherita Monticone
Testo adottato: Francesca Ponzi “Carnet Culture”, ed. LANG
Ore di lezione effettuate nell’a. S. 2017/2018: 83 su 90 previste
PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI
CONOSCENZE/ CONTENUTI Civiltà e attualità: conoscere aspetti della civiltà e cultura francese. Conoscere il lessico
specifico di alcune grandi tematiche, conoscere la lingua corrente e arricchire il lessico.
Migliorare la conoscenza delle strutture morfosintattiche.
CAPACITA’/ COMPETENZE - Leggere, capire e tradurre testi, imparando ad usare la lingua francese come strumento
veicolare per esprimersi su argomenti legati a vari ambiti. - Analizzare il contenuto di testi facendo particolare riferimento a tematiche trattate anche in altre
discipline e specifiche del corso economico sociale - Saper esporre argomenti scelti a partire da letture, da documenti tratti da internet, da fatti di
attualità o da soggetti trattati in altre discipline. - Capire diverse tipologie di testo proposte. Sono stati affrontati pochi testi letterari per
privilegiare il tempo dedicato a tematiche più legate agli obiettivi del corso. - Rispondere a questionari. Produrre testi scritti traendo spunto da letture
- Lavorare in gruppo. Saper selezionare del materiale e saperlo esporre e presentare - Affinare la capacità di sintesi e sviluppare la capacità di espressione personale.
RISULTATI OTTENUTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PERSEGUITI
La partecipazione, l’interesse e il rispetto delle consegne sono stati buoni per quasi tutta la classe,
che conosco da cinque anni. Un buon spirito di collaborazione fra gli alunni e con i docenti ha
favorito il lavoro e migliorato il rendimento. Alcuni alunni si sono distinti per l’impegno costante e gli
ottimi risultati. Per altri studenti restano incertezze in particolare nelle attività di produzione scritta.
In generale i risultati sono migliori nell’esposizione orale.
METODOLOGIE DIDATTICHE Potenziamento delle capacità linguistiche attraverso la comprensione orale e scritta di testi;
questionari, letture guidate, riassunti, produzione di testi su temi proposti. Tentativi di fornire agli
studenti gli strumenti per utilizzare la lingua per esprimersi su ambiti legati al corso di studio.
Proposte di lavoro autonomo di ricerca di materiale ed esposizione orale.
STRUMENTI ED AMBITI DI LAVORO Testo, internet.
MODALITA’ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE Verifiche complessive, eseguite in classe attraverso l’interazione fra studenti e insegnante e fra gli
studenti stessi per valutare la disinvoltura nell’uso della lingua e la capacità d’intervento.
Verifiche più specifiche per valutare le abilità di comprensione e produzione della lingua orale
(interrogazioni, esposizione di articoli, espressione d’idee personali) e di quella scritta
(comprensione del testo, questionari, quesiti a risposta aperta, produzione di testi scritti.). Le
verifiche sono state conformi alle tipologie proposte per l’esame di stato.
Nelle due simulazioni sono state proposte le tipologie B+C (mista) e B (tre domande, risposta
singola da 5 a 7 righe)
MATERIA: MATEMATICA DOCENTE: Rosella Sciutti
Testi adottati: Leonardo Sasso “ Nuova Matematica a colori ” Edizione Azzurra Volume 5 Petrini
Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/2018 (entro il 15 maggio): 92 ore su 90 previste.
PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI
CONOSCENZE/ CONTENUTI
Conoscere i principali concetti affrontati nel corso di quest’anno (concetto di funzione, limite di funzione, derivata di funzione) e saperli sistemare logicamente nella propria rete concettuale.
Conoscere i metodi di risoluzione per il calcolo di limiti e le regole di derivazione, per la determinazione di asintoti, discontinuità, punti di non derivabilità, monotonia, massimi e minimi relativi, concavità e punti di flesso.
Conoscere i diversi passi dello schema che consente di studiare una funzione e saper utilizzare tali informazioni per tracciare il grafico sul piano cartesiano.
Conoscere i diversi passi dello schema che consente di leggere con completezza il grafico di una funzione.
Richiamare alla mente ed esporre, utilizzando in modo consapevole il linguaggio specifico e i simboli propri della disciplina, definizioni, proprietà, regole e teoremi studiati.
CAPACITA’/ COMPETENZE
Saper utilizzare, in situazioni specifiche e in contesti differenti, idee generali, definizioni, proprietà e regole apprese e saper calcolare limiti e derivate di funzioni razionali intere e fratte.
Saper studiare una funzione razionale intera e fratta.
Saper ricavare informazioni da grafici: dominio e codominio, simmetrie particolari, intersezioni con gli assi cartesiani, segno della funzione, limiti, equazioni di asintoti, punti di discontinuità e non derivabilità, monotonia, massimi e minimi relativi e assoluti, concavità e punti di flesso.
RISULTATI OTTENUTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PERSEGUITI
Ad inizio anno è stata somministrata una prova sul programma di quarta per conoscere il livello di
preparazione della classe e gli esiti hanno evidenziato un’assimilazione dei contenuti ancora
piuttosto superficiale e talvolta lacunosa per un gruppetto non esiguo di allievi. In particolare, sono
state riscontrate difficoltà relative alla risoluzione di equazioni e disequazioni di secondo grado,
aggravate da imprecisioni legate al calcolo letterale.
Pertanto si è reso necessario svolgere attività di recupero in orario sia curricolare sia extra-
curricolare. Il programma ha comunque subìto delle riduzioni (lo studio di funzioni si è limitato a
quello delle funzioni razionali intere e fratte).
La quasi totalità degli allievi ha seguito con attenzione, ha dimostrato interesse e impegno costante
sia a scuola sia a casa.
Il profitto dei due terzi della classe risulta pienamente sufficiente e in alcuni casi buono.
Poco meno di un terzo della classe presenta ancora difficoltà dovute a lacune pregresse e anche a
scarse attitudini per la disciplina: di questo gruppo alcuni allievi hanno in parte colmato con
impegno e spirito di sacrificio le loro carenze, mentre altri hanno manifestato ancora errori di
calcolo e di procedimento e lacune nei contenuti.
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezioni frontali alternate a lezioni d’interazione con la classe per la trattazione teorica degli argomenti del programma.
Risoluzione guidata in classe di esercizi e problemi inerenti alle tematiche sviluppate.
Correzione individuale e/o collettiva dei compiti assegnati a casa e delle verifiche scritte.
Attività di recupero e/o potenziamento rivolta all’intera classe durante ore curricolari ed extracurriculari + SOS Matematica.
STRUMENTI ED AMBITI DI LAVORO Uso del libro di testo, della lavagna e di materiale preparato dall’insegnante: fotocopie e schede di
esercizi mirati alla preparazione delle verifiche scritte.
MODALITA’ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE Per la valutazione formativa sono utilizzati i seguenti strumenti: verifiche scritte inerenti alla
risoluzione di esercizi e problemi, domande aperte + quesiti a risposta chiusa con motivazione
della risposta e verifiche orali mirate a valutare le capacità espositive e di formalizzazione verbale
degli argomenti.
La valutazione sommativa finale, oltre che dei risultati ottenuti dalle prove di verifica tiene conto
anche del comportamento tenuto in classe, della partecipazione, degli interventi, dell’impegno
dimostrato e dei progressi di ciascun allievo.
MATERIA: FISICA DOCENTE: Rosella Sciutti
Testi adottati: Ugo Amaldi “Le traiettorie della fisica.azzurro” Elettromagnetismo Relatività e
quanti Scienze Zanichelli
Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/2018 (entro il 15 maggio): 53 ore su 60 previste
PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI
CONOSCENZE/ CONTENUTI
Conoscere le proprietà e le leggi studiate su fenomeni elettrici e circuiti elettrici.
Conoscere le proprietà e le leggi studiate su fenomeni magnetici.
Conoscere il concetto di campo, le differenze e analogie tra campo elettrico e magnetico e le interazioni fra essi.
Conoscere il concetto di campo elettrico e di campo magnetico indotto.
Conoscere le equazioni di Maxwell e la definizione di campo elettromagnetico.
Conoscere la definizione di onde elettromagnetiche ed il relativo spettro.
Utilizzare in modo consapevole il linguaggio specifico della disciplina.
CAPACITA’/ COMPETENZE
Saper applicare la legge di Coulomb.
Saper distinguere i diversi tipi di elettrizzazione di conduttori e isolanti.
Saper calcolare il campo elettrico generato da una carica puntiforme. Saper disegnare le linee di campo nei casi studiati.
Saper calcolare la capacità di un condensatore.
Saper distinguere i collegamenti dei resistori in serie e in parallelo.
Saper applicare le leggi di Ohm.
Saper determinare intensità, direzione e verso del campo magnetico e saper applicare le leggi studiate.
Saper “spiegare” la legge di Faraday–Newmann-Lenz e il funzionamento dell’alternatore e del trasformatore.
Saper analizzare le equazioni di Maxwell.
Saper descrivere la propagazione di un’onda elettromagnetica e lo spettro elettromagnetico.
RISULTATI OTTENUTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PERSEGUITI
Come in matematica anche in fisica sono emerse ad inizio anno scolastico alcune difficoltà,
soprattutto nell’impiego dei termini specifici della disciplina, nell’utilizzo della notazione scientifica e
nell’applicazione di quanto studiato a semplici problemi.
Lo studio è risultato sistematico da parte dei due terzi della classe e in questo caso i risultati sono
stati pienamente sufficienti e qualche volta buoni; negli altri casi lo studio è risultato mnemonico e
un po’ superficiale e talvolta la comprensione è stata soltanto parziale.
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezioni frontali alternate a lezioni d’interazione con la classe per la trattazione teorica degli argomenti del programma.
Risoluzione guidata in classe di semplici problemi inerenti ad alcune delle tematiche sviluppate.
Correzione individuale e/o collettiva dei compiti assegnati a casa e delle verifiche scritte.
Attività di recupero e/o potenziamento rivolta all’intera classe mediante attività di SOS Fisica.
STRUMENTI ED AMBITI DI LAVORO Uso del libro di testo, della lavagna e di materiale preparato dall’insegnante: fotocopie per
approfondimenti ed esercitazioni su domande a risposta chiusa. Uso della L.I.M. anche talvolta per
la visione di filmati proposti da Rai Scuola o tratti da YouTube.
MODALITA’ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE Per la valutazione formativa sono utilizzati i seguenti strumenti: verifiche scritte inerenti alla
risoluzione di semplicissimi problemi (applicazione delle leggi), domande aperte + quesiti a
risposta chiusa con motivazione della risposta e verifiche orali mirate a valutare le capacità
espositive e di formalizzazione verbale degli argomenti.
La valutazione sommativa finale, oltre che dei risultati ottenuti dalle prove di verifica tiene conto
anche del comportamento tenuto in classe, della partecipazione, degli interventi, dell’impegno
dimostrato e dei progressi di ciascun allievo.
MATERIA SCIENZE UMANE DOCENTE Germana Pozzo
Testi adottati:
AAVV “ Sociologia” Einaudi AAVV. “ Metodologia della ricerca” Einaudi
Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/2018: Sono state effettuate 43 ore di lezione nel primo quadrimestre e 39 nel secondo ( al 15 maggio)
per un totale di 82 su 90 previste
PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI
CONOSCENZE/ CONTENUTI
Urbanizzazione e globalizzazione
Contesto socio-culturale ed economico in cui si sviluppa il Welfare state; il significato economico e
politico del terzo settore.
Le trasformazioni socio politiche ed economiche indotte dalla globalizzazione; funzione e influenza
dei mezzi di comunicazione; il multiculturalismo
Metodi e Strumenti della Ricerca antropologica e sociologica
CAPACITA’/ COMPETENZE
- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per orientarsi nel tessuto
produttivo del proprio territorio.
- Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita
sociale e nelle istituzioni esterne alla scuola
- Comunicare e rappresentare eventi, procedure e concetti, utilizzando linguaggi diversi e diverse
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti; in particolare comprendere la necessità
dell’approccio interdisciplinare per affrontare in modo adeguato i problemi posti dalla realtà umana
e sociale
-Comprendere il senso e l’importanza della ricerca come strumento di analisi critica della realtà
- Interpretare i risultati di ricerche e rapporti documentari, applicando le conoscenze dei principali
metodi della ricerca sociale
RISULTATI OTTENUTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PERSEGUITI
Il dialogo educativo è stato improntato alla correttezza e alla cordialità, e il gruppo classe,
ha saputo progredire nel modo atteso. L’interesse per le tematiche affrontate è stato
costante, tuttavia la partecipazione attiva non è stata omogenea e per alcuni si è limitata
ad una generale disponibilità all’ ascolto e allo studio. L’impegno è risultato serio e costante
per la maggior parte degli alunni, ciò ha permesso alla maggioranza di ottenere risultati
positivi; solo alcuni si pongono ad un livello nel complesso appena accettabile.
METODOLOGIE DIDATTICHE Utilizzo della lezione frontale e della lezione dialogata (domande per sollecitare gli alunni
ad una maggiore partecipazione);
proposta agli alunni di studio/esercizi dei piccoli casi per sviluppare le loro competenze e
capacità speculative;
assegnazione di lavori di gruppo, in termini di ricerche e approfondimenti, lettura ed analisi
di testi (o parti di essi) indicati dal docente
STRUMENTI ED AMBITI DI LAVORO
Utilizzo del libro di testo integrato da dispense e presentazioni multimediali fornite dall’insegnante e
materiali reperiti in rete attraverso la ricerca guidata e autonoma. Lettura in forma antologica di
alcuni brani degli autori tratti da varie fonti; analisi di dati statistici e report di ricerca.
MODALITA’ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE
Riguardo agli obiettivi cognitivi specifici è stato valutato:
il grado di apprendimento dei contenuti;
la capacità di collegare, sistemare e rielaborare i concetti appresi;
le capacità espressive e l'uso di un corretto linguaggio specifico;
le capacità di riflessione critica e di rielaborazione personale.
Riguardo agli obiettivi formativi, oltre a quanto espresso nelle singole programmazioni di classe, è
stato posto l'accento su:
l'impegno domestico, il comportamento e la partecipazione alle lezioni in classe e durante i
lavori di gruppo.
Sono state effettuate 4 prove scritte di varie tipologie in preparazione alla prova d’esame e 3
colloqui orali/ test per quadrimestre. Sono stati inoltre considerati i lavori assegnati per compito ai
fini della valutazione formativa.
MATERIA FILOSOFIA DOCENTE Germana Pozzo
Libro di testo: Abbagnano – Fornero “Protagonisti e testi della filosofia” – Paravia
Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/2018 Sono state effettuate 30 ore nel primo quadrimestre e 24 nel secondo ( al 15 maggio) per un totale
di 54 su 60
Obiettivi programmati in termini di conoscenze e capacità
1. Cogliere il progressivo specializzarsi della filosofia in saperi settoriali senza perdere la visione
unitaria della cultura.
2. Conoscere nelle linee generali il pensiero filosofico dall’idealismo hegeliano alla filosofia di
Popper.
3. Leggere con o senza uno schema guida un testo filosofico, rintracciandone le idee centrali.
4. Migliorare la comprensione e l’uso pertinente del linguaggio specifico.
5. Collegare testi filosofici a contesti problematici.
6. Acquisire l’attitudine alla ricerca di altre fonti documentarie e saper lavorare su diversi
materiali per effettuare sintesi e confronti.
7. Ricostruire reti di concetti e il pensiero dei filosofi.
RISULTATI OTTENUTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PERSEGUITI
La classe ha dovuto affrontare anche in quinta il cambiamento del docente titolare; ha evidenziato,
nel corso dell’anno scolastico miglioramenti sul piano delle abilità logiche, espositive e del metodo.
Il livello di acquisizione di conoscenze e competenze risulta ancora eterogeneo, ma nel
complesso positivo per un buon numero di alunni.
Gli obiettivi si possono considerare sostanzialmente raggiunti per la maggior parte della classe,
specie per ciò che comporta la conoscenza del pensiero dei filosofi; più difficoltosi l’uso del
linguaggio specifico e la rielaborazione autonoma del pensiero.
METODOLOGIE DIDATTICHE Lezioni dialogate per l’identificazione dei problemi e per favorire un apprendimento di tipo attivo.
Lezioni frontali per fornire una presentazione ragionata del percorso di lavoro che si intende
compiere, per dare informazioni e conoscenze analitiche, ma anche stimoli e problematizzazioni.
Lavoro a piccoli gruppi per favorire la crescita razionale e sociale degli studenti, lettura ed analisi
collettiva di testi.
STRUMENTI ED AMBITI DI LAVORO
Libro di testo ed eventuali altri manuali reperiti dall’insegnante, testi dei filosofi, appunti e schemi,
materiali reperiti in rete o costruiti dal docente
MODALITA’ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE
Sono state effettuate 4 prove scritte con quesiti a risposta singola e a scelta multipla
in preparazione della terza prova d’esame e 3 colloqui orali. Sono stati inoltre considerati i lavori
assegnati per compito ai fini della valutazione formativa.
MATERIA STORIA DELL’ARTE DOCENTE Grassi Emilia
Testi adottati:
G. Cricco, F. P. Di Teodoro Itinerario nell’arte Dall’età dei lumi ai giorni nostri Vol. 3
Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/2018: 56 su 60 previste
PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI
CONOSCENZE/ CONTENUTI
Conoscenze: Collocazione degli autori e delle opere nel contesto storico
CAPACITA’/ COMPETENZE
Capacità: Saper conoscere autonomamente le caratteristiche fondamentali delle principali opere
architettoniche, pittoriche e scultoree inerenti i periodi e gli stili affrontati e saper effettuare
collegamenti anche con altri ambiti disciplinari.
Competenze: Saper individuare i concetti estetici ed i caratteri stilistici di base.
Saper attuare una lettura dell’opera d’arte sviluppando un’analisi critica che la mette
in relazione con altri contesti storico culturali e disciplinari.
RISULTATI OTTENUTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PERSEGUITI
Conoscenze: livello medio il 70%, alto il 30%.
Competenze: livello medio il 70% alto il 30%.
Capacità: livello medio il 70% alto il 30%.
METODOLOGIE DIDATTICHE
Sono state presentate le conoscenze essenziali chiedendo agli alunni di prendere appunti in
classe e di approfondire mediante l’uso del testo in adozione e di altri, gli argomenti trattati. La
lettura delle opere d’arte è stata realizzata attraverso l’analisi collettiva della classe guidata
dall’insegnante, stimolando la loro curiosità e spingendoli ad una lettura complessa e personale dei
contenuti proposti e a cercare il confronto dei significati di essi.
MODALITA’ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE
Le verifiche sono state effettuate periodicamente alla conclusione delle principali unità didattiche e
hanno tenuto conto anche del grado di interesse e partecipazione dimostrati, dell’impegno e
dell’autonomia di lavoro. Verifiche : N°2 scritte e N°2 orali
MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DOCENTE: Dottino Marilisa
Testo adottato: Sport & Co. – Marietti Scuola
Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/2018: N. 52 (al 15/05/2018)
PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI
CONOSCENZE/ CONTENUTI
Conoscere le capacità condizionali e quali sono gli apparati coinvolti
Conoscere le capacità coordinative e l’importanza dell’intervento delle funzioni neuromuscolari
Conoscere la successione delle combinazioni proposte
Conosce le regole dei giochi di squadra proposti e delle discipline di atletica leggera proposte
Riconosce i diritti fondamentali degli altri
Riconosce i diritti e i bisogni altrui
Conoscere i principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza personale in palestra, a casa
e negli spazi aperti
Conoscere gli effetti dannosi dei prodotti farmacologici tesi esclusivamente al risultato
immediato
CAPACITÀ/COMPETENZE
Dimostrare un significativo miglioramento delle proprie capacità condizionali (resistenza, forza,
velocità, mobilità articolare)
Attuare movimenti complessi in forma economica e in situazioni variabili
Esprimersi col corpo in modo fluido ed armonico
Esegue i fondamentali individuali e di squadra dei giochi di squadra proposti
Esegue i gesti tecnici delle specialità di atletica leggera proposte
Sperimenta nello sport diversi ruoli e le relative responsabilità, sia nell’arbitraggio che in compiti
di giuria
Collabora e interagisce in gruppo per la realizzazione di obiettivi comuni
Agisce in modo autonomo e responsabile per far valere i propri diritti e bisogni
Adotta i principi igienici e scientifici essenziali per mantenere il proprio stato di salute e
migliorare l’efficienza fisica
Adotta le norme sanitarie e alimentari indispensabile per il mantenimento del proprio benessere
RISULTATI OTTENUTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PERSEGUITI
La maggioranza delle allieve/i ha lavorato con continuità e, nonostante alcuni disagi logistici relativi
alla carenza di palestra, con spirito collaborativo e senso di responsabilità. I risultati conseguiti in
termini di conoscenze e competenze sono più che buoni, ottimi per alcuni.
In genere, i ragazzi si sono distinti per entusiasmo partecipativo e desiderio di movimento e gioco.
METODOLOGIE DIDATTICHE
- Percorsi individualizzati
- Attività di gruppo
- Lezione frontale per l’approfondimento dei contenuti teorici
STRUMENTI E AMBITI DI LAVORO
Tutte le strutture sportive utilizzate sono situate all’esterno dell’Istituto questo. Questo fatto, oltre a
creare disagio, ha determinato una inevitabile riduzione dell’orario effettivo delle lezioni.
Materiali e strutture utilizzate:
- Palestra, grandi e piccoli attrezzi
- Strutture private in convenzione
- Libro di testo
MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE
Criteri di valutazione:
Miglioramento delle capacità e conoscenze rispetto alla situazione iniziale
Impegno e motivazione alla materia
Rendimento in termini di abilità, adattamento e controllo motorio
Verifiche effettuate attraverso: osservazioni sistematiche, misurazioni e test strutturati su
diversi livelli di difficoltà, questionari scritti a risposta aperta.
PROGRAMMI ANALITICI
MATERIA ITALIANO DOCENTE Stefano Mossino
Programma d’esame letteratura italiana classe 5 EA/ 5UA
Bologna Rocchi : Rosa fresca aulentissima vol.5
Una cultura e una lingua per l’unità d’Italia
Carducci
Alla stazione in una mattina di autunno
Il positivismo in Europa e in Italia
Il romanzo europeo
Flaubert Madame Bovary:
Zola L’assommoir :
Dickens : La avventure di Oliver Twist
Tolstoj . Anna Karenina
La Scapigliatura
E.Praga Preludio
Letteratura postunitaria
Collodi: Le avventure di Pinocchio
De Amicis Cuore
Verga. La lupa, Cavalleria rusticana . I Malavoglia, Mastro don Gesualdo
Il decadentismo in Europa
L’Estetismo : Huisman- à rebours, Wilde- il ritratto di Dorian Gray
La poesia del Decadentismo
Baudelaire : I fiori del Male- L’albatro- Corrispondenze
Rimbaud : Vocali
Decadentismo italiano
D’Annunzio: Romanzi- Il piacere. Le Laudi – La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, Stabat nuda
aestas
Simbolismo
Pascoli : Il fanciullino- Myricae: Lavandare, X Agosto, Il tuono-Canti di Castelvecchio:Nebbia, il
gelsomino notturno- Primi poemetti: Italy- La grande proletaria si è mossa
L’età dell’ansia ( primo’900)
Il romanzo del primo’900 in Europa : Joyce, Kafka
Il ‘900 e le avanguardie : Il futurismo- Marinetti, Manifesto del, Manifesto tecnico
Intellettuali fascisti e antifascisti in Italia
Italo Svevo: Una vita- Senilità- La coscienza di Zeno: il preambolo
Pirandello : I romanzi- Il fu Mattia Pascal, Le novelle- Il treno ha fischiato, Il teatro- Così è, se vi
pare, Sei personaggi in cerca d’autore, I giganti della montagna
Poeti italiani del ‘900
Ungaretti:In memoria-Veglia-I fiumi-San martino del Carso
Saba: A mia moglie-La capra-città vecchia
Montale: I limoni-Non chiederci la parola-Meriggiare pallido e assorto- La casa dei doganieri
Oltre la registrazione del documento del15 maggio sono in programma i seguenti argomenti: Il
fermento culturale del dopoguerra- alcuni autori, presumibilmente Pavese, Calvino,Pasolini.
N.B. gli argomenti di quest’ultima parte possono essere sostituiti dai candidati con altri più
funzionali alla loro tesina
I
MATERIA STORIA DOCENTE Mossino Stefano
Programma d’esame
La modernità in Europa, speranze e inquietudini
L’Italia tra difficoltà politiche e nazionalismo
Giolitti
La prima guerra mondiale, l’intervento dell’Italia
La vittoria dell’intesa e i trattati di pace
Rivoluzione russa e rivoluzione bolscevica
Il difficile dopoguerra
Il fascismo in Italia
Il dopoguerra in Medioriente
Il regime fascista.
La Germania di Weimar e l’avvento del Nazismo
L’URSS degli anni ’20 e l’avvento di Stalin
Continenti extraeuropei negli anni ’20 e ‘30
La seconda guerra mondiale, lo sterminio, la resistenza
Il secondo dopoguerra
La guerra fredda
Il mondo bipolare e i paesi non allineati
Il lungo dopoguerra,tra competizioni e guerre per procura
La decolonizzazione
Il consumismo e la contestazione del’68 in USA
La ricostruzione in Europa e in Italia
Costituente ed elezioni politiche
Il monocolore D.C.
IL Centrosinistra
Il ’68 in Italia e in Europa
Gli anni’70 e il terrorismo
America Latina dittature neofasciste
La caduta del blocco dell’Est
La guerra della ex Jugoslavia
MATERIA Diritto ed Economia Politica DOCENTE Strambio Maria Laura
Il ruolo dello stato nell'economia
- L'economia mista : il sistema economico italiano , l’art.41 della Costituzione , il ruolo guida dello Stato e le privatizzazioni
- Le funzioni economiche dello Stato : il principio di capacità contributiva e progressività delle imposte , l’intervento pubblico e le sue motivazioni
- Le spese pubbliche : le spese correnti ed in conto capitale - Le entrate pubbliche : imposte ( dirette,indirette), tasse e i contributi - Il disavanzo ed il debito pubblico : i titoli di Stato . - La teoria di Keynes in materia di debito pubblico - La politica del deficit spending ed i tagli alla spesa pubblica
Il Bilancio pubblico e la programmazione economica
∙ I caratteri del Bilancio pubblico ∙ La manovra economica : accenni al DEF , Bilancio pluriennale , Bilancio annuale e legge
di stabilità
La solidarietà economico-sociale
- Lo Stato sociale : art.38 della Costituzione, l’art.4 diritto al lavoro,l’art.32 ( tutela della salute), art.34 (diritto all’istruzione) art. 37 ( tutela del lavoro femminile e minorile)
- La previdenza sociale : ruolo dell’Inps e dell’Inail, le prestazioni e i contributi sociali - Il terzo settore
Gli scambi con l'estero
- Libero scambio e protezionismo. Gli strumenti del protezionismo , vantaggi e svantaggi - La politica commerciale italiana nella storia - La Bilancia dei pagamenti
Le nuove dimensioni dei rapporti internazionali
La globalizzazione. Svantaggi e vantaggi
Il ruolo delle multinazionali
I nuovi strumenti finanziari e la speculazione
La necessità di governance globale e l’importanza del capitale umano
La new economy nel mondo globalizzato
I rapporti monetari tra gli Stati
Le operazioni di cambio : definizione di cambio , domanda di valuta e , svalutazione e rivalutazione
Il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale : principali caratteristiche
Il Sistema monetario europeo e le altre politiche comunitarie
Il ruolo della Bce e delle Banche Centrali nazionali: le manovre di politica monetaria
La politica agricola
La politica ambientale
La Politica estera e di sicurezza
L'ordinamento internazionale
Le relazioni internazionali
Le fonti del diritto internazionali
L'Italia e l'ordinamento giuridico internazionale
L'ONU: organi e compiti
La NATO : i principi ispiratori e gli interventi piu’ recenti
Accenni al G8 e il G20, WTO e l'OCSE
L’Unione Europea
La struttura dell’Unione Europea : il Consiglio dei Ministri, il Parlamento Europeo, il Consiglio europeo e la Corte di Giustizia
Le fonti del diritto comunitario
La Carta dei diritti fondamentali della UE
La cittadinanza europea I valori fondanti della Costituzione
Il fondamento democratico
Gli strumenti di democrazia diretta
L'uguaglianza
Il lavoro come diritto e come dovere
La scelta regionalista
L'internazionalismo Le principali libertà civili
La tutela delle libertà personali
La libertà di circolazione e di soggiorno
La libertà di manifestazione del pensiero
Le garanzie giurisdizionali La funzione legislativa: il Parlamento
Democrazia indiretta e corpo elettorale
La composizione del Parlamento e il bicameralismo
L'organizzazione e il funzionamento delle Camere
La posizione giuridica dei parlamentar: il principio di autonomia e le immunità
L'iter legislativo La funzione esecutiva: il Governo
La composizione e la formazione del Governo
La funzione legislativa del Governo : Decreti Legge . Decreti legislativi Gli organi di controllo costituzionale
Il ruolo costituzionale del Presidente della Repubblica
Elezione e durata della carica del Presidente della Repubblica
Il ruolo della Corte costituzionale
MATERIA Scienze umane DOCENTE Germana Pozzo
Sociologia
La globalizzazione cap. 8 pag. 339
il corpo e spazio
le comunità locali e le comunità urbane: caratteristiche e stili di vita
l’ urbanizzazione dalle origini al mondo contemporaneo: metropoli, megalopoli e smart cities
la globalizzazione e le sue forme: politica, economica, dell’informazione, ecologica, culturale
analisi critiche del mondo globale: Bauman e Beck; distribuzione della ricchezza e disuguaglianza; Stiglitz “Il prezzo della disuguaglianza”; gli indicatori di benessere. Il concetto di benessere equo e sostenibile. Antiglobalismo e teorie della decrescita.
La società multiculturale cap. 8 pag. 356
i fenomeni migratori e le differenze culturali
la differenza come valore
i modelli di integrazione. Multiculturalismo e intercultura
Welfare state e terzo settore cap.9 pag.398
origine ed evoluzione dello stato sociale
la crisi del Welfare e le nuove proposte: Welfare attivo e attivazione delle capabilities
le politiche sociali in Italia: previdenza, assistenza sociale, assistenza sanitaria; economia e salute
il terzo settore: origini, attori, ricchezza e limiti
La dimensione politica della società cap. 9 pag.376
norme, leggi, istituzioni : dalle società primitive a quelle moderne
Lo Stato e il potere ( Weber: i tre tipi di potere; Foucault: la pervasività del potere)
La società civile e l’esercizio del potere politico
Le forme di regime politico: aspetti e caratteri della democrazia e del totalitarismo
La democrazia: consenso, controllo, rispetto delle minoranze, rappresentanza, separazione dei poteri; i rischi della democrazia.
La pubblica amministrazione
La comunicazione e i mass media cap. 7 pag. 292
Aspetti generali: condizioni, forme, difficoltà nella comunicazione
La comunicazione mediale: dall’oralità ai new media; caratteri della comunicazione mediale; il digital divide; fake news e postverità.
Gli effetti dei media sulla vita delle persone e sulla struttura della società( Scuola di Francoforte, Eco)
L’industria culturale e la trasformazione della nostra esperienza
Metodologia della ricerca
La nascita delle scienze sociali
modernità, secolarizzazione, razionalizzazione
La questione metodologica e la definizione di paradigma Metodi e tecniche
La ricerca qualitativa e quantitativa: caratteri generali
I passaggi della ricerca: impostazione, raccolta e rilevazione, organizzazione e analisi dei dati, presentazione dei risultati; differenze tra i due tipi di ricerca
L’indagine campionaria
Indagine statistica: censuaria e campionaria
Il campionamento: cos’è, campionamento probabilistico e non probabilistico, definizioni e principali tecniche di campionamento probabilistico e non probabilistico; errore nell’indagine campionaria
Il questionario: definizioni, fasi di costruzione,tipologie di domande e regole per la loro stesura,verifica del questionario. Le modalità di rilevazione
Le scale: cos’è una scala e quali sono i suoi campi di applicazione; la scala di Likert
La costruzione della matrice dei dati e la sua lettura
Interpretazione dei risultati e costruzione del rapporto di ricerca: i diagrammi, l’aerogramma , il cartogramma; il report di ricerca
L’intervista qualitativa
Requisiti, finalità, confronto con il questionario
Intervista libera e biografica, il ruolo dell’intervistatore e l’impostazione di corrette situazioni di intervista: contatto, conduzione e ruolo
Il focus group: storia e tecnica, punti di forza e limiti Lo studio di caso
Le finalità e l’importanza dei concetti sensibilizzanti
Le origini della ricerca etnografica tra antropologia e sociologia
Come si articola la ricerca etnografica; l’osservatore, i mediatori; paradossi e limiti dell’osservazione partecipante
MATERIA Filosofia DOCENTE Germana Pozzo Programma svolto 1. Hegel
Hegel: i capisaldi del sistema: lo Spirito come totalità e processo, l’identità di pensiero ed essere , la funzione giustificatrice della filosofia. La centralità della dialettica e la partizione del sistema. Lo Spirito oggettivo e la concezione dello stato. Lo Spirito assoluto: arte, religione e filosofia. Filosofia e storia della filosofia.
2. Alternative all’hegelismo: - Schopenauer: il fenomeno come “velo di Maya” e la scoperta della via d’accesso alla cosa in sé. L’assoluto come negatività: l’analisi dell’esistenza umana e la sofferenza universale. Le vie di liberazione dal dolore. - Kierkegaard: l’esistenza come possibilità e il rifiuto dell’hegelismo. Gli stadi dell’esistenza. L’angoscia come sentimento del possibile, la disperazione e la fede. - Marx : caratteristiche del marxismo; la critica al “misticismo logico” di Hegel e la critica della civiltà moderna, del liberalismo e dell’economia borghese; il concetto di alienazione. La concezione materialistica della storia: dall’ideologia alla scienza, struttura e sovrastruttura, la contraddizione dialettica tra forze produttive e rapporti di produzione come legge della storia. Dal “Manifesto del partito comunista”: il concetto della storia come lotta di classe, la
funzione storica della borghesia, la critica al socialismo. “Il Capitale”: merce, lavoro e plus-valore; la rivoluzione e le tappe di affermazione del comunismo.
- Feuerbach : il rovesciamento dei rapporti di predicazione; la critica alla religione; la
filosofia dell’avvenire: umanismo e filantropismo.
3. Il Positivismo:
- Caratteri generali ; rapporti con l’Illuminismo, il Romanticismo e il Neopositivismo.
- Il positivismo sociale di Comte: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; la sociologia
4. La crisi del razionalismo ottocentesco e del paradigma positivistico:
- Nietzsche: “La nascita della tragedia” dionisiaco e apollineo come categorie interpretative della grecità, la critica a Socrate e Platone. Nietzsche e Schopenhauer. Il periodo illuministico e la decostruzione della metafisica; l’annuncio della morte di Dio. “Così parlò Zarathustra”: i concetti di superuomo, eterno ritorno e volontà di potenza; il problema del nichilismo e il suo superamento.
- Freud: la scoperta dell’inconscio; la psiche come unità complessa e la frantumazione del soggetto razionale; l’interpretazione dei sogni e la teoria della sessualità.
- Bergson: i caratteri dello Spiritualismo; concetti di tempo, durata, libertà; lo slancio vitale.
5. La filosofia del Novecento
- L’esistenzialismo: matrici storico-culturali e caratteri generali
- Heidegger: essere ed esistenza; l’essere nel mondo e la visione ambientale preveggente; l’esistenza inautentica: le modalità dell’esistenza anonima; l’esistenza autentica: essere per la morte e voce della coscienza; il tempo.
- Sartre: esistenza e libertà
- Il Neopositivismo: caratteri generali; il principio di verificazione
- Popper contro il Circolo di Vienna: la falsificabilità come criterio di demarcazione e l’impossibilità dell’induzione; scienza e metafisica.
MATERIA: Storia dell’Arte DOCENTE: Emilia Grassi
Argomenti svolti
Il Neoclassicismo
A.Canova: Teseo e il Minotauro. Amore e Psiche. Le Grazie. Monumento a Maria Cristina d’Austria. Paolina Borghese. J. L. David: Il giuramento degli Orazi. A Marat. F. Goya: Il sonno della ragione genera mostri. Il Colosso. Saturno che divora un figlio. Le fucilazioni del 3 maggio. Maya vestida. Maya desnuda. Il Romanticismo
Sublime e pittoresco
C. David. Friedrich: Il naufragio della Speranza. Viandante sul mare di nebbia.
J. Heinrich Fussli: Incubo notturno
William Blake : Paolo e Francesca
Joseph Turner : Vapore durante una tempesta di mare. Ombra e tenebre. La sera del diluvio.
John Constable : Nuvole
Theodore Gericault: La zattera della Medusa. I Pazzi
Eugene Delacroix : La Libertà che guida il popolo.
Il Realismo
Gustave Courbet: Le bagnanti. Le signorine sulla riva della Senna. Gli spaccapietre. L’Atelier.
J. Francois Millet: L’Angelus.
Honorè Daumier: A Napoli. Scompartimento di terza classe.
Impressionismo
Edouard Manet: Colazione sull’erba. Olimpia. Il bar alle Folies-Bergère.
Claude Monet: La Grenouillère. Regata ad Argenteuil. Impressione: il tramonto e il levar del sole.
La Cattedrale di Rouen. Lo stagno delle ninfee.
Pierre Auguste Renoir: Bal au Moulin de la Galette. La colazione dei canottieri.
Edgar Degas: La lezione di danza. L’Assenzio. Quattro ballerine in blu.
Paul Cezanne: La casa dell’impiccato. Donna con caffettiera. I giocatori di carte. I bagnanti. La
montagna di San Victoire.
Postimpressionismo
Georges Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della grande Jatte.
Paul Signac
Paul Gauguin: Il Cristo giallo. Come! Sei gelosa? Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate. Autoritratto. La camera da letto. La sedia di Vincent. La
sedia di Gauguin. La Chiesa di Auvers. Campo di grano con volo di corvi.
Toulouse Lautrec: Al Moulin Rouge. Ballo al Moulin Rouge. Au salon de la rue des Moulins. Le
affiche.
Il simbolismo
I macchiaioli e la pittura in italia nella seconda metà dell’ottocento
Giovanni Fattori: La battaglia di Magenta
Francesco Hayez: La Meditazione.
Gerolamo Induno: La battaglia della Cernaja. La battaglia di Magenta. Un triste presentimento.
Odoardo Borrani: Il 26 Aprile 1859. Le cucitrici di camicie rosse.
Andrea Appiani: Venezia che spera.
Michele Cammarano: Carica dei bersaglieri.
Divisionismo
Giovanni Segantini: Alla stanga. La mucca all’abbeveratoio. Le due madri.
Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato.
Architettura della seconda metà dell’ottocento
Joseph Paxton: Il Palazzo di cristallo.
Alexandre Gustave Eiffel: La Torre.
Alessandro Antonelli: La Mole Antonelliana.
Giuseppe Mengoni: Galleria Vittorio Emanuele II.
Il Novecento: Art Nouveau
Gustav Klimt: Giuditta 1°. Giuditta 2°. Danae. Il Bacio.
Antoni Gaudì: Casa Milà. La Sagrada Familia.
I Fauves
Henri Matisse: Ritratto con la riga verde. Donna con cappello. La gitana. La danza.
Georges Rouault: Allo specchio.
Espressionismo
Eduard Munch: La fanciulla malata. Sera nel corso di Karl Johann. Il Grido. Pubertà. Il bacio. La
danza della vita.
Ernst Ludwig Kirchner: Marcella. Donna allo specchio. Due donne per strada.
E. Heckel: Giornata limpida.
Oskar kokoschka: La sposa del vento.
Egon Schiele: Abbraccio.
Emil Nolde: Papaveri e iris.
Il Cubismo
Pablo Picasso: Poveri in riva al mare. La vita. Autoritratto. Les demoiselles d’Avignon. Fabbrica a
Horta de Ebro. Ritratto di Ambroise Vollard. Natura morta con sedia impagliata. Guernica.
Futurismo
Umberto Boccioni: Beata solitudo. La città che sale. Gli adii. Il lutto. Sviluppo di bottiglia nello
spazio. Materia. Forme uniche della continuità nello spazio.
Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio. Volo di rondini. Le mani del violinista.
Compenetrazioni iridescenti. Plasticità di luci più velocità. Lampada ad arco.
Surrealismo
J. Mirò: Il carnevale di Arlecchino.
S. Dalì: La persistenza della memoria. La giraffa in fiamme. Apparizione di un volto e di una
fruttiera sulla spiaggia. Sogno causato dal volo di un’ape intorno a una melagrana.
Max Ernst: La vestizione della sposa.
Renè Magritte: Condizione umana. Ceci n’est pas une pipe. Golconda.
Contenuti disciplinari programmati dopo il 15 Maggio
Astrattismo
Wassili Kandinski: Primo acquerello astratto 1910. La montagna azzurra. Alcuni cerchi. Composizioni. Improvvisazioni. La freccia. Franz Marc: I grandi cavalli azzurri. Paul Klee: Teatro delle marionette. Vie principali e vie secondarie. Flora sulla roccia. Il prigioniero. Bauhaus Walter Gropius: il Bauhaus a Dessau. (Sassonia) Mies Van der Rohe: Villa Tugendhat. Seagram Building. (New York).
MATERIA: INGLESE DOCENTE: Roberta CANNELLI TESTO: M. Spiazzi. M. Tavella. M. Layton COMPACT PERFORMER CULTURE & LITERATURE LINGUE ZANICHELLI THE VICTORIAN AGE
The first half of Queen Victoria’s reign. Pag. 148/9 Life in the Victorian town. Pag. 150 The Victorian compromise. Pag. 154 The Victorian novel. Pag. 155 CHARLES DICKENS Cenni sugli eventi più significativi della vita ed elenco delle principali opere. Charles Dickens and the children. Pag. 156 “Oliver Twist”. Pag. 157 “Oliver wants some more” Pag. 158 ROBERT LOUIS STEVENSON: VICTORIAN HYPOCRISY AND THE DOUBLE IN LITERATURE Pag. 178 “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” Pag. 178 “The Story of The Door” Pagg. 179-180-181 NEW AESTHETIC THEORIES The Pre-Raphaelite Brotherhood. Pag. 182 Aestheticism. Pag. 184 OSCAR WILDE Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete. Pag. 185 The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty. Pag. 186 “Dorian’s Death”. Pag. 187- 190 THE EDWARDIAN AGE Pag. 224-22 THE WAR POETS Different attitudes to war. Pag. 234 RUPERT BROOKE Pag. 235 The Soldier Pag. 235 WILFRED OWEN Pag. 234 Dulce et Decorum Est Pag. 236/7 THE MODERN NOVEL Pag. 250 Freud and the psyche. Pag. 249 JAMES JOYCE Pag. 264
“The Funeral” Pag. 251 DUBLINERS Pag. 265 “Eveline” Pag. 266-269 THE DYSTOPIAN NOVEL Pag. 303 GEORGE ORWELL George Orwell and political dystopia. Pag. 304 Nineteen Eighty-Four. Pag. 305 “Big Brother is watching you”. Pag. 306/7 “Room 101” (fotocopia) WILLIAM GOLDING (fotocopia) LORD OF THE FLIES (fotocopia) “The End of the Play” (fotocopia) THE THEATRE OF THE ABSURD Pag. 310 SAMUEL BECKETT WAITING FOR GODOT Pag. 311 “Nothing to be done” Pag. 312-313 THE CULTURAL REVOLUTION Pag. 321 Youth culture and street style in Britain Pag. 322 Carnaby Street Pag. 322 PHILIP LARKIN Pag. 323 “ANNUS MIRABILIS” Pag. 32 ARTICOLI DI CULTURA E CIVILTA’: BEFORE THE FLOOD (su fotocopia). Lo studio della vita degli autori si è limitato solo agli avvenimenti più importanti e strettamente collegati, da un punto di vista tematico, ai passaggi delle opere lette in classe. Le notizie di carattere storico hanno come finalita’ l’inquadramento degli autori e delle opere studiate. L’analisi dei testi segue la traccia fornita dal libro di testo.
MATERIA : Lingua Francese DOCENTE: Margherita Monticone
Testo adottato: Francesca Ponzi “Carnet Culture”, ed. LANG
Programma integrato con fotocopie
La mondialisation (photocopies)
Définition. Le rôle des multinationales. La mobilité des flux. Acteurs de la mondialisation
(Qui encourage ? Qui régule ? Qui dénonce ?). Rôle de l’OMC et de l’ONU.
Conséquences de la mondialisation sur l’environnement.
Activités de groupe. Chaque groupe a développé un sujet lié au thème de la mondialisation.
Recherche de matériel sur internet et exposés.
Environnement et énergie (Carnet Culture, unité 2 pag. 50)
Les étapes de la réglementation. La politique de l’atmosphère (pag.51). La politique des déchets
(pag 51). La biodiversité (pag. 52). La terre malade de l’homme (pag.53). Des quartiers durables
pour vivre mieux (pag.57)
Travail individuel de recherche. Chaque élève a développé un sujet lié au thème de
l’environnement. Recherche de matériel sur internet et exposé.
L’Union Européenne (dossier 8 unité 1 pag. 154)
Sa mission et les étapes principales de son histoire (CECA : Traité de Paris 1951, CEE : Traité de
Rome 1957. Années 1980. Maastricht. 2002 l’euro. Les principales innovations du Traité de
Lisbonne).
Comment fonctionne l’Union ? (dossier 8 unité 2 pag. 158)
Que fait l’Union. Le marché intérieur (coopération Schengen) pag.159
Les ambitions européennes d’Emmanuel Macron d’ici à 2024 (photocopie : article internet)
Welfare : état social ou état - providence (photocopie : vidéo internet)
Politiques publiques qui favorisent davantage les plus âgés (photocopie : vidéo internet)
Accès de peur (photocopie : article sur les banlieues).
Interview à Yann Bertrand (photocopie : article sur Arthus-Bertrand)
La femme
La femme dans l’histoire (jusqu’à la révolution française). Recherche individuelle
Le travail des femmes en France de 1914 à 2000 (photocopie : vidéo internet)
Mouvement de libération de la femme (MLF) (photocopie : vidéo internet)
Travail individuel de recherche. Chaque élève a approfondi l’étude d’un sujet sur le thème de la
femme. Recherche de matériel sur internet et exposé.
Littérature.
I seguenti argomenti non sono mai stati inseriti nelle prove scritte. Sono stati solo soggetto
di interrogazione orale.
Le réalisme (photocopie).
Gustave Flaubert: Madame Bovary (Carnet Culture pag. 150)
Le naturalisme (photocopie).
Emile Zola : L’Assommoir. L’idéal de Gervaise (photocopie)
Existentialisme et humanisme (photocopie)
L’existentialisme au féminin : Simone de Beauvoir. Le deuxième sexe. On ne nait pas femme on le
devient (photocopie)
MATERIA: MATEMATICA DOCENTE: Rosella Sciutti
PROGRAMMA SVOLTO MODULO 1: funzioni Definizione di funzione reale di variabile reale e classificazione. Dominio di funzioni razionali e
irrazionali, intere e fratte. Segno ed eventuali intersezioni con gli assi cartesiani (funzioni razionali
intere e fratte). Grafici di alcune funzioni elementari: funzione costante, funzione lineare, funzione
quadratica, funzione cubica e funzione di proporzionalità inversa.
Funzioni crescenti e funzioni decrescenti. Funzioni pari e funzioni dispari. Funzione inversa.
Grafico probabile e lettura di grafici.
MODULO 2: limiti Intervalli e intorni. Introduzione al concetto di limite: approccio numerico e approccio grafico. Definizioni generali di limite: limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito; limite finito di una funzione per x che tende all'infinito; limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito; limite infinito di una funzione per x che tende all'infinito. Teorema di unicità del limite e teorema del confronto (enunciati). Le funzioni continue e l’algebra dei limiti. Algebra dei limiti, nel caso di limiti finiti e aritmetizzazione del simbolo di infinito. Calcolo di limiti che non presentano forme di indecisione.
Calcolo di limiti di funzioni razionali intere e fratte che presentano forme di indecisione:
e
0
0 ; - .
MODULO 3: continuità Funzione continua in un punto e in un intervallo.
Comportamento delle funzioni continue rispetto alle operazioni tra funzioni.
Punti di discontinuità e loro classificazione.
Teorema degli zeri, teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi (enunciati).
MODULO 4: asintoti e grafico probabile
Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui di funzioni razionali fratte.
Grafico probabile di funzioni razionali intere e fratte: determinarne il dominio, riconoscere eventuali
simmetrie particolari, determinarne gli eventuali punti intersezione del suo grafico con gli assi
studiarne il segno e calcolare i limiti agli estremi del dominio.
MODULO 5: derivabilità Definizioni di rapporto incrementale e derivata di una funzione in un punto e loro significato geometrico. Derivabilità e continuità.
Derivate di alcuni funzioni elementari: ky (con dim.); xy (con dim.); nxy ; y = n x .
Algebra delle derivate: derivata della somma algebrica di funzioni; derivata del prodotto di due funzioni; derivata del quoziente di due funzioni; derivata della funzione composta (semplici casi). Classificazione e studio dei punti di non derivabilità. Applicazioni del concetto di derivata: retta tangente ad una curva.
Punti di massimo e minimo relativo e assoluto: definizioni.
Definizione di punto stazionario.
Teorema di Fermat, teorema di Rolle, teorema di Lagrange (enunciati).
Criterio di monotonia per le funzioni derivabili. Criterio per l’analisi dei punti stazionari.
Concavità e convessità di una funzione, punto di flesso: definizioni.
Criterio di concavità e convessità per le funzioni derivabili due volte.
Condizione necessaria per l’esistenza di un punto di flesso.
Teorema di De L'Hôpital e sua applicazione alle forme di indecisione
e
0
0 .
MODULO 6: studio di funzioni e lettura di grafici
Schema per lo studio del grafico di una funzione razionale intera e fratta (fino allo studio della
derivata prima).
Lettura del grafico di una funzione.
MATERIA : FISICA DOCENTE: Rosella Sciutti
PROGRAMMA SVOLTO
MODULO 1: carica elettrica e legge di Coulomb
Elettrizzazione per strofinio. Corpi neutri e corpi carichi elettricamente. Conduttori e isolanti.
Elettrizzazione per contatto. L’elettroscopio. La legge di Coulomb. La forza elettrica e la forza
gravitazionale a confronto: analogie e differenze. Elettrizzazione per induzione.
MODULO 2: campo elettrico e potenziale elettrico
Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee del campo elettrico (il
campo di una carica puntiforme). Le proprietà delle linee di campo elettrico. Il flusso del campo
elettrico e il Teorema di Gauss. Energia potenziale gravitazionale e energia potenziale elettrica.
Energia potenziale di due cariche puntiformi. Il potenziale elettrico e la sua unità di misura. La
differenza di potenziale e il moto spontaneo delle cariche elettriche . Il potenziale di una carica
puntiforme. La circuitazione del campo elettrostatico.
Il condensatore piano. Campo elettrico e capacità di un condensatore piano.
MODULO 3: corrente elettrica continua
Intensità e verso convenzionale della corrente. La corrente continua. L’unità di misura della
corrente.
I generatori di tensione e i circuiti elettrici.
La prima legge di Ohm.
I resistori. I resistori in serie e in parallelo.
La seconda legge di Ohm. Resistività e temperatura.
Inserimento degli strumenti di misura in un circuito: amperometro e voltmetro.
La forza elettromotrice.
Potenza elettrica. Effetto Joule.
MODULO 4: fenomeni magnetici fondamentali e campo magnetico
La forza magnetica. Il campo magnetico terrestre. Le linee di campo magnetico e proprietà.
Campo elettrico e campo magnetico a confronto: analogie e differenze. Rappresentazione delle
linee di campo magnetico generato da calamite rettilinee.
L’esperienza di Oersted. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente. Le esperienze di
Faraday e Ampère. Definizione di ampere e definizione di coulomb.
Intensità del campo magnetico e sua unità di misura (filo percorso da corrente in un campo
magnetico uniforme). La forza magnetica su un filo percorso da corrente.
Forza di Lorentz e moto di una carica puntiforme in un campo magnetico.
Legge di Biot-Savart. Il campo magnetico generato da un solenoide percorso da corrente.
Circuitazione e flusso del campo magnetico.
Il motore elettrico a corrente continua.
Proprietà magnetiche dei materiali. L’elettromagnete.
MODULO 5: induzione elettromagnetica
La corrente indotta.La legge di Faraday - Neumann – Lenz . L’alternatore . Le centrali elettriche. Fonti rinnovabili di energia elettrica. Il trasporto dell’energia elettrica. Il Trasformatore. Il consumo di energia elettrica . Il campo elettrico e il campo magnetico indotto, le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche e le loro proprietà Lo spettro elettromagnetico.
MATERIA : SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE INSEGNANTE: Marilisa Dottino
ALLENAMENTO/DISCIPLINE SPORTIVE - Condizionamento fisico per il miglioramento delle qualità fisiche. - Esperienze varie per il miglioramento delle capacità motorie e coordinative. - Esperienze specifiche in palestra privata per allenamento di capacità condizionali. TEORIA: ∙ Principi teorici dell'allenamento ∙ Conoscere ed allenare le capacità motorie di forza, velocità, resistenza. GIOCO - I giochi sportivi di squadra. - Tecnica dei fondamentali individuali e di squadra.
DISCIPLINE SPORTIVE Il programma è stato orientato al raggiungimento di 2 obiettivi primari: - l’acquisizione di una cultura delle attività di moto e sportive, tendendo a promuovere la
pratica motoria come costume di vita e la coerente coscienza e conoscenza dei diversi significati che lo sport assume nell'attuale società;
- la scoperta e l'orientamento delle attitudini personali nei confronti di attività sportive specifiche e di attività motorie che possano tradursi in capacità trasferibili al campo lavorativo e del tempo libero.
Pertanto, le proposte presentate nel corrente anno sono state:
Atletica: corse veloci (frequenza, ritmo e accelerazione), corse di resistenza (distanze diverse e gestione risorse), Salti (rincorsa e stacco nelle diverse tipologie), lanci (forza esplosiva e tecnica esecutiva).
Giochi sportivi di squadra: basket, pallavolo, tennistavolo, tamburello.
ALLEGATO 2
Simulazione terza prova
SIMULAZIONE TERZA PROVA DI MATEMATICA
QUESITO 1
Osserva il grafico e rispondi
Dominio : ____________________________________________________________________
Codominio: ___________________________________________________________________
Eventuali simmetrie particolari: ___________________________________________________
Eventuali zeri della funzione:______________________________________________________
Eventuali intersezioni asse y: ______________________________________________________
Segno: _________________________________________________________________________
Monotonia: ______________________________________________________________________
3/2
1/2
-1/2
1/4
La funzione è invertibile?____________________________________________________________
Continuità ed eventuale tipologia dei punti di discontinuità: ________________________________
_________________________________________________________________________________
_
Equazioni asintoti:
___________________________________________________________________
)(lim xfx
)(lim xfx
)(lim1
xfx
)(lim1
xfx
)(lim1
xfx
)(lim1
xfx
)(lim2
xfx
)(lim2
xfx
QUESITO 2
Fornisci la definizione di funzione continua in un punto.
Determina e classifica i punti di discontinuità della funzione: xx
xy
3
22
.
TEST A SCELTA MULTIPLA MOTIVA LE RISPOSTE con calcoli, ragionamenti, conoscenze teoriche ecc.
1. La funzione 3
2 1
xy
x
:
A. ha due asintoti verticali di equazione 1x e 1x e un asintoto orizzontale di equazione 0y .
B. ha due asintoti verticali di equazione 1x e 1x e un asintoto obliquo di equazione y x .
C. non ha asintoti verticali mentre ha un asintoto orizzontale di equazione 1y .
D. non ha asintoti verticali mentre ha un asintoto obliquo di equazione y x .
2. Soltanto una delle seguenti funzioni corrisponde ai seguenti requisiti: a) ha dominio coincidente con tutto R; b) è una funzione dispari; c) ha come asintoto orizzontale l’asse x. Quale?
A.2 1
xy
x
B.
2 1
xy
x
C.
2
2 1
xy
x
D.
2
3 1
xy
x
3. La funzione2
32 22
x
xxy
ha come asintoto obliquo la retta:
A. xy 2 B. xy 22 C. 12 xy D. xy 21 E. Nessuna delle precedenti
4. Il valore del3
3lim
3
x
x
x è:
A. 6 B. 1 C. D.
4. La funzione 2
3)(
2
2
x
xxxf è positiva per:
A. 30 x B. 30 xx C. 30 xx D. 320 xx
Quesito n°1 Quesito n°2
Quesiti a scelta multipla
VOTO
______/ 15
1 2 3 4 5
punti 3/15 3/15 3/15 3/15 3/15
________/15* ________/15*
________/15
SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA D’ESAME
FILOSOFIA
Alunno …………………………………………………… Classe V EA 9 gennaio2018
1. Logica e storia, per Hegel: Sono legate da un rapporto di priorità cronologica: le categorie della logica precedono quelle della storia
Sono del tutto indipendenti e autonome: in ciascun ambito, infatti, si applicano categorie specifiche
Si differenziano perché la logica procede attraverso un movimento ciclico e la storia si basa su una progressione lineare
Applicano le stesse categorie, ma solo nella storia sono calate in una dimensione temporale
2. Quale delle seguenti affermazioni di Hegel spiega meglio la tesi della filosofia come “nottola di Minerva”?
“Comprendere ciò che è, è il compito della filosofia, poiché ciò che è, è la ragione”
“Quel che importa allora è conoscere, nella parvenza di ciò che è temporale e transeunte, la sostanza che è immanente e l’eterno che è presente”
“Ciascuno è figlio del suo tempo, così anche la filosofia è il proprio tempo appreso in pensieri. E’ insensato figurarsi che una qualsiasi filosofia vada al di là del suo tempo presente”
“ In quanto pensiero del mondo la filosofia appare soltanto dopo che la realtà ha compiuto il suo processo di formazione e s’è bell’e assestata”
3. Tra Schopenhauer e Kierkegaard:
Solo il primo ritiene possibile per l’uomo la libera scelta Il primo, ponendo alla base di tutto la volontà di vivere, è fondamentalmente ottimista, mentre la filosofia del secondo è dominata dal pessimismo
C’è accordo circa l’inevitabilità del dolore nella vita umana Kierkegaard considera l’esistenza umana chiusa in un circolo di angoscia impossibile da spezzare, mentre per Schopenhauer ciò è possibile grazie allo squarcio del velo di Maya
4. A proposito di Feuerbach si parla di umanesimo perché Riscoprì il valore della filosofia della prima età moderna Indicò nella centralità del soggetto il principio fondamentale della filosofia Propose concreti interventi sociali ed economici a favore delle classipiù povere Indicò nella riappropriazione di se stesso da parte dell’uomo il fine della filosofia
5. La dittatura del proletariato era considerata da Marx: L’esito finale della rivoluzione comunista Una fase necessaria dopo la quale lo stato sarebbe fortemente ridimensionato
Una transizione rigida, ma non violenta Una fase di democrazia diretta, alla quale avrebbero avuto accesso tutti e solo i proletari
Rispondi usando il numero di righe indicato
1. Spiega cosa intenda Marx per concezione materialistica della storia ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Esamina il concetto di esistenza come possibilità in Kierkegaard e spiega
quali conseguenze determina
………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Name …………………………………………… Class……………………… Date …………..
Simulazione di terza prova scritta
English
1. Summarizse Wilde’s opinion about art and morality, making reference to the
passage “Dorian’s death”.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
2. Describe war as depicted in “Dulce et decorum est”.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Choose the right answer
1.THE GREAT EXIBITION OF 1851:
A. Only displayed goods from Britain
B. Provided the funds to build three museums in London
C. Was organized by common people
D. Attracted few people
2.VICTORIAN NOVELIST
A. Felt they had a moral and social responsability
B. Described reality as they imagined it
C. Were mainly women
D. Did not find it easy to have a contact with their public.
3. IN THE WORKHOUSES:
A. Not all residents were required to work
B. The poor were inspired to improve their conditions
C. The suffering of the poor were alleviated
D. Families were almost always separated
4. IN “THE STRANGE CASE OF DOCTOR JAKYLL AND MR HIDE” STEVENSON
IMPLIES THAT:
A. Evil always triumphs
B. Good always wins over evil
C. Man has to annihilate part of his nature to live in civilised society
D. Man can live a life of respectability and depravity at the same time.
5. IN WILDE’S “THE PICTURES OF DORIAN GRAY” THE PICTURE:
A. Is always beautiful
B. Kills the protagonist
C. Is exhibited by Basil Hallward
D. Records the signs of time and corruption
Istituto Monti Asti Data…………Nome ………………………. Simulazione di terza prova Storia Segna la risposta corretta
1) I patti lateranensi stabiliti tra il governo Mussolini e la Santa Sede erano un trattato:
a) Che ripristinava il Concordato napoleonico
b) Che riconosceva i diritti di culto della religione ebraica e valdese
c) Con cui lo stato riconosceva la sovranità del papa su città del Vaticano e dichiarava la
religione cattolica religione di stato e la chiesa riconosceva il regno d’Italia con Roma
capitale
d) Con cui stato e chiesa si dichiaravano indipendenti l’uno dall’altra
2) La riforma del codice penale e del codice di procedura penale del ministro Rocco era
rivolto a:
a) Adeguare i codici a una realtà più moderna rispetto a quella ottocentesca
b) Rafforzare il ruolo della difesa nello svolgimento dei processi
c) Colpire le libertà civili e politiche dei cittadini e rafforzare la pubblica accusa nello
svolgimento dei processi
d) Controllare e reprimere l’attività sindacale
3) Prima guerra mondiale: i rapporti tra stato ed economia si modificarono nel corso
della guerra nel senso che:
a) Lo stato intervenne nel controllo dell’economia regolando il mercato del lavoro, il
credito, i prezzi, il commercio, i trasporti e gli indirizzi produttivi di molti apparati
industriali
b) Lo stato, completamente assorbito dagli eventi del fronte, trascurò l’economia
lasciandola completamente in mano all’iniziativa privata
c) Lo stato provvide alla nazionalizzazione di tutte le industrie, arrivando ad una
temporanea cancellazione della proprietà privata
d) Lo stato intervenne esclusivamente a regolamentare il mercato del lavoro
4) L’autarchia è:
a) Difesa della sovranità di uno stato indipendente
b) Autonomia legislativa
c) Completa autosufficienza economica
d) Dipendenza economica
5) La notte dei lunghi coltelli fu:
1) Un episodio di azioni violente contro sinagoghe ed abitazioni di ebrei
2) Un episodio di lotta armata tra nazisti e comunisti
3) Un episodio di azioni violente organizzate dalle SS contro gli oppositori del regime
nazista
4) Il massacro delle SA di Rohm da parte delle SS
II) Motivi di debolezza e instabilità dei governi liberali in Italia nel dopoguerra. In particolare le
vicende legate alla questione sociale e il Biennio rosso
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
a………..b……….c
III) Elementi di contatto tra il regime fascista e il regime nazista ( eventuali differenze)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
a………..b……….c
a completezza dell’informazione 0>2
b capacità di sintesi 0>2
c uso del linguaggio 0>2
Seconda simulazione di terza prova
Prova di lingua francese
Nom…………………………………..Prénom………………………………classe……………
…………………date……………
Répondez aux questions (de 5 à 7 lignes)
1. Quelles sont les conséquences de la mondialisation sur l’environnement ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Le rôle de la femme dans le monde du travail de 1914 jusqu’aux années 80
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Pourquoi est-ce qu’on peut dire que les politiques publiques favorisent davantage les plus âgés ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Name …………………………………………… Class……………………… Date …………..
Simulazione di terza prova scritta
English test
1. In “Dubliners”, James Joyce tells stories which have some characteristics in common.
Explain in 8-10 lines.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………
2. In “Nineteen eighty-four” Orwell describes a dystopian society. Point out the
differences between the concepts of “dystopia” and “utopia”, making reference to
the novel.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
3. “Lord of the flies” represents a microcosm ruled by a group of boys. Explain how the
situation evolves from the beginning to the end of the novel, pointing out the role of
the protagonists.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………
Liceo Economico Sociale Istituto “A.Monti “ di Asti
Simulazione Terza Prova Classe VEA 04 maggio 2018
Diritto ed Economia
1) Cosa si intende per sistema previdenziale ? Qual e’ il ruolo dell’Inps : come si finanzia ed in base a quali
parametri , quali prestazioni ed indennità eroga ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2) Quali sono gli svantaggi della presenza di una Multinazionale nei Paesi poveri e qual è la ragione
fondamentale che li permette ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3) Quali sono gli strumenti di democrazia diretta nel nostro ordinamento giuridico ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
SIMULAZIONE III PROVA - ESAME DI STATO V EA 4-05-2018
MATEMATICA
QUESITO 1
Osserva il grafico e rispondi:
Dominio:
Immagine:
Intervalli di positività:
Eventuali zeri della funzione:
Eventuali punti di discontinuità:
Eventuali asintoti:
Eventuali punti di non derivabilità :
Eventuali punti di massimo o minimo relativi o assoluti:
QUESITO 2
Fornisci la definizione di limite finito l di una funzione y = f(x) in un punto x0.
Calcola i seguenti limiti : a.
34
1lim
21 xx
x
x ; b.
)23(lim 48 xxx
;
c.
128
2lim
3
35
xx
xxx
x ; d.
62
7lim
3 xx.
QUESITO 3
Spiega il concetto di punto stazionario di una funzione e determina gli eventuali punti stazionari della
funzione xxxf 62)( 3 , precisandone la natura.