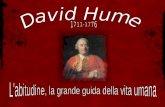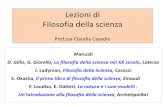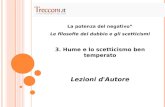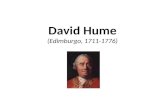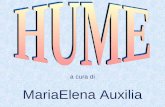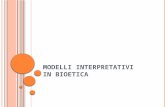5. hume 5
Transcript of 5. hume 5
- 1.
- David Hume
- A cura di Stefano Ulliana
2.
- Panoramica
- 1. Vita e opere.
3. 2. La scienza della natura umana. 4. 3. Il percorso della conoscenza. 5. 4. Morale e societ. 6. 5. Religione e natura umana. 7. 6. Le dottrine estetiche. 8. 7. La politica.
- David Hume
9.
- 1. Vita e opere.
- David Hume(1711 1776 d.C.)si dedica agli studi filosofici e letterari, dopo un'iniziale interesse per quelli giuridici. In Francia compone ilTrattato sulla natura umana(1739). Comincia ad interessarsi di politica e scrive iSaggi morali e politici(1742). Assume poi incarichi politici, diventando segretario del generale St. Clair. Come bibliotecario di Edimburgo ha modo di redigere unaStoria dell'Inghilterra(1752) e di rivedere ilTrattato , pubblicando laRicerca sui principi della morale(1752). Si interessa di religione e scrive iDialoghi sulla religione naturalee laStoria naturale della religione(1757). Diventa segretario del conte di Hartford, ambasciatore inglese a Parigi. Rientrato a Londra ha modo di conoscere e di frequentare Jean-Jacques Rousseau.
10.
- 2. La scienza della natura umana.
- L'oggetto principale della ricerca filosofica humiana la natura umana. Del soggetto umano il filosofo scozzese intese elaborare una visione complessiva ed organica, capace di rendere ragione di tutti i suoi fenomeni psicologici e sociali e di tutte le proprie caratterizzazioni operative. L'uomo per Hume il baricentro di ogni possibile determinazione conoscitiva e pratica (la capitale del regno del sapere). Da qui si dirama infatti la possibile conquista di un sapere certo e determinato, sistematico. Per attingere al nucleo elementare di questo soggetto Hume intende utilizzare un metodo sperimentale, che rigetti ed annulli ogni pretesa e presupposta ipotesi metafisica, che imponga un'immagine predeterminata, un'origine ed uno scopo artefatti e non naturali e/o razionali.
11.
- 3. Il percorso della conoscenza.
- La forza e l'estensione dell'intelletto umano stanno nella capacit dicomprensionedella mente umana. Essa pu attuare questa propria capacit (immaginazione naturale e razionale) attraverso due possibili strumenti, fra di loro coordinati. Prima leimpressionilegate alla sensibilit (sensazioni, sentimenti, passioni ed emozioni, desideri, volont) penetrano nella coscienza, affettano e si diffondono nello spirito con forza e determinazione (vivacit), poi l'immaginazione razionale dell'uomo ne riduce e sintetizza la determinazione (vivacit) rastremandone la forza nella potenza delleidee e dei pensieri . Questo trasferimento d origine alla memoria ed alla rappresentazione. In questo modo Hume pu facilmente sostenere che ogni idea deriva dalla corrispondente impressione e che non esistono idee o pensieri di cui non si sia avuta in precedenza l'impressione.
12.
- La potenza del soggetto umano risiede allora nella capacit di combinare e mettere in relazione queste idee, anche nel modo pi arbitrario possibile, ma tutto questo in ultima analisi dipender sempre dallarelazione fondamentaleche il soggetto umano stesso intrattiene con l'ambiente ed il mondo esterno. In tale relazione diventer allora importante distinguere fra l'aspetto formale e quello del contenuto. Ma la forma non viene considerata prioritaria e separata rispetto al suo contenuto: Hume infatti non accetta l'idea astratta, fa suo il rigetto della negazione positiva operato da Berkeley. L' idearimanesegno collettivocontinuamente variabile per esperienza. Non per tanto la possibilit della variazione che ha in mente Hume, quanto piuttosto vedere quale comportamento umano ingeneri nel soggetto stesso una non-variazione degli atteggiamenti mentali, prima teorici e poi pratici. Tutto questo per accostare alla regolarit, alla costanza ed alla necessit naturale un'equivalente struttura e logica umana.
13.
- L'accostamento per somiglianza fra oggetto e soggetto definisce e determina quell'atteggiamento costante e stabile che viene soprannominatoabitudine . Essa risulta essere determinata come quell'atteggiamento psicologico che trasferisce e trasporta la somiglianza e la convergenza dei fatti naturali verso una medesima denominazione nella identificazione che avviene tramite la collezione organica delle idee. Cos la fonte immaginativa ed identificatrice apre alla possibilit del raffronto fra le idee desunte dall'esperienza ed alla posa in opera della loro relazione. Una relazione che sembra avere una logica interna (o pi differenti logiche interne). Questa logica (o logiche) viene animata dalprincipio dell'associazione delle idee , una forza che connette le medesime e la fa scorrere le une nelle altre.
14.
- Questo principio si articola attraverso l'applicazione di uncriterio generale di vicinanzafra gli elementi che entrano in relazione per essere richiamati e sostituiti nella visione immaginativa. Questa vicinanza pu essere di tipo qualitativo ( somiglianza ), ordinativo ( contiguit spazio-temporale ), oppure di richiamo causale ( causalit ). Le idee complesse fondamentali grazie alle quali l'essere umano costruisce la rete delle proprie relazioni conoscitive sono le idee di spazio e di tempo, la relazione fra una causa ed un effetto, l'idea di sostanza (materiale e spirituale). Tutte questa idee secondo Hume non hanno corrispondenza in alcuna impressione.
15. Spazio e tempo sono modi di disposizione soggettivi, sensibilit interne. Il tempo scorrimento degli elementi portati dall'esperienza; lo spazio l'accostamento e l'ordine immediato degli stessi. 16.
- La relazione fondamentale che distingue e nello stesso tempo unisce l'oggetto al soggetto ha un riflesso nella distinzione operata da Hume fra proposizioni o giudizi espressi che riguardano il pensiero deduttivo e proposizioni che si riferiscono alla possibilit di connettere due o pi fatti naturali fra loro. Nel primo ambito il principio di non- contraddizione, gli assiomi generali e specifici, le singole definizioni costruiscono progressivamente un edificio conoscitivo che si autosostiene e si autosviluppa. Nel secondo ambito invece solamente il confronto con l'esperienza consente di decidere circa l'ammissibilit di un'affermazione. Mentre il primo ambito pu avere un valore ed un contenuto sistematico, il secondo sempre soggetto all'aleatoriet ed eventualit delle situazioni e dei fatti.
17.
- Contro la variabilit infinita ed impredicibile delle situazioni, delle condizioni e dei fatti sembra per stare nel mondo naturale e nel mondo umano una certa regolarit, una certa costanza ed un certo ordine quasi necessario. Come se ci si trovasse di contro a due strutture e due meccanismi, l'uno esterno e l'altro interno, atti a regolare i reciproci funzionamenti ed attivit. Nella scoperta e nella ricostruzione di questi due edifici l'uomo ha a disposizione essenzialmente due concetti: quello che predispone all'utilizzazione della relazione fra causa ed effetto e quello che presuppone l'esistenza di una certa sostanza (materiale o spirituale). Hume sottopone a critica scettica entrambi questi concetti, rigettandone l'applicabilita priori . Ogni fatto naturale ha cause e produce effetti che possono essere conosciuti solamentea posteriori . L'oggetto in s ed immediatamente rimane muto, il soggetto resta cieco e senza indicazioni.
18.
- Lo sviluppo intrinseco delle relazioni fra gli oggetti naturali sembrava al tempo di Hume seguire i principi della gravitazione universale stabiliti da Isaac Newton. Una necessit interna pareva guidare lo sviluppo dell'insieme dei movimenti apparenti e fenomenici dei corpi celesti e terrestri. Si poteva accostare a questa necessit intrinseca oggettiva un'eguale e parallela necessit intrinseca soggettiva? Come i movimenti terminali dei corpi potevano essere previsti con assoluta precisione ed assolutezza, anche le inclinazioni degli spiriti potevano parallelamente trovare predeterminazione certa ed indubitabile nei loro contenuti e scopi? Hume sostiene che un orizzonte di predeterminazione di questo tipo che utilizza in modo assoluto la relazione di causa ed effetto ed il concetto di sostanza sia in senso materiale che spirituale non ha modo, n luogo, per poter sussistere ed esistere (od essere applicato).
19.
- Ma vi un'indicazione per lo spirito e questa data dalla credenza forgiata dall'abitudine. La ripetizione in gran numero di eventi simili, laddove uno dei termini della relazione sia visto come causa mentre il secondo sia valutato e considerato come effetto, produce nello spirito umano una progressiva restrizione delle possibili alternative relative a quell'evento considerato. L'esperienza, prolungata e protratta, porta a selezionare e concentrare su di un unico tipo di relazione la possibilit di quell'evento. Ma non la sua necessit. Esso rimane possibile, ma non certo e determinato. Sulla base di questa supposizione l'evento futuro non prevedibile con necessit, ma risulta come proiezione ulteriore dell'insieme coerente e concentrato dei fatti che si sono realizzati. Senza questa proiezione ulteriore la visione teorica non avrebbe spazio di meditazione e di riflessione, mentre l'azione non riuscirebbe ad adattare i mezzi del proprio operare a finalit che non riesce a vedere (prevedere).
20.
- Questa forza proiettiva sia dal punto di vista teorico, che pratico l'emergere dell'immaginazione razionale. In virt del suo operare Hume sottolinea il fatto che due oggettipossanoessere messi in connessione tramitecontiguit spazialeesuccessione temporale , ma che soprattutto essidebbanoessere messi in connessione fra loro stante l'intreccio e la combinazione di queste due caratterizzazioni perch questa relazione necessaria che qualcosa che comincia abbia una causa il risultato di unaimpressione soggettiva , che diventa idea e idea che si presuppone. Si presuppone comerelazione fra una causa ed un effetto . Questa impressione soggettiva come gi stato detto si forma, si forgia e si viene progressivamente determinando, affinando e definendo, grazie a quella individuazione che viene costruita per ripetizioni invariate dei medesimi rapporti concreti fra cause particolari ed effetti particolari. L'individuazione che per somiglianza continua costruisce l'abito o abitudine dellacredenzao persuasione ( belief ).
21.
- Anche se filosofi successivi come I. Kant, J. Fichte e F.W.G. Hegel identificheranno lo spazio aperto dal principio della riflessione humiana come lo spazio dell'immaginazione razionale, il filosofo scozzese bad sempre ad escludere che la forza e la natura della propria impressione soggettiva fondamentale, pur trasferendosi in un'idea, fosse qualcosa che dipendesse dall'intelletto o dalla ragione analitica e discorsiva. Le inferenze che si venivano costituendo per effetto della consuetudine e/o abitudine avevano per se stesse una pura e semplice caratterizzazione quantitativa, che pareva superare le qualit nascoste nelle cose. La credenza e l'abitudine costruisce poi anche l'idea della sussistenza separata e prioritaria del mondo esterno: le cose continuano ad esistere indipendentemente dai noi che le avvertiamo e rispetto al momento nel quale le avvertiamo.
22.
- Poi l'uomo ritiene che le proprie sensazioni, impressioni ed idee possano essere a loro volta separate dal mondo esterno. Cos la separazione diviene doppia e reciproca. Si costituiscono due termini o poli di una relazione dialettica: l'oggetto ed il soggetto. Per effetto dell'azione del primo sul secondo e di un'azione che esprime costanza e coerenza di impressioni il soggetto comincia a pensare che il mondo esterno sia stabilmente determinato e che parallelamente a questa determinatezza vi stia nel soggetto una determinatezza simile, se non proprio eguale: allora egli pensa che agli oggetti esterni corrisponda continuamente l'immagine esatta dei medesimi. Ma la riflessione filosofica sulle immagini ne scopre la variabilit e la diversit rispetto agli oggetti esterni e ne cerca se non l'origine, che reputa ancora esterna almeno il fondamento in una propria attivit separata.
23.
- Ecco allora nascere l'idea filosofica dell'esistenza di una sostanza spirituale l'anima di contro alla presenza esterna, continua ed indipendente delle cose del mondo le sostanze materiali. In realt per Hume sostiene che sia la supposizione nella sussistenza ed esistenza della sostanza spirituale nella sua identit costante sia quella relativa alla preesistenza dei corpi esterni nella loro identit costante - siano forme di un'immaginazione che non ha fondamento razionale, ma solamente giustificazione in un'attivit psicologica: quella appunto tesa a rendere sostanziale l'insieme vario ed eterogeneo delle singole impressioni, sensazioni e percezioni individuali con l'idea di un oggetto esterno e con quella di una soggettivit interna al proprio corpo. Criticata in questo modo la credenza nell'idea di una sostanza spirituale e materiale, Hume pu procedere oltre, nella trattazione del problema dell'io.
24.
- Il termine e nome dell'io viene posto ed applicato a contraddistinguere una realt che si intende sulla base della precedentemente criticata idea di sostanza coesa e coerente, sia dal punto di vista corporeo che spirituale. L'unit per identit del corpo e dell'anima e del corpo all'anima sembrano essere dei postulati di credenza comune ed indiscutibile. In realt per l'accostamento per contiguit e per la relazione di causa ed effetto reciproco del corpo sull'anima e dell'anima sul corpo - fra queste due entit ancora un'operazione dell'immaginazione: non v' infatti impressione dell'io, ma solamente delle miriadi di sensazioni che compaiono nel teatro della nostra coscienza. L'io dovrebbe cos essere riportato ad un fascio di percezioni che si susseguono nel tempo.
25.
- Si potrebbe pensare che sia la sensazione, tramutata in sensibilit ed in sentimento di s, ad aprire e distinguere un impulso ed un istinto naturale, capace poi di utilizzare l'immaginazione come attivit principale di creazione, nella supposizione della sostanza spirituale e materiale, e nella loro combinazione reciprocamente dialettica, soprattutto sul piano dell'attivit. In questa doppia attivazione compare allora un orizzonte razionale superiore, non scisso da quella immaginazione. Questo orizzonte razionale verrebbe cos forse considerato da Hume come la proiezione ulteriore della potenza e del fattore immaginativo, un incremento di quella volont di vita che sembra essere tesa alla conservazione del soggetto e dell'oggetto, fondamentalmente del loro rapporto.
26.
- La potenza alterativa continua e costante che sembra esibire da un lato la sensazione, che procede apparentemente dal mondo suppostamente esterno, grazie alle impressioni ed alle percezioni, e dall'altro l'attivit della mente, che continua a combinare e dividere le proprie idee, una potenza alterativa che Hume tende a confinare attraverso i due poli immaginativi opposti dell'oggetto e del soggetto. Questa potenza alterativa sembra per affliggere la mente e l'animo dell'uomo nel suo rapporto con il mondo e gli altri esseri quando procede ed causa ed origine delle passioni e delle emozioni. In questo caso il teatro ed il luogo dell'espressione della sensibilit e del sentimento viene immediatamente vissuto come indubitabilmente proprio e singolare (il proprio io).
27.
- Se quindi Hume sottopone a critica l'immediatezza del rapporto fra oggetto ed immagine di sensazione ( l'opinione volgare) e l'immediatezza dell'opposto rapporto determinativo e positivo ideale ( l'idea dei filosofi), ci viene fatto risolvendo l'aporia consistente in una loro sterile e vacua contrapposizione: la sensazione del mondo esterno ed il sentimento di s, interno, vengono appoggiati a due confini-limite, posti in essere e determinati dall'immaginazione. Il ritorno e reimpossessamento di s che Hume indica attraverso il liberarsi delle passioni o lo scatenarsi delle emozioni convoglia subito la sua speculazione verso una prima ridefinizione del concetto di intelletto e di ragione. Se l'eguaglianza della natura umana consiste in una comune capacit di intendimento delle inclinazioni al bene, allora lo stesso orizzonte e panorama delle decisioni morali diviene patrimonio comune dell'umanit.
28.
- Trattato sulla natura umana
- Dialoghi riguardanti la religione naturale
29.
- 4. Morale e societ.
- Conseguenza delle ultime affermazioni poste nella parte teoretica dunque che pare sussistere un'unica e generale capacit sentimentale verso il bene, una comune intelligenza atta a definire gli strumenti di attuazione delle finalit e degli scopi dibattuti e decisi da un'universale abilit umana, la ragione (illuminismo humiano).di fronte a questa convergenza delle facolt umane che la speculazione morale del filosofo scozzese fa scoccare il concetto della responsabilit e del merito personale, collettivo ed individuale. Da verificarsi in modo obiettivo ed osservativo. Di qui il concetto di trasparenza istituzionale ed individuale, con il conseguente prorompere e costituirsi di un'opinione e di un'etica pubblica. Il giudizio comune valuta la liceit e la bont dei comportamenti collettivi ed individuali, secondo il criterio della loro utilit sociale ovvero pubblica.
30.
- La situazione economica e sociale delle diverse comunit umane contraddistinta dalla finitezza dei beni e dalla loro diversa distribuzione ed utilizzazione. I limiti e le regole che vengono imposti alla collettivit civile e politica secondo un ideale ed una pratica effettiva di giustizia intendono escludere gli estremi opposti della loro concentrazione assoluta o della loro diffusione generalizzata. Essi vogliono valere come strumenti di equilibrio per l'arricchimento della societ nel suo complesso. Per la moltiplicazione dei beni stessi, rispetto alla loro condizione iniziale, e per la loro distribuzione massima realizzabile. Solamente i soggetti che reagiscono ai soprusi ed alle sopraffazioni possono quindi arrogarsi il diritto naturale e razionale di chiedere il rispetto dell'obbligo sociale e politico della giustizia.
31.
- Insieme alla virt della giustizia anche le altre virt (umanit, benevolenza, amicizia, fedelt, sincerit, ...) sono quindi dei comportamenti ritenuti necessari, perch utili alla conservazione ed al miglioramento della vita civile e politica collettiva. Questa conservazione e questo miglioramento sono poi la ragione fondamentale per l'istituzione dei governi, rispetto ai quali diventa quindi necessariamente obbligata la virt politica dell'obbedienza. L'assolutismo illuminato della posizione politica humiana si fonde cos con la giustificazione filosofica dello sviluppo delle forze borghesi, in rapido accrescimento nell'Inghilterra del XVIII secolo (prodromi della prima rivoluzione industriale). La fondazione della morale naturale sul generale sentimento di simpatia per gli altri sentire, intendere e volere la felicit dei propri simili e su un generoso interesse per l'umanit non lo distoglie dai condizionamenti della propria appartenenza ideologico-politica (partito deiTories ).
32.
- 5. Religione e natura umana.
- L'analisi del fatto religioso compiuta da David Hume nei suoiDialoghi sulla religione naturale(1779) e nella suaStoria naturale della religione(1757) conduce la riflessione inglese ed europea verso la costituzione di una religione deista, tesa a distinguere fra i caratteri comuni di una spiritualit immanente, al contempo naturale e dotata di una propria giustificazione pratica e razionale, ed una credenza o fede nelle manifestazioni del sovrannaturale, legata alla diversit dei testi sacri esistenti, dei luoghi e costumi relativi ai popoli che li hanno accettati ed adottati. Questa distinzione fra religione naturale e religione rivelata e positiva rimonta con tutta evidenza alla distinzione humiana fra l'orizzonte imprecisato (ma universale) della ragione naturale e l'effetto impositivo perch ipostatico e sostanzializzatore dell'immaginazione.
33.
- Nei suoiDialoghiil filosofo scozzese fece valere questa distinzione assegnando l'affermazione dell'esistenza di Dio ad una ragione di fatto o d'esperienza, quindi al campo immaginativo e positivo. In questo modo egli tolse valore di prova alle tradizionali argomentazioni ontologiche, cosmologiche e teleologiche, che pretendevano di offrire un valore razionale ed un contenuto logico a ci che invece per principio esorbita e fuoriesce dall'affermazione della ragione e dalla determinazione dell'intelletto. Il potere divino viene cos storicamente, culturalmente e civilmente, a determinarsi nella formazione di una prima religione di tipo politeistico e naturale, capace di incarnare le idee create dall'immaginazione umana: la presenza di una molteplicit nascosta e segreta di forze e di cause che governano il mondo naturale ed umano, minacciandolo o salvaguardandolo a seconda dell'obbedienza o disobbedienza dimostrate dall'uomo.
34.
- L'infinito divino pu essere chiamato in campo ed immaginato dall'uomo nel momento in cui questo si trovi in balia delle forze naturali e, per timore o speranza, richieda una forma di salvezza totale dai pericoli, che immagina elargita da chi lo ha creato e costituito, secondo finalit che per coerenza non possono essere negative (Dio come ente infinito e perfetto). In questo modo la religione politeistica e naturale della civilt greco-romana viene sostituita dalla religione sovrannaturale ebraico-cristiana, che impone alle coscienze degli uomini la sovra-impressione astratta di un soggetto da adorare completamente, origine e finalit dell'intero mondo creato. Di fronte a questo signore e padrone assoluto ogni diversione, opposizione e resistenza viene immediatamente qualificata come opera del maligno e quindi perseguitata (intolleranza e settarismo). Di qui la necessit per i poteri politici degli Stati moderni di limitare opportunamente l'intervento delle forme religiose istituzionalizzate nella vita civile e politica.
35.
- 6. Le dottrine estetiche.
- Se ragione ed intelletto sembrano indicare una capacit di presa superiore da parte della facolt immaginativa e di tutte le forze che essa successivamente capace di elaborare ed organizzare, in modo logico e conseguente, sino alle forme pi estreme di fanatismo e di superstizione religiosa, essi sembrano nello stesso tempo guardare ad una capacit di fruizione presente nell'animo umano a loro consorella e quasi parallela: l'animo umano pare poter gustare della bellezza delle opere della natura e dell'arte umana con un sentimento di piacere particolare. Sicuramente individuale nella propria espressione e nel proprio riconoscimento, esso per pu essere riportato al criterio comune della perfetta armonia, sia fisica che spirituale e morale (stato di sanit). Anche il sentimento del gusto nasce dalla radice della natura umana, l'immaginazione, e quindi si muove e perfeziona solamente con l'esperienza: Sensi fini, sentimento delicato, esercizio della pratica, perfezionamento dei paragoni rendono critico il giudizio estetico.
36.
- 7. La politica.
- NelContratto originarioDavid Hume definisce la propria posizione politica situandola fra due tesi opposte, quella dell'origine divina del potere governativo e quella lockiana del contratto sociale. Dalla prima prende la necessit di una finalizzazione razionale superiore del potere stesso, dalla seconda la sua giustificazione e legittimazione popolare. Esse quindi si possono incontrare ed essere cos entrambe superate grazie alla eliminazione e negazione di una doppia arbitrariet, quella di un potere superiore tirannico e rivolto al male e quella di un potere che sorge con un atto di violenza e di sopraffazione, destinato a perdurare nel tempo con i suoi effetti nefasti. Questa doppia e convergente negazione dovrebbe potersi istituire - nelle intenzioni del pensatore scozzese nel momento in cui i diritti individuali (vita, libert, propriet, felicit) si fondono nella accettazione e definizione generale di un panorama completo di doveri collettivi.
37.
- Se gli uomini sentono dentro di s deidoveri naturali ,che sono indipendenti da qualsiasi imposizione esterna e che non sembrano possedere alcuna apparenza di pubblica o privata utilit come il senso dell'amore familiare, la gratitudine verso i benefattori, la piet per gli sfortunati essi paiono dover accettare, per la stessa conservazione della vita sociale e propria, anche deidoveri sociali- come il rispetto della propriet altrui (giustizia), il rispetto delle promesse (fedelt) e l'obbedienza generale al potere civile e politico. Quando doveri naturali e doveri sociali si uniscono, allora il senso della ricerca delle proprie soddisfazioni personali riesce a non ledere il diritto equivalente altrui, e questo viene garantito e pu essere garantito solamente nel momento in cui venga assegnata e rilasciata una completa fiducia (edobbedienza civile ) agli organi rappresentativi della nazione, ai suoi poteri legislativi, esecutivi e giudiziari.