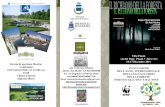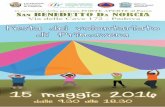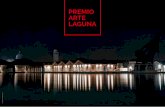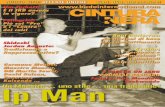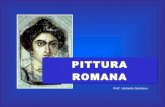312 Dall'Estetica Della Pittura Alla Fotografia
-
Upload
larisa-oancea -
Category
Documents
-
view
35 -
download
5
description
Transcript of 312 Dall'Estetica Della Pittura Alla Fotografia

I suggestivi e straordi-nari influssi intercorsinell’arte tra pittura emezzo fotografico dallametà dell’Ottocento finoai nostri giorni, meri-tano un’attenzione par-ticolare al fine di affron-tare e ripercorrere quellungo e certe volte tra-vagliato cammino cheha condotto alla defini-zione di fotografia comeespressione artistica.Quello che oggi è un datoaccettato universalmente,nel secolo passato fu og-getto di appassionati di-battiti culturali chehanno coinvolto il con-cetto stesso d’arte ed este-tica. Praticamente siamodovuti arrivare agli anniCinquanta per affermareche un procedimentocreativo realizzato permezzo di una strumen-tazione tecnica potevaassumere valore di operad’arte. Non è stato quindiindolore il raggiungi-mento a rango di pro-cesso artistico della fo-tografia, non facile ac-cettare l’impegno e lasensibilità di un foto-grafo, alla stessa streguadi un pittore o di unoscultore, non si è affer-mato con naturale con-vincimento che l’uso diun certo obiettivo, di unparticolare filtro, di unafonte di luce rispetto adun’altra, di un’angola-zione più originale e ar-dita, potevano e dove-vano considerarsi comel’uso di un pennello apunta affilata o rotonda,o di un gessetto più omeno morbido, o di una
sgorbia a sezione largaanziché stretta, o di untipo di colore più pastosoe compatto rispetto adaltro pigmento. Questiultimi elementi, legatistrettamente alle uffi-ciali ed accreditate tec-niche artistiche, a se-conda del loro uso, po-tevano cambiare il risul-tato dell’opera d’arte.Perché quindi la gestionetotale del mezzo foto-grafico, l’impegno del-l’operatore che sceglievasoluzioni e modalità spe-cifiche, non erano rico-nosciute come compo-nenti di un processo ar-tistico? Le risposte possono es-sere molte, ma sostan-zialmente il motivo ditale ostilità creatasi trapittura e fotografia, puòessere ricercato nell’evo-luzione che la pitturastessa ebbe verso la metàdell’800, quando allafortuna dell’arte accade-mica idealizzata ed incui si aberrava il disegnodal vero, s’impose il rea-lismo in una volontà dimimetismo che raggiun-gesse la copia della re-altà. Successivamente alrealismo si affiancò lavolontà di rendere l’im-pressione delle cose: duerealtà a confronto quindi,in un susseguirsi di emo-zioni visive che segna-rono la strada della mo-derna estetica dell’im-magine. Quando la fo-tografia fece il suo in-gresso nella vita del-l’uomo moderno e co-minciò ad occupare spaziprima destinati solo alle
rappresentazioni pitto-riche, il graduale pas-saggio della percezionevisiva che per secoli siera affidata esclusiva-mente alla visione di undisegno, di un affresco,di un quadro, si spostòverso altri elementi per-cettivi della natura equindi della realtà cir-costante, in un tipo direaltà rappresentata. Taleevoluzione fu uno scon-volgimento per i canoniestetici e conoscitividi quel periodo, eccoquindi la diffidenza difar traslare su altre re-altà oggettive (dal qua-dro alla fotografia) il va-lore di opera d’arte. Conl’avvento di questa ri-voluzione, la pitturastessa iniziò quel pro-cesso di allontanamentodalla realtà ormai terri-torio della fotografia, equell’avvicinamentosempre più marcato versol’astrazione che, solo in-terrotta da correnti epi-
Dall’estetica della pittura alla fotografia
n° 312 - ottobre 2003
© Tutti i diritti sono riservati Fondazione Internazionale Menarini - è vietata la riproduzione anche parziale dei testi e delle fotografieDirettore Responsabile Lucia Aleotti - Redazione, corrispondenza: «Minuti» Via Sette Santi n.1 - 50131 Firenze - www.fondazione-menarini.it
C. Monet: La grenouillère - New York, Metropolitan
Museum of Art
C. Monet: Donna con parasole e bambino Washington, National Gallery
E. Munch: Il grido - Oslo, Nasjonalgaleriet

pag. 2
sodiche, non si è ancorafermata. Pensiamo in-fatti all’estetica del ‘900con il verismo dei mac-chiaioli, l’impressioni-smo, l’espressionismo,il cubismo, il futurismo,l’astrattismo e l’infor-male, che ha segnato uncrescente distacco dallarealtà reale per una re-altà interpretata.Il massimo autore di que-sta rivoluzione fu Mo-net che con la tecnicadelle ombre colorate, enon più col chiaroscuro,
si avvicinò al procedi-mento fotografico. Nel1874, sua e degli altriimpressionisti la volontàdi scegliere come luogodella prima storica espo-
sizione parigina propriolo studio del fotografoNadar, come a simbo-leggiare l’integrazionecon i nuovi artisti. Le ca-ratteristiche estetiche e
formali dell’impressio-nismo riuscirono a rom-pere, similmente alla fo-tografia, schemi che sem-bravano inamovibili edentrare in territori rite-
sopra: J. Zyplakov: Lenin che parla a Pietroburgo
sotto: E. Degas: Interno dei magazzinidel cotone a New Orleans - Parigi,
Musée d’Orsay
sopra: Ragazza in poltrona, lastra al collodio - 1865
a lato: Il’Ja Repin: Riposo - Mosca,Galleria Tret’Iakov

pag. 3
nuti inaccessibili. Aria,acqua, luce, vento, di-vennero gli elementiemozionali e formali dellanuova arte, e come il rag-gio luminoso impressio-nava la lastra fotografica,così i pennelli di Monete Renoir fissavano sullatela la traduzione dellarealtà. Stabilito che sipoteva interpretarla con-notando le immagini diastrazioni formali e cro-matiche a servizio del-l’impressione che l’uomo-artista voleva rendere,inizia un processo veloceed impetuoso versol’astrazione pura, quelladello spirito, degli statid’animo: Il grido diMunch nel 1893 divenneuna delle opere simbolodel turbamento e del do-lore. Col cubismo, nel-l’esasperazione delleforme spezzate, come af-fermava Picasso, finivail tempo della Bella Pit-tura, dove si annulleràogni indugio realistico.Anche il drammaticotema della Guerra pro-pose all’artista vari puntidi vista e la percezionevisiva si trovava neglistessi mesi a osservareGuernica e Lenin che parlaa Pietroburgo.Il vuoto lasciato dunquedalla pittura, nel suo tra-dizionale rapporto conla realtà, fu gradualmentecolmato dalla fotogra-fia, il rivoluzionariomezzo iniziò a subire gliimpulsi dell’estetica le-gata alla storia dell’arte;i temi prescelti per leprime grandi mostre fo-tografiche seguivano lamoda delle tematiche
più in voga in pittura:il ritratto, la naturamorta, il paesaggio. Pro-prio il ritratto offrì spuntie materiali molto inte-ressanti raggiungendoesiti di mutuo scambio.La fotografia diventavail termometro della si-tuazione estetica del mo-mento: si fotografavaquello che stava assu-mendo valore estetico equello di cui mancava ladocumentazione. Glistudi dell’architettura edella scultura ebbero ungrande impulso graziealle imponenti campa-gne fotografiche dedi-cate a queste discipline,così come le arti minorie i prodotti dell’artigia-nato entrarono a far partedei cataloghi più scelti.Anche la pittura ormaisensibilizzata dal feno-meno della fotografiainiziava ad introdurrenei propri canoni este-tici riferimenti moltoevidenti al processo fo-tografico. Non sarebberostati forse mai concepitii due bellissimi quadridi Degas: La famigliaBellelli o l’Interno dei ma-gazzini del cotone a NewOrleans se non fosse esi-stita già la fotografia.Nel primo ad una clas-sica impostazione di ri-tratto d’interno si con-trappone la libertà asso-luta di osservazione deisoggetti come se la loroattenzione fosse cattu-rata da eventi diversi daquelli della riproduzione,nel secondo, realizzatodall’artista dopo il suoviaggio negli Stati Uniti,assistiamo ad una delle
prime istantanee pitto-riche, immagine comerubata da un fotorepor-ter, meno ortodossa ri-spetto alla pittura e sem-pre più vicina al mododi fotografare accettandolicenze estetiche comeil taglio delle figure aibordi della tela. L’astrazione privilegia ilmovimento e la pitturasi impossessa della tec-nica cinematograficacome esemplifica il Nudoche scende le scale di Du-champ. L’elaborazioneintellettuale che in que-sti anni si stava impos-sessando del processotrova un’eloquente sin-tesi nel celeberrimo qua-dro di Pellizza da Vol-pedo, Quarto Stato trattodal precedente studio fo-tografico della Donna conbambino, gelatina di bro-muro d’argento 1896.Ma sono forse i canoniespressivi del surreali-smo a mostrare megliol’evoluzione estetica edella rappresentazioneraggiunta in questi de-cenni. Magritte con Lachiave dei campi apre unafinestra sulla natura, sta-tica, ferma di atmosfera,come chiara simbologiadella condizione umana,i vetri rotti simboleg-giano l’eliminazione dellabarriera tra contenitoree contenuto, tra internoed esterno, tra uomo erealtà. Questo quadroè la metafora della pit-tura e allo stesso tempodella fotografia, ambe-due strumenti per cono-scere il mondo.
miriam fileti mazza
E. Degas: La famiglia Bellelli - Parigi, Muséed’Orsay
Donna con bambino, gelatina di bromuro d’argento
G. Pellizza da Volpedo: Quarto Stato - Milano,Palazzo Marino
R. Magritte: La chiave dei campi - Madrid, Collezione Thyssen Bornemiszka