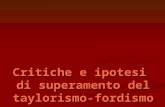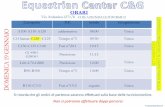3. ORARI DI LAVORO E CONCILIAZIONE · Il taylorismo, l’orario standard e la sua riduzione...
Transcript of 3. ORARI DI LAVORO E CONCILIAZIONE · Il taylorismo, l’orario standard e la sua riduzione...
3. ORARI DI LAVORO E CONCILIAZIONE
INDICE TESTI
2017
Fine dell’orario come misura del lavoro? Tecnologie, smartworking, lavoro digitale, QRS
2016
Il tempo di lavoro scelto. Produttività e qualità della vita, AREL/il Mulino
2014
Smartworking. C’è davvero bisogno di una legge?, viaDogana
Work-life balance e performance aziendale nella prospettiva del Diversity Management, con
Egidio Riva, SDL
2013
Conciliazione, UnaCittà
Quale flessibilità è meglio incentivare per la produttività, con Luciano Pero, AREL
2011
Telelavoro e lavoro mobile in Italia. Casi aziendali, ARIFL
2006
Work-life balance and Industrial Relations in Italy, ESA
2005
Work-life balance e relazioni di lavoro, AIS
2003
Sindacato ed imprese nella contrattazione della qualità della vita, DRI
Worker participation in bargaining on working-time in Italy, SCENARIO 21
1
Fine dell’orario come misura del lavoro? Tecnologie, smartworking, lavoro digitale
Anna M. Ponzellini
Una versione rivista di questo testo è stata pubblicata in: Quaderni di Rassegna Sindacale, n. 3-2017
Abstract In soli pochi anni, le tecnologie, i mercati e la pressione dei lavoratori per un migliore equilibrio tra vita e lavoro hanno aperto spazi, prima inimmaginabili, di flessibilità dell’orario per le imprese e di libertà per chi lavora. Il lavoro da remoto ha rafforzato questa tendenza e la presenza non rappresenta più una misura del lavoro. Un percorso recente, che per ora riguarda solo alcune attività e alcuni gruppi occupazionali, ma che lascia presagire sviluppi veloci nella misura in cui la tecnologia libera molte posizioni di lavoro e molti lavoratori dal vincolo taylor-fordista del tempo-luogo unico per il lavoro. Tuttavia, il venire meno dei limiti precisi dell’orario fordista ha aperto alcuni rischi. Il primo è quello dell’invasione del lavoro nella quotidianità. Il secondo riguarda le nuove forme di controllo del lavoro. Within just a few years, technologies, markets and workers’ claim to a better work-life balance lead to greater flexibility in company working hours and increased freedom in people's working life, developments never imagined before. Teleworking strengthened this trend, so that the presence at workplace does not represent anymore a measure of work. This is a recent shift that for now involves only few activities and few occupational groups, yet all the indicators are that this changes and developments will spread fast since technology is going to disrupt many jobs and free many workers from the Taylorist constraint of a unique working time and place. However, the loss of the precise schedules of traditional working hours might have risky downsides such as the blurring boundaries between a worker's job and his personal life and the yet to be defined ways of remote controlling of workers.
1. “Lavorare meno per lavorare tutti”. Il taylorismo, l’orario standard e la sua riduzione bloccata
La storia degli orari di lavoro è stata a lungo soprattutto una storia della durata dell’orario. La definizione della giornata lavorativa standard, regolata da legge e contratti, era stato un passaggio organizzativo importante per il lavoro industriale quando abbandonò la distribuzione del lavoro a domicilio, concentrò i lavoratori in uno spazio comune (la “fabbrica”), regolò la subordinazione e sostituì la paga per pezzo1 con una durata giornaliera di presenza sotto la supervisione di un capo. Da quel momento, la riduzione della giornata lavorativa fu, insieme all’aumento del salario, uno dei temi fondamentali del conflitto operaio. Fu anche un tema vincente, visto che la giornata lavorativa nella gran parte dei Paesi industrializzati, tra la fine dell’Ottocento e gli anni Sessanta del Novecento arrivò a dimezzarsi (da 16 ad 8 ore), aiutata dall’enorme aumento della produttività generato dal sistema di produzione taylor-fordista. La pressione per un’ulteriore riduzione – che avrebbe dovuto portare a 35 ore la settimana lavorativa - continuò nei decenni successivi ma ebbe successo solo in Germania e Francia. Dalla metà degli anni Novanta il processo di riduzione generalizzata si interruppe e persino i Paesi che erano andati più avanti ebbero qualche ripensamento.
Le cause di questa battuta d’arresto furono più d’una. Da un lato, si era forse verificato il naturale esaurirsi della spinta al miglioramento delle condizioni di lavoro - in sostanza le otto ore rappresentavano una giornata lavorativa passabile – e il movimento dei lavoratori si era dato un obbiettivo diverso e più complicato, utilizzare la riduzione dell’orario per aumentare i posti di lavoro, “lavorare meno per lavorare tutti”. Con ciò però aveva innescato un dibattito infinito tra specialisti (o
1 Il sistema del cottimo restò più lungo, ma solo come indicatore di produttività.
2
presunti tali) e contemporaneamente proposto una posta in gioco che non era sufficientemente in grado di generare consenso tra i lavoratori. Dall’altro, come argomenta Aldo Marchetti nel suo testo sulla storia dell’orario di lavoro, perché in quegli anni era sopraggiunta la globalizzazione e la concorrenza in termini di costo del lavoro da parte dei Paesi di nuova industrializzazione si presentò anche con la messa a disposizione di lavoratori meno tutelati dei nostri sul piano dell’orario di lavoro e questo fu un incentivo per le imprese a delocalizzare o anche solo a minacciare di farlo... (Marchetti, 2010). Tuttavia, contò probabilmente anche il fatto che proprio in quei decenni nei Paesi industrializzati si realizzò un consistente aumento del lavoro part time, a segnalare “uno slittamento dalla strategia collettiva a strategie individuali di riduzione d’orario” (Lehndorff, 1999). Un passaggio profetico per quanto avvenne poi.
2. “Giusto in tempo”. La stagione del toyotismo e dell’orario flessibile
Il fenomeno del part time – che per la verità stentò a diffondersi in Italia – fu certamente la prima rottura dell’idea fordista del lavoro uguale per tutti. Ma non rappresentò che l’inizio della progressiva erosione dell’orario standard, un processo che, come vedremo, può essere considerato sostanzialmente positivo ma anche pieno di contraddizioni. I grandi cambiamenti dell’orario che si verificarono a partire da quegli anni hanno prevalentemente a che fare con un’altra dimensione del tempo di lavoro: la collocazione, ovvero il quando – nella giornata, nella settimana o nell’anno – vengono richieste le mie ore di lavoro (a tempo pieno o a tempo ridotto che siano). Nell’industria, per garantire il miglior utilizzo delle macchine, vi fu il passaggio ai turni avvicendati, che superarono l’idea del turno “normale” come ancora viene denominato quello al centro della giornata. Anche se c’erano sempre stati i turni notturni, i sabati e le domeniche di chi lavorava sui cicli continui. Nei servizi, dove l’orario di lavoro si era “disaccoppiato” da subito dagli orari di apertura dei servizi, furono oltre ai turni mattutini e pomeridiani, i sabati e poi anche le domeniche (Ponzellini e Tempia, 2003).
Dagli anni Novanta in avanti fu chiaro che non si sarebbe più tornati indietro nel processo di de-standardizzazione dell’orario. Nell’industria, alla competizione globale si cominciò a rispondere con una stringente razionalizzazione dei processi industriali e dei costi di produzione, che divenne paradigma con l’avvento del toyotismo e del suo imperativo al just-in-time. La riduzione degli sprechi impose la saturazione delle macchine e delle persone, che si tradusse in una turnistica ancora più articolata. Ma è stata soprattutto l’eliminazione delle scorte che rivoluzionerà la manifattura e condurrà al nuovo sistema di orario basato sulla flessibilità stagionale/annua: si affermò il cosiddetto orario multi-periodale o plurisettimanale, per cui alcune settimane all’anno si lavorano più ore (fino a 48) e altre meno ore (fino a 32) in ragione della stagionalità dei prodotti o, più spesso, dell’andamento delle commesse. Per anni - finché non vi è stata consapevolezza del fatto che questo era il nuovo modo di produrre - il conflitto industriale sugli orari si concentrò contro i sabati lavorativi.
Nel settore dei servizi, che nel frattempo era enormemente cresciuto, la domanda di flessibilità arrivò con la personalizzazione dei servizi agli utenti e ai consumatori che portarono a tempi di apertura progressivamente più lunghi, spesso tendenti alle 24h su 24h. Call-centre e distribuzione organizzata aprirono la strada a modelli di organizzazione del lavoro che prevedono una elevata incidenza di part time (più facile da modularizzare) e orari di lavoro flessibili su fasce giornaliere di disponibilità oraria2.
2 In settori con margini ridotti di produttività - alcuni dei quali come i call centre minacciati dalla concorrenza di
lavoratori e impianti off-shore - gran parte dell’efficienza si basa sul fatto di avere l’organico giusto in ogni momento: è essenziale una ferrea corrispondenza tra flussi di vendita (o di telefonate in arrivo) e lavoratori presenti, che può essere raggiunta solo attraverso il continuo aggiornamento della programmazione fino a ridosso del momento della prestazione lavorativa e che comporta inevitabilmente frequenti modifiche dei turni. Questo fatto ha comportato per i lavoratori una progressiva riduzione della certezza della collocazione del proprio orario, che nel lavoro part-time era inizialmente tutelata dalla legge. La contrattazione di clausole di flessibilità che prevedano la possibilità di scelta dei turni è attualmente un modo per superare in parte questo disagio.
3
Sistemi simili di organizzazione del lavoro e degli orari si sono diffusi anche nelle cooperative di servizi a domicilio, nei fast food, in alcuni comparti della logistica.
3. “Flessibilità win-win”. Scegliere il proprio orario
Siccome il lavoro in turno e nelle unsocial hours (orari notturni e serali, domeniche e festività) a qualcuno non piaceva, il sindacato risolse il problema – o credette di farlo – attraverso maggiorazioni salariali che crescevano man mano l’orario si allontanava dallo standard. Anche il lavoro straordinario, che si era diffuso moltissimo nelle realtà medio-piccole e meno razionalizzate, ebbe premi elevati (che non meritava): una giungla retributiva che la dice lunga su come la contrattazione aziendale dagli anni Ottanta a ora si sia concentrata nella monetizzazione di un (effettivo o presunto) disagio del non-standard, piuttosto che nella ricerca di soluzioni organizzative coerenti con i nuovi paradigmi organizzativi e insieme in grado di garantire una buona qualità del lavoro.
Qualche passo in questa direzione comincia a essere compiuto solo in tempi più vicini a noi. In realtà, già dall’inizio erano in molti, soprattutto donne, a preferire gli orari a turni a quello normale (che prendeva tutta la giornata), come si vide nel caso delle infermiere o nel caso dei turni 6x6 nell’industria tessile (che compattavano e accorciavano l’orario giornaliero, anche se bisognava rinunciare al sabato). Donne e giovani continuarono a essere inclini a orari lontani dallo standard - il part time, i turni avvicendati, il lavoro stagionale – e arrivarono a smentire anche la logica delle unsocial hours, come si vede nel caso della preferenza di studenti e madri di famiglia per gli orari serali alla Whirlpool negli anni Novanta o, più recentemente, nella preferenza per turni che iniziano all’alba (ma in compenso finiscono presto) in Luxottica. Naturalmente si trattava di preferenze spinte da specifiche condizioni sociali, come la necessità di conciliare il lavoro con la cura dei figli o con lo studio.
Solo recentemente, diventa più chiara – forse prima alle direzioni aziendali che allo stesso sindacato - la possibilità di un percorso virtuoso nell’organizzazione degli orari, che rispetti l’obiettivo dell’efficienza aziendale ma lo contemperi con quello del raggiungimento di una buona qualità di vita per le persone. Questo incontro win-win della domanda-offerta di flessibilità dell’orario comincia a realizzarsi in alcune situazioni organizzative, specialmente quelle dove le donne sono in maggioranza. All’inizio sono soprattutto le aziende dei servizi: Auchan, Unicoop, Carrefour, Ikea nella grande distribuzione; Mc Donalds’ e altre catene della ristorazione; i grandi call centre, come Call&Call (Pero e Ponzellini, 2015).
Per esempio, chi lavora in Ikea può scegliere i turni di lavoro, collocando le sue preferenze in una tabella elettronica relativa a un dato periodo di programmazione (in genere, otto settimane). Nel caso di sovrapposizione delle preferenze, interviene un sistema automatico di totalizzatori che garantisce equità nella distribuzione dei turni meno “gettonati”. Contrariamente a quello che si pensa, i lavoratori si dispongono in modo molto vario nei diversi turni, i casi di sovrapposizione sono meno di uno su dieci. Visto che l’efficacia del sistema è legata alla numerosità del bacino di persone che possono ruotare sui turni, l’azienda sta investendo in programmi formativi e di affiancamento che permettano a molti lavoratori di raggiungere la polivalenza necessaria a ricoprire le diverse posizioni e a massimizzare le loro possibilità di scelta (Italia Lavoro, 2016).
Altre aziende, anche nell’industria, hanno introdotto la possibilità di scelta tra diversi “menù di orario”: è il caso, per esempio, di ZF, un’azienda metalmeccanica del nord-est che fin dai primi anni Duemila ha concordato col sindacato la possibilità per i dipendenti di scegliere, ogni due mesi, tra tre tipi d’orario settimanale: la settimana ad orario “normale”; quella a orario “carico” (che prevede la disponibilità al lavoro straordinario il sabato mattina o a un’ora in più al giorno); quella a orario “scarico” (che prevede il venerdì pomeriggio libero o un’ora in meno al giorno) (Pero, 2002). In altri sistemi sociali e contrattuali, come quello tedesco, è la squadra di lavoro – sei/otto operai coordinati da un team leader – che ha il compito di organizzare ferie, permessi, cambi turno e, soprattutto, di decidere di volta in
4
volta quando collocare le ore in più richieste dai target produttivi e quando collocarne il recupero: un sistema di banca-ore che garantisce una elevata reciprocità tra esigenze d’impresa e esigenze dei singoli anche senza l’intervento di un incentivo salariale per le ore straordinarie o multiperiodali (Pero e Ponzellini, 2015).
Negli uffici, infine, dove i vincoli imposti dalle tecnologie e dal lavoro diviso e coordinato sono minori, lo spazio di flessibilità concesso ai lavoratori si diffonde presto. Nelle sedi impiegatizie delle grandi società – ma anche in molti uffici pubblici - si afferma il flexitime, ovvero la possibilità di variare l’orario d’inizio e fine della giornata. L’orario flessibile col tempo in alcune realtà si è via via allargato, aprendo la possibilità di “recuperare” su periodi più lunghi: la settimana, il mese, l’anno.
Siamo forse ancora lontani da una piena reciprocità tra domanda e offerta di flessibilità, tuttavia si è aperta una strada. Un percorso che rappresenta una svolta rispetto alle tradizionali piattaforme sindacali che, di fronte ai vari problemi aperti dal cambiamento organizzativo, si davano da fare per trovare una one-best-way (tipicamente fordista) in grado di accontentare tutti. La nuova strada consiste invece nell’agevolare la de-standardizzazione e quindi la scelta dell’orario da parte dei singoli. All’inizio interpretata come forma di tutela per le madri o per i caregiver, ora ha assunto l’aspetto di una forma di libertà aperta a tutti: in questo modo viene legittimata la diversità nelle preferenze e nelle condizioni sociali e il sostegno ai progetti personali dei lavoratori.
3. “Lavorare smart”. Le tecnologie abilitano mobilità e libertà ma rendono incerti i confini tra lavoro e non lavoro
Negli ultimi trent’anni il telelavoro e i suoi succedanei - smartworking o lavoro agile3 - hanno lasciato intravvedere per molte attività lavorative una nuova possibilità di scelta: non solo “quanto” e “quando” ma anche “dove” lavorare (Ponzellini e Tempia, 2003). Si comincia così a mettere in discussione il luogo di lavoro. Come si intuisce, abbiamo a che fare con modi di lavorare strettamente legati alle possibilità aperte dalle tecnologie, un percorso recente ma che lascia presagire sviluppi veloci nella misura in cui la tecnologia libera, letteralmente, molte posizioni di lavoro e molti lavoratori dal vincolo taylor-fordista del tempo-luogo unico per il lavoro. Se non la fine della “fabbrica”, intesa come luogo della manifattura, certamente sembra avvicinarsi la fine di quel modello di luogo di lavoro mutuato dall’industria – concentrato in uno spazio circoscritto, delimitato da tornelli di ingresso e da dispositivi segnatempo, controllato a vista dalla gerarchia - che ha caratterizzato l’ultimo secolo e mezzo di lavoro privato e anche pubblico. Le tecnologie che si sono rivelate davvero abilitanti per l’autonomia spazio-temporale - e quindi anche per l’equilibrio tra vita e lavoro delle persone - sono tecnologie ormai consolidate (più da Terza che da Quarta rivoluzione industriale), come le ICT: laptop, smartphone, tablet, possibilità di connettersi alla rete aziendale da casa o comunque da remoto, software di protezione dei dati e poi badge per la rilevazione delle presenze, software per la gestione dei turni della flessibilità, dispositivi per pc che rilevano l’inizio e la fine dell’attività, applicativi che consentono i controlli a distanza (Ponzellini, 2006). Strumenti non ancora utilizzati in tutte le loro possibilità – forse perché le barriere che incontrano non sono tanto tecniche ma sociali e di regolazione - e che saranno certamente potenziati dalle nuove opportunità aperte dalla possibilità di archiviazione, estrazione e analisi delle informazioni, dall’intelligenza artificiale e dalla creazione di algoritmi sempre più sofisticati che standardizzeranno molte attività e renderanno possibili ancora più interventi da remoto, anche attraverso le innumerevoli
3 Denominazioni come “smartworking” e “lavoro agile” sono usate dalle aziende da diversi anni per regolare al loro interno forme occasionali di lavoro mobile e da remoto: in altri Paesi si parla, senza troppe distinzioni, di “teleworking” ma in Italia l’Accordo interconfederale sul Telelavoro del 2004 ha introdotto una normativa così vincolante – anche perché troppo legata ad un assetto tecnologico già allora in via di superamento - che non si prestava ad essere utilizzata per formule più leggere, e meno onerose dal punto di vista degli adempimenti, del vecchio telelavoro a domicilio.
5
piattaforme on-line di scambio di servizi e di lavoro digitale previste dalla rivoluzione di Industria 4.0.
In linea di massima si tratta di tecnologie “amichevoli” ma che hanno aperto un capitolo nuovo nella quotidianità delle persone: la necessità di gestire le sovrapposizioni e le interferenze tra il tempo di lavoro e il tempo di non lavoro. Tanto più se svincolato da controlli di orario, il lavoro mobile e da remoto tende infatti a provocare una situazione di blurring boundaries (confini confusi) tra il lavoro e le altre attività della giornata (Webster, 2004). Un fatto che ha cambiato la nostra quotidianità, quasi indipendentemente dal lavoro che svolgiamo e rispetto al quale si dovrà prevedibilmente costruire una cultura che sappia prendere gli aspetti abilitanti delle nuove tecnologie e respingerne le insidie. Richiede certamente la messa in campo di nuove abilità dei lavoratori nell’autogestione del proprio tempo, finora sconosciute nel lavoro dipendente. Tuttavia, non va esclusa anche la possibilità di qualche intervento di regolazione.4
Pratiche di lavoro a distanza sono già sperimentate da decenni soprattutto per dirigenti e quadri ma anche per diverse attività impiegatizie e tecniche – come contabilità, buste-paga, gestione amministrativa, marketing, assistenza alla clientela - che possono essere svolte in parte o interamente da
remoto. Recentemente in Italia è stata introdotta anche una normativa specifica sul Lavoro agile (Legge 22 maggio 2017 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”). La nuova legge, che ha l’ obiettivo dichiarato di “incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, regola, fortunatamente con sufficiente leggerezza, le condizioni di questa particolare modalità di lavoro, che resta comunque, oltre che subordinato, sottoposto alla normale disciplina legale e contrattuale dell’orario di lavoro.
Tra le prime aziende a stipulare accordi collettivi sul lavoro agile (ancora prima della legge) per l’insieme dei propri dipendenti, vi sono Nestlè e Barilla. E’ interessante analizzare le norme che vengono inserite negli accordi, perché rendono evidenti le nuove possibilità tecniche e contemporaneamente gli sviluppi impliciti di innovazione organizzativa che sottendono. Nestlè prevede che il lavoro agile sia svolto solo per periodi limitati nel tempo. Anche Barilla – che lo apre a tutti gli impiegati e quadri – definisce un massimo di otto ore la settimana, ma ne promuove la rotazione, lasciando quindi intravvedere l’intento di organizzare in modo diverso gli spazi interni ed esterni dell’azienda. Il controllo della prestazione è molto articolato nel caso di Nestlè, dove, da un lato, si dichiara che la gestione dell’orario è lasciata all’autonomia del lavoratore ma contemporaneamente è prevista la sua disponibilità a essere contattato durante l’orario lavorativo. Soprattutto, però, una clausola dell’accordo prevede che “i dati raccolti in merito alla quantità e qualità della prestazione non costituiscono violazione dell’art.8 della L.300”. Nel caso di Barilla, è invece semplicemente esplicitato il divieto al lavoro straordinario. Come si vede, anche se per ora resta fermo il riferimento al classico orario di ufficio (tutt’al più, con quel po’ di flessibilità già concessa a chi lavora negli spazi aziendali), entrambe le aziende cominciano ad interrogare i loro sistemi di coordinamento e controllo e prevederne gli sviluppi necessari a supplire al venir meno del controllo esercitato dall’orario: sia quando fanno cenno alla possibilità del lavoratore di autoregolamentarsi l’orario (dentro i paletti di controlli più tradizionali, come la telefonata del capo o del collega) ma contemporaneamente liberano il campo ad altre misurazioni della performance (Nestlè), sia quando ipotizzano il passaggio ad una flessibilità più spinta dell’orario purché non condizionata dalle maggiorazioni della straordinario (Barilla).
In altre aziende, come Muoversi - piccola azienda del terziario avanzato che gestisce una piattaforma di
4 Più che di affermare un generico “diritto alla disconnessione”, si tratta forse semplicemente di regolare le richieste di disponibilità che vanno oltre il lavoro “ordinario”, non importa dove prestato, come ad esempio la necessità di rispondere a un cliente per un bisogno specifico, il presidio della posta, interventi di assistenza o di manutenzione urgenti, ecc.. A queste si potrebbe far fronte allargando il campo dell’istituto, già esistente nei CCNL, della “reperibilità”.
6
servizi alle imprese – il passaggio al lavoro agile apre orizzonti più avanzati, soprattutto in materia di organizzazione aziendale e del lavoro. Per il momento, anche qui la possibilità di lavoro da remoto riguarda solo una media di quattro giornate al mese, al massimo due giorni nella stessa settimana. I luoghi dove è possibile lavorare a distanza sono solo quelli dove esiste una connessione veloce: la propria abitazione, spazi di coworking, bar con wifi, hotel, business centre, biblioteche, aerei, treni. Nel regolamento si annuncia comunque un (non ben precisato) “superamento del lavoro a tempo verso il lavoro su obiettivi individuali e comuni” e, soprattutto, una diversa gestione degli spazi aziendali attraverso l’actvity-based workplace ovvero la differenziazione degli ambienti di lavoro in base alle attività da svolgere: spazi per il lavoro ordinario, spazi speciali adatti alla concentrazione (silenzio), spazi per riunione, superando così le postazioni fisse personali. Il coordinamento degli spazi e dei tempi viene risolto attraverso l’acceso dei lavoratori ad una agenda elettronica collettiva (un google calendar aziendale). Come nel caso Barilla, si tratta dunque di un sistema finalizzato anche a risparmiare sui costi immobiliari ma più del precedente destinato a cambiare la logistica aziendale e il consueto rapporto dei lavoratori con lo spazio di lavoro (Italia Lavoro, 2016).
4. “Il contadino non timbrava il cartellino”. Verso la fine della presenza come controllo e misura del lavoro.
Come abbiamo visto sopra a proposito prima del flexitime e poi dello smartworking, il lavoro amministrativo e tecnico si presta più di altri alla flessibilità dell’orario di lavoro. Le aziende di progettazione e di produzione di software, le attività di marketing e di assistenza alla clientela, le società di consulenza sono, non a caso, quelle che sono andate più avanti nella ricerca contemporaneamente di nuove forme di flessibilità d’orario e di nuove misure della prestazione. Si tratta spesso di aziende che hanno bisogno di massima flessibilità sul tempo perché hanno relazioni con clienti globali, lavorano su commesse a scadenza, devono gestire bisogni di assistenza tecnica non prevedibili. Gli sviluppi in questa direzione del lavoro dei professional hanno portato frequentemente alla soppressione del cartellino.
Micron, azienda di semiconduttori che ha in Italia uno stabilimento interamente dedicato alla progettazione, ha eliminato la timbratura per i quadri e sta per estendere lo stesso sistema ai settimi livelli. L’obiettivo dichiarato è di migliorare l’efficienza aziendale, migliorando contemporaneamente la conciliazione tra lavoro e famiglia. Per chi lavora sui progetti, il nuovo sistema fa leva sulla responsabilizzazione sui tempi di consegna (che vanno rispettati in modo stringente per evitare penali), quindi sulla eventualità di lavorare molte ore quando si è sotto scadenza a cui poi corrisponde la possibilità di prendersi due giorni o anche una settimana off, senza dover chiedere a nessuno. Per il gruppo di esperti del pronto intervento di manutenzione, è cambiato il sistema della reperibilità, ora regolato dalla presa in carico, a rotazione, di uno smartphone collegato alle macchine (che sono presso clienti dovunque nel mondo): il telefono squilla quando queste richiedono assistenza e il lavoratore reperibile deve rispondere, che sia notte o giorno, connettersi da dove vuole e risolvere il problema. Per i lavoratori delle qualifiche inferiori, il nuovo orario di lavoro prevede una fascia giornaliera molto ampia, dalle 6 alle 21, in cui il dipendente può collocare il suo orario di lavoro in misura non inferiore a sei ore giornaliere e secondo il consueto sistema di flexitime (trimestrale) a contatore: l’ampiezza della fascia giornaliera in cui le attività aziendali possono essere svolte elimina la necessità per l’azienda di ricorrere a turni di lavoro coprendo, quando necessario, richieste di assistenza più ampie da parte dei clienti. Leggendo l’accordo sia ha l’impressione di un impianto di regolazione dell’orario completamente ribaltato (non ha caso, l’accordo firmato deroga dal CCNL e “annulla e sostituisce ogni precedente accordo o prassi aziendale esistenti”) (Italia Lavoro, 2016; Della Rocca, 2017).
Come si vede, se il taylorismo aveva standardizzato gli orari e la produzione a magazzino aveva consentito di “linearizzare” l’anno, la settimana e la giornata di lavoro, ora il polmone di tempo-lavoro rappresentato da questo tipo di organizzazione è venuto meno: non abbastanza veloce, non abbastanza flessibile. La nuova economia chiede di lavorare solo ed esattamente quando serve. Anche se ciò vuol dire meno ore in alcuni periodi e magari molte di più in altri frangenti. Si ritorna ad alcuni caratteri
7
dell’organizzazione del lavoro pre-fordista, quando l’artigiano lavorava su ordinazione e il contadino doveva rispondere all’avvicendarsi delle stagioni e all’imprevedibilità degli eventi atmosferici. Com’è noto, il contadino non timbrava il cartellino...
Nelle aziende dove non c’è più l’obbligo di timbrare, è l’operatore stesso che certifica il tempo di lavoro impegnato, compilando un time sheet: una scheda elettronica, su un’agenda o su un portale aziendale, in cui si dichiarano i tempi lavorati nelle singole giornate (in genere divisi per tipo di attività, per progetto o per cliente) e che serve anche per la contabilità dei costi e per il controllo di gestione. In alcune attività più rutinarie che si svolgono online - telemarketing, assistenza clienti, registrazione buste-paga – al momento in cui il lavoratore a distanza si connette alla rete aziendale, il tempo che passa al lavoro viene registrato. In tutti i casi, cambia il ruolo del capo: da semplice supervisore, diventa organizzatore del lavoro dei collaboratori, con un’idea più precisa dei carichi di lavoro da assegnare, in grado di stabilire scadenze e di esercitare verifiche intermedie e finali sui risultati delle attività.
Dal punto di vista del sistema di controllo, mentre il vincolo al luogo di lavoro è superato facilmente dalle tecnologie che permettono di lavorare a distanza, il vincolo dell’orario di lavoro è meno facile da abolire completamente dato che, anche indipendentemente dal formale riferimento all’orario settimanale medio previsto dalla legge, il tempo lavorato continua a essere una misura importante della prestazione. Diventa però una misura meno stringente. I nuovi sistemi, infatti, mettono l’accento su altri aspetti della quantità e qualità della performance: il rispetto dei tempi di consegna, la prontezza di risposta a un guasto, l’esigenza di fare fronte a una richiesta non prevista del cliente o a tempi di espletamento di un’attività non pianificabile, un numero standard di clienti da seguire. Il dipendente “responsabilizzato” risolve le richieste di flessibilità oraria con la sua disponibilità e, sperabilmente, ottiene vantaggi simmetrici per la sua vita privata.
In conclusione, ci si avvia verso un sistema di controllo delle prestazioni non più basato sulla presenza, ovvero sulla dimensione in cui il tempo si salda col luogo di lavoro e con la supervisione diretta del capo (Ponzellini, 2017). Il sistema che sta emergendo dai nuovi paradigmi organizzativi è misto: mentre il riferimento all’orario diventa sempre più formale, si fa leva sull’interiorizzazione dell’obiettivo aziendale (la responsabilizzazione), sul nuovo ruolo dei capi e su misure di risultato. Un sistema più efficiente per l’impresa, apparentemente più “umanizzato” per il dipendente. Un sistema privo di rigidità ma forse più incerto dal punto di vista della tutela. Staremo a vedere5.
Si deve aggiungere che casi come Micron non solo rendono evidente superamento del vincolo al luogo di lavoro, del cartellino e delle consuete cadenze giornaliere e settimanali dell’orario, ma in qualche modo rendono superata tutta la regolazione degli orari: come si è visto sopra, con questo tipo di organizzazione si può eliminare il ricorso agli straordinari (e alle loro maggiorazioni); sono resi inutili i turni (perché si lavora su fasce di disponibilità a scelta); sono resi superflui i permessi (assorbiti dalla flessibilità dell’orario che consente di assentarsi anche senza precise giustificazioni).
5 Colpisce comunque, all’opposto, il caso di un recente accordo DHL. L’ambiente e il tipo di attività – consegna di
pacchi – sono certo molto lontani dai casi precedenti di attività del terziario avanzato. L’e-commerce ha provocato un’espansione enorme delle consegne e anche una maggiore complessità (essendo coinvolti destinatari privati, le merci vengono consegnate anche e soprattutto in orari unsocial e spesso ripetutamente). Molti fattorini e corrieri in precedenza erano lavoratori autonomi - “padroncini” con mezzo proprio, soci-lavoratori di cooperative, ecc. - e svolgevano il loro lavoro con ritmi intensi e un alto livello di autosfruttamento. DHL ha introdotto un’organizzazione digitalizzata dei magazzini e della distribuzione (carichi pianificati automaticamente sui palmari dei fattorini, assegnazione per zona in modo di aumentare l’efficienza) e ha scelto di contrattualizzare i suoi collaboratori come dipendenti allo scopo di programmare con più certezza le proprie attività. Questi adesso sono meno autonomi ma, sembrerebbe, godono di condizioni di lavoro migliori: orario certo, straordinari pagati, numero standard di consegne e ritiri, certezza del salario (Panara, 2017). Anche qui, staremo a vedere. Il confronto tra i due casi certamente mette in evidenza come il ruolo della contrattazione si sia fatto più complesso, non esista più un’unica strada buona per tutti i tipi di attività, tutti tipi di lavoratori. Va bene aprire strade nuove ma bisogna anche procedere per tentativi ed errori.
8
5. Il lavoro digitale6 e il tempo flessibilissimo (ma denso) del lavoratore autonomo su piattaforma
Il crowdworking è una modalità di lavoro che si sta diffondendo man mano le imprese diventano in grado di standardizzare una serie di operazioni e di esternalizzarle piuttosto che, come succedeva fino a qualche tempo fa, servendosi di una azienda di servizi o di un singolo collaboratore, accedendo ad una piattaforma sul web che le mette in contatto con “un gruppo indefinito e sconosciuto di individui in grado di risolvere problemi specifici o procurare loro servizi specifici o anche prodotti, in cambio di un pagamento” (Eurofound, 2015). La tecnologia è essenziale, sia perché il lavoro è prevalentemente fatto online, sia perché l’incontro tra lavoratore e cliente avviene attraverso la piattaforma digitale, sia anche perché il lavoro produce contenuti e valore per i proprietari delle piattaforme (Gandini, Pais e Beraldo, 2016).
Molto lavoro autonomo professionale - soprattutto le attività che hanno a che fare con la programmazione, con i contenuti multimediali, con la grafica web, con la costruzione di banche dati e l’analisi dei dati, ma anche con il marketing e la contabilità – è ormai lavoro svolto “in the cloud” e transita sulle piattaforme.7 Alcuni compiti sono semplici, come taggare immagini, rivedere dei testi, trascrivere audio clips, classificare siti web. Spesso comunque si tratta di attività mediamente qualificate che prevedono l’uso di svariati programmi, applicativi specifici e competenze specialistiche. E’ abbastanza prevedibile che in futuro il mercato del lavoro dei free-lance – in gran parte costituito da laureati – avverrà in larga misura sul web e, a giudicare dall’attuale funzionamento delle piattaforme, andrà incontro ad un ulteriore spezzettamento delle attività: per come si sta sviluppando ora, il lavoro digitale non prevede quasi mai rapporti di lavoro continuativo, solo in alcuni casi l’incarico è previsto per un intero progetto (che al massimo però comporta qualche centinaio di ore), il più delle volte si tratta di piccole attività spot.
Fatte queste premesse generali, vediamo di considerare gli aspetti che riguardano l’orario di lavoro dei crowdworkers. Trattandosi di una forma di lavoro molto recente, non sembra esistano ricerche che si siano soffermate su questo specifico aspetto. In linea di massima, la procedura prevede che un lavoratore iscritto alla piattaforma selezioni un’offerta di un’azienda ed entri in competizione con altri per aggiudicarsela: gli incarichi che si troverà di fronte saranno a volte brevi lavori spot pagati a forfait e a volte progetti più ampi per i quali viene stabilito un compenso orario (in genere, nell’ordine di qualche decina di dollari o meno, il compenso dipende anche dalla reputazione raggiunta dal lavoratore).
Negli incarichi “a forfait”, si riproduce la tradizionale situazione del lavoro autonomo, il cui tempo di lavoro non è calcolato.8 Negli incarichi “a tempo” – che sono quelli che qui ci interessano – la procedura prevede che il lavoratore, tutte le volte che accede alla piattaforma per svolgere la sua attività, attivi un’applicazione contatempo. Per impedire opportunismi (mi connetto e poi vado a bere il caffè...), il software di controllo registra l’attività che l’operatore sta facendo ogni dieci minuti, anche verificando i programmi che sta usando e che devono essere coerenti con l’attività pagata. Succede quindi che, quando si prende una pausa a volte anche solo per una sigaretta, l’operatore preferisca
6 In questo contesto, per “lavoro digitale” intendiamo la sua accezione più ristretta, ovvero il lavoro su piattaforma digitale, denominato anche “crowdworking”. 7 La piattaforma più importante è Amazon Mechanical Turk (350mila diverse attività), che intermedia principalmente lavoretti ripetitivi di data-entry, trascrizioni audio, taggaggio di immagini, ecc. Nel lavoro più professionale, principalmente di contenuti multimediali, traduzioni, analisi dei dati, Elance e oDesk, ora riuniti nella piattaforma Upwork, contavano, nel 2015, 10 milioni di clienti registrati che lavorano (ma non necessariamente a tempo pieno) per 4 milioni di imprese, 2700 diverse figure professionali attive in 180 Paesi. 8 Per scelta. In effetti, è proprio sulla previsione (giusta o sbagliata) di saper correre più veloce rispetto allo standard di tempo previsto per un determinato compenso, che il lavoratore autonomo basa la sua competitività.
9
spegnere il contatempo. Benché possa scegliere in completa autonomia quando lavorare,9con questa modalità di lavoro, il lavoratore si ritrova un tempo di lavoro puntigliosamente misurato e particolarmente denso: una condizione tipica del taylorismo e a cui il conflitto operaio aveva risposto con la richiesta di pause pagate.
Il pattern di lavoro “a tempo” su piattaforma sembra quindi far venire allo scoperto quanto la libertà goduta dai lavoratori free-lance sia controbilanciata da condizioni di lavoro non solo notoriamente meno tutelate ma anche in controtendenza con gli sviluppi positivi in termini di autonomia sul tempo di lavoro che abbiamo visto conquistata dai dipendenti. Sarà questo il nuovo modello di tempo nel lavoro free-lance sulle piattaforme digitali? Se così fosse, certamente è necessario immaginare delle forme di regolazione. Qualche giuslavorista suggerisce che sia il momento di arrivare ad una definizione più ampia di chi sia un lavoratore (worker), superando la separazione tra chi è subordinato (employee) e tutti gli altri che lavorano e introducendo tutele in tutti quei casi in cui si riscontri uno stato di dipendenza, che sia da un datore di lavoro o che sia da un cliente (Davidov, 2005).
Conclusioni. Tempo e tecnologia, libertà e regole
Il coworker Ikea può scegliere quando lavorare e conquistarsi così un migliore equilibrio tra vita e lavoro, ma il suo tempo di lavoro resta accuratamente misurato, anche perché la sua presenza in negozio è indispensabile per l’organizzazione per cui lavora... L’impiegata di Nestlè in smartworking un giorno la settimana o per qualche mese dopo la maternità, ha un capo che le ha assegnato dei precisi carichi di lavoro e glieli misurerà; deve essere raggiungibile al telefono nelle fasce orarie prefissate, anche se in qualche caso potrà farlo dai giardinetti dove ha accompagnato i bambini; è comunque contenta di risparmiare il tempo inutile del pendolarismo quotidiano... Il professional che lavora in una società di progettazione conosce gli obiettivi che deve raggiungere, gli standard di qualità e le scadenze da rispettare; si è abituato a gestire la sua attività secondo i ritmi che gli sono più consoni ma che devono essere anche efficienti per l’azienda, per cui non gli pesa tenere sotto controllo la posta anche la sera o nel week-end; per rendere conto del suo lavoro deve solo compilare, settimanalmente o mensilmente, il resoconto dettagliato delle attività prestate per il controllo di gestione; non chiede permessi per le visite mediche e, a volte, neanche per il solito doppio a tennis del mercoledì pomeriggio, ma quando è sotto scadenza non ci sono né sabati né domeniche... Lo studente che lavora sulla piattaforma Upwork vende a buon prezzo un servizio di data-analytics che conosce bene e quindi sa fare velocemente; lavora nei tempi liberi tra un esame e l’altro e magari anche in viaggio mentre va a trovare amici in giro per il mondo; ogni tanto pensa che lavorerà così per sempre e comunque, per ora, non gli pesa più che tanto che mentre è online il suo tempo-macchina sia insistentemente monitorato... In soli pochi anni, le tecnologie, i mercati e la pressione dei lavoratori per un migliore equilibrio tra vita e lavoro hanno aperto spazi, prima inimmaginabili, di flessibilità per le imprese e di libertà per chi lavora. Molti lavoratori hanno conquistato la possibilità di scegliere quando collocare il loro tempo di lavoro, pur dentro i vincoli dei risultati attesi, e la loro vita personale ne è molto migliorata. In molte occupazioni il riferimento all’orario di lavoro è diventato meno stringente, addirittura solo formale in quelle attività in cui sono più sviluppati i sistemi di valutazione della prestazione e i sistemi di controllo di gestione. Il lavoro da remoto ha rafforzato questa tendenza e il controllo della presenza si rivela in molti casi ormai inutile.
Tuttavia, il venire meno dei limiti precisi dell’orario fordista ha aperto alcuni rischi. Il primo è quello di un’invasione incontrollata del lavoro nella quotidianità. Qui il problema non sta tanto nella crescente sovrapposizione/interferenza tra le attività lavorative e le attività personali e di cura – che forse è semplicemente un ritorno a una (augurabile) quotidianità pre-fordista – quanto nella necessità, per i
9 Non a caso, il lavoro su piattaforma è prevalentemente prestato nel tempo libero da giovani occupati ad alta scolarità per rimediare reddito aggiuntivo (del tipo degli informatici “moonlighters” negli anni Ottanta e Novanta), oppure da studenti, disoccupati o lavoratori dipendenti in congedo parentale (Eurofound, 2015).
10
lavoratori, di riprendere quella capacità di autogestire il proprio tempo di lavoro che il fordismo aveva loro sottratto e, per il sindacato, di aprire spazi di negoziazione, più che su generici richiami al “diritto alla disconnessione”, sulle specifiche condizioni della loro reperibilità. Com’è stato detto, le nuove organizzazioni hanno sostituito il paradigma taylorista de “l’uomo giusto al posto giusto” con quello de “l’uomo giusto al tempo giusto” (Della Rocca, 2017): perché questo imperativo non diventi totale acquiescenza alle ragioni d’impresa e la qualità del lavoro peggiori rispetto a prima, le ragioni e i vincoli di questa disponibilità vanno accuratamente vagliate e regolate (e non soltanto monetizzate). Il secondo rischio, riguarda il controllo del lavoro esercitato da remoto attraverso le tecnologie. L’eliminazione della presenza come forma di controllo della prestazione va considerata un passaggio positivo verso quella libertà “nel” lavoro di cui parlava Bruno Trentin. Non ha senso immaginare un ritorno indietro. Non ha senso neppure immaginare che le imprese non sostituiscano il controllo tramite la presenza con le altre forme di controllo permesse dalle tecnologie: sarà quindi utile agevolare le tecnologie che abilitano la libertà di chi lavora e, nel contempo, entrare concretamente nel merito del “controllo digitale” che, come nell’accordo Nestlè, ci deve essere ma non deve essere lesivo della privacy.
In generale, l’autonomia sul proprio orario di lavoro sta avvicinando la condizione del lavoratore subordinato a quella del lavoratore autonomo. Contemporaneamente, tuttavia, il lavoro dei free-lance sulle piattaforme rischia di portare il lavoro autonomo verso i sistemi di controllo tipici del lavoro subordinato. Più in generale, il lavoro online “a tempo” - che abbiamo esaminato nel caso delle piattaforme ma che dobbiamo attenderci si diffonda in molte attività esercitabili da remoto anche da parte di lavoratori dipendenti – merita qualche intervento regolatorio, se non si vuole che i margini di autonomia conquistati si traducano in un peggioramento della qualità del lavoro. Infine, man mano viene superato il vincolo della presenza e la misura dell’orario perde la sua consistenza, sembra tempo di immaginare figure e soluzioni organizzative ibride tra lavoro subordinato e lavoro autonomo.
Bibliografia
Chiesi A. (1985), Il tempo di lavoro: un modello di domanda-offerta, Quaderni IRES Lombardia.
Davidov G. (2005), “Who is a worker?”, in Industrial Law Journal, Volume 34, Issue 1, 1 March 2005, p. 57–71
Della Rocca G. (in corso di pubblicazione), “Il lavoro in digitale, il tempo e gli orari: la crisi del sistema degli orari standard”, in A. Cipriani, A. Gramolati, G. Mari (a cura di), Lavoro 4.0. Le trasformazioni delle attività lavorative nelle IV rivoluzione industriale
Eurofound (2015), New forms of employment. Crowd employment. https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/crowd-employment
Gandini A., Pais I. and Beraldo D. (2016), Reputation and trust on online labour markets, in “Work organization, labour & globalisation”, Vol.10, Number 1, Spring
Lehndorff S. (1999), From collective to individual reduction in working time? Trends and experiences with working time reduction in the European Union, in “Transfer”, vol.4, n.4.
Italia Lavoro (2016), Progetto Equipe2020, http://www.equipeonline.it
Marchetti A. (2010), Il tempo e il denaro. Saggi sul tempo di lavoro dall’età classica all’epoca della globalizzazione, Milano, Franco Angeli
11
Panara M. (in corso di pubblicazione), “Caso DHL. Intervista”, in A. Cipriani, A. Gramolati, G. Mari (a cura di), cit.
Pero L. e Ponzellini A.M. (2015) “Il nuovo lavoro industriale tra innovazione organizzativa e
partecipazione diretta”, in D.Carrieri, P.Nerozzi e T.Treu (a cura di), La partecipazione incisiva. Idee e
proposte per rilanciare la democrazia nelle imprese, Il Mulino, Bologna
Pero L. (2002), I menù alla francese e gli orari di lavoro flessibili, in “Sviluppo e Organizzazione”, Vol.192, pp. 33-46.
Ponzellini A.M. e Tempia A. (2003), Quando il lavoro è amico. Aziende e famiglie: un incontro possibile, Edizioni Lavoro, Roma
Ponzellini A.M. (2006) (a cura di), Quando si lavora con le tecnologie. Donne e uomini nelle professioni dell’Information & Communication Technology, Edizioni Lavoro, Roma
Ponzellini A.M. (2017), “Tempo di lavoro scelto: produttività e qualità della vita”, in Carlo Dell’Aringa,
Claudio Lucifora, Tiziano Treu (a cura di), Salari, produttività, disuguaglianze. Verso un nuovo modello
contrattuale?, AREL-il Mulino, 2017.
Webster J. (2004), “Lessons from practices improving women’s place in ICT professions”, in G. Valenduc (ed.) Widening Women’s Work in Information and Communication Technologies, Fondation Travail Université, Namur
1
IL TEMPO DI LAVORO SCELTO: PRODUTTIVITA’ E QUALITA’ DELLA
VITA
Anna M. Ponzellini
Una versione riveduta di questo testo è stata pubblicata in: Carlo Dell’Aringa, Claudio Lucifora,
Tiziano Treu (a cura di), Salari, produttività, disuguaglianze. Verso un nuovo modello
contrattuale? , AREL-il Mulino, 2017.
1. INTRODUZIONE
La letteratura organizzativa ha da tempo evidenziato come, sia nell’industria che nei servizi, la
flessibilità dell’orario sia una delle leve più importanti per l’aumento delle performance delle
imprese. Periodiche rilevazioni sulle condizioni di lavoro e la letteratura sul work-life balance
(WLB) ci confermano che la possibilità di lavorare negli orari più conciliabili con la propria vita
personale e familiare è uno dei desideri più sentiti da quote crescenti di lavoratori, a cominciare
dalle donne. Tuttavia, differentemente da una buona parte dei Paesi con i quali competiamo nei
mercati e ai quali abbiamo l’ambizione di paragonarci in termini di sistema sociale, in Italia alla
prova dei fatti perdurano orari di lavoro rigidi e mal regolati che tengono in scacco efficienza delle
imprese e qualità della vita di lavoro.
L’ipotesi di questo mio lavoro è che su questo gap pesi, oltre al ritardo delle imprese nell’adeguare i
sistemi organizzativi alle nuove condizioni della produzione e dei mercati, il fatto che la cultura
sindacale fa fatica ad allontanarsi da una rappresentazione standardizzata del lavoratore come
“maschio capofamiglia” e che questo abbia contribuito a mantenere nei contratti nazionali le norme
d’orario tipiche del sistema taylor-fordista e a ispirare la contrattazione aziendale della flessibilità
alla monetizzazione piuttosto che alla ricerca di reciprocità tra bisogni di flessibilità d’impresa e
bisogni sociali.
2. IL TEMPO STA PERDENDO TERRENO COME MISURA DEL LAVORO
Il tempo sta perdendo terreno come misura del lavoro (e quindi del salario), a favore di misure di
risultato. Questo sta succedendo per due buoni motivi. Il primo riguarda l’impresa e la sua crescente
consapevolezza che la performance di un lavoratore, soprattutto nelle attività a più elevato valore
aggiunto, non è solo funzione del tempo dedicato ma anche della qualità della prestazione. Il
secondo riguarda chi lavora e la sua crescente esigenza di liberarsi dal vincolo del “cartellino” per
2
organizzare al meglio le combinazioni da un lato tra tempo impegnato nel lavoro e remunerazione e
dall’altro tra tempo dedicato al lavoro e tempo delle attività personali e di cura. Lo stesso fenomeno,
sia pure ambivalente, della recente crescita del lavoro autonomo professionale in tutti i paesi
avanzati – nonché del suo consolidarsi come componente strutturale del sistema produttivo italiano
- ha una delle sue forze trainanti nella ricerca da parte di molte persone di spazi di intraprendenza e
auto-organizzazione della propria attività (Ranci, 2012). In generale, comunque, aumentano i
segnali della fine di quello stretto rapporto tra orario e salario che ha caratterizzato l’epoca taylor-
fordista.
Può anche essere che, col tempo, una parte dei lavoratori realizzi un maggiore controllo sul tempo
uscendo tout court dal lavoro subordinato. Tuttavia, quello che ci preme analizzare è quello spazio
di autonomia organizzativa e dell’orario compatibile già da ora con la regolazione del lavoro
dipendente. Qui è tradizionalmente la “presenza” – ovvero la dimensione in cui il tempo si salda al
luogo di lavoro – che funziona come la misura di controllo standard del lavoro. Le misure di
risultato, infatti, prevedono sistemi di controllo più complessi del combinato disposto tra timbratura
del cartellino e supervisione del capo (oppure, in qualche caso, ritmo della linea di montaggio) che
caratterizza il vecchio paradigma. Non a caso, sistemi basati sul rapporto fiduciario e su valutazione
“secca” dei risultati stanno prendendo piede molto lentamente e per il momento solo per le
qualifiche apicali, dove cominciano a essere aboliti il calcolo degli straordinari e l’obbligo del
badge o della firma. Per gli altri lavoratori, la fase di transizione verso una maggiore
autodeterminazione dell’orario è quella della flessibilità, sia del tempo che del luogo di lavoro.
Anzi, dell’incontro tra la flessibilità richiesta dall’impresa e la flessibilità desiderata da ciascun
lavoratore. Un incontro difficile ma non impossibile.
3. DALLA CONTRAPPOSIZIONE DELLE FLESSIBILITÀ A UNA GESTIONE DEL
TEMPO DI LAVORO COME MODELLO DI DOMANDA E OFFERTA
Ci concentreremo qui sulla flessibilità degli orari, pur consapevoli del fatto che questa, ove
possibile (certamente non dietro il banco di un negozio o su una linea di montaggio), apre la strada
a forme di flessibilità del lavoro più ampie che comprendono anche il luogo dove si lavora, come
nel caso di telelavoro e smartworking.
La flessibilità dell’orario di lavoro è guidata da grandi trends dell’economia e della società. Dal
versante dell’economia sono due i principali processi in corso. Il primo riguarda la produzione
industriale la cui domanda, nei mercati globali, è diventata sempre più imprevedibile e sottoposta a
competizione sui costi. I nuovi paradigmi organizzativi hanno trovato risposte a questi cambiamenti
3
attraverso sistemi come il just in time, il miglioramento continuo e la riduzione degli sprechi (siano
essi spazi di stoccaggio, impianti insaturi o risorse umane non ben utilizzate). Sul piano
dell’organizzazione e della razionalizzazione del costo del lavoro, l’imperativo di rispondere
tempestivamente ai picchi e ai flessi della domanda di mercato, sia evitando di accumulare scorte
nei magazzini sia rispettando con precisione le scadenze imposte dal cliente, comporta l’aumento
delle ore di lavoro in alcuni momenti e riposi forzati in altri, oltre che una pianificazione del lavoro
più a breve termine (che si scarica in parte sui dipendenti).
Il secondo riguarda la terziarizzazione dell’economia con l’enorme espansione del settore dei
servizi, alle imprese ma soprattutto alle persone, che funzionano con regimi di apertura
progressivamente più lunghi, spesso tendenti alle 24h su 24h. Tutto il lavoro che ha a che fare con
clienti e utenti – trasporti, uffici pubblici, ospedali, supermercati, banche, ristoranti, servizi alle
persone – deve infatti adeguarsi alle esigenze dei consumatori: flussi giornalieri e settimanali di
clientela in un magazzino o di chiamate in un call-centre, domanda di assistenza in alcune ore
precise della giornata, domanda di turismo solo in alcuni mesi dell’anno (ma per molte ore
giornaliere), progetti a scadenza nella gran parte del terziario avanzato... Ne consegue che le attività
terziarie, se vogliono guadagnare efficienza nell’uso delle risorse, finiscono per dover imporre ai
dipendenti le fasce orarie nella giornata o le giornate della settimana in cui lavorare, compresi orari
serali, sabati, domeniche.
Sul versante della società, gli ultimi trent’anni hanno visto un cambiamento epocale realizzarsi nella
femminilizzazione del mercato del lavoro. L’entrata delle donne nel lavoro, benché ancora non
pienamente compiuta nel caso italiano, ha posto con forza il problema della conciliazione tra tempo
di lavoro e tempo per la famiglia e ha originato una pressione da parte di molte lavoratrici verso
soluzioni di orario ridotto, ingresso e uscita flessibile dal lavoro, rifiuto di alcuni turni e preferenza
per altri... Nel tempo, l’espansione del lavoro femminile ha generato una cultura di condivisione
della cura tra uomini e donne e progressivamente, anche a causa della concomitante crescita della
personalizzazione degli stili di vita, la richiesta di un buon equilibrio tra lavoro e vita e di una più
autonoma gestione del tempo di lavoro è diventata un obiettivo importante, al di là del genere, per
una platea amplissima di lavoratori.
La ricerca di flessibilità del tempo di lavoro ha dunque origini diverse: risposta alla variabilità dei
mercati e alla personalizzazione dei servizi, necessità di tenere sotto controllo i costi di produzione,
articolarsi delle preferenze dei dipendenti. Esigenze dal lato dell’impresa e da quello dei lavoratori.
I risultati dell’esperienza organizzativa e normativa degli ultimi vent’anni suggeriscono che la
risposta più efficace non sta nella loro contrapposizione, né nell’adozione di misure specifiche per
4
fasce protette di lavoratori. In entrambi i casi, infatti, il gioco negoziale tra azienda e dipendenti è
risultato al massimo uno scambio a somma-zero: una monetizzazione del disagio dei lavoratori, che
comunque alza i costi per le imprese senza dare ai dipendenti maggiore libertà; una tutela per i
caregiver, ma limitata al perimetro specifico degli “aventi diritto”, che ha costi che le imprese
traducono presto o tardi in discriminazione.
4. DESTANDARDIZZARE L’ORARIO RICHIEDE INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA
Secondo un approccio che condivido, la risposta più efficace sta piuttosto in un processo di
complessiva destandardizzazione dell’orario di lavoro. Si tratta cioè di superare l’idea stessa
dell’orario “normale” - quello delle otto ore al centro della giornata, per cinque giorni la settimana,
per più o meno quarantotto settimane l’anno – che è poi l’orario che ha scandito il lavoro del
Novecento non solo nella fabbrica ma negli uffici privati, nelle banche e in gran parte degli uffici
pubblici. Andare oltre l’orario standard, significa immaginare - e poi organizzare e regolare - la più
vasta possibile articolazione degli orari, sulla base di schemi che raccolgano da un lato le preferenze
dei lavoratori, ovvero l’”offerta” di tempo, dall’altro le preferenze delle imprese, ovvero la
“domanda” di tempo di lavoro (Chiesi, 1985). Si produrrebbe così un mercato degli orari di lavoro
che, nel medio termine, potrebbe teoricamente permettere a ogni domanda di trovare la relativa
offerta e viceversa. Un incontro di mercato (o quasi), che spetta però alle relazioni industriali
promuovere e governare.
Non a caso, sia pure a velocità differenti, il processo di destandardizzazione degli orari è in corso in
tutti i Paesi avanzati. In qualche misura si può dire che ha sostituito il processo di riduzione
generalizzata degli orari che ha caratterizzato le politiche sindacali sul tempo di lavoro nel corso del
Novecento. Si tratta di un passaggio non semplice, che ha implicazioni non banali dal punto di vista
della organizzazione d’impresa: coinvolge il sistema tecnologico, quello della organizzazione dei
processi di lavoro ma anche, e forse di più, il sistema di pianificazione e controllo. Gli orari non-
standard, infatti, rompono l’unità del controllo tradizionale fondato sul rapporto tra tempo-presenza
e salario. Già il semplice avvicendamento del lavoro in turni o l’orario flessibile in ingresso e uscita
incrinano l’efficacia del controllo esercitato in base a supervisione diretta; così come gli orari
inferiori alle normali otto ore giornaliere mettono in discussione il riferimento ai carichi di lavoro
“normali”. Entrambe queste uscite dai sistemi tradizionali postulano altre forme di controllo (o di
autocontrollo). Non a caso, da un lato si stanno progressivamente affermando sistemi di valutazione
delle prestazioni non più esclusivamente basati sulla presenza ma sull’affidamento di attività
misurabili in termini di volumi, scadenze, standard di qualità (ultimamente anche su spinta della
applicazione dello smartworking). Dall’altro, all’interno di un processo generale di delega e
5
riduzione della gerarchia, si sperimentano cambiamenti a livello di microstrutture – per esempio, la
creazione di team dotati di alcune autonomie – che permettono di gestire in modo decentrato una
pianificazione degli orari che diventa più complessa.
5. LE DUE DIMENSIONI DELLA FLESSIBILITÀ DELL’ORARIO: DURATA E
COLLOCAZIONE
Per capire le direzioni del cambiamento, va innanzitutto chiarito che la flessibilità dell’orario si
declina su due assi, quello della “durata” e quello della “collocazione” del tempo di lavoro. La
flessibilità della durata comprende gli schemi che prevedono la variazione in meno (riduzione
generalizzata o contratti part time) o in più (orario straordinario) dell’orario standard.
Il part time è un tipo di orario spesso richiesto dai dipendenti, di solito dalle donne, per conciliare
meglio il lavoro con la vita familiare, anche se in anni più recenti in taluni comparti - come la
grande distribuzione, i call centres e i servizi alle famiglie - è diventato lo schema d’orario
largamente preferito, perché più efficiente, dalle stesse aziende. Com’è noto, il part time è
diffusissimo fin dagli anni Sessanta nei Paesi Scandinavi, dove la combinazione tra orario ridotto e
occupazione nei servizi pubblici costituisce la modalità prevalente del lavoro femminile (circa tre
donne su quattro lavorano sei ore o meno al giorno): un modello che secondo alcuni sociologi
sarebbe valido anche per il nostro Paese (Esping Andersen, 1990), anche se ultimamente non è
esente da critica per gli evidenti effetti di segregazione di genere sul mercato del lavoro. In tempi
più recenti (anni Novanta), i Paesi Bassi hanno optato per la diffusione di una formula più paritaria,
quella di “un reddito e mezzo per famiglia” ovvero combinazioni di part time verticali (tre o quattro
giorni settimanali) che consentissero alle coppie di dividersi al meglio tra lavoro e cure parentali:
attualmente quasi un olandese su due lavora a part time (gli uomini meno delle donne, comunque).
Aldilà delle formule specifiche che lo connotano, alcuni osservatori hanno letto nella diffusione del
part time che ha caratterizzato molti Paesi nella seconda metà del Novecento, una prima fase,
transitoria, dell’evoluzione della partecipazione femminile al mercato del lavoro (Bosch, 1999),
oppure anche una risposta alla frenata che ha subito il processo di riduzione generalizzata degli
orari di lavoro in Europa, nel senso di “uno slittamento dalla strategia collettiva a strategie
individuali di riduzione dell’orario di lavoro” (Lehndorff, 1999).
Tuttavia, in Italia e in parte anche in altri Paesi come Francia e Germania, questo schema d’orario
ha attecchito con difficoltà. Forse a causa della non disponibilità dei servizi pubblici di adottare con
più decisione questa formula organizzativa (anche se, in qualche modo, gli orari mattutini compatti
in gran parte delle pubbliche amministrazioni e gli orari ridotti degli insegnanti ne hanno
6
rappresentato un sostituto funzionale) o forse, più semplicemente, a causa delle difficoltà delle
imprese, specialmente le piccole, a uscire dalla comodità dell’orario standard. Comunque, come si
vede dalla Figura 1, negli ultimi anni vi è stato in Italia un discreto aumento di lavoratori part time,
che hanno portato nel 2015 la nostra percentuale vicina alla media europea (18.3 contro 19.6; per le
donne, 32.3 contro 32.1).
Stiamo però assistendo a un fenomeno controverso. Le analisi incrociate tra rilevazione delle forze
di lavoro e dati amministrativi ci dicono che sono cresciuti particolarmente due fenomeni, almeno
in parte collegati: quelli dei “falsi part time”, per cui circa un quarto dei part time rilevati, e molti di
più tra i maschi, corrisponde in realtà a posti a tempo pieno solo in parte regolarizzati (De Gregorio
e Giordano, 2014) e quello del “part time involontario” (lavoratori che avrebbero preferito un orario
standard). Se ne può concludere non solo che l’incidenza effettiva del part time in Italia è ancora più
contenuta di quanto non emerga dalla statistiche, ma anche che la crescita della domanda di orario
non-standard da parte delle organizzazioni aziendali non sta andando nella direzione di un incontro
con la domanda di conciliazione: se infatti guardiamo la Figura 2, possiamo rilevare che, se ormai
quasi una donna su tre lavora part time, oltre l’80% di queste risultano però involontarie (Eurostat,
2015).
7
All’opposto, e se vogliamo anche curiosamente, la variazione della durata dell’orario “in aumento”
– il cosiddetto straordinario - è assolutamente consueta nei nostri settori manifatturieri e dei servizi:
a causa della diversità delle norme che regolano l’orario normale nei diversi Paesi è difficile avere
dati comparati sulle ore straordinarie lavorate, tuttavia i data base internazionali segnalano ore
lavorate in Italia superiori alle media europea (AMECO, 2016). Lo straordinario, concepito
originariamente per affrontare situazioni eccezionali, in Italia è via via diventato abituale in molte
aziende incapaci di affrontare la crescente domanda di flessibilità delle produzioni e dei servizi
attraverso formule meno primitive e controproducenti dal punto di vista organizzativo (Pero e
Ponzellini, 2012). Non è estranea a questo fenomeno una pressione dei lavoratori verso
quell’aumento delle retribuzioni che in alcuni periodo il sindacato non è stato in grado di realizzare
attraverso regolari aumenti delle paghe tabellari. Ne deriva che gli straordinari hanno finito per
costituire forse il più importante fattore di flessibilità salariale, ma restano strumento di flessibilità
organizzativa discutibile. Inoltre non rappresentano certamente una leva per l’incontro tra bisogni di
flessibilità dei tempi produttivi e dei tempi sociali: anzi, oltre a costituire una delle maggiori cause
del gender pay-gap, rischiano di essere causa di una vera e propria selezione avversa
all’occupazione femminile, vista la minore propensione delle donne, e in generale dei caregivers, a
lavorare oltre l’orario contrattuale.
L’altro asse della destandardizzazione è quello della collocazione dell’orario di lavoro. Un esempio
classico di variazione della collocazione (giornaliera) dell’orario è rappresentato
dall’avvicendamento del lavoro in turni, forma di flessibilità che si diffonde presto, fin dagli anni
Settanta, nella manifattura italiana e risponde alla necessità delle imprese di saturare l’uso degli
10,3 13,4 14,6 15,3 15,4 15,4 15,5 18,3 21,5 26,6 28,8 30,5 30,8 31,0 32,2 32,7 33,0 36,2
39,9 42,4 43,8 51,0
56,6 61,7
70,2 71,9 76,6 78,6 81,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
Fonte: Eurostat
Figura 2 – Donne occupate in part - time involontario (15 - 64 anni) nei paesi dell’Unione europea – Anno 2015 (incidenza percentuale sul totale degli occupati in part - time)
8
impianti. Nel terziario, la turnistica invece si è diffusa per la necessità affrontare orari giornalieri e
settimanali di apertura progressivamente più lunghi. Benché altri sistemi, e anche la medicina del
lavoro, ritengano più opportuno il lavoro su turno fisso, nel nostro sistema contrattuale è previsto
l’obbligo di avvicendamento nei diversi turni compreso, quando c’è, il notturno. Il risvolto sociale
del lavoro a turni è ambivalente: da un lato, lavorare la notte o anche cambiare continuamente
bioritmo costituisce sicuramente uno stress fisico, dall’altro, la compattezza dell’orario lo fa
diventare spesso persino preferibile da chi ha impegni di cura. Come nel caso dello straordinario,
comunque, la contrattazione ha risolto il disagio attraverso un’incentivazione monetaria
rappresentata dall’“indennità di turno” (che quasi raddoppia nel caso di turno notturno), piuttosto
che cogliere l’opportunità di gestire l’incontro tra preferenze potenzialmente diverse.
Tra le altre forme di flessibilità della collocazione degli orari, la flessibilità giornaliera (“flexitime”)
– ovvero la possibilità per le persone di variare l’orario di ingresso e in uscita – in Italia è diffusa
molto meno della media europea (solo poco più di un terzo di lavoratori può usufruirne), è meno
ampia di quanto prevista in altri Paesi ed è sostanzialmente confinata ai lavori dove è più banale la
sua applicazione, ovvero alle attività di ufficio. Invece, la flessibilità su base annua, che riguarda
prevalentemente il lavoro operaio, è diffusa in tutto il sistema manifatturiero secondo la formula
degli “orari multiperiodali”, che prevedono la possibilità di aumentare l’orario settimanale in alcune
settimane e ridurlo in altre sulla base di limiti di ore e di indennità definiti nei contratti nazionali.
Tuttavia in questo caso l’orario, sia in superamento che in recupero, resta strettamente governato
dalle esigenze delle imprese: infatti, a differenza che in molti altri Paesi europei, non c’è legame tra
orario multiperiodale e “banca delle ore”, intesa come possibilità per i lavoratori di accumulare ore
a debito e a credito e di usufruirne poi secondo proprie esigenze (mentre quella che nei CCNL
italiani viene denominata banca delle ore è un istituto più ridotto, collegato alla possibilità di
parziale recupero delle ore straordinarie prestate).
È proprio questa difficoltà di fare sintesi del sistema degli orari multiperiodali con il sistema di
banca ore e con il flexitime giornaliero – rendendo dunque la flessibilità su base annua
reciprocamente fruibile da azienda e dipendenti - che viene confermata dai risultati della Third
European Company Survey sulle pratiche manageriali di orario flessibile nelle aziende europee.
Come si vede dalla Figura 3, che combina tre tipi di diversa ampiezza di flessibilità, l’Italia risulta
tra gli ultimi Paesi nell’uso di flessibilità su scelta del dipendente, collocandosi ben sotto la media
europea, al ventitreesimo posto (e avendo persino perso qualche posizione rispetto all’analoga
survey del 2009). Un assetto degli orari decisamente antiquato e scarsamente employee-friendly.
9
6. FLESSIBILITÀ DEGLI ORARI E PERFORMANCE D’IMPRESA
Si sta affermando la tesi che il cambiamento organizzativo in direzione della destandardizzazione
degli orari di lavoro possa rappresentare non solo un miglioramento della vita per chi lavora ma
anche un fattore di competitività per quei Paesi e quei sistemi che sono in grado di utilizzarne al
massimo il potenziale. È questa anche l’ipotesi della European Company Survey, che ha creato una
tipologia di aziende - distinguendole in limited, selective, encompassing - a partire dall’uso più o
meno ampio di tre istituti di flessibilità: part time, flexitime e possibilità di accumulare ore per
utilizzarle in seguito (ovvero il sistema di banca ore nella sua formulazione di reciprocità).
Dall’indagine intanto risulta che le aziende italiane si collocano sopra media europea nel tipo
“limited” (una sola forma di flessibilità e applicata a un numero non elevato di dipendenti).
L’analisi mette poi in relazione l’indice di flessibilità con la performance d’impresa e con il
benessere dei lavoratori e raggiunge la conclusione che solo le aziende che applicano
contemporaneamente le tre pratiche hanno sia buoni risultati di performance che buoni risultati di
benessere nel luogo di lavoro, mentre un’applicazione selettiva delle pratiche e in particolare
l’applicazione di una sola pratica (in questo caso, probabilmente il solo part time) sembra avere
risultati simili per la performance d’impresa ma inferiori per il benessere dei lavoratori (European
Company Survey, 2015).
Sullo stesso tema uno studio dell’Osservatorio EurWork (basato su casi aziendali in quattro Paesi
europei): qui emerge chiaramente che la forma di flessibilità che ha una relazione più diretta sulla
performance d’impresa è la banca delle ore, perché consente ai lavoratori di disporre meglio del
10
proprio orario e alle aziende di allineare il numero di ore lavorate all’effettivo variare della
domanda di lavoro (Eurofound, 2012). Conclusioni simili sul rapporto tra flessibilità e produttività
arrivano da un rapporto dell’ILO che, analizzando i risultati di molti studi e ricerche empiriche,
conclude che la possibilità per i lavoratori di usufruire di schemi flessibili di orario aumenta la
produttività del lavoro, fondamentalmente per due ragioni - abbassa l’assenteismo e aumenta la
retention dei lavoratori (quindi ottimizza l’investimento in capitale umano) - ma anche perché
riduce lo stress e migliora la motivazione, fattori che comunque hanno buoni effetti sulla
performance (ILO, 2012). Proprio sul rapporto tra numero di ore lavorate, fatica/stress e
produttività, sembra insistere uno studio dell’OCSE che, in base alla costruzione di uno specifico
indicatore di produttività - il PIL per ora lavorata – il cui andamento è analizzato nel periodo 1990-
2015, evidenzia come nei Paesi dove si lavorano meno ore, per esempio la Germania, la produttività
sia più alta (OECD, 2016). Più in generale, gli studi di management includono da sempre la
flessibilità dell’orario di lavoro tra le pratiche ad alta performance (HPWP) (Black and Lynch,
2004).
7. NORME OSTILI E RELAZIONI DI LAVORO CONFLITTUALI NON AGEVOLANO
LE SOLUZIONI DI FLESSIBILITÀ
Cosa troviamo nei contratti nazionali italiani, al capitolo “orario”? Part time vincolato da tetti,
flexitime riservato agli impiegati, flessibilità annua esigibile solo dall’impresa… In compenso,
straordinari resi molto appetibili dalle maggiorazioni anche se poco performanti e lavoro in turni
avvicendati ben remunerato ma senza possibilità di scelta. In poche parole, la tipica regolazione
dell’assetto organizzativo fordista basato su volumi produttivi stabili, risorse altamente
intercambiabili e sul lavoratore-maschio-standard: una organizzazione del lavoro nella quale
l’orario “normale” garantiva una elevata prevedibilità della prestazione per entrambi i contraenti, le
eccezioni andavano adeguatamente ricompensate, la possibilità di scelta esclusa da un paradigma
organizzativo ispirato alla filosofia della one-best-way.
Non solo. La rigida normativa dei CCNL produce al livello aziendale un processo estenuante di
micro-contrattazione: nella cultura ancora conflittuale che caratterizza il nostro sistema di relazioni
industriali, infatti, ogni richiesta di modifica dell’orario viene vissuta come una “eccezione” al
vecchio paradigma organizzativo, che quindi va o monetizzata con un’indennità - ne fa fede la
contrattazione aziendale della flessibilità degli orari che è diventata un capitolo cospicuo della
contrattazione del salario - o di cui va ridotta la portata attraverso l’apposizione di vincoli, tetti
massimi, condizioni di utilizzo. Questo vale anche per le esigenze di flessibilità più banali, come
quelle dei picchi e flessi produttivi causati dall’andamento delle commesse o indotte dai sistemi di
11
pianificazione della produzione regolati dal just in time, che andrebbero invece considerate la nuova
normalità. Un sistema di gestione degli orari scoraggiante per le organizzazioni. Tanto che c’è da
chiedersi fino a che punto possa essere adatto a regolare le dinamiche della produzione Industry 4.0
e dei servizi on-demand nell’era della mass customisation.. ma anche i tempi personali delle donne
e degli uomini nell’era delle famiglie dual-earner/ dual-caregiver.
8. WORK-LIFE BALANCE: RETORICA DELLA TUTELA PIUTTOSTO CHE
CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO PER TUTTI
Un secondo ostacolo a una buona regolazione della flessibilità è (stato) lo scarso interesse delle
relazioni industriali per il tema dell’equilibrio tra vita e lavoro e per le sue implicazioni
organizzative. In realtà, non solo il tema del work-life balance in Italia è arrivato tardi nella
contrattazione, è stato inserito nel filone della tutela delle lavoratrici-madri e in generale nelle
politiche di promozione dell’occupazione femminile ed è quindi stato interpretato prevalentemente
come insieme di protezioni per soggetti deboli, da indirizzare “alle mamme” (dopo la legge
903/1977, almeno formalmente anche ai padri). Ma soprattutto è successo che, quando la normativa
WLB arrivava a toccare gli orari - per esempio nel caso di congedi, permessi, condizioni per la
trasformazione del rapporto dal tempo pieno al part time, esenzione da alcuni turni - veniva
comunque concepita, e scritta nei contratti, come separata dai normali istituti di flessibilità
dell’orario.
D’altra parte, le politiche di WLB sviluppate a partire dagli anni Novanta dalle grandi aziende, si
sono prevalentemente ispirate a una filosofia organizzativa – quella del diversity management –
basata sull’assunto di una diversità di interessi tra i generi, che ne ha favorito una applicazione
riservata e specifica (Ponzellini e Riva, 2014). Nel tempo, l’esperienza ha evidenziato che puntare
troppo su norme specificamente indirizzate alle donne favorisce la creazione di ghetti che, alla fine,
le penalizzano (un esempio per tutti: dove sono state applicate forme di part time riservato alle
madri, queste hanno poi impedito loro qualsiasi carriera). Col tempo è diventato evidente che la
contrattazione del WLB è stata ispirata più da assunti di principio che da una realistica
considerazione dei costi: questa è stata una delle ragioni del suo modestissimo successo, non
essendo riuscita a varcare il perimetro delle grandi multinazionali o delle aziende di servizi pubblici
(Ponzellini, 2006).
Non stupisce quindi che sia stata proprio la crisi a proporre negli anni più recenti una chiave nuova
per guardare al WLB, evidenziando come la leva degli orari, e l’attenzione alle preferenze dei
soggetti, costituisca uno strumento formidabile per realizzare l’incontro tra obiettivi produttivi e
12
obiettivi sociali. I casi che proponiamo nel paragrafo successivo danno un’idea di come si stiano
sviluppando il confronto e le sperimentazioni nei luoghi di lavoro, anche in contesti in cui
l’ottimizzazione dei costi è fondamentale.
9. ANALISI DI DUE CASI DI MANOVRE SUGLI ORARI
Soluzioni per l’incontro di domanda e offerta di part time nella grande distribuzione organizzata
Il settore della distribuzione organizzata è stato tra i primi a esperire il disaccoppiamento tra orario
di servizio e orario di lavoro. La flessibilità dell'orario richiesta riguarda proprio la necessità di
adeguare le presenze dei dipendenti agli orari di apertura dei negozi che ormai di fatto superano le
dodici ore giornaliere su sette giorni settimanali, ma anche ai flussi di clientela molto variabili nella
giornata e nella settimana. L'organizzazione del lavoro si basa generalmente sull'uso di un organico,
formato da un mix di lavoratori a part time e full-time, adeguato alle curve di carico delle vendite
che vengono statisticamente rilevate. Per chi lavora part time, il numero di ore settimanali, la fascia
oraria di collocazione della prestazione e le giornate di lavoro nella settimana sono specificati nei
contratti individuali, dato che la legge prevede vincoli specifici – che col tempo sono stati in parte
attenuati (ultimamente anche a seguito del Jobs act) - all’uso dei lavoratori in fasce orarie diverse da
quanto originariamente stabilito.
La programmazione dei turni avviene generalmente a tre stadi e a ogni stadio è complicato per le
aziende adattare il programma ai vincoli dei contratti individuali. La prima pianificazione di
massima, effettuata su base annua, non è sempre in grado di ottimizzare in modo efficiente gli
andamenti più imprevedibili (come le previsioni atmosferiche, la concomitanza con eventi locali):
ciò rende necessario un aggiustamento della pianificazione più a ridosso, in genere da quattro a sei
settimane prima. Infine, resta da risolvere il problema delle sostituzioni per malattia o permesso o
ferie: su queste si interviene da una settimana a quarantotto ore prima (limite massimo concesso dai
CCNL). Come si vede, l’elevata flessibilità dei flussi commerciali, oltre a rendere ardua la
pianificazione per le aziende, crea difficoltà ai dipendenti nel pianificare i propri tempi personali
(specie nelle piccole aziende, i dipendenti sono sottoposti a continui cambiamenti di turno e ciò
rende le condizioni di lavoro nel settore notoriamente difficili). È evidente quindi l’opportunità di
trovare uno “scambio reciproco” di flessibilità che porti vantaggi anche i dipendenti. Ma attraverso
quale meccanismo? Nel settore della grande distribuzione, come in quello dei call-centre, la
maggior parte dei dipendenti sono donne – tra tempo e salario le donne scelgono (a volte sono
costrette a scegliere) il tempo – quindi la contropartita negoziale possibile, la sfida non ancora
coerentemente raccolta dalla contrattazione, non è tanto un’ennesima indennità ma uno scambio tra
13
la flessibilità necessaria alle aziende e una maggiore autonomia alle persone nella scelta del tempo
di lavoro: scelta dei turni, autogestione dei cambi-turno, rapidità nella gestione dei permessi, dei
recuperi, delle ferie. Non sono poche le aziende della GDO che stanno andando in questa direzione,
e tutte con risultati positivi. Anche se non tutte le esperienze si sono spinte verso le soluzioni più
avanzate, quelle che prevedono la delega dell’autogestione dell’orario alle squadre di lavoro.
Qui sotto i casi di due grandi gruppi internazionali - il primo nel settore “food”, il secondo nel
settore “non-food” – che hanno applicato sistemi evoluti di turnistica part time, in grado di
ottimizzare l’uso delle risorse garantendo, entro certi limiti, la prevedibilità degli orari per i
dipendenti attraverso sistemi che danno loro la possibilità di scegliere i propri turni.
Gruppo Alfa: In questa azienda, come nella gran parte della GDO, quasi il 50% dell’organico è a
part time e la maggioranza dei dipendenti sono donne. Si tratta del gruppo che ha inventato, ormai
una quindicina di anni fa, il sistema delle “isole-cassa” che delega alle squadre la micro-gestione
dell’orario. Il lavoro delle cassiere viene organizzato in squadre di 12-13 persone, con
caratteristiche di sesso, età e situazione familiare diversificate; alla squadra viene consegnata la
programmazione dei turni mese per mese e ciascuno può decidere dove collocarsi; le dipendenti
possono inoltre sostituirsi vicendevolmente per esigenze personali (tanto che a volte riescono anche
a non lavorare per una settimana). Il sistema è considerato molto positivamente dai dipendenti, che
riescono a conciliare esigenze personali e lavorative. I casi in cui il gruppo non trova un accordo al
suo interno sono bassissimi e l’assenteismo si è ridotto significativamente.
Gruppo Beta: E’ un grande gruppo della distribuzione “non-food” e ha implementato nel 2015 il
sistema “time”, su base volontaria. Chi aderisce al sistema ha la possibilità di scegliere i turni di
lavoro in cui vuole lavorare ma deve anche accettare, in caso di sovrapposizione delle preferenze,
l’entrata in funzione di un dispositivo automatico di totalizzatori (che garantisce l’equità).
Contrariamente a quello che generalmente si pensa, anche qui i lavoratori si dispongono in modo
molto vario nei diversi turni – per esempio, non è affatto detto che tutte le madri scelgano il turno
del mattino – quindi i casi di risposta negativa alla preferenza sono meno di uno su dieci. Siccome
l’efficacia di questi sistemi è legata al bacino di persone che possono ruotare sui turni e quindi al
grado di fungibilità delle risorse, questo caso si presenta più complicato del precedente. Infatti, a
differenza dei supermercati “food” dove praticamente il personale appartiene in larga maggioranza
ad un unico profilo, quello delle cassiere, nella distribuzione “non food” vi è una elevata
articolazione dei profili: cassiere, banconisti, addetti alla logistica, assistenti alla vendita
diversificati ai base ai prodotti. L’innovatività di questa esperienza consiste nell’intervento sulle
competenze che sta accompagnando il nuovo sistema di orari: attraverso sperimentazioni di job
14
rotation, l’azienda sta infatti riducendo le macro-aree specialistiche e creando figure promiscue
(polivalenti) che possono ruotare nei turni insieme.
9.2 Un medesimo obiettivo di flessibilità ma sistemi diversi di relazioni industriali generano
risultati di performance differenti. Confronto tra due stabilimenti di uno stesso gruppo
industriale in Germania e Italia
Nella produzione industriale la flessibilità degli orari procede con ancora maggiore lentezza rispetto
al settore dei servizi, perché qui l’organizzazione del lavoro è stata fin dall’inizio plasmata su una
rappresentazione maschile del lavoratore e, anche per questo, l’orario standard è più difficile da
mettere in discussione. Come abbiamo visto, nella manifattura il più importante driver della
flessibilità viene dal versante impresa e riguarda la necessità di rispondere ai costi più bassi alle
variazioni della domanda di mercato. La risposta è la flessibilità dell’orario su base annua, che nel
nostro sistema contrattuale corrisponde all’orario multiperiodale (alcune settimane di quarantotto
ore contro corrispondenti settimane di trentadue), un sistema chiuso, governato dall’impresa sulle
proprie esigenze. Non è così altrove: in Germania, nei Paesi nordici, in Francia queste varianze sono
assorbite in un sistema di banca ore (possibilità di andare in debito o in credito di ore rispetto
all’orario settimanale) che funziona contemporaneamente in base alle esigenze dell’impresa e dei
lavoratori. La diversità tra i due sistemi è molto evidente nel confronto tra due stabilimenti dello
stesso gruppo industriale, uno in Germania e l’altro in Italia.
Stabilimento tedesco. Fin dal 1997 ha introdotto, con un accordo in deroga, un sistema avanzato di
orari di lavoro. Innanzitutto, è prevista la scelta tra due possibili durate settimanali: le vecchie
quaranta ore oppure le nuove trentasei ore (dopo la riduzione generalizzata applicata nel settore a
metà degli anni Novanta) e questo permette ai dipendenti di collocarsi nelle due modalità in
rapporto al personale trade-off tra preferenza salariale e di tempo libero. Inoltre, il tempo
giornaliero di produzione è dalle 6 alle 20 e i lavoratori possono scegliere quando entrare - alle 6,
alle 9, anche alle 12 (orari fissi scelti, in luogo di turni avvicendati) - e quante ore lavorare, da un
minimo di quattro ad un massimo di dieci ore giornaliere. La flessibilità su base annua, quindi le
variazioni dell’orario settimanale ormai indispensabili a ogni azienda industriale per rispondere alle
variazioni della domanda nei vari periodi dell’anno, viene garantita da un sistema che prevede la
possibilità per i singoli sia di superare l’orario quando l’azienda lo chiede (fino a +50 ore nei sei
mesi), sia di lavorare ore in meno (fino a -50) quando ne hanno bisogno per ragioni personali. Due
aspetti rendono molto efficace questo sistema. Il primo è che la flessibilità non ha a che fare con i
soldi (non esistono indennità né maggiorazioni), in compenso la possibilità di variare l’orario è
assolutamente reciproca tra esigenze aziendali e personali. Il secondo aspetto è che la flessibilità è
15
gestita nei team di lavoro: i target di produzione, settimanali e di medio periodo, sono resi
trasparenti a tutti e quindi il team collettivamente decide come collocare le ore in più eventualmente
necessarie a raggiungerli (lo straordinario è limitato a eventi davvero eccezionali) e anche le
eventuali sospensioni collettive di lavoro. Inoltre il team ha la responsabilità di decidere in merito
alle esigenze di permesso e di ferie dei singoli, fino anche a due giorni nella settimana, senza
ricorrere al capo reparto.
Stabilimento italiano. I prodotti vengono forniti da catalogo in quarantotto ore, quindi esiste una
domanda aziendale di flessibilità su base annua a brevissimo termine. Tradizionalmente, la
flessibilità produttiva si otteneva programmando al momento dell’arrivo della commessa tutte le ore
straordinarie necessarie, gradite da molti lavoratori per le elevate maggiorazioni salariali,
specialmente il sabato. Vista l’onerosità del sistema, l’impresa nel 2012 ha chiesto di introdurre le
regole previste in Germania: il compromesso che viene raggiunto mostra tutte le difficoltà, culturali
e normative, di passare ad un sistema più semplice, più equo, più partecipato e più vantaggioso in
termini di WLB come quello tedesco. Da un lato, con un accordo in deroga sono elevate le ore di
flessibilità annua multiperiodale prevista dal CCNL (una quota vicina a quella tedesca), venendo
incontro ai costi aziendali: l’orario multiperiodale, che prevede una maggiorazione più contenuta,
sostituisce una parte dello straordinario. I lavoratori mantengono però gli straordinari del sabato e
ottengono, in cambio del sacrificio salariale, sia un premio annuo forfettario di flessibilità per tutti,
sia anche l’assunzione a tempo indeterminato di una parte dei lavoratori precari. Infine, la proposta
di introdurre team come luogo di partecipazione e autogestione della flessibilità viene per il
momento accantonata. Il sistema introdotto mantiene quindi una sostanziale distanza da quello
tedesco: la flessibilità garantita è soltanto quella dell’impresa, non essendoci alcuna reciprocità
nell’utilizzo delle ore (conta anche il fatto che in Germania l’organico è in maggioranza femminile
e qui maschile); il riferimento “mentale” dei rappresentanti dei lavoratori italiani appare ancora
l’orario standard, anche se non esiste più da tempo neppure in questo stabilimento; perdura l’idea
dello “scambio a somma zero” tipico di relazioni conflittuali (anche se qui è interpretato nel modo
migliore, con la conquista di più occupati stabili). A rendere emblematica la differenza dei due casi,
il diverso impatto sulla performance dei due sistemi: il delivery time (tasso di prodotto consegnato
in tempo) dello stabilimento tedesco supera il 97%, mentre quello italiano è fermo all’89%.
10. EMERGE UN NUOVO PARADIGMA SOCIO-ORGANIZZATIVO?
Come si vede piuttosto bene dai casi, un nuovo paradigma per gli orari avanza. E appare anche
abbastanza semplice. Da un lato, la leva della destandardizzazione degli orari viene usata per andare
incontro alla nuova organizzazione della produzione e dei servizi: settimane ad orario differenziato,
16
schemi part time collocati negli orari e nei giorni più opportuni, orari h.24 e domenicali dove
necessario. In questo modo si riesce a migliorare la competitività delle imprese, che stanno in
mercati sempre più complessi e mutevoli o che hanno a che fare con consumatori e utenti sempre
più esigenti. Nel contempo, questa stessa gamma di schemi-orario è usata per permettere a chi
lavora una più ampia possibilità di scelta (entro i limiti consentiti dal sistema organizzativo in cui
lavorano) e di trovare così risposte personali alle diverse occorrenze delle fasi di vita: part time di
varia durata e collocazione servono a conciliare il lavoro non solo di chi ha impegni familiari ma
anche di studenti o di chi ha ragioni di salute o di età per ridurre l’orario; i turni a scelta e la banca-
ore per gestirsi impegni personali (che possono comportare assenze di ore o anche di giornate).
Naturalmente, sarebbe sciocco pensare che l’incontro dei tempi sia sempre così semplice come
appare dai casi di successo. E’ in realtà un matching che necessita di adattamenti reciproci,
ingegnerie organizzative e, forse, tempi non brevi. Le imprese non riusciranno certo ad evitare
“tutti” i costi sociali della flessibilità: gli orari meno sostenibili andranno comunque incentivati.
Non tutti i lavoratori troveranno l’orario perfetto: qualcuno si dovrà accontentare di una seconda
scelta. La contrattazione aziendale dovrà prevedere punti di caduta e soluzioni di ripiego, la
contrattazione nazionale dovrà definire regole generali che permettano ai lavoratori di negoziare la
propria soluzione individuale all’interno di un quadro di garanzie... Ma l’alternativa al tentare il
miglior incontro possibile tra dipendenti e imprese è quella di costringere gli uni (dipendenti) ad
adattarsi ad orari incompatibili con la propria vita familiare, come succede a molte donne che
finiscono per lasciare il lavoro. O le altre (aziende) a pagare un costo economico per concessioni e
regimi di tutela che possono pesare sulla propria competitività. Si può anche lasciare che sia il puro
gioco del mercato del lavoro a trovare i punti d’incontro. Negli ultimi trent’anni il mercato ha
provveduto ad allocare spontaneamente in alcuni settori - quelli della grande distribuzione, dei call
centre o dei servizi alle persone – le persone (donne) che potevano offrire solo orari ridotti. L’ha
fatto con una discreta efficienza ma indubbiamente ci sono stati prezzi da pagare che forse in casi
analoghi un buon governo del mercato del lavoro e una buona strategia di relazioni di lavoro
avrebbero potuto evitare, puntando più in alto in termini di produttività e offrendo migliori
soluzioni di condizioni di lavoro.
11. CONCLUSIONI
La rigidità del tempo (e del luogo) di lavoro costituisce un residuo di un’organizzazione del lavoro,
quella taylor-fordista, che per moltissime attività non solo non è più necessaria ma non è neppure
conveniente. Lavoratori e organizzazioni se ne stanno quindi allontanando. Nei casi più avanzati in
cui si combinano flessibilità di tempo e di luogo, la nuova organizzazione del lavoro sembra
17
prefigurare per certi aspetti un ritorno all’unità del luogo di vita e di lavoro di tipo pre-industriale
(la cascina al limitare del campo, l’abitazione sopra la bottega), per altri sembra rappresentare un
ingresso nel futuro della connessione globale e della personalizzazione degli stili di vita e di lavoro.
I paradigmi organizzativi fondati sulla variabilità dei mercati, dei prodotti e dei servizi e sulla
conseguente necessità di adattamento dei processi investono in pieno il sistema degli orari. Le
persone, dal canto loro, fanno pressione per ottenere spazi di autonomia nell’organizzazione della
propria prestazione. Come emerge anche dai casi, un buon sistema di orari, per funzionare, deve
fare leva su altri aspetti dell’organizzazione: realizzare almeno una discreta polivalenza del
personale; introdurre strutture, come i team di lavoro, che gestiscano in loco e in tempo reale le
microvariazioni della produzione e dei servizi, gli imprevisti, i bisogni della quotidianità dei singoli,
attraverso una delega verso il basso del potere manageriale; creare una cultura fondata sulla
partecipazione responsabile dei lavoratori agli obiettivi aziendali. A giudicare dai confronti
internazionali, in questo processo di cambiamento il sistema italiano appare particolarmente in
ritardo e questo non giova alla nostra performance e alla qualità della vita dei nostri lavoratori.
Sembrerebbe dunque il terreno ideale per costruire nuove relazioni di lavoro. Ma come
immaginarle? Il sindacato sembra chiamato a imboccare almeno due svolte culturali. La prima,
nell’abbandonare la cultura del conflitto e sostituirla non con la passiva resa alle ragioni del mercato
ma con una strategia “alta”, mirata a recuperare la competitività del nostro sistema. La seconda
nell’uscire da un’antiquata rappresentazione del lavoratore e, quindi, dall’idea della superiorità
dell’orario standard. Questo cambiamento di prospettiva porterebbe a introdurre già nei contratti
nazionali norme di base che permettono di adeguare la durata e la collocazione del tempo di lavoro
alle nuove esigenze personali e di produzione, rimuovendo vincoli anacronistici (i tetti al numero
dei lavoratori part time, i limiti alle variazioni degli orari annui) e introducendo un sistema “vero”
di banca delle ore in grado di realizzare effettiva reciprocità tra flessibilità domandata e offerta.
Una buona parte di questo disegno è realizzabile aprendo nuovi spazi ai rappresentanti dei
lavoratori: a loro, che possiedono la conoscenza dei processi aziendali indispensabile per
confrontarsi operativamente con le decisioni organizzative, dovrebbe essere chiesto, più che di
costruire periodiche piattaforme rivendicative e complessi accordi difficili da rimettere in
discussione, di partecipare insieme al management alla progettazione e alla sperimentazione delle
nuove soluzioni organizzative. E anche al controllo della produttività che ne deriva, controllo che a
oggi appare fuori dall’orizzonte del sindacato: ed è un errore perché buoni sistemi di flessibilità
abbattono l’assenteismo, migliorano il flusso dei processi, adeguano la risposta ai mercati e ai
consumatori. In più, la produttività che si genera favorisce lo spazio per una contrattazione non
18
rituale di premi. Non a caso, proprio a partire da una nuova consapevolezza della flessibilità
dell'orario come leva per la performance aziendale, le Leggi di stabilità 2016 e 2017 hanno stabilito
incentivi fiscali alla contrattazione di secondo livello quando introduca innovazione organizzativa e
anche nuovi schemi orario in grado di far crescere la produttività.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Black S. and Lynch L. (2004), What's driving the new economy? The benefits of workplace
innovation, in “Economic Journal, Royal Economic Society”, vol. 114(493), pp. F97-F116, 02.
Bosch G. (1999), Working time in Europe: Tendencies and emerging issues, in “International
Labour Review”, vol. 138, issue 2, pp.131-149, June.
Chiesi A. (1985), Il tempo di lavoro: un modello di domanda-offerta, Quaderni IRES Lombardia.
De Gregorio C. e Giordano A. (2014), “Nero a metà”: contratti part time e posizioni full time tra i
dipendenti delle imprese italiane, Istat Working Papers, n.3.
Esping Andersen G. (1990), The Three Worlds of Welfare Capitalism, Cambridge, Polity Press.
European Commission (2016), Annual data set, Macro-economic data base AMECO
Eurostat (2010), EU-Labour Force Survey. Ad hoc Module: Reconciliation between Work and
Family Life, EU/LFS online Publications. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/EU_labour_force_survey_-_ad_hoc_modules
Eurostat (2015), EU-LFS, European Commission.
Fondazione Europea di Dublino (2013), Organisation of working time: Implications for
productivity and working conditions, Luxembourg, Publications Office of the European Union.
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1250en.pdf
Fondazione Europea di Dublino (2015), Third European Company Survey. Workplace practices:
patterns, performance and well-being, Luxembourg, Publications Office of the European Union.
ILO (2012), The effects of working time on productivity and firm performance: a research synthesis
paper/ prepared by Lonnie Golden, International Labour Office, Conditions of Work and
Employment Branch, Geneva, ILO. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
travail/documents/publication/wcms_187307.pdf
ISFOL (2013), Le dimensioni del lavoro autonomo in Italia e in Europa, Roma, ISFOL.
Lehndorff S. (1999), From collective to individual reduction in working time? Trends and
experiences with working time reduction in the European Union, in “Transfer”, vol.4, n.4.
OECD (2016), GDP per hour worked (indicator), https://data.oecd.org/lprdty/gdp-per-hour-
worked.htm
Parlamento Europeo (2016), Risoluzione “Creazione di condizioni del mercato del lavoro
19
favorevoli all’equilibrio tra vita privata e vita professionale”, 16.09.2016.
Pero L. (2002), I menù alla francese e gli orari di lavoro flessibili, in “Sviluppo e Organizzazione”,
Vol.192, pp. 33-46.
Pero L. e Ponzellini A.M. (2012), Quale flessibilità dell’orario è meglio incentivare per la
produttività?, in “AREL europa-lavoro-economia”, vol.6, pp. 39-42.
Ponzellini A.M. (2006), Work-life balance and Industrial Relations in Italy, in “European
Societies”, Vol.8/2, June, pp. 273-294.
Ponzellini A.M. e Riva E. (2014), Work-life balance e performance aziendale nella prospettiva del
Diversity Management, in “Sociologia del Lavoro”, fascicolo 34, p. 84-102.
Ranci C., a cura di (2012), Partite Iva. Il lavoro autonomo nella crisi italiana, Bologna, Il Mulino
Riva E. (2009), Quel che resta della conciliazione, Milano, Vita e Pensiero.
SMARTWORKING: MA C’E’ DAVVERO BISOGNO DI UNA LEGGE?
Anna M. Ponzellini
Uscito in VIA DOGANA N.2 2014
Pensando, anche giustamente, che il lavoro-fuori-dal-luogo-di-lavoro sia soprattutto un affare di
donne, qualche mese fa tre parlamentari (donne) hanno deciso di presentare un disegno di legge
sullo smartworking. Le leggi esistenti in realtà non vietano affatto che azienda e lavoratore si
mettano d'accordo perché alcune mansioni si svolgano in tutto o in parte fuori dal luogo di lavoro. E
poi c’è la contrattazione aziendale, che ha permesso in molti casi di introdurre norme collettive
ritagliate sulle specifiche attività aziendali. L’intento dichiarato della proposta presentata da Alessia
Mosca, Irene Tinagli e Barbara Saltamartini è quello di semplificare il precedente la normativa sul
telelavoro.. ma in realtà il rischio è proprio quello di riprodurre il risultato fallimentare dell’accordo
interconfederale del 2004. Come in quel caso, infatti, la proposta suona esageratamente protettiva
(ve le ricordate le “povere telelavoratrici”?). Perché mettere un tetto alle ore che si possono fare a
distanza (forse le donne hanno bisogno di essere “indotte” a non rinunciare alla socializzazione in
azienda?). Perché preoccuparsi della sicurezza (!) degli “strumenti informatici” - che poi sono,
come si sa, pc, tablet e smartphone - fino a chiedere al datore di lavoro una procedura sulla
informazione dei rischi e addirittura l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro? Perché ribadire che
chi lavora, ogni tanto o anche spesso, fuori dai locali aziendali ha gli stessi diritti degli altri
lavoratori (si teme che ogni novità possa essere usata per discriminare le donne)? La proposta di
legge appare dettata, piuttosto che dai problemi concreti eventualmente incontrati da chi fa questo
lavoro – sia detto per inciso Eurostat ci informa che per ora in Europa ed in Italia a telelavorare
sono soprattutto i maschi – dalla vecchia rappresentazione fuorviante e paternalistica che vede la
“lavoratrice” - in quanto donna e in più obbligata a conciliare il lavoro con la cura - come soggetto
bisognoso di tutela. Ma questo rischia di produrre una legislazione non solo inutile ma dannosa. E
proprio per le donne. Ne abbiamo illustri esempi nel passato: trent’anni fa i “tetti” al numero dei
part time (dietro cui ora si trincerano le aziende che non vogliono mettere mano all’organizzazione),
dieci anni fa una normativa anacronistica sul telelavoro (col risultato che nessuna azienda ha voluto
introdurlo). E ora magari un’altra legge inutile, e pure legata a tecnologie volatili, destinate chissà
ad essere superate nel giro di poco.
1
Work-life balance e performance aziendale nella
prospettiva del diversity management
Anna M. Ponzellini e Egidio Riva
Una versione riveduta è stata pubblicata in: Sociologia del Lavoro, n.134/2014
1. Introduzione
La gestione della diversità delle risorse umane è, fuor di dubbio, una
delle questioni nodali con le quali le imprese sono oggi chiamate a
confrontarsi. Quale esito delle profonde trasformazioni demografiche,
socio-culturali, istituzionali compiutesi nella seconda metà del XX secolo,
il profilo delle forze di lavoro è radicalmente, quanto rapidamente, mutato
(cfr. Blossfeld e Drobnič, 2001; Crompton et al., 2007; per l’Italia si veda
Reyneri, 2011). Nei mercati del lavoro dei Paesi a economia avanzata, il
tratto dell’omogeneità, definito dal netto prevalere della sola componente
maschile1, è a mano a mano evaporato. Al suo posto si è invece affermata
un’eterogeneità sostanziale che richiede di essere riconosciuta e, anzi,
valorizzata nell’interesse delle imprese (AA.VV., 2001; Cuomo e Mapelli,
2007; European Commission, 2005; Thomas, 1999); più in generale, come
mette in luce, tra gli altri, l’approccio della c.d. womenomics (cfr. Del
Boca, Mencarini e Pasqua, 2012; Ferrera, 2008; McKinsey, 2009;
Wittenberg-Cox e Maitland, 2010), nell’interesse complessivo di ciascun
Paese. Effettivamente, la molteplicità dei punti di vista e la pluralità dei
modi di fare, portato della varietà delle origini sociali e delle esperienze di
vita, possono contribuire in modo decisivo alla performance dell’impresa,
nella misura in cui riescano a mettere in circolo creatività, innovazione,
talento (Konrad, 2003; Mor Barack, 2005). Di qui la centralità di politiche
organizzative che consentano alle risorse umane, intese nel senso letterale
del termine, di essere – indipendentemente dal o meglio in ragione del
proprio background – uno strumento strategico a disposizione delle imprese
(Cuomo e Mapelli, 2007), anche per far fronte all’incertezza e variabilità
1 Si potrebbe aggiungere l’acronimo Wasp (White Anglo-Saxon Protestant), utilizzato
prevalentemente in ambito nordamericano, per meglio qualificare l’omogeneità di cui si
discute, riconducendola così al prevalere di un modello non solo maschile ma altresì fondato
sull’esclusione di qualsiasi minoranza.
2
tipiche dei mercati globalizzati.
Tra le iniziative di gestione organizzativa della diversità, che dunque
hanno come fine quello di mettere il fattore lavoro in condizione di
esprimere al meglio il proprio potenziale, figurano certamente le politiche
di work-life balance (d’ora in avanti WLB). Intendiamo, con questa
espressione, le pratiche organizzative volte a consentire una combinazione
virtuosa tra i diversi mondi vitali; una combinazione, cioè, in grado di
generare, sia dal punto di vista affettivo che da quello strumentale, una
fertilizzazione reciproca tra gli ambiti della vita quotidiana, famiglia e
lavoro in prima battuta (Gambles et al., 2006; Greenhouse e Powell, 2006;
Kossek e Lambert, 2005; Pitt-Catsouphes et al., 2006; Rapoport et al.,
2002). Di questa categoria fa parte un insieme variegato di misure, le quali
insistono su quattro assi, tra di loro complementari (Den Dulk, 2001;
Pedrini e Petri, 2009):
1) organizzazione del lavoro (flessibilità di tempo e luogo di lavoro);
2) retribuzione (indennità, benefit monetari, etc.);
3) servizi (di cura, time-saving, informativi, etc.);
4) cultura (formazione, informazione, comunicazione interna)
e intervengono, riducendone la portata, sui fattori che alimentano il
conflitto percepito tra l’esperienza professionale, la famiglia, la vita privata
(Greenhaus e Beutell, 1985).
Negli ultimi anni si è assistito al proliferare di studi sulle politiche
organizzative di WLB e sugli effetti che queste sono in grado di produrre.
Da varie angolature, e secondo differenti prospettive disciplinari, la ricerca
ha mostrato che il modo in cui si articola il rapporto tra lavoro, famiglia e
vita privata comporta conseguenze sostanziali sia per gli individui sia per
l’impresa. Più in particolare, soprattutto nel campo dei management studies
e in quello della psicologia, si è arrivati a evidenziare come i programmi
aziendali di WLB, mentre da un lato riducono lo stress e la tensione, specie
per le donne, dall’altro lato, costituiscono una fonte di vantaggio
competitivo per l’impresa, perché impattano positivamente su
committment, engagement, produttività, efficienza, efficacia (cfr. Eby et al.,
2005; Lapierre et al., 2008; Kossek e Ozeki, 1998). Ciò a dire che le
politiche di WLB sono virtualmente in grado di produrre, secondo
l’espressione coniata da Kramer e Porter (2011), “valore condiviso”, perché
agenti catalizzatori del benessere individuale e familiare e, al contempo, dei
risultati economici e della performance aziendale.
Sulla scorta di queste premesse, l’articolo prende in esame le politiche
organizzative di WLB, proponendone una lettura che le vede quale
dispositivo per affrontare, congiuntamente, la sfida della gestione della
diversità nei luoghi di lavoro e quella della competitività dell’impresa. Nel
3
dettaglio, il paragrafo che segue offre un inquadramento, a livello
concettuale e operativo, e una discussione critica del legame che intercorre
tra WLB e diversity management (d’ora in poi DM). Quindi, attingendo sia
alla letteratura in materia sia agli esiti dell’attività di consulenza
organizzativa e ricerca empirica compiuta dagli autori, l’articolo si
sofferma sui vantaggi derivanti dall’adozione di politiche aziendali di WLB
e sulle questioni connesse all’innovatività e sostenibilità delle stesse. Le
implicazioni di quanto presentato e discusso sono affrontate nel paragrafo
conclusivo, il cui scopo è di offrire spunti utili non solo all’analisi
accademica ma anche alla pratica organizzativa.
2. Work-life balance, tra pari opportunità e diversity management
Come noto, la riflessione sulla gestione organizzativa della diversità ha
preso piede nel corso degli anni ’80 del secolo passato sulla scia, per un
verso, dei cambiamenti intervenuti nella composizione della forza lavoro e,
per un altro verso, della legislazione in materia di uguaglianza e pari
opportunità (Mor Barak, 2005; Thomas, 2006). La progressiva visibilità
delle donne e delle minoranze etniche ha innescato, dapprima negli Stati
Uniti e quindi in buona parte dei Paesi sviluppati, un animato dibattito sul
modo in cui le sfide poste dalla crescente differenziazione interna alla forza
lavoro avrebbero potuto/dovuto essere affrontate. Come rileva Thomas
(1990, pp. 108-112), la legislazione allora vigente, nella forma delle azioni
positive (c.d. affirmative o positive actions), non sembrava fornire una
risposta adeguata alle esigenze delle imprese, perché incentrata sulla
rimozione delle discriminazioni che ostacolavano l’accesso al lavoro delle
categorie socialmente svantaggiate, o meglio di alcune di esse. Le imprese
necessitavano invece – è questo il succo dei rilievi mossi dallo studioso e
consulente statunitense – di un approccio rinnovato e maggiormente
inclusivo, che consentisse a «ciascun talento di trovare la propria
collocazione» a tutti i livelli di un sistema organizzativo in cui la diversità,
riconosciuta e promossa nelle sue molteplici forme e manifestazioni,
avrebbe potuto «forse garantire un bonus» in termini di performance.
Quanto appena proposto, fatta salva la sua necessaria
contestualizzazione, rimanda agli elementi identificativi del DM, definito
per differenza rispetto alla logica delle pari opportunità; elementi che pare
opportuno ricapitolare, prima di addentrarci nel cuore della trattazione.
Attingendo all’ormai consolidato patrimonio di letteratura in materia e, in
particolare, all’opera di sistematizzazione compiuta da Monaci (2012), è
utile ricordare, una volta di più, come il DM sia un approccio organizzativo
4
di matrice volontaristica, orientato alla creazione di valore mediante
l’investimento strategico sulle risorse umane. Gestire la diversità significa,
più nello specifico, investire sull’unicità delle persone e,
conseguentemente, creare le condizioni affinchè esse siano in grado di
contribuire concretamente al conseguimento degli obiettivi aziendali.
Come? Sono Thomas ed Ely (1996: 80) a esplicitarlo: garantendo
«different, important, and competitively relevant knowledge and
perspectives about how to actually do work» [corsivo originale]. Al centro
dell’attenzione vi è, dunque, il modo di lavorare, in vista dell’efficienza,
della competitività, del profitto aziendale. Mentre le azioni positive e le
pari opportunità hanno un forte ancoraggio nelle teorie dei diritti umani e
della giustizia sociale, alla base del DM vi sono, piuttosto, motivazioni di
ordine economico, che possono, comunque, combinarsi a giustificazioni di
stampo etico e sociale. “Diversity is good for business”, ma solo se il DM
agisce quale cinghia di trasmissione di nuove idee, valori, visioni,
competenze, qualità, a tutti i livelli della gerarchia aziendale. Ciò richiede,
ad ogni buon conto, che la valorizzazione della diversità, di ciascuna
diversità, si eriga a pilastro della strategia d’impresa (Thomas, 2004); che
le differenti prospettive e i diversi approcci al lavoro di cui sono portatrici
le minoranze alimentino di continuo il cambiamento organizzativo, il quale
è, prima di tutto, un cambiamento culturale e quindi nei modi di fare.
Aprendosi alla diversità l’impresa «apprende e cresce» (Thomas ed Ely,
1996, p. 86). Arriva, cioè, a sviluppare a un sistema che è inclusivo e,
proprio per questo, creativo, flessibile (ossia capace di adattarsi al variare
delle condizioni di mercato), competitivo, efficiente.
Nel complesso, vi sono molte differenze tra la prospettiva del DM e il
paradigma su cui si fondano le politiche antidiscriminatorie e di pari
opportunità (Agocs e Burr, 1996; Kandola e Fullerton, 1994; Konrad et al.,
2006; Thomas, 1991). Sebbene il DM trascenda l’approccio delle pari
opportunità (senza tuttavia sconfessarlo, ma anzi inglobandone le principali
istanze, cfr. Thomas ed Ely, 1996), si tratta di differenze marcate che, come
ribadisce Monaci (2012), attengono non solo ai driver (interni oppure
esterni all’organizzazione), ma anche e soprattutto a obiettivi, destinatari,
meccanismi di intervento. Adottare come punto di riferimento delle
politiche organizzative l’uno o l’altro approccio ha, pertanto, delle
ripercussioni sull’impostazione, sui processi d’implementazione, come pure
sugli esiti di quanto messo in atto.
Il WLB, forse più degli altri ambiti dell’Human Resource Management,
ha risentito, nel proprio percorso d’istituzionalizzazione, di una tensione
continua e, per molti versi, irrisolta, tra i due approcci in parola. In
Europa, per collocarsi in uno scenario a noi più familiare, questa situazione
5
è, quantomeno in parte, il riflesso del quadro che si è venuto a disegnare a
livello comunitario. È vero, infatti, che l’intervento politico e normativo
delle istituzioni di governo europee in materia ha costituito una chiara
fonte d’ispirazione per i Paesi membri e dunque una cornice di senso
imprescindibile per le imprese (Ackers ed El-Sawad, 2006; Graziano et al.,
2011). Vediamo più nel dettaglio.
Il discorso sul WLB – un termine comparso per la prima volta nei
documenti ufficiali dell’Unione Europea, in specie in un programma di
azione, nel 1974 – ha cominciato a prendere forma negli anni Ottanta,
anche se le prime misure in materia sono state adottate solo qualche tempo
dopo. È però sul finire degli anni Novanta che la proposta formulata dalle
istituzioni comunitarie ha assunto contorni più definiti. Sotto l’ombrello
della Strategia Europea per l’Occupazione, le politiche di WLB, quale parte
integrante del capitolo sull’uguaglianza di genere, sono state progettate e
attuate, mediante specifiche Direttive e Raccomandazioni, con lo scopo
principale di rimuovere gli ostacoli sulla via della partecipazione delle
donne al mercato del lavoro. In effetti, il progressivo piegarsi dell’agenda
sociale agli obiettivi di ordine economico e finanziario ha portato con sé
una chiara enfasi sull’occupazione e sull’occupabilità dei gruppi
svantaggiati, nel caso specifico delle donne, e, di contro, la sostanziale
rinuncia a considerare anche gli uomini tra i destinatari delle azioni in
parola (Stratigaki, 2004). Una tale impostazione ha senz’altro contribuito al
processo di costruzione sociale del WLB quale “problema femminile”, in
questo modo limitando, fortemente, il potenziale d’innovazione, sociale e
culturale, insito nelle politiche in questione (Riva e Zanfrini, 2010). A
questo riguardo basti ricordare che il tema della partecipazione degli
uomini alle attività domestiche e di cura, una delle pre-condizioni per una
maggiore e più duratura presenza femminile sul mercato del lavoro, è
progressivamente sparito dal dibattito. Ugualmente, la scelta di concentrare
l’attenzione sulla fase d’inserimento (o reinserimento) sul mercato del
lavoro, ha finito per spingere ai margini un altro obiettivo di rilievo:
contrastare e ridurre la segregazione occupazionale di genere, segnatamente
nella sua dimensione verticale, e dunque mettere le donne nelle condizioni
di poter esprimere e far fruttare il proprio capitale umano lungo l’intera
carriera lavorativa. In definitiva, l’interpretazione del WLB in chiave di
pari opportunità data dalle istituzioni comunitarie è, indiscutibilmente,
parziale e limitata. Risulta, infatti, essere incentrata su un target definito (le
donne, per di più limitatamente alla fase del corso di vita caratterizzato
dalla presenza di figli piccoli) e su obiettivi circoscritti (l’incremento
dell’occupazione, intervenendo sullo svantaggio femminile circa le
condizioni di accesso e partecipazione al mercato del lavoro). Per di più
6
finisce per trascurare la rilevanza dei processi di cambiamento culturale e
di revisione dei ruoli di genere (cfr. Stratigaki, 2004).
A ben vedere, non è difficile scorgere questi stessi limiti nella pratica
organizzativa. La letteratura, in proposito, offre ampi e solidi riscontri.
Prima di discuterne è utile ricordare che le fonti dell’attivazione delle
imprese nel campo del WLB possono essere molteplici. Vi è, in particolare,
una forte variabilità tra i contesti nazionali in ordine al contributo che le
imprese offrono, a complemento di quanto previsto dai sistemi di welfare
pubblico (Evans, 2001; OECD, 2007). Tale variabilità è spiegata dal
quadro istituzionale di riferimento, in specie dalle peculiarità del modello
di protezione sociale che fa da sfondo all’azione organizzativa, ma dipende
molto anche dalla struttura e dalle caratteristiche organizzative (settore di
attività, dimensioni, etc.) e dal profilo della forza lavoro impiegata
(percentuale di donne, di lavoratori qualificati, etc.) (Crompton e Lyonette,
2006; Den Dulk et al., 2012; Riedmann, 2006). Le imprese, in effetti, sono
portate a intervenire, per un verso, sulla scorta di tendenze di tipo
isomorfico (DiMaggio e Powell, 1983), in risposta alle pressioni
istituzionali che ricevono dal contesto esterno; pressioni che possono
realizzarsi sotto forma di provvedimenti a carattere vincolante ovvero
incentivante (quali i meccanismi di detassazione o decontribuzione) (Den
Dulk et al., 2013; Ollier-Malaterre, 2008; Ponzellini, Riva e Scippa, 2013).
Per un altro verso, sono spesso le motivazioni interne a farla da padrone. Il
riferimento corre certamente al prevalere della logica del “business case”,
laddove il WLB diventa il viatico per gli obiettivi di crescita e competitività
(Lewis e Lewis, 1996; Lewis e Cooper, 2005), ma anche a forme di
volontarismo organizzativo le cui radici vanno rintracciate nella storia e
nella cultura aziendale, che molto spesso sono emanazione della storia e dei
valori di un singolo imprenditore o di un gruppo familiare (Magatti, 2001;
Mazzucchelli, 2010).
Detto questo, come accennato in precedenza, anche in ambito
organizzativo il WLB – o meglio il modo in cui esso è agito – è soggetto a
tensioni continue, che sono il prodotto dell’ondeggiare delle logiche e delle
strategie manageriali in materia lungo il continuum che vede, a un
estremo, il paradigma delle pari opportunità e, all’estremo opposto,
l’approccio del DM. Così, seppure il termine e la sua graduale
riformulazione in una chiave gender-neutral (per una discussione più
approfondita si rimanda a: Fleetwood, 2007; Rapoport et al., 2004; Riva,
2009) suggeriscano una progressiva trasformazione in senso maggiormente
inclusivo del campo, fino a includere il complesso delle risorse umane e la
varietà dei rispettivi percorsi biografici, l’evidenza empirica segnala,
invece, che permane una netta centratura delle politiche organizzative di
7
WLB sulle sole donne, in modo particolare quelle con carichi di cura
(Poggio, 2010; Smithson e Stokoe, 2005). Per di più, relativamente pochi
sono i casi di aziende che, attraverso le misure in parola, si propongono di
liberare il contributo delle proprie risorse umane da vincoli e barriere
altrimenti penalizzanti e rendere così i processi organizzativi più efficaci ed
efficienti (Baylin, 2006). Molto più diffusa appare, piuttosto, la
consuetudine di implementare interventi che, guidati da finalità e obiettivi
di carattere sociale ed etico, non mirano a promuovere e valorizzare il
talento (quello femminile ma non solo) in vista del miglioramento della
prestazione organizzativa. Da ciò consegue la concreta possibilità che il
WLB – inteso come un tema accessorio, avulso dalla strategia
organizzativa – sia sacrificato sull’altare dei tagli di bilancio o comunque a
fronte del verificarsi di condizioni di mercato tali da richiedere una scelta di
riallocazione del budget destinato alla gestione delle risorse umane (Riva,
2013). Da ultimo, ed è forse questa la questione più spinosa,
l’implementazione delle politiche di WLB avviene, di norma, mediante la
semplice adozione di misure, benefit e programmi; senza cioè che la cultura
organizzativa sia esaminata ed eventualmente modificata (Lewis, 1997;
2001). Le aziende che si muovono nel recinto del DM partono, piuttosto,
dal presupposto che, parallelamente all’introduzione di politiche formali,
occorra un cambiamento profondo, nelle pratiche lavorative come nei
valori e nei modelli di condotta diffusi e condivisi in ambito organizzativo.
Un cambiamento da cui dipende non solo l’efficacia delle stesse misure
formali di WLB – la cui fruizione rimane altrimenti circoscritta a nucleo
ristretto di persone, proprio per questo facilmente identificabili e,
consegumentemente, vittima di un forte stigma sociale (Blair-Loy e
Wharton, 2002; Smithson e Stokoe, 2005) – ma anche il successo delle
organizzazioni, ripensate a partire dalla revisione del modo in cui
conseguire l’efficacia della prestazione lavorativa (Baylin, 2006).
3. Pratiche di WLB e performance aziendale
3.1 Un modello di WLB normativo e costoso
Negli ultimi vent’anni, in Italia e nella maggioranza degli altri Paesi
d’Europa, il WLB è stato prevalentemente declinato secondo un approccio
“normativo”, guidato dalle direttive europee, dalle diverse leggi nazionali e
in molti casi anche da specifiche norme contenute nei contratti nazionali di
lavoro, complessivamente orientate ad affermare l’uguaglianza di genere e
le pari opportunità. Un approccio che ha nei fatti generato misure quasi
8
esclusivamente dirette alle madri, secondo una logica d’inclusione e tutela
dei gruppi svantaggiati. In particolare nel caso italiano, l’art. 2 della Legge
125/1991 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel
lavoro”, prevede azioni che possono «favorire, anche mediante una diversa
organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro,
l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali». Qualche anno
dopo, l’art. 9 della Legge 53/2000 “Disposizioni per il sostegno della
maternità e della paternità”, si prefigge lo scopo di incentivare «la
flessibilità degli orari» e «forme di articolazione della prestazione
lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro», replicando una
procedura che prevede la concessione di contributi alle aziende che
predispongono le azioni, e confermando una strategia istituzionale volta
contemporaneamente, da un lato, a sanzionare le discriminazioni nei
confronti delle donne, a introdurre nuovi diritti per le madri e i padri, a
promuovere la contrattazione sindacale e, dall’altro, a incentivare i
comportamenti virtuosi delle aziende. Com’è stato rilevato dalle analisi di
monitoraggio delle leggi in questione (CNEL, 2002; Gottardi, 2002),
nonostante l’impegno negoziale dei sindacati e le campagne di
sensibilizzazione degli organismi di parità, il ricorso a questi supporti da
parte delle aziende è stato molto limitato (e via via è andato a perdersi con
la riduzione dei finanziamenti pubblici). Nonostante una forte enfasi, a
volte anche da parte degli studiosi, sulle cosiddette “buone prassi di
WLB”, complessivamente i risultati di questa stagione vanno considerati
modesti: le esperienze di qualche significato si limitano a poche grandi
imprese private o di servizio pubblico e alle multinazionali, sono quasi
sempre guidate da una logica di breve periodo e non hanno intaccato
sostanzialmente il tradizionale paradigma fordista dell’organizzazione
spazio-temporale del lavoro (Piazza, 2009; Ponzellini e Tempia, 2003;
Riva, 2009). Sulla risposta tiepida delle aziende – alcune delle quali, specie
le multinazionali anglo-americane, già dagli anni Ottanta stavano
purtuttavia maturando una cultura manageriale più woman friendly – ha
sicuramente pesato, oltre che il più o meno esplicito scoraggiamento da
parte delle principali organizzazioni datoriali, il timore di irrigidire le
azioni di WLB in cogenti normative contrattuali di tutela (Ponzellini,
2006).
Non a caso, a conclusione di un ventennio e nel pieno della crisi
economica, persino gli stessi attori di queste politiche cominciano a
dubitare che la strada giusta per realizzare un maggior benessere e un
migliore equilibrio tra gli spazi vitali di chi lavora sia quella di invocare
tout court dei “diritti”. E di certo sono adesso più noti i rischi di
ghettizzazione di alcune modalità di lavoro tutelato – il part time, i congedi
9
prolungati e altre facilitazioni quando concessi in via esclusiva alle madri
di bambini piccoli o ad altre/i caregivers – che, in una sorta di perverso
bilanciamento, finiscono quasi sempre per comportare una rinuncia alla
carriera. È anche ormai evidente l’effetto indirettamente discriminatorio
che hanno taluni costi connessi alle tutele legali e contrattuali della
maternità sull’assunzione delle giovani donne, soprattutto nelle PMI,
considerato che, nella misura in cui tali costi, o gli altri “disagi”
organizzativi connessi anche solo all’eventualità di una maternità, appaiono
elevati, il datore di lavoro sarà indotto ad assumere un maschio. Si è
trattato, insomma, di un modello costoso e ambivalente, per quanto
eticamente corretto, che sta mostrando la corda alla prova del sistema
produttivo italiano, in larga misura formato da piccole e piccolissime
imprese. E che comunque sta subendo i contraccolpi della crisi.
Forse anche per queste ragioni, l’orizzonte in cui si collocano
attualmente le pratiche aziendali di WLB in Italia appare più ampio e meno
scontato e più diffuse le contaminazioni con altre pratiche aziendali come
l’innovazione organizzativa (Campagna e Pero, 2004; Cappellari, 2002;
Chiesi et al., 2006) o i sistemi di welfare aziendale (Maino, 2012;
Ponzellini, Riva e Scippa, 2013; Treu, 2013). Sembrano funzionare meglio
culture aziendali e pratiche HR meno legate ai diritti e più attente agli
impatti positivi del WLB sul cambiamento organizzativo (Lewis e Lewis,
1996; Lewis e Cooper, 2005) e alla generazione di “valore condiviso”
(Kramer e Porter, 2011). Innanzitutto non sono più solo le madri, né solo le
donne, le beneficiarie delle azioni. In secondo luogo si confrontano logiche
e culture diverse. Una tradizione aziendale di radicamento nella vita della
comunità è spesso il motore dell’introduzione di servizi aziendali per i
dipendenti e per i loro figli figli aperti al territorio, magari ispirati allo
storico esempio di Olivetti ad Ivrea, ma ormai spesso collocati all’interno
di reti multi-stakeholder o comunque di partnership con gli enti locali, sotto
forma di sperimentazioni di “secondo welfare” (Maino, 2012). In modo
parzialmente diverso, una cultura aziendale più “contemporanea” ed
europea, eticamente ispirata alla responsabilità sociale d’impresa 2 ,
introdurrà misure di WLB per i propri dipendenti partecipando a uno sforzo
d’innovazione sociale finalizzato ad arginare l’arretramento del welfare
pubblico (Canale, 2012). Con un obiettivo differente, anche se del tutto
compatibile, una propensione alla valorizzazione del brand porterà a
introdurre misure di WLB in grado di valorizzare l’immagine aziendale,
2 Questa la definizione di Corporate social responsibility adottata dalla Commissione
Europea COM(2001)366: «un concetto secondo il quale le imprese integrano
volontariamente questioni di carattere sociale e ambientale all’interno della propria gestione
aziendale nonché nell’ambito delle relazioni con i rispettivi partecipanti interessati».
10
privilegiando una logica di mercato (Mazzuchelli, 2010). Infine, una
cultura manageriale orientata alla valorizzazione della diversità – per
quanto nel nostro Paese meno diffusa che nel mondo anglosassone –
cercherà di usare la diversità come vantaggio, “sfruttando” le competenze
relazionali e organizzative dei/delle dipendenti che hanno esperienza di
cura e gestione familiare, oppure semplicemente cercando di trovare un
incontro tra i loro differenti bisogni e preferenze con le esigenze aziendali
(Baylin, 2006, Mor Barack, 2005).
3.2 I nuovi approcci sostenibili e aperti generano valore condiviso
In tutti i casi, la crisi ha messo le imprese di fronte all’imperativo della
sostenibilità delle pratiche di WLB: quale che sia l’approccio adottato, la
questione dei costi o comunque il rapporto tra i costi e il loro rendimento
sono diventati centrali.
Da tempo la letteratura manageriale anglo-americana (e poi anche
italiana), soprattutto di indirizzo psicologico, ha ipotizzato l’esistenza di un
impatto positivo sulle performance aziendali generato dal miglioramento
del benessere dei dipendenti – e quindi della loro motivazione al lavoro – in
presenza di pratiche aziendali family-friendly (Baylin, 2006; Bombelli,
2003; Cuomo e Mapelli, 2007; Den Dulk, 2001; Lewis e Lewis, 1996): le
indagini di clima o di benessere organizzativo puntualmente lo confermano.
Più recentemente la filosofia womenomics ha sottolineato il vantaggio di
coltivare i talenti femminili (soprattutto di livello manageriale) adattando il
contesto aziendale alla flessibilità connessa alle vite delle donne, anche al
fine di un’espansione dell’economia nel suo complesso (Del Boca,
Mencarini e Pasqua, 2012; Ferrera, 2008; McKinsey, 2009; Wittenberg-
Cox e Maitland, 2010). La letteratura economica sul rapporto tra
innovazione organizzativa e performance d’impresa e anche le periodiche
indagini della Commissione Europea sulla qualità della vita di lavoro
includono ormai le buone pratiche HR – ivi comprese flessibilità degli
orari, delega e autonomia del lavoro, misure che hanno forti connessioni
con il WLB – tra le c.d. High Performance Work Practices (HPWPs), cioè
tra le pratiche manageriali che hanno un impatto positivo complessivo
sull’andamento economico delle aziende (Black e Lynch, 2001; Cox,
Rickard e Tamkin, 2012; Eurofound, 2012; Leoni, 2008). Per trovare studi
quantitativi specificamente mirati sull’impatto di alcune misure di WLB3
3 Si tratta, in particolare, di politiche family-friendly, lavoro flessibile, orari ridotti,
sussidi per i servizi d’infanzia.
11
sulla produttività delle aziende bisogna fare riferimento a una ricerca di
qualche anno fa svolta di comune intesa tra London School of Economics e
Standford University che, elaborando i dati di una survey di 732 imprese
americane ed europee di medie dimensioni, raggiunge la conclusione che il
WLB è una scelta manageriale che non influisce, né in senso positivo né in
senso negativo, sulla performance economica delle imprese: nel senso che,
se ha dei costi questi vengono ripagati (Bloom, Kretschmer e Van Reenen,
2006). Altre evidenze giungono da due indagini più recenti; la prima a cura
del Ministero della Famiglia tedesco (Bmfsfj, 2005) su un campione di 10
aziende; la seconda su un campione di 20 aziende svizzere (Prognos, 2005).
Dopo aver rilevato i fattori di costo prodotti dall’assenteismo dei lavoratori
con responsabilità di cura e avere preso in esame le misure di supporto
(counselling al rientro dal congedo, flessibilità dell’orario, telelavoro, aiuti
finanziari per la cura dei figli), questi studi hanno potuto misurare un
ritorno sull’investimento che va dal 25% (in uno scenario reale) al 78% (in
uno scenario ottimale). La seconda indagine ha anche permesso di
specificare dove si creano gli effetti positivi di queste politiche: sul rientro
delle madri, che avviene più di frequente; sulla scelta del tempo parziale
“lungo” in luogo del tradizionale metà tempo, che permette di evitare
assunzioni in sostituzione; sulle carriere, atteso che l’abbattimento del
turnover consente più promozioni in-house e meno reclutamento esterno.
In generale, nell’esperienza italiana non è ancora diffusa l’attenzione
alla valutazione dell’impatto sulla performance delle pratiche di WLB.
Tuttavia si possono citare una serie di casi aziendali nei quali l’impatto
positivo è evidente, quasi sempre misurabile, in alcune occasioni anche
misurato. Quelli che abbiamo selezionato in funzione di esempio, e che di
seguito sono elencati, provengono sia da quel patrimonio consistente di casi
aziendali che si è accumulato sul tema4 e su cui abbiamo più volte avuto
occasione di riflettere, sia dalle molteplici esperienze di consulenza che
abbiamo svolto in questi anni. Caratteristiche comuni ai casi che riportiamo
sono l’immediata visibilità del rapporto costi/benefici ma anche
l’interessante diversità dei benefici (che, come si può vedere, non si
limitano alla pur importante riduzione del tasso di assenteismo delle
madri).
Un call-centre che lavora 24 ore su 24, e occupa circa 500 dipendenti a
part-time, prevalentemente donne, con un’età media di 36 anni, ha
inventato due nuovi profili-orario volontari: uno aperto ai genitori di
4 Cfr. Osservatorio della Consigliera nazionale di Parità, Osservatorio Nazionale sulla
Famiglia, Premio Famiglia-Lavoro Regione Lombardia, Percorsi di Secondo Welfare,
Archivio della contrattazione Cisl Lombardia, Wiki laFemMe di Italia Lavoro, Archivio
della Generatività e altri ancora.
12
bambini sotto i 4 anni che non prevede turni serali e uno per studenti (e
lavoratori che hanno un secondo lavoro) che prevede una
concentrazione dei turni nelle ore serali. In questo modo ha ridotto in
modo sensibile l’assenteismo, tradizionalmente elevato nei call-centre,
scongiurando la delocalizzazione all’estero del plant.
Una società assicurativa ha scommesso sul rapporto positivo tra WLB e
sviluppo organizzativo, affidando a una dirigente intermedia che stava
per entrare in congedo di maternità il compito di riorganizzare il suo
ufficio in previsione dell’assenza: la dirigente ha addestrato i suoi
collaboratori a lavorare in autonomia, ottenendo un evidente
miglioramento organizzativo che, al ritorno, le ha fatto guadagnare una
promozione. L’esperienza ha reso evidente il valore della delega e ha
permesso di diffondere il modello della lean organisation per il
miglioramento di tutta l’azienda (e non solo per la facilitazione del
WLB di una donna dirigente).
Una delle più grandi società di produzione di software ha incentivato e
garantito ottime condizioni ai dipendenti che preferiscono lavorare da
casa (home-office). La misura è stata pensata per i caregivers, ma è
estesa a tutti i dipendenti (al momento quelli coinvolti sono
prevalentemente professionisti maschi). In questo modo ha rafforzato la
sua immagine sul mercato.
Un’azienda multinazionale leader di mercato nella distribuzione di
abbigliamento e prodotti per l’infanzia, quando è arrivata in Italia, ha
deciso di assumere come commesse solo madri di bambini piccoli,
puntando sulle loro “life skills”: ampia conoscenza del mercato dei
prodotti per l’infanzia, esperienza pratica delle esigenze dei bambini,
buona capacità di relazione con lo specifico target di clienti. In questo
modo ha aumentato l’occupazione femminile e ottenuto risultati di
vendita che hanno superato le previsioni.
Stanno a pieno titolo tra le misure di WLB anche quegli interventi
d’innovazione organizzativa che, pur essendo principalmente trainati da
esigenze di mercato, tengono un occhio alla diversa composizione del
personale e alle esigenze di conciliazione dei/delle dipendenti. In questi
ambiti, spesso, i guadagni di produttività sono formidabili. Per esempio, un
grande gruppo italiano del settore moda ha introdotto un turno anticipato
(5-13 e 12-20) in un impianto di logistica, avendo riscontrato la necessità di
far partire prima la merce verso gli aeroporti che collegano lo stabilimento
con il mercato nordamericano. La richiesta di adesione volontaria
all’anticipo – che un primo momento non aveva avuto il consenso del
sindacato, in quanto orario considerato unsocial – ha registrato un grande
favore tra il personale e soprattutto tra le lavoratrici, anche superiore
13
all’esigenza aziendale. A distanza di pochi mesi, la nuova turnazione ha già
prodotto un aumento del livello di servizio del 30%. Come si vede, qui la
pratica non nasce da un preciso orientamento al WLB dei dipendenti, ma
finisce per avere un impatto positivo su di esso perché si situa all’interno di
una logica la quale presuppone – coerentemente con la filosofia di fondo
del DM – che le preferenze individuali siano molteplici (e non solo che
vadano tutelate le mamme o i genitori che hanno problemi di cura) e che
dall’incontro tra queste e i bisogni dell’azienda possa derivarne una
impatto “win-win” (Lewis, 1997; Pero e Ponzellini, 2013). Un esempio di
questo nuovo approccio, meno basato sui diritti e più orientato a
ottimizzare i risultati di tutti gli attori in gioco attraverso la leva
dell’innovazione organizzativa, è stato fatto proprio anche da una delle
istituzioni pubbliche di governo del mercato del lavoro, l’agenzia del
ministero del Lavoro Italia Lavoro. Il progetto LaFemMe per la
promozione di una buona occupazione femminile nel Mezzogiorno, varato
nel 2012 e tuttora in corso, attraverso l’intervento di consulenti promuove
infatti nelle aziende interventi di cambiamento organizzativo e degli orari
finalizzati contemporaneamente all’aumento della produttività e al
miglioramento del WLB.
4. Riflessioni conclusive
L’articolo ha inteso mostrare come, nel processo di progettazione e
adozione delle politiche organizzative di WLB si confrontino, e talvolta
coesistano, due diverse impostazioni: la prima, e più tradizionale,
imperniata sull’applicazione di un modello normativo, tendenzialmente
eterodiretto; la seconda improntata al cambiamento organizzativo, e
orientata da culture e pratiche aziendali tese alla valorizzazione delle
risorse umane. Come discusso, sono approcci che sfociano in interventi
profondamente diversi quanto a diffusione, obiettivi, risultati, probabilità di
tenuta nel tempo. In proposito, diversi sono i segnali che puntano in
direzione di una graduale trasformazione delle logiche sottostanti ai
programmi aziendali WLB, in funzione dell’innovazione, dell’efficienza,
della produttività e della sostenibilità. Assecondare una tale trasformazione
è, oggi più che mai, un compito imprescindibile. Anche quale portato della
crisi economica, non è più tempo per iniziative sporadiche e di corto
respiro. Le politiche di WLB vanno, piuttosto, concepite, anche dalle parti
sociali, all’interno di un vero e proprio disegno strategico, teso al
miglioramento del benessere delle risorse umane e all’obiettivo specifico di
performance atteso dalle imprese. Solo in questo modo è immaginabile che
14
si possa innescare un circolo virtuoso, che si alimenti dalla verifica dei
risultati raggiunti, selezioni le pratiche più efficaci, le replichi e le diffonda
fino a modificare le culture aziendali. A questo riguardo, due sono le
questioni sulle quali vale la pena di soffermarsi, in conclusione: la
valutazione dell’impatto delle politiche di WLB e la definizione di cosa
costituisca una “buona prassi”. Si tratta, peraltro, delle questioni attorno
alle quali si chiarisce il contributo che quest’articolo apporta, sia alla
pratica organizzativa sia alla riflessione teorica in materia.
In merito al primo punto, va rilevato come un’attenta valutazione dei
costi e dei benefici possa costituire un forte incentivo alla diffusione delle
misure di WLB, specie nei mondi aziendali dove non esistano culture e
tradizioni in tal senso: nelle piccole imprese dove il problema dei costi è
centrale o anche nel manifatturiero, dove gli indicatori di performance sono
quasi esclusivamente “fisici”. L’operazione non è semplicissima. Le
aziende hanno, correttamente, l’esigenza di misurare questo rapporto,
dando trasparenza ai costi connessi all’impiego di personale che ha
responsabilità familiari, e nel contempo, valutando i benefici che derivano
dall’adozione delle diverse misure. Il nodo è anche cosa misurare. I costi
sono abbastanza facili da individuare: aumento del turnover, aumento del
tasso di assenteismo, costi d’indennità e dei permessi retribuiti,
investimento per servizi aziendali e quant’altro offerto come misura di
WLB. I benefici, invece, possono toccare molti aspetti che hanno a che fare
con le competenze, l’organizzazione, il mercato. Per questo, anche se,
come abbiamo visto, gli economisti aziendali prediligono le misure
quantitative, quali il ritorno sull’investimento (ROI) o il confronto
sull’andamento della produttività del lavoro, a volte può essere utile
affiancarvi valutazioni di tipo qualitativo. In ogni caso è importante
selezionare gli indicatori giusti, tenendo presente che i potenziali benefici
connessi alle politiche di WLB – come si evince anche anche dagli esempi
riportati in precedenza – riguardano principalmente tre aree:
1. Produttività in senso stretto: riduzione assenteismo, saturazione degli
impianti, miglioramento del livello di servizio, etc.;
2. Capitale umano e sviluppo organizzativo: sviluppo delle competenze,
riduzione del turnover, attrattività del luogo e del posto di lavoro,
riduzione della discontinuità, clima e motivazione, flessibilità ed
efficacia dell’organizzazione del lavoro, sviluppo delle carriere
femminili, etc.;
3. Reputazione e immagine di mercato.
La scelta di quali benefici tenere periodicamente sotto controllo va
comunque rapportata alle logiche aziendali che guidano le misure: spesso si
15
tratta di orientamenti non esplicitati che, invece, sarà conveniente rendere
trasparenti sin dalla fase di progettazione.
Quanto alla definizione delle “buone prassi”, bisogna ricordare che, per
essere correttamente portate a esempio, condivise e divulgate, le soluzioni
organizzative devono avere caratteristiche di qualità e d’innovatività,
accompagnarsi a un profondo processo di revisione delle pratiche e delle
culture vigenti e dare altresì prova di avere raggiunto e saper mantenere nel
tempo i risultati che si erano prefissate. A ben vedere, nell’aneddotica e
nella letteratura, soprattutto sullo scenario nazionale, ricorrono
frequentemente i medesimi casi, che sono oggetto di pura descrizione e/o
generico commento, piuttosto che di un vero e proprio processo di
selezione e analisi critica. “Casi noti”, dunque, più che “buoni esempi”.
Oppure casi caratterizzati dalla semplice adozione di misure formali, più o
meno inedite e generose, ma non accompagnate da reali processi di
cambiamento delle culture e dei sistemi organizzativi. Ebbene, in una
cornice, non solo quella italiana, in cui vi è povertà di interventi
organizzativi e in cui il tema del WLB fatica ad affermarsi, il concetto di
“buona prassi” rischia di perdere il proprio significato quando non tenga
conto, al di là della mera qualità del progetto, delle soluzioni adottate per
un’efficace implementazione delle misure, della loro sostenibilità nel
tempo, della portata dei loro risultati per le persone e per le organizzazioni.
Sarebbe quindi opportuno sviluppare metodologie di selezione e di
classificazione, anche ispirate alla letteratura internazionale, che
consentano di utilizzare meglio gli studi di caso per costruire nuovo sapere
teorico e organizzativo.
Bibliografia
16
AA.VV. (2001), Harvard Business Review On Managing Diversity, Boston, Harvard
Business School Press.
Ackers P., El-Sawad A. (2006), Family friendly policies and work-life balance, in Redman
T., Wilkinson A., eds., Contemporary Human Resource Management, Harlow, Pearson
Education.
Agocs C., Burr C. (1996), Employment equity, affirmative action and managing diversity:
assessing the differences, International Journal of Manpower, 17, 4/5: 30-45.
Bailyn L. (2006), Breaking the mold: Redesigning work for productive and satisfying lives,
Ithaca, Cornell University Press.
Barabino M.C., Jacobs B., Maggio M.A. (2001), Il Diversity Management, Sviluppo &
Organizzazione, 184: 19-31.
Black S., Lynch L. (2001), How to compete: The impact of workplace practices and
information technology on productivity, Review of Economics and Statistics, 83, 3: 434-
445.
Blair-Loy M., Wharton A. (2002), Employee’s Use of Work-Family Policies and the
Workplace Social Context, Social Forces, 80, 3: 813-845.
Bloom N., Kretschmer T., Van Reeen J. (2006), Work-life balance, management practices
and productivity, Anglo-German Foundation for the Study of Industrial Society.
Blossfeld H.P., Drobnič S., eds. (2001), Careers of Couples in Contemporary Societies:
From Male-Breadwinner to Dual-Earner Families, Oxford, Oxford University Press.
Bmfsfj (2005), Betriebswirtschaftliche Effekte familienfreundlicher Maßnahmen,
disponibile al sito http://www.bmfsfj.de (consultato il 12 Dicembre 2013)
Bombelli M.C. (2003), Uguali o diversi? Riflessioni per un utilizzo consapevole del
Diversity Management, Economia & Management, 5: 99-110.
Campagna L., Pero L. (2004), Competere con la flessibilità sostenibile, Sviluppo &
Organizzazione, 201: 113-130.
Canale L. (2012), Innovazione sociale e secondo welfare. Quale impulso dalla Unione
europea?, La Rivista delle Politiche Sociali, 4, pp. 183-203.
Cappellari R. (2002), Il tempo e il valore. Flessibilità e gestione dell’orario di lavoro,
Torino, Utet.
Chiesi M., Storti C., Musolesi C., Pero L. (2006), Orari personalizzati, flessibilità aziendale
e conciliazione, Sviluppo & Organizzazione, 213: 67-86.
Cnel (2002), Il lavoro delle donne tra tutela legislativa e previsioni contrattuali, Documenti,
n. 3, febbraio.
Cox A., Rickard C., Tamkin P. (2012), Work organisation and innovation, European
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin.
Crompton R., Lewis S., Lyonette C. (2007), Women, Men, Work and Family in Europe,
Basingstoke, Palgrave Macmillan.
Crompton R., Lyonette C. (2006), Work-Life ‘Balance’ in Europe, Acta Sociologica, 49, 4:
379-393.
Cuomo S., Mapelli A. (2007), Diversity Management. Gestire e valorizzare le differenze
individuali nell’organizzazione che cambia, Milano, Guerini e Associati.
Del Boca D., Mencarini L., Pasqua S. (2012), Valorizzare le donne conviene, Bologna, Il
Mulino.
Den Dulk L. (2001), Work-Family Arrangements in Organisations: A Cross-National Study
in the Netherlands, Italy, the United Kingdom and Sweden, Amsterdam, Rozenberg.
Den Dulk L., Groeneveld S., Ollier-Malaterre A., Valcour M. (2013), National context in
work-life research: A multi-level cross-national analysis of the adoption of workplace
work-life arrangements in Europe, European Management Journal, 31: 478-494.
17
Den Dulk L., Peters P., Poutsma E. (2012), Variations in adoption of workplace work-
family arrangements in Europe: The influence of welfare-state regime and
organizational characteristics, International Journal of Human Resource Management,
23, 13: 2785-2808.
Di Maggio P. J., Powell W. (1983), The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and
Collective Rationality in Organizational Fields, American Sociological Review, 48, 2:
147-160.
Eby L. T., Casper W. J., Lockwood A., Bordeaux C., Brinley A. (2005), Work and Family
Research in IO/OB, Content Analysis and Review of the Literature (1980-2002),
Journal of Vocational Behavior, 66: 124-197.
Eurofound (2012), Organizzazione dell’orario di lavoro: implicazioni per la produttività e
per le condizioni di lavoro, disponibile al sito
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/501/it/1/EF12501IT.pdf (consultato il
20 Dicembre 2013).
European Commission (2005), The Business Case for Diversity. Good Practices in the
Workplace, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities.
Evans J. M. (2001), Firms’ contribution to the reconciliation between work and family life.
Occasional papers, 48, Paris, OECD Publishing.
Ferrera M. (2008), Il fattore D. Perché il lavoro delle donne farà crescere l’Italia, Milano,
Mondadori.
Fleetwood S., ed. (2007), The International Journal of Human Resource Management,
Special Issue: Work-life balance, 18, 3.
Gambles R., Lewis S., Rapoport R. (2006), The Myth of Work-Life Balance: The Challenge
of Our Time for Men, Women and Societies, Chichester, John Wiley.
Gottardi D. (2002), Lavoro delle donne e azioni positive. L’esperienza giuridica italiana,
Bari, Cacucci.
Graziano P., Jacquot S., Palier B., eds. (2011), Letting Europe In. The Domestic Usages of
Europe in Reconciliation Policies, European Journal of Social Security, 13, 1.
Greenhaus G., Powell. G. (2006), When work and family are allies: A theory of work-family
enrichment, Academy of Management Review, 31: 72-92.
Greenhaus J.H., Beutell N. J. (1985), Sources of conflict between work and family roles,
Academy of Management Review, 10: 76-88.
Italia Lavoro, Progetto LaFemMe (2013), Work life balance ed innovazione organizzativa
per aumentare la produttività delle imprese, Position Paper, Seminario tecnico
internazionale, Roma 26 ottobre 2013.
Kandola, R., Fullerton J. (1994), Managing the Mosaic. Diversity in Action, IPD, London.
Konrad A. (2003), Special issue introduction: defining the domain of workplace diversity
scholarship, Group and Organization Management, 28, 1: 4-17.
Konrad A., Prasad P., Pringle J. , eds. (2006), Handbook of Workplace Diversity, London,
Sage.
Kossek E. E., Lambert S. (2005), Work And Life Integration: Organizational, Cultural and
Psychological Perspectives, Mahwah, LEA Press.
Kossek E. E., Ozeki C. (1999), Bridging the work–family policy and productivity gap: A
literature review, Community, Work and Family, 2, 1: 7-33.
Lapierre L. M., Spector P. E., Allen T. D., Poelmans S., Cooper C. L., O’Driscoll M. P.,
Sanchez J. L., Brough P., Kinnunen U. (2008), Family-supportive Organization
Perceptions, Multiple Dimensions of Work-family Conflict, and Employee Satisfaction:
A Test of Model Across Five Samples, Journal of Vocational Behavior, 73: 92-106.
Leoni R., a cura di (2008), Economia dell’Innovazione. Disegni organizzativi, pratiche di
lavoro e performance d’impresa, Milano, Franco Angeli.
18
Lewis S. (1997), Family friendly policies. A route to changing organizational change or
playing around at the margins, Gender, Work & Organization, 4: 13-23.
Lewis S. (2001), Restructuring workplace cultures: the ultimate work-family challenge?
Women in Management Review, 16,1: 21-29.
Lewis S., Cooper C. (2005), Work-Life Integration. Case Studies of Organisational Change,
Chichester, John Wiley.
Lewis S., Lewis J. (1996), The Work-Family Challenge. Rethinking Employment, London,
Sage.
Magatti M. (2011), Verso nuovi modelli di business, Milano, Bruno Mondadori.
Maino F., (2012), Il secondo welfare: contorni teorici ed esperienze esemplificative, La
Rivista delle Politiche Sociali, 4: 167-182.
Mazzucchelli S., a cura di (2010), Conciliazione famiglia e lavoro: buone pratiche di
welfare aziendale, Bologna, Osservatorio Nazionale sulla Famiglia, disponibile al sito
http://www.politichefamiglia.it/media/74076/definitivo_mazzucchelli.pdf (consultato il
10 Gennaio 2014).
McKinsey & Company, Valore D (2009), Il valore della flessibilità: una leva per una
maggiore rappresentanza, disponibile al sito http://valored.it/osservatorio-d/ricerche/
(consultato il 10 Dicembre 2013)
Monaci M. (1997), Genere e organizzazione. Questioni e modelli interpretativi, Milano,
Guerini e Associati.
Mor Barak M. (2005), Managing Diversity: Toward a Globally Inclusive Workplace,
Thousand Oaks, Sage.
OECD (2007), Babies and Bosses. Reconciling Work and Family Life: A Synthesis of
Findings for OECD Countries, Paris, OECD Publishing.
Ollier-Malaterre A. (2009), Organizational work-life initiatives: Context matters. France
compared to the UK and the US, Community, Work and Family, 12: 159-178.
Pedrini M., Petri C. (2009), Politiche e misure di conciliazione nelle aziende socialmente
responsabili, in Annoni S., a cura di, Famiglia e Lavoro in Lombardia. L’esperienza del
Progetto e Premio FamigliaLavoro, Altis, Milano. (http://altis.unicatt.it/altis-
2009_quaderno.pdf)
Pero L, Ponzellini A.M. (2013), Quali flessibilità dell’orario è meglio incentivare per la
produttività, Arel europa-lavoro-economia, 1: 39-42.
Piazza M. (2009), La vita nel lavoro, il lavoro nella vita, Economia e società regionale, 4:
108-128.
Pitt-Catsouphes M., Kossek E., Sweet, S. (2006), The Work-Family Handbook: Multi-
Disciplinary Perspectives, Methods, and Approaches, Mahwah, N.J., LEA Press.
Poggio B. (2010), Pragmatica della conciliazione: opportunità, ambivalenze e trappole,
Sociologia del lavoro, 119: 65-77.
Ponzellini A. M., Riva E., Scippa E. (2013), Modelli di welfare aziendale. Una discussione
a partire dai dati dell’Osservatorio sulla contrattazione di CISL Lombardia, Paper
presentato alls Sesta conferenza annuale ESPAnet Italia, Italia, Europa: Integrazione
sociale e integrazione politica, Rende, 19-21 Settembre 2013.
Ponzellini A.M. (2003), Sindacato e imprese nella contrattazione della qualità della vita,
Diritto delle Relazioni Industriali, 3/4, XIII: 685-695.
Ponzellini A.M. (2006), Work-life balance and Industrial Relations in Italy, European
Societies, Vol.8, 2: 273-294.
Ponzellini A.M. (2008), Le azioni positive nella prassi, in Minervini A., a cura di, Il codice
delle Pari Opportunità, Atti del Convegno, Università di Bergamo, 2 febbraio 2007.
Ponzellini A.M., Tempia A. (2003), Quando il lavoro è amico, Roma, Edizioni Lavoro.
Porter M.E., Kramer M.R. (2011), Creating Shared Value. How to reinvent capitalism and
19
unleash a wave of innovation and growth, Harvard Business Review, 89, 1-2: 62-77.
Prognos (2005), Analisi dei costi e dei benefici economici di una politica aziendale di
sostegno alla famiglia, disponibile al sito
http://www.worklife.ch/static/files/docs/befu_i.pdf (consultato il 4 Dicembre 2013).
Rapoport R., Bailyn L., Fletcher J. K., Pruitt P. H. (2002), Beyond work-family balance:
Advancing gender equity and workplace performance, San Francisco, Jossey-Bass.
Reyneri E. (2011), Sociologia del mercato del lavoro (2 vol.), Bologna, Il Mulino.
Riedmann A., with Bielenski H., Szczurowska T., Wagner A. (2006), Working time and
work-life balance in European companies, Luxembourg, Office for Official Publications
of the European Communities.
Riva E. (2009), Quel che resta della conciliazione. Lavoro, famiglia, vita privata tra
resistenze di genere e culture organizzative, Milano, Vita e Pensiero.
Riva E. (2013), Workplace work-family interventions: Italy in times of welfare state
retrenchment and recession, International Journal of Sociology and Social Policy, 33,
9/10: 565-578.
Riva E., Zanfrini L., a cura di (2010), Non è un problema delle donne. La conciliazione
lavorativa come chiave di volta della qualità della vita sociale, Sociologia del lavoro,
119.
Smithson J., Stokoe E.H. (2005), Discourses of Work-Life Balance: Negotiating
‘Genderblind’ Terms in Organizations, Gender, Work and Organization, 12, 2: 147-168.
Stratigaki M. (2004), The Cooptation of Gender Concepts in EU Policies: The Case of
“Reconciliation of Work and Family”, Social Politics: International Studies in Gender,
State and Society, 11, 1: 30-56.
Thomas D. A. (2004), Diversity as a strategy, Harvard Business Review, 82, 9: 98-108.
Thomas D. A., Ely R. J. (1996), Making Differences Matter: A New Paradigm for
Managing Diversity, Harvard Business Review, 74: 79-90.
Thomas R. (1990), From affirmative action to affirming diversity, Harvard Business
Review, 68, 2: 107-117.
Thomas R. (1991), Beyond Race and Gender: Unleashing the Power of Your Total Work
Force by Managing Diversity, New York, American Management Association.
Thomas R., Woodruff M. I. (1999), Building a House for Diversity: How a Fable about a
Giraffe & an Elephant offers new strategies for today’s work-force, New York,
American Management Association.
Treu T., a cura di (2013), Welfare aziendale. Migliorare la produttività e il benessere dei
dipendenti, Milano, Ipsoa.
Wittenberg-Cox A., Maitland A. (2010), Rivoluzione Womenomics. Perchè le donne sono il
motore dell’economia, Milano, Edizioni Il Sole 24 ore.
20
Work-life balance e performance aziendale nella prospettiva del diversity
management
L’articolo prende in esame le politiche organizzative di work-life balance,
proponendone una lettura che le vede quale dispositivo per affrontare,
congiuntamente, la sfida della gestione della diversità nei luoghi di lavoro e
quella della competitività dell’impresa. Più in particolare, l’articolo offre
un inquadramento, a livello concettuale e operativo, e una discussione
critica del legame che intercorre tra work-life balance e diversity
management. Quindi, attingendo sia alla letteratura in materia sia agli esiti
dell’attività di consulenza organizzativa e ricerca empirica compiuta dagli
autori, si sofferma sui vantaggi derivanti dall’adozione di politiche
aziendali di WLB e sulle questioni connesse all’innovatività e sostenibilità
delle stesse.
Parole chiave: work-life balance; diversity management; pari opportunità;
performance aziendale; valore condiviso
Work-life balance and organizational effectiveness in the perspective of
diversity management
The article examines workplace work-life balance arrangements as an
effective means both to manage diversity in organizations and to boost
organizational effectiveness. The manuscript critically analyzes the link
between work-life balance and diversity management. Then, drawing on
previous scholarship as well as on empirical research, it addresses
methodological issues and concerns about the evaluation of the potential
consequences of workplace work-family initiatives on employees and
organizations.
Keywords: work-life balance; diversity management; equal opportunity;
organizational effectiveness; shared value
CONCILIAZIONE
Anna M. Ponzellini
Pubblicato su Una città, n.205, agosto-settembre 2013, p. 14 Negli ultimi venti anni nel nostro paese la fecondità è andata a picco e non tende affatto a risalire come invece, in un modo o nell'altro, è successo negli altri paesi industrializzati. Questo dato si accompagna ad altre dinamiche recenti che condividiamo con gli altri paesi - maternità sempre più tardive, aumento delle difficoltà a concepire, dilagare del figlio unico - che ci segnalano che siamo di fronte ad un cambiamento davvero epocale della maternità' in cui si intrecciano - in modi al momento difficili da dipanare - nuove culture di genere e familiari, fattori biologici e comportamenti sociali e lavorativi. Se il calo delle nascite fosse il portato solo di nuove scelte riproduttive sarebbe anche accettabile, basta seguire i vivace dibattiti sui media e sui social network in cui le donne si accalorano nel rivendicare la propria libertà nel decidere se avere o non avere un figlio e nel negare la presunta superiorità delle madri. Ma le statistiche ci dicono che le italiane vorrebbero fare più figli di quanti fanno (ISTAT misura periodicamente il gap tra figli "effettivi" e "attesi")… Quindi ci sembra che questo sia un problema che vada affrontato, e anche al di là delle preoccupazioni economiche relative al tasso di sostituzione demografico. In realtà, più che a un destino, come ai vecchi tempi, o a una libera scelta, come si è sperato che potesse diventare, per una giovane donna (italiana) del nuovo millennio fare figli assomiglia a un'impresa davvero complicata. Perché ormai l'orizzonte in cui si colloca una maternità è sempre e comunque un orizzonte di lavoro: presente o assente, stabile o precario, di necessità o di realizzazione che sia… Tenere insieme figli e lavoro significa trovare un equilibrio nei tempi quotidiani, negoziare nuovi ruoli di coppia, modificare i capitoli del budget familiare, organizzare un network di servizi e di aiuti: tutte cose difficili quando non impossibili, costose finanziariamente ed emotivamente e che costringono a prendere atto delle carenze del nostro sistema di welfare. E se c’è di mezzo il lavoro, le ricadute di una maternità' non sono solo per le madri ma anche per le imprese, soprattutto se sono piccole. Di queste difficoltà si parla poco ma è un errore, perché gran parte della discriminazione che subiscono le ragazze al momento dell'accesso al lavoro e anche nel corso della carriera dipende proprio da costi presunti ma anche da quelli reali - in denaro e soprattutto in carico organizzativo - che le maternità inevitabilmente comportano nei luoghi di lavoro. Intanto ci sono i costi salariali. Spiace dirlo ma la legge non aiuta: è vero che l'indennità pari all'80% del salario previsto per la tutela della maternità la paga l'Inps, ma poi i contratti impongono che il datore di lavoro integri il 20% mancante e anche, pro-quota, le mensilità aggiuntive e le ferie, quindi ogni madre costa circa il 30% in più di un normale lavoratore. E poi l'azienda deve ogni mese anticiparle il salario, scalandolo dai versamenti contributivi che fa all'Inps per i dipendenti. Ma un'impresa che ha solo due o tre dipendenti - sono tantissime in Italia - resta a credito con l'Inps (che su richiesta rimborserà ma in tempi lunghi): in questo caso, il piccolo imprenditore che deve sostituire una dipendente in maternità di stipendi finisce per doverne pagare due, per tutti i cinque mesi del congedo obbligatorio (o più se la maternità è anticipata) e a volte non è in grado di farlo. Questa è solo una parte del problema. Sono forse ancora più "stressanti " per il piccolo imprenditore, come si vede dalle interviste, i problemi organizzativi causati dall'assenza della madre. La sostituzione di una lavoratrice già professionalizzata - a maggior ragione se di qualifica elevata come accade sempre più spesso nel caso delle donne più giovani - è tutt'altro che semplice: in qualche caso bisogna cercare sul mercato esterno e non sempre si trova, in altri addestrare velocemente una collega. Se la lavoratrice dopo la maternità lascia il lavoro, poi, il danno per la piccola impresa può essere incalcolabile. Una buona gestione dell'assenza di maternità diventa così una leva importante: mantenere un buon rapporto con la lavoratrice mentre è assente (di là della formalità' imposta dagli adempimenti previsti dalla legge), fare in modo che
trasmetta le sue conoscenze a chi la sostituirà, accontentare le sue esigenze di orario quando rientra, mantenere un buon clima in azienda in modo che quando serve scatti la cooperazione tra i colleghi sono strade obbligate per non perdere l'investimento in capitale umano. Comunque spesso non basta neppure la buona gestione del datore di lavoro. "Conciliare" il lavoro con la cura dei figli è una sfida che resta difficilissima. Da noi soprattutto, visti gli scarsi mezzi messi a disposizione dallo Stato. Rientrare al lavoro, anche a part time, significa trovare un nido, una baby sitter o un parente a cui lasciare molte ore il bambino. È un problema di soldi, visto che da noi i nidi - servizi ancora considerati "a domanda individuale", quindi il cui costo viene addebitato in parte consistente all'utente - sono oltre che meno diffusi anche molto più costosi che in tutti gli altri paesi europei. È un problema di soldi anche perché se un genitore vuole lasciare il lavoro per curare un bambino riceve un'indennità pari solo al 30% della sua paga (mentre in tutta Europa si supera il 60-70%), perché gli assegni familiari sono molto modesti, perché manca un sistema di "doti" o "bonus" che accompagnino il minore fintanto che è a carico dei genitori... Ma certamente non è solo un problema di soldi: contano la separazione dal bambino, la preoccupazione che non sia assistito bene, il senso di colpa per averlo lasciato. E poi: la difficoltà a ottenere un part time, un orario flessibile, la possibilità di assentarsi quando è necessario. Forse è proprio questa impossibilità di un buon equilibrio tra lavoro e cura dei figli alla radice di un fenomeno abbastanza recente, quello delle "madri a tempo pieno", in altre parole di quelle madri che, quando nasce un bambino, scelgono di lasciare il lavoro per un periodo lungo o addirittura di dare forfait, apparentemente in modo definitivo, con il lavoro. E' un fenomeno che sta succedendo in tutti i paesi cosiddetti avanzati: una nuova generazione di donne, sorde alle sirene dell'emancipazione e della carriera che avevano dato l'imprinting alla generazione delle loro madri, non raccoglie la sfida del "voglio lavorare e anche avere figli" e sceglie di occuparsi personalmente dei propri bambini, di allattarli a lungo, di cucinare appositamente per loro, di seguire da vicino la loro crescita. E' un fenomeno di cui ci colpiscono gli atteggiamenti più radicali - i precetti dell'allattamento al seno fino a due anni, del cibo solo bio e cucinato in casa (negli Usa nell'ultimo anno c’è stato un aumento del 135% delle conserve fatte in casa!) - e che in parte avrà sicuramente a che fare con la crisi e la difficoltà' a trovare e tenere un lavoro che spinge le donne a cercarsi un'identità più gratificante. Ma che ci dice anche qualcosa su quella mitologia della "conciliazione vita-lavoro" a cui abbiamo voluto credere forse troppo negli ultimi vent'anni!
1
Quali flessibilità dell’orario è meglio incentivare per la produttività
Luciano Pero, Anna M. Ponzellini
Uscito su AREL europa-lavoro-economia, n1, 2013
L’importanza della flessibilità per i sistemi produttivi
Non c’è dubbio che esista una forte correlazione positiva tra flessibilità degli orari di lavoro e
produttività aziendale. Da quando le imprese si trovano costrette in produzioni sempre meno
standardizzate e in mercati globali sempre più competitivi (con picchi e flessioni della domanda
sempre più difficili da prevedere) e da quando l’innovazione tecnica ha aperto nuove possibilità (in
qualche caso, anche vincoli) nell’utilizzo degli impianti, il vecchio sistema fordista non regge più. In
particolare nel caso delle produzioni industriali, la globalizzazione ha aperto una competizione sui
mercati mondiali (e anche europei) che richiede risposte di flessibilità non occasionali ma
strutturali. Sistemi organizzativi realmente flessibili consentono il miglioramento dei processi, la
saturazione degli impianti, la puntualità nelle consegne, il rispetto delle scadenze previste dai
contratti di fornitura. Permettono quindi di generare aumenti significativi di produttività e, in questo
modo, di contrastare le delocalizzazioni e difendere l’occupazione. Il caso tedesco – economia
industriale molto simile alla nostra – dimostra come la messa a sistema di regimi di flessibilità
dell’organizzazione delle produzioni realizzata negli ultimi otto-dieci anni abbia costituito uno dei
fattori più importanti di competitività dell’intera economia. Una flessibilità, tra l’altro, non imposta
ai lavoratori ma “scambiata”1.
Rimuovere i fattori d’inefficienza e le flessibilità poco produttive
Se poi ribaltiamo lo sguardo e consideriamo, oltre ai benefici per la produttività che possono
derivare dall’aumento della flessibilità degli orari, i vantaggi che potrebbero derivare
dall’eliminazione di alcuni fattori di improduttività, la via da seguire appare ancora più chiara. Dal
punto di vista dei costi aziendali, vi sono almeno tre fattori che generano evidenti inefficienze nella
gran parte delle imprese: da una parte l’assenteismo, dall’altro l’abuso dello straordinario, da ultimo
l’esternalizzazione della flessibilità attraverso l’uso di rapporti d’impiego temporanei.
L’assenteismo, tradizionalmente molto elevato in Italia in tutti i settori (anche se ultimamente in
calo), è una risposta quasi-scontata dei lavoratori a un’organizzazione del lavoro molto rigida e
ancora segnata dai vincoli del modello fordista – orario standard giornaliero e settimanale - anche
laddove le possibilità aperte dall’innovazione tecnica consentirebbero una diversa gestione delle
esigenze di tempo individuali. In secondo luogo, il dilagare delle ore straordinarie combina la scarsa
capacità di pianificazione e razionalizzazione dei processi da parte delle imprese (anche di quelle
grandi, non più solo di quelle minori) con la fame di retribuzione aggiuntiva da parte dei lavoratori la
cui dinamica salariale reale è stata notoriamente negativa – almeno per il settore privato – per tutto
1 L’aumento significativo dei salari (il 4.3%) previsto dal recente rinnovo del contratto dei metalmeccanici tedeschi ci
dice, tra l’altro, della relazione positiva che esiste tra un’ampia contrattazione aziendale in deroga – 1788 contratti tra il
2008 e il 2010 (in gran parte proprio sulla flessibilità dell’orario) - e la dinamica salariale, coma si rileva in R. Morese
(2012), La lezione tedesca sui salari, Newsletter Nuovi Lavori n.101, 24-12-12. http://www.nuovi-
lavori.it/newsletter/article.asp?qid=1193&sid=110
2
l’ultimo decennio. Lo straordinario è una risposta organizzativamente “povera” alle esigenze sempre
meno eccezionali di flessibilità della produzione e al contempo rappresenta un costo altamente
improduttivo per le aziende perché spesso aumenta anziché ridurre i problemi di efficienza
organizzativa (squadre improvvisate e non assortite, addetti impiegati su lavorazioni che non
conoscono, ore in più non necessarie se non come strumento in mano ai capi per fidelizzare alcuni
lavoratori), tanto che, come è noto, le aziende più efficienti ed organizzate lo usano poco.2 Tuttavia
è stato soprattutto lo straordinario ad essere incentivato dai governi con reiterati provvedimenti di
detassazione. Infine, è sempre più chiaro come il forte ricorso nell’ultimo quindicennio da parte delle
imprese a rapporti di lavoro precari e la scarsa propensione che ne consegue a investire su queste
risorse in termini di addestramento, formazione e “fidelizzazione”, vadano considerati tra i fattori di
declino della produttività del lavoro in Italia. Una contrattazione della produttività non meramente
nominalistica – come sempre più appare dall’analisi degli accordi sui sistemi premianti - deve quindi
distinguere tra gli strumenti di flessibilità e selezionare quelli possibilmente in grado anche di ridurre
l’assenteismo, i costi improduttivi dello straordinario, il ricorso a risorse marginali e meno efficienti.
Quali sono questi strumenti?
Quali allora le flessibilità da incentivare?
In Italia, negli ultimi 20-25 anni, le risposte alle crescenti esigenze di flessibilità produttive imposte
dalle tecnologie e dai mercati si sono concretizzate attraverso l’aggiunta di turni (rigidi), una
flessibilità stagionale/multiperiodale limitata, un uso molto controllato (attraverso il regime dei
“tetti”) del part time e, al contrario, una crescente permissività nell’uso degli straordinari.
Complessivamente poca attenzione è stata riservata a un processo di vera e propria
destandardizzazione dell’orario di lavoro, nel senso della introduzione accanto all’orario standard di
regimi di orari diversificati sia in termini di numero di ore, sia in termini di loro collocazione nella
giornata, nella settimana, nell’anno. Non avere avuto il coraggio di regolare in modo più ampio la
flessibilità è stato uno sbaglio, sia nei confronti delle imprese che ne hanno un disperato bisogno, sia
nei confronti delle persone che hanno visto sottovalutati i loro bisogni di conciliazione. Per esempio,
il part time (forse sarebbe meglio dire: “orari ridotti”) non solo può rendere meno costose attività che
richiedono un volume inferiore di ore giornaliere o coprire più efficientemente i picchi giornalieri
nei flussi della clientela nelle attività terziarie e nei lavori amministrativi, ma può anche essere
utilizzato nelle attività manifatturiere per espandere il volume della produzione quando non è
necessario attivare un turno aggiuntivo completo, oppure per razionalizzare il processo produttivo
con anticipi e posticipi giornalieri (part time mattutini, part time serali) e settimanali (part time week
end), o anche per rispondere ad attività stagionali o periodiche pianificabili (il part time verticale). Al
contempo, gli orari ridotti intercettano la domanda sociale di lavorare meno ore che proviene dai
genitori di bambini piccoli, dagli studenti e dai lavoratori anziani. Oltre a far lievitare, come ci
dicono le statistiche, la produttività oraria. Analogamente una flessibilità più ampia su base
plurisettimanale – ovvero la possibilità di superare ma anche di ridurre l’orario giornaliero e/o
settimanale - risponde ai picchi e ai cali delle produzioni senza aumentare l’orario medio lavorato
(quindi riducendo il ricorso allo straordinario) ma anche, quando è concepita come simmetrica,
risolve le esigenze personali di cura, di studio, di riposo, di salute e quindi ha un impatto positivo
sull’assenteismo. In entrambi i casi, si tratta di quella “nuova organizzazione dell’orario che
consente alle imprese di adeguare il capitale umano alle esigenze temporali imposte dall’attività
economica” ma nel contempo anche “aumenta il grado di influenza che i lavoratori possono
esercitare sull’orario”, come previsto da programma Europa 2020.3
2 L. Pero (2012), Produttività o stagnazione: la contrattazione collettiva ad un bivio, in Mondoperaio, n. 10, 2012. 3 Eurofound (2012), Organizzazione dell’orario di lavoro: implicazioni per la produttività e per le condizioni di lavoro,
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef12501_it.htm
3
Per questo, a nostro giudizio, sono soprattutto gli orari ridotti e la flessibilità oraria – non gli
straordinari - che andrebbero incentivati attraverso le forme di detassazione e decontribuzione che
sono state chieste al governo dal recente Accordo interconfederale sulla Produttività4.
L’Accordo interconfederale sarà veramente utile alla produttività solo se gli incentivi alla
flessibilità saranno selettivi, i risultati misurabili, le competenze organizzative dei negoziatori
all’altezza della sfida
L’accordo “Linee programmatiche per la crescita della produttività e della competitività in Italia”,
firmato dalle associazioni datoriali e dai sindacati con esclusione della Cgil, ha il merito di segnalare
l’importanza della contrattazione collettiva nel promuoverne la crescita della produttività e
correttamente considera la contrattazione decentrata dell’orario come una delle leve più importanti
per la realizzazione degli incrementi di produttività del lavoro. Non possiamo che essere d’accordo.
L’auspicio è che, alla fine, non succeda – com’è finora accaduto – che siano proprio gli straordinari,
e in generale, un’idea di flessibilità solo ai fini d’impresa, a godere dei benefici fiscali e contributivi.
L’accordo potrebbe fare ben di più: promuovere attraverso adeguati incentivi un percorso di messa a
regime della flessibilità degli orari, che abbia il suo perno nell’aumento delle ore di flessibilità
multiperiodale/ plurisettimanale a disposizione delle imprese e che aumenti nel contempo le ore (e le
giornate) esigibili dai lavoratori. L’obiettivo potrebbe essere quello di realizzare una flessibilità
oraria “di sistema” come quella negoziata negli accordi tedeschi ma anche in eccellenti accordi
aziendali italiani (Zf, Italiana Assicurazioni, Endress-Hauser, Luxottica, Zanussi, Nestlé, Ferrero ed
altri). E’ comunque utile sottolineare che l’organizzazione degli orari è una cosa estremamente
complessa (come si è visto anche recentemente con il caso delle Ferrovie Nord!) e per negoziarla ci
vogliono da una parte e dall’altra solide competenze, si deve procedere per sperimentazioni e messe
a punto successive: questa può essere una delle ragioni per cui finora la flessibilità è stata spesso
piuttosto subita che negoziata. Altre condizioni importanti sono la partecipazione dai lavoratori alla
definizione dei sistemi e il costante monitoraggio dei risultati di produttività ottenuti.
Un’occasione per razionalizzare le normative sulla flessibilità presenti nei CCNL
L’applicazione dell’accordo interconfederale potrebbe costituire anche un’opportunità per rivedere e
riordinare le normative sulla flessibilità oraria presenti nei diversi contratti di lavoro. Nella gran
parte dei casi le norme sono troppe e mal integrate tra loro, perché sovrapposte in rinnovi contrattuali
successivi. In particolare, gli istituti che regolano la flessibilità favorevole ai lavoratori (orari
flessibili giornalieri, permessi, banca del tempo) sono trattati a parte rispetto a quelli che regolano la
flessibilità favorevole all’impresa (straordinari di vari tipi, orari multiperiodali e/o plurisettimanali) e
in questo modo ne è difficile l’utilizzo su un piano di scambio. I primi sono gravati da una serie di
vincoli (“tetti”, tempi di preavviso, scadenze, “fasce massime”), i secondi accompagnati da una vera
e propria giungla di maggiorazioni monetarie. Crediamo che risultati migliori, anche per le imprese,
si possano ottenere integrando i due sistemi di flessibilità – in termini generali al livello del CCNL e
più specifici al livello aziendale – e ottimizzando i vantaggi derivati dalla reciprocità, come già
succede in altri Paesi: semplicemente un numero di ore flessibili “in su e in giù”, a disposizione
dell’azienda e del dipendente, da portare in pari in un determinato intervallo (numero di ore e
condizioni di utilizzo possono essere differenziati a seconda delle specificità aziendali/settoriali),
affiancato da un numero contenuto di ore straordinarie, indennizzate, a disposizione per le effettive
4 Un meccanismo di incentivazione degli orari inferiori alle 40 ore era già ricompreso nella l.196/1997, art. 13 (cd
pacchetto Treu) che stabilisce una rimodulazione delle aliquote contributive in base alle fasce orarie (ove le riduzioni di
orario siano definite contrattualmente), con aliquote più basse nel caso di orario ridotti. Tuttavia non è mai entrato in
applicazione e anzi, paradossalmente, sono stati proprio gli orari straordinari ad essere incentivati!
4
emergenze. Va parzialmente in questa direzione – anche se ancora senza affrontare direttamente
l’integrazione delle normative - il recente rinnovo del CCNL metalmeccanici che prevede l’aumento
delle ore di flessibilità su base plurisettimanale esigibili dalla imprese (da 64 ad 80), nello stesso
tempo aumenta (da 6 a 8) i permessi/PAR a gestione individuale e, per la prima volta, introduce un
criterio di esigibilità anche per i lavoratori stabilendo che i permessi dovranno essere concessi anche
senza preavviso in caso di malattie dei figli e dei congiunti.
1
Strumenti di conciliazione lavoro-famiglia:
dalle esperienze alle proposte
IL TELELAVORO E IL LAVORO MOBILE IN
ITALIA
(Anna M. Ponzellini)
2011
2
INDICE
Introduzione: obbiettivi e metodologia
Prima parte: informazioni generali
1. La definizione tradizionale
2. Molti tipi di telelavoro
3. Chi sono i telelavoratori/lavoratori mobili?
4. La diffusione
5. Una forma di lavoro molto tutelata
6. Vantaggi per tutti
7. Migliora l’equilibrio vita-lavoro
8. Costi e benefici del telelavoro
9. Perché in Italia si è diffuso poco?
Seconda parte: la nostra indagine
1. I principali risultati delle sperimentazioni osservate
2. Le nuove tecnologie: dal telelavoro “strutturato” al “lavoro mobile”
3. Telelavoro nel pubblico e lavoro mobile nel privato?
4. Col lavoro a distanza l’assenteismo cala, la produttività aumenta.. ma c’è
nascosta qualche insidia
5. Pianificazione e controllo delle attività sono cruciali, se si vuole fare a meno
della misurazione a tempo
6. Capi e colleghi: il lavoro a distanza interroga la struttura delle relazioni
interne
7. Chi lavora a distanza è contento, di più se il lavoro è flessibile (ma qualcuno
torna volentieri in azienda)
8. Contingenti numerici, condizioni soggettive vincolanti, tempi massimi: il
sindacato ha ancora paura del telelavoro
Raccomandazioni
Le schede delle esperienze e l’elenco degli intervistati
3
IL TELELAVORO E IL LAVORO MOBILE
ABSTRACT
Questa monografia di approfondimento è stata realizzata dalla Fondazione
regionale Pietro Seveso (Anna M. Ponzellini). L’obiettivo era comprendere come
mai il telelavoro – ovvero uno strumento per eccellenza indicato per migliorare la
conciliazione tra vita e lavoro - sia così poco utilizzato in Italia. Per prima cosa,
abbiamo deciso di considerare accanto al telelavoro anche il lavoro mobile, una
modalità di lavoro attualmente in grande sviluppo. L’indagine non solo ha
analizzato, a distanza di tempo, i risultati – successi e insuccessi - di diverse
sperimentazioni messe in atto da aziende private, da amministrazioni ed enti
pubblici, da lavoratori dipendenti e da professionisti autonomi del lavoro della
conoscenza ma ha anche raccolto, tramite interviste, i giudizi – positivi e critici –
dei dirigenti che hanno guidato queste esperienze. Insieme ad alcune informazioni
generali sulle varie forme in cui si sta evolvendo il lavoro a distanza (Prima parte),
lo studio fa il punto delle principali criticità emerse (Seconda Parte) e avanza
alcune proposte alle parti sociali e agli operatori pubblici per la messa a punto di
strumenti di indirizzo e di sviluppo (Raccomandazioni). In particolare vengono
elaborati suggerimenti per le parti sociali ma anche per le lavoratrici e i lavoratori
dipendenti e anche autonomi.
4
INTRODUZIONE
OBIETTIVI E METODOLOGIA DEL LAVORO
Obiettivi dello studio
Siamo tra quelli che credono che la rottura dell’organizzazione del lavoro taylorista-fordista
costituisca un momento di liberazione per tutti quelli che – donne ma anche uomini – credono
nell’importanza dell’ “altro” lavoro, cioè del lavoro di cura che ciascuno di noi è chiamato
a fare come contributo per la manutenzione del mondo. Il modello di lavoro industriale tipico
del secolo scorso, invece, ha giocato la carta della localizzazione centralizzata degli
impianti e dei luoghi di lavoro, della centralità del tempo di lavoro rispetto agli altri
tempi della vita, della presenza come base del sistema di controllo sul lavoro, al fine di
raggiungere il rapporto più efficiente tra tecnologia e lavoro. In questo modello, la tradizionale
divisione del lavoro sessuale tra maschio “procacciatore di pane” (breadwinner) e donna
“prestatrice di cura” (caregiver) si è consolidata oltre misura (nel periodo fordista “puro”, in
Italia subito dopo la guerra, il tasso di partecipazione femminile al lavoro, con l’esodo dalle
campagne, è addirittura crollato). La formidabile efficienza del modello industriale e del suo
sistema di controllo hanno “contaminato” praticamente tutte le altre attività – anche quelle per
cui centralizzazione, rigidità d’orario e controllo sulla presenza non sarebbero state necessarie,
per esempio la gran parte delle attività amministrative e “di concetto” (anche quelle della
Pubblica amministrazione). Per quasi cent’anni si è interrotta quella tradizionale
sovrapposizione tra lavoro e vita quotidiana che aveva caratterizzato il lavoro nelle
società precedenti, sia nelle attività agricole (casa, stalla e campi) che in quelle artigianali e
professionali (casa e bottega, casa e ufficio).
Con le nuove tecnologie, soprattutto le più recenti dotate di grande flessibilità, siamo alla
vigilia di uno straordinario “ritorno al futuro”. Certamente, non dimentichiamo che
esistono ancora oggi molte occupazioni che sono vincolate - agli impianti, ai clienti, agli utenti
– come il lavoro operaio ma anche quello di tutti coloro che lavorano front-line, dagli operatori
della distribuzione, agli insegnanti, ai medici e agli infermieri, ai vigili urbano, etc. Vediamo
però che la tecnologia sta rendendo possibile lavorare a distanza anche a figure che fino a poco
tempo fa sembravano le più tipiche del lavoro industriale, come gli operatori di controllo, gli
addetti ai grandi impianti automatizzati, l’assistenza tecnica1. Lavorano da distanza (anche
planetaria!), in remote working, informatici ed addetti ai sistemi di telecomunicazione ma
sempre più anche figure professionali tipicamente “di contatto”, come i medici e tecnici sanitari
(telemedicina), come gli insegnanti (e-learning), come psicologi e assistenti sociali (centri
aiuto). Fanno lavoro mobile addetti alle vendite, promotori commerciali ed ispettori. In spazi
neo-fordisti come i call-centres, ma anche dentro le pareti domestiche, sono ormai milioni nel
mondo i lavoratori che mediante telefono o consolle telematica si occupano di telepromozioni,
vendite, assistenza ai clienti2.
1 Eiro (2002) The impact of work of next generation mobile phones,
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/1998/12/feature/at9812116f.htm 2 J.H.E. Andriessen, M. Vartiainen (2006), Mobile virtual work: a new paradigm?, Saltsa, Springer.
5
Inoltre, le molte occupazioni che non necessitano un collegamento on-line costante e
che quindi possono essere svolte negli orari preferiti, permettono già a molte lavoratrici e
lavoratori di mettere insieme i vantaggi del lavoro delocalizzato a quelli della flessibilità
dell’orario, studiando per sé la giusta combinazione – e variandola nel corso del proprio
ciclo di vita - di lavoro per il mercato, lavoro di cura, tempo per le relazioni, le
passioni, la formazione, il volontariato3.
Questo enorme cambiamento crea indubbiamente qualche timore. La crescente
sovrapposizione tra tempi che prima erano “giudiziosamente” separati può certamente dar luogo
a invasione del lavoro nella vita personale. La riduzione delle esperienze collettive e delle
relazioni nei luoghi di lavoro (in realtà chat, social forum, blog, comunità professionali stanno
ampliando le relazioni interpersonali a dismisura) può far temere la fine del sindacato e della
contrattazione collettiva e magari l’arrivo di forme di maggior sfruttamento del lavoro.
Fortunatamente, comunque, è ormai fuori luogo la preoccupazione che la possibilità di lavorare
da casa (per altro, in genere solo in parte) possano riportare indietro le donne nel cammino
di emancipazione.
Al di là dei timori e delle dispute ideologiche, è evidente che il processo è ormai avviato. Tanto
vale guardarlo bene in faccia e favorirlo, anche contro una certa resistenza delle
imprese, proprio come strada di progressiva liberazione da alcuni degli aspetti più vincolanti e
spiacevoli del lavoro: il pendolarismo, la rigidità del cartellino, la routine degli orari, le rinunce
e le difficoltà a tenere insieme gli altri aspetti della vita. A cambiare in meglio – alla fine - sarà
proprio la vita delle donne. Quanto ai possibili aspetti negativi – isolamento? fine della
dimensione solidaristica del lavoro? maggiore possibilità di sfruttamento dei lavoratori? - si
tratta non di negarli ma di lavoraci intorno.
Solo poche settimane fa il Corriere della Sera metteva in evidenza il fatto che l’Italia è la
“maglia nera” in Europa e nel mondo occidentale quanto a percentuale di
lavoratori in telelavoro: nel 2007 solo sette/ottocentomila, pari a poco più del 3% dei
lavoratori contro il 27% di Olanda e Svezia e il 18% di Danimarca, Germania e Regno Unito.
Eppure in Italia ci sono città metropolitane come Milano e Roma dove il telecommuting
(pendolarismo) è dispendioso e molto complicato, pensiamo solo alle proteste di questi ultimi
anni dei pendolari sui treni lombardi: centinaia di ore all’anno avvelenate dalle attese e dalla
lentezza dei treni che potrebbero essere dedicate alla cura e al riposo.
Il telelavoro non decolla neppure nella pubblica amministrazione, per la quale
all’estero ci sono ormai modelli di organizzazione del lavoro a distanza ben collaudati,
nonostante sia stato fatto qualche sforzo per gettare le basi per nuovi modelli di lavoro4. Adesso
poi che il lavoro da casa non si identifica più necessariamente con postazioni tecnologiche e di
dispendiosi collegamenti “dedicati” ma si giova di tecnologie snelle come pc, cellulari, banda
larga e internet, e quindi può essere alla portata di moltissime figure professionali impiegatizie e
tecniche, l’introduzione di forme di telelavoro sembrerebbe meno complessa e costosa da
sperimentare. Tuttavia, è indubbio che il telelavoro – e ancora di più il lavoro mobile -
richiedono alle aziende il coraggio di passare a forme diverse di coordinamento e controllo del
personale, che non siano la supervisione gerarchica “a vista”. Possiamo esaminare le difficoltà
che hanno incontrato aziende ed enti che hanno percorso questa strada, situazioni anche molto
diverse per tecnologie, procedure, risorse umane, come la Provincia di Milano, la Solvay, il Cna
3 Anna M. Ponzellini, a cura di (2006), Quando si lavora con le tecnologie. Donne e uomini nelle professioni
dell’Information & Communication Technology, Edizioni Lavoro, Roma. 4 Dipartimento Funzione pubblica (2004), Lo sviluppo del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, Presidenza del
Consiglio, Roma
6
di Bologna, un ente pubblico di grandi dimensioni? Possiamo cercare di capire perché le
sperimentazioni non si sono diffuse in altre aziende ma spesso neppure dentro le aziende che
hanno avviato i progetti-pilota?
Questo lavoro è un tentativo di andare in questa direzione. Capire meglio le ragioni –
aziendali, sindacali, culturali - della difficoltà alla diffusione di modi di lavorare che
potrebbero portare molto sollievo alla vita delle donne e di chiunque voglia un migliore
equilibrio tra lavoro e vita. Dare conto dell’evoluzione di tecnologie woman-friendly.
Indicare le strade percorribili per cambiare l’organizzazione del lavoro e rendere possibile
questi nuovi modi di lavorare.
Una metodologia innovativa
Esiste una moltitudine di ricerche effettuate negli ultimi anni per documentare lo stato degli
strumenti aziendali di conciliazione tra lavoro e vita personale e familiare. La gran parte
delle ricerche riguarda casi aziendali di “buone prassi”, in molti casi le indagini si
riferiscono allo stesso numero, limitato, di aziende, ormai molto note. Questo vale
anche per le esperienze di telelavoro realizzate a partire dalle esigenze delle lavoratrici madri.
Sembra a questo punto più interessante immaginare un percorso in parte inverso, che parta
cioè dai problemi reali che le aziende incontrano quando si cimentano nel cambiamento a
partire dalle esperienze realizzate (anche al di fuori delle azioni finanziate, naturalmente). Molte
esperienze di telelavoro, anche di successo, infatti, non hanno avuto seguito. Si sono limitate ai
piccoli numeri da cui è partita la sperimentazione e comunque non hanno contaminato altre aree
aziendali e/o altre aziende e altri settori. E’ quindi importante capire perché e studiare
direttamente con gli operatori aziendali le soluzioni per il successo.
E’ quanto abbiamo tentato di realizzare con questo studio sul telelavoro.
Nella Prima parte vengono analizzati “a tavolino”, a partire dalla letteratura esistente
(libri, ricerche, studi aziendali, normative), le caratteristiche, i vantaggi e gli elementi di criticità
rilevati nell’uso di questo strumento sia dal punto di vista delle aziende che da quello dei/delle
dipendenti. Si dà conto dei diversi stadi evolutivi delle tecnologie e delle formule di
organizzazione del lavoro che consentono, si ricostruisce in grande linea il processo di
regolazione legale e contrattuale, si ricostruisce anche il dibattito sociale e culturale. Si prende
atto che l’evoluzione tecnologica oggi favorisce, rispetto al telelavoro tradizionale, il
lavoro mobile e che quest’ultimo è molto più interessante anche dal punto di vista
dell’equilibrio vita-lavoro
Nella Seconda parte si discutono invece i principali elementi critici per il successo delle
esperienze di telelavoro, a partire dalla voce stessa degli operatori: manager aziendali,
consulenti, esperti in tecnologie, lavoratori e lavoratrici. Gli operatori sono stati
selezionati a partire dalle principali esperienze realizzate (in gran parte in Lombardia ma anche
altrove) di telelavoro finalizzato alla conciliazione. Ne abbiamo selezionate nove, di cui
cinque nella Pubblica amministrazione (Provincia di Milano, Provincia di Torino,
Comune di Cremona, Inail; Università di Verona) e quattro nel privato
(Astrazeneca, Solvay, Boehringer-Ingelheim, Cna di Bologna), due di professionisti
del terziario avanzato. Con loro abbiamo realizzato interviste individuali per approfondire i
problemi e, quando possibile, delineare le soluzioni. Le domande che abbiamo posto sono
7
molteplici ma anche ben mirate. L’indagine, infatti, non aveva l’ambizione di risolvere tutti i
problemi ma di toccare alcuni, pochi forse, nodi critici. Sul telelavoro ci siamo chiesti: perché
un dispositivo che funziona in molti Paesi non riesce ad essere introdotto anche da noi? Quanto
contano il ritardo tecnologico, la rigidità normativa e contrattuale, l’inerzia della organizzazione
tradizionale, la cultura dei capi, anche la preferenza dei dipendenti per modi di lavoro già
conosciuti rispetto all’ignoto? Abbiamo scelto di discutere solo con chi ha già sperimentato e
cercato di vedere dove sono le ragioni del successo o del fallimento. Abbiamo osservato
vantaggi e svantaggi, ciò che ha risolto o non ha risolto i problemi delle lavoratrici, ciò che ha
funzionato/ non ha funzionato per le aziende. Abbiamo messo insieme le idee, per diffondere
qualche strumento in più per avere successo e incoraggiare qualche nuova, ma più solida,
sperimentazione.
8
PRIMA PARTE
INFORMAZIONI GENERALI
1. La definizione tradizionale
Il telelavoro può essere definito come “lavoro a distanza facilitato dalle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione” oppure anche “una modalità di lavoro grazie a
cui, impiegano infrastrutture telematiche ed informatiche, è possibile valicare i tradizionali
confini fisici e logistici dell’ufficio”. All’inizio era semplicemente identificabile con il
lavoro effettuato in casa da un/una dipendente di una impresa (home-based teleworker)
tramite collegamento ICT. Lo sviluppo delle tecnologie, specialmente quelle delle
telecomunicazioni, e anche lo sviluppo di forme di lavoro diverso da quello dipendente
(lavoro autonomo e parasubordinato), hanno molto ampliato negli ultimi anni le modalità di
effettuazione del lavoro a distanza e le occupazioni/professioni che ne sono coinvolte.
2. Molti tipi di telelavoro
1. Tradizionalmente, tipi diversi di telelavoro sono stati classificati a seconda della
localizzazione:
Telelavoro da casa (home-based working) Lavoro effettuato da casa attraverso un pc o terminale collegato on line, banda larga o fibra
ottica, alla rete aziendale. E’ la forma più rigida organizzativamente ma anche quella più
regolamentata dal punto di vista contrattuale (a causa del timore che potesse diventare un
ambito lavorativo di sfruttamento soprattutto di lavoratrici con bassa professionalità e
vincoli familiari). Molto spesso si tratta di lavoro on-line (per esempio, chi risponde a
chiamate telefoniche come se fosse in un call centre) con ben poca flessibilità per gli
individui.
Uffici satellite E’ una forma collettiva di lavoro remoto, che consiste nella possibilità di lavorare a distanza
rispetto alla sede centrale dell’azienda in uffici locali organizzati dall’impresa per gruppi di
dipendenti. Si tratta di forme di decentramento che non sono necessariamente in funzione di
mercati locali (come nel caso dell’apertura di filiali aziendali o sportelli decentrati per
essere più vicini ai clienti) ma che sfruttano il potenziale delle tecnologie di
telecomunicazione in funzione di un decentramento del lavoro, per ragione di costi o anche
per andare incontro ai bisogni dei dipendenti che vivono in una certa zona. Tipicamente
alcuni call centre di banche o di imprese di telefonia. Ma anche i centri di elaborazione dati
collocati “offshore” da molte aziende inglesi e americane in India, Filippine e Cina, che
testimoniano come le possibilità del telelavoro siano orami globalizzate.
Remote working
9
Varietà di telelavoro (da casa o da uffici saltellite), tra lavoratori collegati tra loro e alla rete
aziendale o alla rete dei clienti.
Telecottages E’ una forma individuale (ma in spazi collettivi) di lavoro remoto che consiste nella
possibilità di lavorare in centri, spesso pubblici, dove una serie di facilitazioni viene messo
a disposizione dei lavoratori di aziende diverse per lavorare a distanza. Si tratta spesso di
località distanti dai centri principali o in aree economicamente depresse. Telecottages sono
stati impiantati in UK, Irlanda e Scandinavia con l’idea di promuovere le opportunità di
impiego in comunità economicamente sfavorite. In Italia sono state fatte sperimentazioni in
Sicilia, espressamente mirate all’occupazione delle donne.
Lavoro mobile (mobile work) E’ una forma ormai molto diffusa di telelavoro tra agenti di commercio, rappresentanti,
ispettori, addetti all’assistenza tecnica. Muniti di tecnologie mobili leggere (laptop, cellulari,
palmari, blackberry, etc.) questi lavoratori spediscono ordini, report, accedono alle banche
dati aziendali o si collegano con i sistemi dei clienti, da dappertutto: casa, uffici dei clienti,
mentre viaggiano, mentre sono in vacanza. Il lavoro mobile è ormai tipico anche per una
parte della giornata o della settimana degli executive e di tutto lo staff di alta qualifica (per
terminare e spedire un lavoro, per accedere agli archivi aziendali, almeno per il controllo
della posta). E’ una modalità molto diffusa anche tra i professionisti autonomi (non solo
delle professioni della conoscenza, anche per artigiani, commercianti, creativi, etc.).
Azienda virtuale E’ l’estrema conseguenza del lavoro mobile. Si tratta di una società che non ha una sede
fisica ma che è costituita esclusivamente da professionals che comunicano tra loro e con i
clienti attraverso ICT (addirittura qualche volta è composta da lavoratori che vivono in paesi
diversi).
2. Attualmente appare più interessante la distinzione tra telelavoratori in base al tempo:
Telelavoro a tempo pieno E’ quello più classico. Spesso si tratta di lavoro continuativamente on-line, con un orario
che corrisponde a quello dei lavoratori tradizionali, con organizzazione e tutele rigide. E’ in
genere quello dei pubblici dipendenti che lavorano su procedure o degli addetti ai call centre
in entrata o in uscita. In qualche caso, può invece alternare attività on line e attività off-line
e anche avere una maggiore flessibilità di orari (fascia rigida, fascia mobile, reperibilità)
Telelavoro parziale (o alternato) Sembra la forma di telelavoro regolamentato più diffusa attualmente. In questo caso, la
scelta delle aziende – e anche degli stessi lavoratori/trici – è quella di lavorare alcune ore (di
solito, al mattino) in azienda e alcune ore a casa, ancora più spesso l’alternanza è su base
settimanale. In generale, le imprese chiedono almeno un giorno alla settimana in sede (o
almeno per le riunioni di staff). L’azienda in questo modo controlla meglio l’andamento del
lavoro e la motivazione e per le/i dipendenti c’è il vantaggio di mantenere relazioni e
rapporti personali.
Telelavoro discontinuo Sono gli staff di alto livello e gli executive che possono decidere quando e dove lavorare.
10
3. Un’ultima importante classificazione, visti cambiamenti che si sono verificati negli ultimi
dieci anni nel mercato del lavoro, è in ragione della forma di impiego:
Telelavoratore dipendente Il telelavoratore dipendente è quello tradizionale che lavora da casa, con forme molto
precise di tutela contrattuale: esiste una direttiva Europea, a cui in Italia è stato fatto seguito
con accordi interconfederali e normative nei contratti nazionali di categoria che assimilano
in tutto e per tutto il telelavoratore al lavoratore subordinato tradizionale e tentano di
scoraggiare forme di ipersfruttamento del lavoro e la possibile elusione delle normative di
sicurezza e di privacy.
Lavoratore mobile dipendente
Esistono anche lavoratori dipendenti che fanno lavoro mobile, in genere su base informale
quando il lavoro fuori ufficio riguarda professionals, managers e alte qualifiche. Questo tipo
di lavoro è diffuso nelle aziende più evolute, soprattutto high-tech (dove in alcuni casi
l’intero processo di gestione della risorsa avviene on-line: il reclutamento, la selezione,
l’assunzione – in genere con contratto dipendente ma a tempo determinato rinnovabile – la
valutazione della performance, etc.). In altre aziende il lavoro mobile è forse scoraggiato dal
sindacato, per la impossibilità di tenere sotto minuto controllo (per esempio, dentro un
accordo sindacale) la molteplicità delle flessibilità potenziali e quando si teme la scelta di
“delega sulla fiducia” al/alla dipendente.
Lavoratore mobile free-lance Il telelavoratore non subordinato nasce dalla particolarità di molte forme di lavoro tecnico o
professionale di buona qualificazione che trovano preferibilmente collocazione – volontaria
o involontaria - sul mercato del lavoro come attività autonome o free-lance. In qualche caso,
si tratta di professionisti free-lance che aspettano di avere una propria consistenza
economica per costituire una azienda e dotarsi di un ufficio vero e proprio. Questo tipo di
lavoratore può da un lato lavorare presso l’ufficio del cliente/committente (in questo caso la
sua posizione sconfina con forme di outsourcing o anche di vera e propria evasione dagli
obblighi del lavoro subordinato e della Direttiva europea sul telework) o dall’altro
sconfinare invece con l’azienda virtuale. Rispetto ad entrambi i casi si può notare come,
nella crescente de-regolazione del mercato del lavoro, vi sia una significativa difficoltà a
definire le caratteristiche giuridiche di alcune attività in termini generali ancora prima che
rispetto alla modalità di lavoro a distanza.
3. Chi sono i telelavoratori/lavoratori mobili?
La maggior parte dei telelavoratori in Europa e USA:
Sono maschi
Hanno un livello medio-alto di scolarità
Hanno inquadramento come managers o professionals
Sono lavoratori del settore ICT
Quindi, nonostante l’importanza del lavoro mobile per la conciliazione, almeno nelle
statistiche ufficiali, le donne che lavorano a distanza sono sottorappresentate. Questo
è in parte dovuto alla minor presenza delle donne, non tanto nel telelavoro tradizionale, ma
nelle occupazioni più aperte accessibili lavoro mobile: professioni high-tech (soprattutto
nell’area dei progettisti e gestori di sistemi) e professioni manageriali.
11
4. La diffusione
Secondo i dati della Commissione europea, il telelavoro è in costante crescita in tutto il
mondo: in Europa ha superato i 9 milioni di lavoratori mentre negli stati Uniti sono già oltre
15 milioni. In Italia, i telelavoratori stimati sono solo 800 mila, la percentuale di
telelavoratori sul totale è la più bassa dei Paesi UE.
5. Una forma di lavoro molto tutelata
Esiste in Europa un Accordo-quadro sul telelavoro firmato dalle parti sociali europee nel
luglio del 2002. L’accordo è stato successivamente implementato nei vari Paesi attraverso
accordi nazionali intercofederali o settoriali o anche codici di condotta. Al centro del
sistema di regolazione, sta l’idea che lavorare a distanza non cambia la sostanza del
rapporto di lavoro subordinato. In realtà, infatti tutto l’intervento di regolazione è stato
portato avanti sulla base dei timori espressi dalle organizzazioni sindacali che il telelavoro
in qualche modo rompesse il sistema di tutela costruito attorno al rapporto di lavoro
dipendente.
In Italia l’accordo sul telelavoro è stato siglato nel giugno 2004 da Cgil, Cisl, Uil e
Confindustria (più altre 19 associazioni imprenditoriali). A seguito di questo accordo norme
sul telelavoro sono entrate nella maggior parte dei contratti collettivi nazionali. Sono anche
stati siglati importanti accordi aziendali (tra i più importanti: Telecom, IBM Group, Bull,
Tim, Poste italiane, Inps, Università di Verona, Inail).
Gli aspetti più importanti dell’accordo-quadro europeo e degli accordi di settore sono:
la natura volontaria del telelavoro
le condizioni di lavoro (che prevedono che al telelavoratore spettino uguali diritti
legali e contrattuali rispetto a chi la sua mansione la svolge in ufficio)
la protezione dei dati
la strumentazione fornita
salute e sicurezza
organizzazione del lavoro e formazione
tutela della privacy
La preoccupazione della Commissione europea di mantenere un monitoraggio elevato di
questa forma di lavoro si è concretizzata nella realizzazione di un osservatorio stabile sul
telelavoro presso la Fondazione europea di Dublino5 che fornisce costanti informazioni di
ricerca sui più importanti aspetti sociali del telelavoro.
6. Vantaggi per tutti
Il telelavoro comporta benefici significativi per le imprese, i lavoratori dipendenti ed
autonomi, lo sviluppo della economia locale. Inoltre, è potenzialmente vantaggioso per la
5 http://www.telework-mirti.org/reports.htm
12
società in generale, per esempio attraverso la riduzione dell’inquinamento dovuto al
trasporto automobilistico6.
I benefici per le imprese sono molto evidenti. I principali evidenziati dalla letteratura
sono:
risparmio sui costi immobiliari
flessibilità organizzativa
aumento della produttività
aumento della motivazione dei dipendenti
I benefici per i lavoratori sono ancora più evidenti. I principali:
riduzione del costo e del tempo di trasporto
opportunità per residenti di aree di difficile mobilità
flessibilità d’orario (non sempre)
migliore equilibrio tra vita professionale e vita familiare
possibilità di lavorare per imprese fuori dal proprio territorio
I benefici per la società e per l’economia sono decisamente importanti:
riduzione della congestione del traffico
riduzione dell’inquinamento atmosferico dovuto al traffico
ampliamento delle opportunità occupazionali di aree economicamente depresse o
isolate (montagna, isole)
un ponte verso il lavoro per persone con difficoltà (handicappati, persone con
familiari disabili, genitori con bambini da curare)
I benefici per le donne:
lavorare da casa, in tutte le modalità, è comunque una opportunità importante per
chi ha impegni di cura difficili da delegare
lavorare con tecnologie mobili e orari flessibili consente di non abbandonare il
lavoro, rientrare presto dalla maternità, evitare il part-time alle donne che hanno un
figlio
le tecnologie mobili sono un importante alleato dell’auto-imprenditorialità
femminile, soprattutto nell’area del lavoro della conoscenza e delle libere
professioni
Internet, i business networks, le professional communities consentono comunque
alle donne che lavorano a distanza di evitare l’isolamento, mantenere i rapporti con
i colleghi, coltivare relazioni professionali, ampliare il proprio mercato, sviluppare
le proprie competenze.
7. Migliora l’equilibrio tra vita e lavoro
6 La letteratura sul tema è molto vasta. In italiano, si veda per tutti: Sergio Campodall'Orto e Massimo Gori (2000),
Conoscere il telelavoro. Caratteristiche, esperienze, guida all'utilizzo, FrancoAngeli, Milano. Interessanti ai nostri
fini, anche i risultati di una indagine europea sul telelavoro nelle piccole-medie imprese eGap (2006), Attitudes to teleworking, (vedi: http://ec.europa.eu/research/headlines/news/article_05_02_15_en.html)
13
Abbiamo visto che la maggior parte dei telelavoratori sono maschi, che lavorano a distanza
per loro scelta personale, favoriti da alta scolarità ed alta qualifica e dal fatto che (per ora)
più spesso delle donne lavorano nei settori e nelle professioni tecnologicamente avanzati
(informatica, telecomunicazioni, ingegneria, progettazione, management, etc.). Per la verità,
non è poi improbabile che una parte di questi maschi sfruttino la maggiore libertà concessa
loro dalle tecnologie per essere più presenti nei confronti della famiglia e dei figli.
Tuttavia non c’è dubbio che lavorare da casa - o comunque in modo mobile e flessibile -
costituisca un grande vantaggio per chi durante al giornata ha impegni vincolati alla
famiglia, come quasi sempre le madri e le donne in genere: essere presente a casa
quando i bambini non sono a scuola, quando sono molto piccoli, quando sono malati,
andarli a prendere a scuola e accompagnarli nelle loro attività extrascolastiche, portarli in
vacanza, etc. come anche assistere familiari anziani, handicappati o malati7.
Da questo punto di vista, è chiaro che i diversi tipi di telelavoro hanno benefici di
dimensione diversa rispetto alla possibilità di conciliare il lavoro con gli impegni familiari.
Quello prevalentemente on-line, in orari uguali a quelli degli altri dipendenti,
regolato da procedure precise consente quasi esclusivamente di risparmiare i tempi di
pendolarismo: la possibilità di dedicarsi alla cura di bambini o altri soggetti da curare in
casa, infatti, è molto limitata dalla necessità di mantenere un adeguato ritmo di lavoro. Ben
più interessante il caso del lavoro che si può autogestire dal punto di vista dei tempi,
perché non prevede la presenza simultanea degli altri lavoratori o del cliente: in
questo caso sarà più facile alternare (al limite anche sovrapporre) i due impegni,
articolandoli su un arco giornaliero, o settimanale, più lungo: lavorando per esempio anche
alcune ore serali o in parte delle giornate di festa. Ancora più interessante, ma limitato ad
alcune occupazioni (progettazione, ricerca, consulenza per appuntamenti, alcuni compiti
manageriali, professioni creative e della comunicazione, giornalismo etc.), il telelavoro che
non prevede attività on-line e vincoli a colleghi o clienti e che è interamente
valutabile dai risultati: in questo caso, le possibilità di articolazione spazio-temporale e
di sovrapposizione di impegni diversi è massima anche se diventa molto importante una
ferrea auto-organizzazione.
Possiamo quindi notare che il tipo di telelavoro che è stato inizialmente progettato, a
partire dalla’inizio degli anni 80, proprio avendo come target le lavoratrici e come
obiettivo quello di migliorare le loro possibilità di conciliazione si è rivelato alla fine
piuttosto deludente: infatti, almeno nelle sue prime formulazioni anche condizionate dal
livello di tecnologia esistente, si trattava di lavoro molto rigido e controllato, quindi del
tutto inadatto a rendere più facile la compresenza/sovrapposizione di impegni di
lavoro e impegni di cura. A ciò si può aggiungere che nella prima fase - dalla metà
degli anni 80 fino alla metà degli anni 90 - almeno in alcuni paesi, come l’Italia, dove
l’ingresso di massa delle lavoratrici nel mercato del lavoro era ancora recente, la posizione
7 C’è poco di specifico sul rapporto tra telelavoro e donne, il lavoro più completo è: Huws U. (2000), Equality and
telework in Europe, European Commission, DG Employment and Social Affairs, www.euro-telework.org. Esiste
invece una bibliografia più vasta sugli strumenti e le buon prassi di conciliazione tra lavoro e famiglia, che include
anche il telelavoro, di cui indichiamo i principali riferimenti: Piazza M., Ponzellini A.M., Provenzano E., Tempia A.
(1999) Riprogettare il tempo, Edizioni Lavoro; Piazza M. (2000), I sistemi di conciliazione tra tempi del lavoro
familiare, i tempi del lavoro professionale e i tempi dei servizi, in Quaderni Irer, n.16, Regione Lombardia; Ponzellini
A.M., Tempia A. (2003), Quando il lavoro è amico. Aziende e famiglie: un incontro possibile, Edizioni lavoro;
Natoli G. (2004), Teoria e prassi per la conciliazione lavoro e famiglia, Quaderni Spinn, n.12.
14
del sindacato di fronte a questa forma di lavoro fu estremamente sospettosa nell’idea che si
trattasse di un modo per “ricacciare le donne tra le pareti domestiche”!
Solo più avanti i progressi tecnologici – pc portatili, collegamenti in banda larga o fibre
ottiche, internet, smartphones (Blackberry, iPhone) - hanno reso possibile lavorare a
distanza, almeno per parte della giornata o della settimana, a molte più occupazioni. Dal
momento in cui i contatti con l’azienda possono avvenire da qualsiasi pc connesso alla rete,
per molte mansioni è possibile lavorare a distanza on-line o off-line a seconda delle
necessità, spedire il proprio lavoro via internet, mantenere collegamenti con capi, colleghi e
clienti via email o via cellulare. Ultimamente, attraverso collegamenti di terza generazione,
non è neppure più necessario collegarsi ad una rete fissa ma si può comunicare per lavoro
anche solo per mezzo di un cellulare o di una scheda pc. Risulta molto evidente, allora che
le tecnologie ICT, che inizialmente sembravano mettere a disagio le donne più degli
uomini, si stanno invece rivelando le migliori amiche delle donne, consentendo loro di
lavorare da qualsiasi postazione, al limite anche mentre sono con i figli ai giardinetti o in
vacanza.
Queste nuove forme di lavoro – forse più lavoro mobile che telelavoro in senso stretto –
aprono però una serie di problemi. Molti vedono in questa scomparsa dei confini tra lavoro
e vita una grossa minaccia e un ipersfruttamento delle donne (e dei lavoratori in
generale), l’invasione della vita privata da parte dei problemi di lavoro, un surplus di
stress per le famiglie. In realtà, è probabile che ancora una volta si gridi allo scandalo
troppo presto e si vogliano vedere solo le insidie della nuova organizzazione del lavoro.
Questa organizzazione necessita infatti di modelli di autogestione del tempo e dello
spazio che sono ancora tutti da costruire per un armonico bilanciamento tra vita e lavoro. E
che forse non sono adatti a tutte le persone ma che possono cambiare considerevolmente in
meglio la qualità della vita delle lavoratrici e dei lavoratori con impegni di cura.
8. Perché in Italia si è diffuso così poco?
Nonostante l’Unione Europea cerchi di promuovere questa forma di lavoro per i benefici
che ne derivano (migliore conciliazione tra vita e lavoro, minore impatto sull’ambiente) e
nonostante l’accordo interconfederale che quattro anni fa hanno firmato le parti sociali, in
Italia il numero di lavoratori e lavoratrici in telelavoro è molto basso: nel 2007 solo 800
mila, che rappresentano il 3,2 % degli occupati. Molto pochi se si pensa che negli altri
Paesi d’Europa le percentuali di lavoratori che in tutto o in parte lavorano o da casa o
comunque “in remoto” (uffici satelliti aziendali o telecottages pubblici) sono molto
superiori: sfiorano il 30% nei paesi nordici (anche in conseguenza di intere zone di difficile
accesso durante l’inverno) e sono tra il 15 e il 18% anche in Olanda, Germania, Danimarca
e Regno Unito.
Le ragioni sono diverse. Da un lato il tessuto economico italiano è formato in larga misura
da piccole e medie imprese: questo da un lato significa che le imprese sono già molto
distribuite sul territorio (questa è in altri Paesi una delle ragioni della creazione di “uffici
satellite”), dall’altro significa che si tratta di imprese dove vi è maggiore difficoltà a studiare
sistemi di telelavoro, che potrebbero alla fine riguardare un numero molto esiguo di
dipendenti. Nel caso delle piccole imprese, tra l’altro, è possibile che gran parte del
telelavoro sia informale, ovvero che l’incidenza sia maggiore ma non venga rilevata.
15
Una seconda ragione, più preoccupante, è che il telelavoro non si è diffuso proprio nel
settore che all’estero, e soprattutto in Usa già dagli anni 80, ha la più alta incidenza di
telelavoratori, ovvero la Pubblica amministrazione. Qui il ritardo è più evidente ed è
dovuto a molti fattori: arretratezza tecnologica, difficoltà all’innovazione organizzativa,
ruolo e cultura dei capi affliggono la gran parte (non tutte) i luoghi di lavoro pubblici.
Questa situazione penalizza soprattutto le donne, che nella P.A. sono presenti in larga
misura e in grande maggioranza proprio sulle posizioni amministrative che sono
ampiamente telelavorabili.
Una terza ragione è ancora più seria. Riguarda il sindacato e il modo con cui si rapporta
con tutte le novità che emergono dal mondo del lavoro per la minaccia che l’innovazione
comporta per il suo consolidato modello di rappresentanza. Nel criticare il telelavoro come
modo di lavorare che penalizza le donne perché “impedisce di socializzare” o “le riporta a
casa”, è facile scorgere il timore che il venir meno del luogo tradizionale del lavoro – la
fabbrica fordista – e forse anche del tempo tradizionale del lavoro – l’orario standard
giornaliero – metta in crisi la sua capacità di contattare i lavoratori (anche per loro “a
vista”), di organizzarli e di controllare il lavoro.
16
SECONDA PARTE
LA NOSTRA INDAGINE:
ESPERIENZE DI SUCCESSO E CRITICITA’
1. I principali risultati delle sperimentazioni osservate e
alcune osservazioni ricorrenti
Come abbiamo visto sopra, i casi analizzati sono stati otto in grandi organizzazioni (quattro nel
pubblico e quattro in aziende private) e alcune/i lavoratrici/tori free-lance, quindi in situazione
che potemmo chiamare di “auto-organizzazione”. In tutti i casi, l’obiettivo di una buon
equilibrio vita-lavoro è al centro della scelta, anche se solo nel caso delle grandi organizzazioni,
l’idea del telelavoro è nata come sperimentazione specifica per risolvere problemi di
conciliazione di noe-madri o altri dipendenti con impegni di cura.
Volendo sintetizzare i giudizi emersi dalle interviste, potremmo concludere che:
praticamente tutte le sperimentazioni hanno dato esito soddisfacente
(tuttavia) non sempre la sperimentazione ha dato il via alla diffusione su larga
scala del telelavoro
Questa sintetica conclusione – che era poi anche l’ipotesi di ricerca da cui siamo partiti – ci
conferma la necessità, se vogliamo capire meglio la portata positiva ed eventualmente anche i
rischi di questo strumento - di spingere lo sguardo un po’ più in profondità.
Per questa ragione abbiamo esaminato dettagliatamente e discusso con i nostri testimoni alcuni
dei temi ricorrenti nella riflessione sul telelavoro: tecnologie, organizzazione del lavoro,
ruolo dei capi, posizione del sindacato, produttività, soddisfazione dei e delle
dipendenti, abitudini e cultura, socialità.
2. Le nuove tecnologie: dal telelavoro “strutturato” al “lavoro
mobile”
Fino a qualche anno fa il costo per attrezzare una postazione di lavoro in casa avevano un certo
peso nello scoraggiare l’introduzione del telelavoro, in particolare in Italia dove le tecnologie si
sono sviluppate piuttosto tardi e sono arrivate tardissimo della pubblica amministrazione. “Ma
attualmente – dice Maria Cecilia Scaldalai della Provincia di Milano (progetto sperimentale
e.work, che coinvolge una decina di lavoratrici con problemi di conciliazione) – basta un
collegamento con Adsl veloce a spese della amministrazione e con una password si può entrare
praticamente in tutte le procedure aziendali”.
Negli ultimi quindici/vent’anni il progresso tecnologico ha reso possibile sviluppare il
telelavoro a costi bassi e ad utilizzi sempre più flessibili. Non sono più solo le aziende high-
tech – come Cisco, Microsoft, Nokia, Polycom, Intel e Ibm – a consentire il lavoro mobile ai
propri dipendenti attraverso dotazioni tecnologiche avanzate. Pc e notebook, smartphone, linee
Adsl e collegamenti wireless sono ormai a disposizione di tutti e rendono facile lavorare lontano
17
dalla propria sede. L’esempio, certamente, è venuto per prime dalle aziende che la tecnologia la
producevano come quelle di elettronica, di informatica, di telecomunicazioni e di telefonia:
anche in Italia le prime ad introdurre il telelavoro sono state Telecom e Ibm. Ma poi si è
allargato alle aziende dove la cultura organizzativa è più avanzata e le figure professionali
hanno mediamente una qualifica elevata, per esempio le aziende chimiche e farmaceutiche –
Solvay, Boehringer, Astrazeneca – e in generale tutte le aziende multinazionali che in Italia
sviluppano soprattutto il business commerciale, quindi hanno soprattutto personale di vendita
(che è mobile per definizione), addetti al marketing e all’assistenza clienti, posizioni non
difficili da rendere flessibili in termini di localizzazione. “Inizialmente, alcune difficoltà
tecniche le abbiamo avute – commenta Patrizia Fabricatore, direttore delle risorse umane di
Astrazeneca, dove da alcuni anni il telelavoro è possibile in molti dei ruoli aziendali – a causa
di problemi di velocità dei sistemi, visto che in zona non esisteva fibra ottica. Poi abbiamo
risolto con Adsl (insieme a quella forniamo ai dipendenti un kit essenziale: computer,
stampante, cassettiera e sedia ergonomica)”.
Ma passi avanti significativi vengono anche da alcune amministrazioni pubbliche e società
per azioni a capitale pubblico, come alcune amministrazioni locali (le Province di Milano e
Torino, il Comune di Cremona, l’Università di Verona), l’Inail, le Poste italiane. “Chi parla di
soluzioni onerosa per la pubblica amministrazione, sbaglia: i costi sono davvero contenuti,
basta l’Adsl e un software per collegarsi all’intranet”, ci dice Scaldalai. Non solo, “i tempi per
installare una linea Adsl a domicilio sono del tutto accettabili, all’incirca 15 giorni”, aggiunge
Ninci di Inail, responsabile di una delle esperienze più importanti - 700 tra lavoratrici e
lavoratori (ma pochi) - di telelavoro in area pubblica in Italia. Inoltre, alcuni lavori si possono
fare off-line: questo amplia di molto la platea dei potenziali fruitori, come è successo
all’Università di Verona dove “il telelavoro si è esteso da benefit per le emergenze conciliative
ad opzione possibile – naturalmente solo per alcuni giorni la settimana - per tutti i lavoratori
che hanno problemi di distanza dalla sede. Sfruttando il fatto che non tutti lavoravano nello
stesso momento, almeno in una prima fase è stato possibile la condivisione di personal
computer e connessioni flat rate”, commenta Donata Gottardi, ordinaria di Diritto del Lavoro
presso l’università e ideatrice del progetto.
Forse all’inizio c’era un problema di sicurezza ma ormai le reti sono rese sicure attraverso
sistemi evoluti di protezione dei dati: attualmente, per esempio, esistono sistemi, come le VPN
(reti private virtuali), in grado di realizzare connessioni sicure tra due o più punti (PC, reti, ecc.)
geograficamente distanti e quindi trasmettere dati anche attraverso una rete pubblica, come
Internet, grazie alla codifica di tutto il traffico da un punto all'altro. In alternativa le applicazioni
aziendali condivise possono essere remotizzate con l'utilizzo di terminali remoti o tramite
pagine web "attive". Tanto che, alla fine, “sono ormai poche le procedure e le banche dati della
nostra ammnistrazione a cui non si può ancora accedere”, ci dice Scaldalai. Ma allora qual è il
problema? “Il telelavoro stravolge la cultura organizzaziva del settore pubblico: timbratura del
cartellino, presenza, contatto diretto, lavoro per adempimenti…” (su questo torniamo più
avanti). Ma non solo, aggiungiamo noi dopo le interviste, molti dirigenti pubblici a volte non
hanno proprio idea delle possibilità della tecnologia, amplificano problemi semplici,
sopravalutano i costi. “E’ un peccato che a volte non ci sia sensibilità e competenza necessaria
da parte delle amministrazioni, visto che in parecchi casi col telelavoro si potrebbe andare
anche oltre i problemi strettamente connessi alle esigenze di conciliazione e risolvere i casi
della mobilità difficile, penso per esempio ai e alle dipendenti che abitano in zone isolate di
montagna”, commenta Clara Bassanini di Pari e Dispari, alla luce di una esperienza pluriennale
nel campo della consulenza agli enti locali sulle politiche di genere.
In conclusione, se guardiamo allo sviluppo delle tecnologie e al loro impatto
sull’equilibrio tra lavoro e vita, non c’è dubbio che sia sempre più ampio il numero
18
di professioni che possono essere coinvolte e sempre maggiore il grado di
flessibilità che consentono. Il vero salto in avanti è quello del telelavoro
destrutturato ovvero del lavoro mobile: in questo senso possiamo davvero parlare
di tecnologie woman-friendly, niente di più lontano da quanto un tempo temevano
alcuni, che il telelavoro avrebbe ricacciato le donne tra le pareti domestiche..
3. Telelavoro nel pubblico e lavoro mobile nel privato?
In fondo, come si è visto, dotazioni tecnologiche “leggere” e orari flessibili non sono così
distanti neanche dalla portata delle organizzazione più burocratiche. Tuttavia, un primo sguardo
alla questione tecnologie e telelavoro col filtro delle esperienze analizzate, fa saltare subito
all’occhio la differenza sostanziale tra le aziende private e le amministrazioni
pubbliche.
Per le aziende private di cui conosciamo le storie, l’offerta di flessibilità spazio-temporale ai
dipendenti nasce dall’obbiettivo di “attrarre talenti”, dato che a parità di condizioni, gli
uomini e le donne migliori vogliono lavorare nelle aziende che consentono più libertà. Ed è un
obiettivo spesso rivolto proprio ai talenti femminili, visto che ormai è chiaro che è soprattutto
nel bacino femminile che si annida il potenziale di talenti inespresso. “Di conseguenza” come
ha dichiarato recentemente l’Amministratore delegato di Microsoft “alle donne tra i 30 e 40
anni, cioè in una fascia di età in cui la maternità è normale, bisogna che l’azienda sia in grado
di dare la possibilità rientrare dopo un figlio senza dover rinunciare alla carriera”.
E’ molto diversa la situazione delle aziende e amministrazioni pubbliche che hanno introdotto il
telelavoro: l’obiettivo iniziale è sempre di tipo sociale: “Si introduce per permettere ai
dipendenti che hanno dei problemi di conciliazione, di alleviare la loro situazione di disagio”,
commenta Enrico Chiais, dirigente della Provincia di Torino che ha attivato alcune postazioni
da casa e quattro telecentri per le dipendenti con problemi di famiglia (in genere si tratta di
assistenza di anziani o disabili, visto che l’età media nella amministrazione non contempla che
pochi casi di maternità). Questo significa stare anche dentro le strette compatibilità del
negoziato col sindacato: telelavoro come diritto per alcune/i, magari anche a scapito della
produttività della mansione. Non che sia sbagliato in sé, anzi. Però forse è sbagliato che sia
negato ad altre occupazioni dove magari i ritorni in termini di produttività sarebbero più alti
perché “non ci sono le condizioni soggettive”. Insomma, come già a suo tempo il part-time, il
telelavoro nelle amministrazioni pubbliche nasce lontano da obiettivi di produttività e di
mercato dei talenti, nasce già dall’inizio come “costo” tecnico-organizzativo, piuttosto
che come obiettivo di performance.
Analogamente, dal punto di vista delle modalità di lavoro, nel pubblico il telelavoro sarà più
spesso quello “strutturato”: full-time, estremamente regolato sui tempi e sulle procedure,
concesso solo agli “aventi diritto”, in quanto presentano caratteristiche precise di difficoltà per
la conciliazione, e lungo una precisa lista di priorità: bambini fino a 8 anni, anziani e disabili
“criticati, distanza dal luogo di lavoro. Questo spiega anche perché gli ambiti di applicazione nel
pubblico appaiano spesso “prudenti”: preferenza per il lavoro on-line da casa o per i telecentri -
dove il lavoro si svolge esattamente come nell’ufficio centrale – per la Provincia di Torino; solo
per situazioni di emergenza – e durata massima un anno – per Inail. Alla fine è legittimo
chiedersi - qualcuno lo fa – quale sia il reale impatto sulla conciliazione: “Forse poco, a queste
condizioni: servirebbero altri strumenti, come la flessibilità degli orari”, commenta Chiais
(Provincia di Torino).
19
Nelle aziende private il lavoro a distanza assume forme molto più articolate: per esempio, il
lavoro da remoto o il lavoro a distanza alternato al lavoro in ufficio, o anche modalità
del tutto informali. Per esempio, un dirigente di Accenture, Rodolfo Landini, ha dichiarato:
“Riteniamo che lavorare sempre da soli rischia di far sentire la persona isolata e abbandonata
e, alla lunga, a portare forme di rigetto verso questa modalità: è importante mantenere un
contatto diretto con l'azienda, per questo il nostro programma prevede che le persone svolgano
da remoto al massimo due giorni la settimana”. Per le figure professionali di buona
qualificazione, nelle aziende più avanzate, – e nel lavoro autonomo professionale – l’opzione
più diffusa è invece piuttosto del telelavoro “informale”: scelto occasionalmente dalla/dal
dipendente in base ad esigenze spesso autogestite, sostenuto da ampie dotazioni tecnologiche
(smartphone, banda larga in casa pagata dall’azienda, schede per collegarsi ai propri file da
qualunque accesso) per tutti i dipendenti e orari flessibili.
Certo, si tratta di un modello che ha senso soprattutto nel terziario avanzato. Ma perché non
potrebbe esserlo anche la Pubblica amministrazione, un terziario avanzato?
Secondo gli operatori intervistati, sì. Non a caso, Antonella Ninci (Inail) dichiara: “Il
nostro vero obiettivo è andare oltre la rigidità tecnica e normativa del modello introdotto e
aprire al telelavoro destrutturato: portatile e reti wireless, per intenderci”. Le fanno eco gli
altri dirigenti pubblici intervistati: “Bisogna superare la normativa pubblica sul telelavoro, che
è troppo rigida” commenta (Provincia Milano) “e pensare quando si può a semplici dotazioni di
pc portatili e cellulari per la reperibilità telefonica”; “Col secondo progetto metteremo insieme
la flessibilità degli spazi con quella dei tempi, cercando di evitare il lavoro da casa integrale”,
aggiunge Chiais (Provincia Torino).
In conclusione, una riflessione va fatta – e, come abbiamo visto, tra gli addetti ai
lavori è già in corso - sul telelavoro pubblico. Sempre tenendo fermo l’obiettivo del
favorire le personali esigenze dei/delle dipendenti di migliorare l’equilibrio delle
loro vite, bisogna prendere atto che la rigidità del modello tradizionale di “lavoro a
casa” (o in sedi decentrate) aiuta troppo poco. Le tecnologie già ora permettono di
andare anche nelle organizzazioni pubbliche verso le forme più flessibili del lavoro
mobile: basta avere il coraggio di fare il passo successivo.
4. Col lavoro a distanza l’assenteismo cala, la produttività
aumenta... ma c’è nascosta qualche insidia Tutti gli intervistati concordano sul fatto che l’assenteismo dei dipendenti in telelavoro si
riduce di molto: anche in caso di malattia lieve, visto che non deve uscire di casa, il lavoratore
spesso non interrompe il lavoro e comunque più difficilmente chiede permessi per le malattie
dei bambini o altre ragioni: il progetto e.work (Provincia di Milano) segnala che tutti i dirigenti
giudicano positivamente l’esperienza, tra l’altro perché “diminuiscono le assenze della
lavoratrice-madre, in quanto può autogestirsi le emergenze”, anche Enrico Chiais, dirigente
della Provincia di Torino che ha attuato una sorta di decentramento verso uffici periferici (anche
comunali) per aiutare i/le dipendenti con problemi di famiglia, si dice soddisfatto
dell’esperienza “perché diminuendo i disagi si sono ridotte le assenze”.
L’aumento della produttività viene in molti casi anche da cambiamenti importanti nel rapporto
col lavoro. “L’autonomia nella organizzazione del lavoro ha fatto aumentare la motivazione e
la soddisfazione delle dipendenti coinvolte e prodotto un oggettivo miglioramento qualitativo
e quantitativo della prestazione lavorativa”, ci dice Fabricatore (Astrazeneca) mentre alla
20
Provincia di Milano, il monitoraggio finale dei risultati è ancora più esplicito: le lavoratrici non
solo hanno avuto vantaggi di flessibilità ma “constatano il rafforzamento della responsabilità e
il miglioramento della capacità di autodisciplinarsi e di auto organizzarsi: in pratica, un
risultato importante in termini di crescita dell’autostima”, come scrive Scaldalai.
Quando è misurabile comparativamente, anche il rendimento medio del lavoro aumenta. Il
caso più eclatante, in Italia è quello di Poste italiane che ammettono aumenti del rendimento dei
lavoratori in remote working fino al 30% e cali dell’assenteismo fino al 25%. Per non parlare
del fatto che dove il telelavoro è diffuso a livello di massa, calano di molto anche i costi
aziendali per gli spazi immobiliari e i costi di trasporto (e la perdita di tempo) dei dipendenti:
British Telecom, per fare un esempio, dopo dieci anni di telelavoro ha risparmiato 300 milioni
di euro di spesa per gli immobili e 1.800 anni di tempi di trasferta per il personale. Ma anche se
piccolissima scala, l’effetto è molto evidente: “Per un programmatore come me, lavorare da
casa ha vantaggi indubbi dal punto di vista della concentrazione, visto che in ufficio le
interruzioni telefoniche e fisiche erano continue..”, ci racconta Franco G. che lavora per una
azienda di produzione software.
Per il pubblico, la concessione della possibilità di lavorare a distanza costituisce anche una leva
per trattenere le risorse: di fronte a gravi problemi di famiglia, la lavoratrice può essere
tentata di lasciare (o almeno di prendersi una lunga aspettativa) ma “dato che di questi tempi
non si può assumere, il telelavoro ci consente di non perdere una risorsa”, ha dichiarato Ninci
(Inail). In generale, il telelavoro per le lavoratrici madri consente alle aziende di “limitare il
ricorso a lunghi congedi parentali delle dipendenti”, per l’impatto negativo che hanno sul
rendimento e sullo sviluppo professionale, come si dice esplicitamente negli accordi di Solvay e
Boehringer.
Ma la produttività aumenta anche e forse soprattutto in ragione del check-up
organizzativo che l’introduzione dei nuovi modi di lavorare comporta. In Solvay, “il lavoro di
analisi organizzativa relativo alle verifica di telelavorabilità delle attività e gli adattamenti
organizzativi e procedurali che ne sono conseguiti hanno fornito interessanti spunti di sviluppo
organizzativo”, spiega Valeria Sborlino, che ha seguito come consulente esterna una delle
esperienze-pilota di telelavoro, quella della Solvay.
L’aumento di produttività è correlato alla flessibilità e all’ampliamento della capacità creativa
delle risorse umane: come da sempre insegnano le grandi organizzazioni high-tech – Microsoft,
Apple, Ibm – le prime ad introdurre grande flessibilità e autonomia nel lavoro, l’uso delle
tecnologie mobili (laptop, palmari, reti wireless) aumenta l’una e l’altra. Lo sostiene anche
Roberta Cocco, dirigente marketing e responsabile progetto futuro@lfemminile di Microsoft
Italia, quando afferma: “la difficile congiuntura economica impone alle aziende più alti livelli di
flessibilità e creatività: una delle chiavi per raggiungere questi risultati è proprio
rappresentata dai nuovi dispositivi mobili, che introducono modelli organizzativi molto
innovativi rendendo finalmente possibile conciliare i tempi del lavoro e della vita personale”.
Addirittura, in alcuni casi, il rischio è quello di lavorare troppo. E’ di questi giorni lo studio
di Cisco Systems sul multitasking digitale che rivela come molti lavoratori – soprattutto liberi
professionisti – abbiano una “giornata digitale” ben superiore alla normale giornata di 24 ore,
perché usano contemporaneamente più tecnologie: telefonano mentre rispondono alla posta
elettronica o navigano su Internet, sentendo musica on-line o chattando. Per chi lavora su
obiettivi stabiliti in base ai carichi di lavoro medi, come all’Inail e alla Provincia di Milano e in
genere per di dipendenti delle grandi organizzazioni, questo rischio è più contenuto. Ma per i
dirigenti o per i professionisti in proprio, l’esperienza di lavorare troppo è abbastanza consueta:
manca uno stacco netto tra giornata lavorativa e altri tempi della vita, si è portati a finire quello
21
che si sta facendo, si subisce la pressione della scadenza. Anche indipendentemente dall’uso
delle tecnologie, il workaholism è particolarmente diffuso proprio tra i managers e nelle
professioni autonome: avvocati, commercialisti, artigiani. Il problema dovrebbe comunque
toccare di meno le donne e tutti quelli che hanno vincoli di cura: in questo caso, infatti, è
probabile che gli impegni familiari pongano freno alla seduzione del lavorare troppo..
Comunque, il fenomeno merita qualche riflessione. L’impressione è che l’abitudine a
lavorare in modo etero-controllato ci abbia condizionato al punto che aspettiamo che siano
altri a dirci quando abbiamo lavorato abbastanza. Va costruito insomma un modello di auto-
organizzazione dei tempi e di misurazione di quanto si produce, che può venire solo
con l’esperienza: sbagliando per eccesso e per difetto, tenendo a bada l’ansia e i sensi di colpa.
Bisogna riconoscere che le organizzazioni e i loro sistemi di controllo hanno (avuto) una loro
funzione. Ma non per questo decidere che si deve tornare indietro!
Qui dunque già possiamo segnalare una seconda questione. Il passaggio dal taylorismo alla
autonomia del lavoro porta probabili guadagni all’impresa ma non è un passaggio
indolore per chi lavora. Per alcuni c’è un problema di trovare, fuori dal controllo a
vista, una propria motivazione. Per altri, al contrario, il problema è quello di
contenere la smania di lavoro. In entrambi i casi, nell’attesa che si affermi una
nuova cultura, è opportuna qualche forma di accompagnamento: formazione,
gruppi di ascolto, monitoraggio delle esperienze e dei risultati.
5. Pianificazione e controllo delle attività sono cruciali, se si
vuole fare a meno della misurazione a tempo
Secondo alcuni modelli, il 60% del lavoro che si svolge nelle aziende potrebbe essere eseguito
tranquillamente da casa, con tutti i criteri di sicurezza e privacy che le attuali tecnologie
permettono. Eppure la semplice analisi empirica mostra che non è solo questione di tecnologia,
ma anche di cultura. La cultura della presenza e del tempo è dura a morire: sono pochi
i dirigenti che quando chiamano una delle persone con cui lavorano e sentono che è in giro non
lo considerano un problema, anche se qualcuno c’è: “quando questo succede penso
semplicemente che magari lavorerà a mezzanotte cercando un equilibrio personale tra impegni
familiari e di lavoro”, afferma il manager di una multinazionale americana dell’informatica.
Da noi, persino nelle aziende informatiche, le cose sono diverse. Una delle nostre testimonianze
riguarda un lavoratore informatico, che gestisce sistemi da remoto (le aziende-clienti sono
all’estero), fa quindi un’attività che non prevede la presenza fisica in azienda. Per gravi
problemi familiari ha chiesto di poter lavorare da casa – il lavoro sarebbe esattamente lo stesso –
ma si è sentito rispondere che l’azienda non è d’accordo, perché teme che tutti potrebbero
restare a casa “a farsi i loro porci comodi”.. La stessa dirigente della Provincia di Milano che ha
portato avanti con entusiasmo la sperimentazione di cui abbiamo riferito, confessa che questa
esperienza, attualmente legata a ragioni di conciliazione, non potrebbe facilmente essere estesa a
tutti i dipendenti: il timore, magari non confessato, dell’alta dirigenza pubblica, è “che
i dipendenti, specialmente i maschi, se ne approfittino per fare un'altra attività”.
Al datore di lavoro non piace il fatto che un suo dipendente non sia presente fisicamente perché
non è possibile controllarlo, vedere che cosa sta facendo. In Italia siamo ancora ancorati al
modello gerarchico burocratico, si tende a voler avere un controllo fisico della presenza del
lavoratore e del tempo lavorato. In pratica, è opinione dominante che il lavoratore, se sta al
22
suo posto di lavoro, produce di più e meglio e che non c’è niente che possa sostituire la
supervisione “a vista”. Come ci ha detto Francesco Ferrari, Responsabile Sviluppo
Organizzativo e Risorse Umane di Cna di Bologna, vale ancora il principio che “l’occhio del
padrone ingrassa il cavallo”. Per non parlare del fatto che, nei ruoli manageriali e dei
professionals, in Italia l’abitudine a vere e proprie forme di “presenzialismo” sono molto diffuse
e la cultura del “visibile quindi fedele” è difficile da sconfiggere: Franco G., un informatico
intervistato ricordava che “anche se l'azienda dove lavoro è forse una delle più evolute e
moderne, quando ho scelto il lavoro mobile ho avuto problemi a convincere i miei capi che un
lavoratore da casa spesso produce di più di quello che si ferma in ufficio fino a tardi, per farsi
vedere o magari solo per sfruttare la connessione veloce a Internet!”.
Insomma, il controllo è uno dei problemi più importanti - anzi forse “il” problema –
quando si parla di telelavoro. Eppure la gran parte delle attività sono misurabili (se non
misurate) e anche nella pubblica amministrazione il controllo di gestione è quasi dappertutto
una realtà. E allora? Tecnicamente il passaggio è già possibile, culturalmente no: c’è difficoltà
e pigrizia a modificare abitudini consolidate.
D’altra parte, l’innovazione nel sistema di controllo e di organizzazione del lavoro, almeno
all’inizio, comporta un grande sforzo organizzativo. Innanzitutto bisogna fare l’analisi delle
attività e della loro telelavorabilità: “Non tutte le nostre attività si possono lavorare a
distanza”, dichiara Ferrari (Cna), “una parte del lavoro è di contatto face-to face col cliente ed è
difficile risolvere il problema solo dirottando sul cellulare le chiamate telefoniche o
assicurandosi la reperibilità del dipendente in alcune fasce orarie. Il lavoro di back-office
invece si può fare da casa: questo comporta la ricostruzione di alcune mansioni da affidare a
chi lavora a distanza”. Decisamente più ampia la telelavorabilità realizzata in Astrazeneca:
“Abbiamo suddiviso le attività tra quelle che producono un output digitalizzabile, cioè gestibile
e fruibile attraverso le Ict e invece quelle il cui output ha una natura materiale o relazionale
(confezionamento di prodotti, coordinamento di persone, etc.) quindi difficilmente
digitalizzabile. A parte questi ultime, dal lavoro a distanza sono esclusi solo i ruoli che
lavorano su sistemi non accessibili fuori dall’azienda. Quelli che lavorano sugli altri ruoli –
siano essi addetti alla segreteria, alla pianificazione della produzione, al customer service, alla
gestione dei dati – possono accedere al telelavoro” ci spiega Fabricatore.
In secondo luogo, bisogna definire i risultati misurabili che ci si attende da ciascuno.
“Abbiamo sempre puntato alla cultura della performance basata sui risultati”, ci dice
Fabricatore di Astrazeneca “quindi il passaggio al lavoro a distanza non è stato un problema”.
Allo stesso modo in Solvay “il telelavoro ha semplicemente consolidato una cultura aziendale
basata sull’organizzazione dei processi di lavoro per obiettivi, collegato alla valutazione
annuale della performance in relazione agli obiettivi raggiunti, che già esisteva in azienda”,
commenta Sborlino. Dove c’è esperienza di controllo di gestione, come alla Provincia di
Milano, non c’è problema: “si fa riferimento agli standard di produzione”, conferma Scaldalai.
E proprio i dirigenti della Provincia di Milano confermano che il significativo passo avanti col
telelavoro è proprio “la certezza del risultato”. Dove non c’è già questa cultura, il lavoro da fare
è in questa direzione. All’Inail, dove il telelavoro è molto diffuso ma solo per ragioni di
emergenza familiare (dura al massimo 1 anno), si è risolto il problema “assegnando alla/al
dipendente un progetto speciale, in genere il recupero di un arretrato o qualcosa di simile”, ci
dice Ninci: in questo modo si è evitato il problema di definire i risultati attesi dai ruoli così
come sono attualmente organizzati. Ma in genere, se manca un lavoro preventivo di analisi delle
attività e di lavoro per obiettivi, questa è la parte più difficile. Per esempio, nel lavoro di
Fiorenza P. una professionista free-lance (progettista di cooperazione internazionale) che
abbiamo intervistato, “non sempre il committente fa lo sforzo di definire degli standard, a volte
23
non è neanche facile, definisce un certo numero di giornate a forfait o una percentuale del
budget del progetto .. (e alla fine, se lavori in sede e ti vede, è più convinto!)”.
Quando i risultati attesi sono stabiliti, basta solo controllare se i risultati vengono
raggiunti, adeguare gli obbiettivi di volta in volta, sanzionare il non raggiungimento dei
risultati. Certamente, “nelle posizioni meno strutturate, i capi fanno più fatica, il loro controllo
è più discrezionale e a qualcuno può non piacere” fa notare Sborlino (Solvay).
Proprio in vista di uno sforzo organizzativo così importante, a volte le sperimentazioni
introdotte in questi anni – generalmente su piccoli numeri – si sono rivelate particolarmente
onerose per le direzioni aziendali. “Per consentire il telelavoro abbiamo prodotto un grande
sforzo di persuasione dei dirigenti e dei colleghi e a volte anche il ridisegno delle mansioni” –
dice Ferrari (Cna) – “per poi scoprire che solo poche/i dipendenti sono interessati. Ne concludo
che è necessario avere una certa ‘massa critica’ perché valga la pena intraprendere questa
soluzione”. D’altra parte, dove l’organizzazione funzionava già bene, col telelavoro si registra
un ulteriore passaggio organizzativo che avvantaggia tutta l’azienda. La HR manager di
Astrazeneca ci conferma: “Col telelavoro è cambiata davvero l’organizzazione del lavoro,
perché è aumentata l’autonomia degli individui nella gestione ed organizzazione dei
propri compiti”.
Come si vede, il grande lavoro da fare viene prima di varare il lavoro a distanza. Consiste in
un grande sforzo organizzativo di analisi delle attività e delle mansioni, di loro
riformulazione quando è necessario, di introduzione di nuovi sistemi di controllo in
base ai risultati e tutto il cambiamento che questo comporta nella cultura aziendale
e nei comportamenti dei responsabili e dei dipendenti.
6. Capi e colleghi: il lavoro a distanza interroga la struttura
delle relazioni interne
Avevamo immaginato che telelavoro e lavoro mobile potessero creare problemi con i capi: c’è
tutta una letteratura in tal senso. Quello che non immaginavamo era la possibilità di problemi
con i colleghi: per fortuna rari ma presenti nelle nostre esperienze e quindi interessanti da
vagliare.
Inutile dire che, quando si implementano queste forme di lavoro, la dirigenza intermedia,
ovvero il capo diretto dei dipendenti che lavorano a distanza, si trova di fronte a un
cambiamento decisamente significativo, il cui impatto per giunta ricade in grande parte proprio
su lui. Se l’organizzazione è già evoluta – controllo di gestione, analisi dei carichi di lavoro,
sistema premiante collegato ai risultati – le difficoltà sono minori. Se l’organizzazione è più
tradizionale, la responsabilità – pur all’interno di norme aziendali generali magari negoziate col
sindacato - di stabilire obiettivi concreti di lavoro, di misurarli e di premiare o
sanzionare il lavoro svolto sta tutta al capo.
Se non esiste già un elenco ragionato di posizioni telelavorabili, è ai dirigenti che spetta anche il
compito ingrato di decidere chi può lavorare a distanza e chi no, come eventualmente
accorpare le mansioni e ridistribuire il lavoro tra i colleghi. Secondo Sborlino, che ha seguito
l’esperienza Solvay, c’è effettivamente stato qualche problema per i dirigenti, quando dovevano
stabilire a chi assegnare il telelavoro e a chi no. “Quando la scelta è fatta in ragione di
condizioni soggettive - ovvero problemi dei dipendenti – si scontra con l’idea di universalità dei
diritti, quando è fatta in ragione delle condizioni oggettive – le caratteristiche della posizione di
24
lavoro – genera la richiesta di modifica della organizzazione del lavoro o delle mansioni:
insomma in tutti i casi, il responsabile deve prendersi delle responsabilità”. Anche Fabricatore
sostiene che per i responsabili all’inizio non è stato facile: “A parte il fatto che non avevano più
il collaboratore sott’occhio, è stato loro richiesto un grande lavoro di pianificazione. Da
questo punto di vista, è servito che il lavoro mobile fosse introdotto per via sperimentale..”. La
stessa situazione è segnalata alla Boeheringer: “Non abbiamo fatto una analisi generale delle
attività telelavorabili: tocca ai capi decidere di volta in volta se il telelavoro è possibile o no e a
quali condizioni. Il compito non è facile, per cui la direzione risorse offre supporti per
raggiungere una valutazione il più possibile oggettiva: un giudizio troppo soggettivo creerebbe
tensioni tra il capo e il collaboratore eventualmente escluso o i colleghi”, ci dice Alessandra
Giacobbe delle direzione Risorse umane dell’azienda.
Altre volte, probabilmente, la difficoltà è nella verifica dei risultati quando non sono quelli
attesi: bisogna capire dove sta il problema, ripianificare, incoraggiare ma a volte anche
evidenziare il risultato negativo: non tutti i capi sono capaci di gestire questi aspetti del
controllo della prestazione che nel vecchio sistema erano comodamente risolti dalla timbratura
del cartellino. Nella nuova organizzazione della prestazione, “è necessario che si instauri un
rapporto forte di fiducia tra capo e collaboratore”, aggiunge Giacobbe (Boehringer-Ingelheim).
La prima difficoltà resta comunque quella culturale, la resistenza ad accettare che qualcosa
cambi nell’organizzazione e, ancora di più, la resistenza a mettere in discussione il
proprio ruolo. Alla Provincia di Milano, la questione dei capi intermedi è stata risolta
intervenendo di volta in volta. “Un’esperienza come quella che abbiamo fatto richiede una
analisi dettagliata delle attività e dei ruoli: in qualche caso ne è emersa un fotografia
impietosa. I capi hanno dovuto affrontare il problema della pianificazione e lavorare sia nella
revisione del proprio ruolo - visto che a volte ci si è scontrati con la mancanza di competenze
(che per altro non erano proprio previste nell’avanzamento di carriera) – sia delle relazioni
interne al gruppo. Ma non c’è stata molta opposizione e alla fine erano soddisfatti tutti”.
In realtà una delle difficoltà che i capi devono affrontare è quella di rendere coerente la nuova
modalità lavorativa col lavoro dei colleghi del/della lavoratrice a distanza. A volte si possono
telelavorare solo alcune delle attività precedentemente previste per quella posizione e allora
bisogna fare accettare ai colleghi una distribuzione diversa. Altre volte l’interazione tra i
colleghi a distanza diventa più difficoltosa, bisogna formalizzare modalità di confronto e
di cooperazione che prima avvenivano spontaneamente, magari istituzionalizzando riunioni
settimanali o confronti preventivi, o gruppi di lavoro che prima non erano necessari: da questo
sforzo di lettura delle interazioni tra colleghi e tra capo e collaboratori a volte nasce una
migliore organizzazione del flusso di comunicazione e del modello di relazioni interne: è, per
esempio, il caso della Provincia di Milano.
In quasi tutti i casi in cui il telelavoro è stato introdotto come “benefit sociale”, almeno all’inizio
si sono ingenerate tensioni tra colleghi: “la possibilità di lavorare da casa tutti i pomeriggi o
parte della settimana è stata vissuta da alcune colleghe come privilegio immeritato - ai miei
tempi non c’era.. – e comunque con l’aspettativa negativa di dover magari supplire alle
conseguenze organizzative dell’assenza della collega dovendo lavorare di più, come capita
quando viene concesso il part-time..”, ci ha detto Ferrari di Cna Bologna (il progetto è appena
iniziato). Anche alla Provincia di Milano, il monitoraggio segnala “colleghi e colleghe
inizialmente scettici…” ma alla fine soddisfazione per tutti, dal momento che “qualche
moderata modifica sul versante dei ruoli e delle relazioni ha comunque rispettato le
professionalità di tutti” e “prodotto risultati al di là delle aspettative”.
25
In conclusione, possiamo dire che il problema dei capi esiste ma solo quando non ci
sono un disegno organizzativo e un sistema di controllo adeguati e quindi anche
una buona cultura aziendale di sostegno. Il problema dei colleghi si verifica solo in
qualche caso, in particolare nelle realtà dove il telelavoro è una specie di benefit
non disponibile per tutti. In ogni caso, comunque, la rete delle relazioni interne –
tra colleghi e tra capi e collaboratori - richiede molta attenzione e qualche
maggiore formalizzazione: cosa che alla fine migliora anche il lavoro interno.
6. Chi lavora a distanza è contento, di più se il lavoro è
flessibile (anche se qualcuno torna volentieri in azienda)
Le interviste di monitoraggio della sperimentazione in Solvay – telelavoro classico
“homebased” per madri e padri di bambini entro l’anno di età - raccontano di una ampia
soddisfazione delle lavoratrici (valutazione media: 4,84 su scala 1-5): nell’ordine ciò che riceve
la valutazione più alta sono i rapporti con il proprio responsabile e i colleghi mentre
viene segnalata qualche maggiore difficoltà rispetto alla conciliazione tra lavoro e
maternità, aspetto legato alla presenza o meno di un aiuto esterno e a particolari fasi di crescita
dei bambini; solo in pochi casi si registrano difficoltà dovute al fatto di non essere in ufficio ma
viene comunque sottolineata l’importanza di identificare chiaramente le attività da svolgere
durante il telelavoro, così come le relative modalità di valutazione. Anche in Cna Bologna, dove
l’esperienza è appena iniziata, sembra che mentre vi è stata subito una buona risposta dal punto
di vista dell’efficienza organizzativa, in alcuni casi sia necessaria una fase di rodaggio più
lungo per gli aspetti che si riferiscono alla organizzazione familiare. Comunque,
Rosanna M., una delle lavoratrici coinvolte che è assistente di direzione, ci ha detto: “La mia
esperienza è assolutamente positiva e, per quanto riguarda il tipo di attività di cui mi occupo, è
risultata realizzabile senza alcun problema né organizzativo né di relazione con la struttura
aziendale. Con il telelavoro la conciliazione famiglia/lavoro è realmente attuabile”.
Nei quasi dieci anni di applicazione all’Università di Verona, il telelavoro – inizialmente
“azione positiva”, legato alle lavoratrici ma poi esteso come possibile opzione a tutti in base ad
alcuni criteri sociali e organizzativi – ha avuto un grande successo. Le richieste sono
moltissime, “tanto che – commenta Gottardi,– siamo stato costretti ad irrigidire i criteri di
accesso, cosa che non volevamo fare: non è sempre facile distinguere in base a criteri oggettivi
il reale stato di bisogno…”.
Sono soddisfatte dell’esperienza le lavoratrici che hanno sperimentato l’e.work alla
Provincia di Milano. Ed è interessante che sottolineino al primo posto aspetti di crescita
professionale: una migliore capacità di auto-organizzarsi, rafforzamento della responsabilità,
una visione più completa del processo di lavoro. Tra le criticità, viene evidenziata qualche
maggiore difficoltà di rapporto con i colleghi, ampiamente controbilanciata dai benefici di una
gestione più serena del ruolo familiare. Scaldalai ritiene che si tratti di aspetti “in parte
fisiologici, in parte risolvibili sul piano organizzativo, migliorando il flusso di comunicazione” .
Anche i risultati della Provincia di Torino sono incoraggianti. Lavoratrici e lavoratori che
hanno lavorato nei telecentri hanno potuto risolvere almeno in parte l’esigenza di essere più
presenti in famiglia, avendo ridotto i tempi di pendolarismo. Anche qui qualche problema
organizzativo, in questo caso dovuto alla necessità di dividere gli spazi con lavoratori addetti ad
altre funzioni. “Nel nostro caso – dice Chiais - il problema non è tanto quello del gradimento in
sé da parte della lavoratrice: vediamo infatti che le esigenze di stare più vicini alla famiglia e
26
soprattutto agli anziani, stanno crescendo e temiamo che troppe richieste compromettano il
funzionamento dell’ente”.
Anche ad Astrazeneca, dove il telelavoro è parziale (alcuni giorni a casa, alcuni in
azienda), i risultati della sperimentazione sono stati così buoni che si è deciso di confermarla
alle sperimentatrici ed estenderla come normale alternativa di lavoro. In questo caso, dice
Fabricatore: “qualche timore di isolamento è stato scongiurato dall’elevata flessibilità dei
giorni telelavorabili che viene concordata tra manager e collaboratore”. Le fa eco una
dipendente in telelavoro Miranda F., che dice “La lontananza dall’azienda non pesa perché il
contatto c’è, giornaliero, sia col capo che coi colleghi, inoltre telelavoro solo due giorni la
settimana”.
E’ soddisfatta Sabina D., che ha un bambino piccolo e lavora a distanza in modo semi-
strutturato, nel senso che ha un contratto di telelavoro che le lascia la possibilità di
scegliere l’orario: “E’ proprio grazie a questa flessibilità che riesco a garantire uno
standard prestazionale piuttosto elevato: spesso, infatti, lavoro di primissima mattina o alla
sera tardi, o comunque quando mio figlio dorme (e la casa si zittisce), quindi in orari che in
ufficio sarebbero palesemente impossibili”.
Non cambierebbe per nulla al mondo la soluzione che ha trovato - lavorare per metà a casa
e per metà in ufficio - Pier Enzo W., dipendente di una multinazionale chimica che ha sede
nel milanese: “Faccio un lavoro che mi piace, esco ogni tanto coi colleghi, mantengo la vita
privata. Non sarebbe così, se passassi tutto il mio tempo in ufficio o tutto a casa”.
E’ più che contento Christian L., dipendente di una media azienda manifatturiera lombarda, che
addirittura lavora dall’estero: “Gli strumenti per il telelavoro ci sono e sono funzionali. Io è
un anno che lavoro dall’Olanda, dove mi sono trasferito e devo dire che non solo è migliorata
la mia qualità di vita, sono molto più concentrato sui problemi, sui progetti e su tutto quello che
la mia posizione richiede. Non mi stresso nel traffico, non inquino con la mia auto ogni giorno e
tramite connessione a banda larga sono collegato con il mondo e riesco a controllare tutti i
dispositivi che mi permettono di lavorare al meglio”.
Ma c’è anche qualcuno che torna volentieri in azienda. E non potrebbe non essere così.
All’Inail, il telelavoro è concesso per un anno, quindi poi le lavoratrici rientrano in ufficio e,
come ci racconta Ninci, “in genere anche quelle che hanno i bambini piccoli sono contente di
ritornare alle consuete relazioni con colleghi e capi”. Tanto sanno che, in caso di necessità,
potranno riprendere il telelavoro quando vorranno.
7. Numeri contingentati, condizioni soggettive vincolanti,
tempi massimi: il sindacato ha ancora paura del telelavoro
Oltre che una opportunità preziosa per le lavoratrici e i lavoratori con problemi di cura e una
opzione di lavoro diffusa nelle aziende high-tech e nelle knowledge professions, il lavoro
flessibile a distanza sta diventando una modalità sempre più necessaria
nell’economia globalizzata: clienti all’estero e servizi off-shored prevedono per i dipendenti
una reperibilità amplissima che spesso comprende la notte, la cosiddetta disponibilità “around
the clock”. Questo quadro mette bene in evidenza le difficoltà a cui si trova di fronte il
sindacato anche da un punto di vista più generale, data il crescente bisogno delle imprese,
27
anche indipendentemente dal lavoro a distanza, di flessibilità degli orari: le nuove forme di
lavoro sicuramente non toccano attualmente la gran parte di lavoratrici e lavoratori
ma sembrano diffondersi abbastanza velocemente. Su questo, il sindacato sembra non avere
un piano preciso.
Quando anni fa si è profilato il problema del telelavoro – quello classico – la risposta è stata più
che prudente. Non solo in Italia ma in tutta Europa le parti sociali hanno scelto la strada della
tutela più che quella del sostegno alla sua diffusione, come invece raccomanda la
Commissione europea. In realtà, la normativa sul telelavoro nasceva in un momento di
grande novità e di incertezza sugli sviluppi della tecnologia e la prudenza era inevitabile. I
timori erano due: che le donne meno qualificate fossero ghettizzate in forme di lavoro poco
tutelate, come il vecchio lavoro a domicilio; che il telelavoro rompesse quella “unità di
luogo” che ha caratterizzato per un secolo il sindacato industriale.
Si inaugura così un processo di tutela, di cui sono capisaldi: l’Accordo quadro europeo (16
luglio 2002), l’Accordo interconfederale (9 giugno 2004) e, soprattutto, la normativa introdotta
nel pubblico impiego (legge 16 giugno 1998, n. 191, detta Bassanini ter), il cui orientamento
prevalente è quello di confermare che il regime contrattuale del telelavoratore resta quello del
lavoro subordinato con tutte le sue regole e condizioni di lavoro. In realtà, poi, nel dubbio di
vedersi sfuggire di mano il controllo della organizzazione della prestazione, l’atteggiamento del
sindacato è andato ben oltre questa previsione – di per sé del tutto condivisibile – e ha finito per
collocarsi piuttosto in una posizione di difesa molto rigida della organizzazione del
lavoro tradizionale. Infatti, la contrattazione si è sviluppata immaginando una solo forma di
telelavoro, quello homebased tradizionale on-line, in cui il lavoratore fa a casa esattamente ciò
che faceva in ufficio con gli stessi orari, le stesse pause, etc.: attorno a questa sono stati costruiti
una serie infinita di vincoli - le condizioni particolari per averne diritto, il tetto massimo di
lavoratori, il tempo massimo di utilizzo, la ripartizione dei costi, le caratteristiche ergonomiche
della postazione (!), le condizioni di sicurezza, di privacy, di orari di lavoro, di reperibilità, etc.
– che lo rendono pressoché impossibile da applicare su scala ampia se non, come nei fatti
succede, in condizioni di evasione degli accordi contrattuali. Qualcuno dei nostri intervistati ha
commentato che “la normativa è talebana: non si può lavorare sempre da casa, sempre on-
line, etc.”. Altri, anche di area pubblica, hanno spiegato di aver evitato le postazioni fisse per
“bypassare la legge 626 con tutte le sue costose rigidità”. Qualcuno ha sostenuto che il lungo
elenco di condizioni – quelle soggettive legate alle esigenze di conciliazione, quelle oggettive
legate alla tele lavorabilità – “rendono veramente complicata la gestione da parte dei
managers”.
Succede così che le forme più flessibili di lavoro a distanza - quelle ormai più diffuse, quelle
che non più basate sull’orario ma sui risultati, quelle tra l’altro che prevedono la più ampia
autogestione e quindi le migliori condizioni per la conciliazione – restano attualmente
prive di qualsiasi riferimento normativo e affidate agli accordi informali e fiduciari
tra capo e collaboratori. Intervenire su queste forme è certamente complicato ma, come
abbiamo visto, è proprio il lavoro mobile la nuova frontiera ed è lì che andrebbe costruita
qualche rete (leggera) di protezione.
Il sindacato invece ha fatto sua l’unica vera obiezione al telelavoro – quella di possibili rischi
di isolamento (comunque sono ipotizzabili solo nel caso del telelavoro totalmente homebased)
– e ne ha fatto molto di più: una bandiera. Nonostante il gradimento elevato da parte
dei lavoratori che abbiamo registrato anche in questo studio sui risultati delle
sperimentazioni aziendali (tutte fatte, tra l’altro, attraverso accordo sindacale), alcuni
sindacalisti anche poche settimane fa hanno fatto dichiarazioni del tipo: “Le persone hanno
28
bisogno di parlarsi e di vedersi, non è tutto risolvibile con la webcam e i messenger. E infatti i
milioni di telelavoratori che aveva previsto l'Ue non sono arrivati”. E ancora: “Sarà anche per
la debolezza che abbiamo nelle nuove tecnologie, ma di sicuro è perché (noi italiani) abbiamo
un approccio culturale diverso rispetto al lavoro. Per noi è un elemento centrale anche in
termini di relazioni sociali, di integrazione e di crescita professionale. Il telelavoro riduce
queste possibilità”8.
Il sindacato ha diritto di difendere il suo ruolo, soprattutto visto che lo fa in difesa dei lavoratori.
E certamente la frammentazione dei luoghi di lavoro non lo avvantaggia. Ma le
nuove tecnologie sì: forse è di questo che bisognerebbe parlare. Le accorate difese contro
l’isolamento delle lavoratrici, invece, non sono del tutto convincenti. Già altre volte si
era già sentita questa difesa delle lavoratrici (contro loro stesse!): era quando si è cominciato a
parlare di part-time e allora si era detto che non garantiva l’autonomia economica (ma la vera
paura era la rottura dell’unicità del contratto di lavoro). Per ‘sdoganare’ il part-time sono
dovuti passare quasi vent’anni, speriamo che non ce ne vogliano altrettanto per
poter lavorare a distanza.
8 Corriere della Sera, 18 gennaio 2009
29
RACCOMANDAZIONI
SUGGERIMENTI ALLE PARTI SOCIALI, ALLE
ISTITUZIONI,
A LAVORATORI E LAVORATRICI,
Per concludere
Non il telelavoro tradizionale ma lavoro mobile è veramente woman-friendly, dato che
unisce tecnologie leggere e flessibilità d’orario.
Le nuove tecnologie Ict mobili sono pienamente accessibili alle donne.
Le nuove tecnologie Ict sono destinate ad essere il principale alleato delle donne e degli
uomini che aspirano ad un migliore equilibrio vita-lavoro
Suggerimenti alle imprese
1. Il lavoro a distanza richiede un grande sforzo organizzativo (vale per le
organizzazioni private e per quelle pubbliche) Tutti gli esperti concordano: il telelavoro è molto più un problema organizzativo che
tecnologico. Per questo è necessario intraprendere con pazienza un lavoro di analisi, di
pianificazione e di controllo delle attività, per poter passare dalla misurazione a tempo alla
valutazione in base ai risultati. Non si possono introdurre forme di lavoro mobile – che non
siano il vecchio rigido lavoro on-line da casa o telelavoro nei telecentri - se non si compie
prima questo passaggio organizzativo. Questa innovazione è comunque richiesta dalle
organizzazione più evolute – e molte l’hanno già fatto – anche indipendentemente dal
lavoro a distanza, per migliorare la trasparenza organizzativa e la misurazione della
performance. Una volta modificati organizzazione e sistema di controllo, il gioco del lavoro
a distanza è fatto. E il gioco vale la candela perché motivazione dei/delle dipendenti,
responsabilità, produttività e qualità aumentano.
2. L’innovazione tecnologica e la sua diffusione hanno messo a disposizione
supporti tecnici molto adattabili e a costi bassi Va sfatata la vecchia idea delle rigide “postazioni” casalinghe: tecnologie mobili come
laptop, palmari, smartphones e collegamenti di ultima generazione consentono di lavorare
da qualsiasi luogo, di accedere alle reti aziendali, di tenere costanti contatti con capi e
colleghi, con i clienti e, soprattutto per le lavoratrici e i lavoratori autonomi - con la propria
comunità professionale.
3. Nella pubblica amministrazione l’introduzione di forme di lavoro a distanza
può essere una buona leva per non perdere risorse, nel privato è certamente
un modo per attrarre talenti Nella perdurante difficoltà ad assumere che caratterizza la nostra pubblica amministrazione,
il migliore utilizzo del personale diventa un fattore-chiave nella gestione delle risorse
umane: contenere le dimissioni per ragioni di cura, la durata dei congedi e le assenze per
30
malattie ei bambini consente alle amministrazioni di migliorare le performance e di
fidelizzare i/le dipendenti. Nelle organizzazioni private – ma anche in quelle pubbliche –
offrire una buona qualità della vita di lavoro soprattutto nelle fasi più delicate, come quelle
che riguardano la cura di bambini piccoli, può essere la mossa vincente per garantirsi le
donne e gli uomini migliori.
4. Va costruita una nuova cultura e nuove competenze per il management
intermedio Nel privato come nel pubblico, il passaggio dalla supervisione a vista e dalle relazioni
informali alla valutazione in base ai risultati e a relazioni interne più strutturate non avviene
automaticamente. I capi diretti possono trovare difficoltà nel dover abbandonare abitudini
consolidate, nel doversi assumere nuove responsabilità, nel trovarsi in prima linea nel
processo innescato dalle nuove forme di valutazione (magari in qualche caso anche senza le
competenze necessarie). E’ molto importante che siano molto seguiti nella fase iniziale dal
top management e che siano oggetti di interventi formativi ad-hoc.
5. Anche i lavoratori vanno guidati e assistiti Ci sono quelli che lavorano troppo, quelli che non ce la fanno ad organizzarsi, quelli che si
deprimono di fronte al venire meno della routine delle relazioni sociali aziendali. Per
selezionare le persone giuste, tenere alta la motivazione dei dipendenti e assisterli nel
passaggio a questa modalità diversa di lavoro le imprese devono mettere a disposizione
qualche supporto: tutor che li aiutino ad auto-organizzarsi e gestirsi gli obiettivi, assistenti
informatici, eventualmente anche un supporto psicologico (come fa già Ibm).
Suggerimenti al sindacato
1. La cultura sul lavoro femminile e la conoscenza delle diverse potenzialità
del lavorare a distanza vanno adeguate L’approccio limitativo e tutelante al telelavoro che si riconosce nella regolazione legale e
contrattuale voluta dal sindacato, è plasmato sul “vecchio” telelavoro. Se all’inizio la
cautela era necessaria nel dubbio che le donne potessero essere fermate nel loro percorso di
emancipazione e “ricacciate a casa” e che a casa ricadessero nel ghetto del lavoro a
domicilio, adesso è chiaro sia che sono le donne a voler sfruttare il potenziale delle
tecnologie per acquistare maggiore flessibilità per il loro equilibrio esistenziale, sia che il
lavoro a distanza – prevalenza di maschi qualificati – non è affatto un “ghetto per donne
dequalificate”.
2. La normativa è troppo rigida: nel tempo è prevedibile un effetto
boomerang Le nostre interviste parlano chiaro: una delle difficoltà a introdurre il telelavoro per le
direzioni aziendali dipende dalla rigidità delle normative di legge, specialmente pubbliche, e
delle norme contrattuali. Il sindacato deve innanzitutto credere nella possibilità di forme di
controllo del lavoro diverse da quella dell’orario di lavoro e della presenza timbrata sul
cartellino, perché solo per questa strada sarà possibile dare al lavoro dipendente la
flessibilità che già ha – con costi umani e sociali molto maggiori – il lavoro autonomo.
Come spesso succede, la rigidità della tutela ha già provocato l’effetto contrario ovvero una
larga diffusione di forme di lavoro a distanza, informali e del tutto prive di tutela, quando
non è stata la principale ragione dell’outsourcing di molte attività e dell’instaurarsi di
31
rapporti di lavoro autonomo non altrimenti giustificati9. La strada contrattuale è quella del
proporre nuovi modi di misurare la prestazione e di remunerare il lavoro e, a partire da
quelli, definire alcune norme-quadro di tutela che difendano la volontarietà (ci sono davvero
quelle e quelli che hanno nell’azienda l’unica occasione di socialità) ma allarghino la
casistica oltre le ragioni di emergenza conciliativa (aumenta il rischio di ghettizzazione) in
direzione di una più complessiva qualità della vita di lavoro. Norme-quadro sulle quali sia
possibile innestare una contrattazione individuale obbligatoria.
3. Puntare invece sull’impatto sociale positivo del lavorare a distanza Addirittura, il sindacato potrebbe essere lo sponsor di una grande campagna di
sensibilizzazione per il lavoro a distanza. Chiedendo alle aziende – e soprattutto alla
amministrazione pubblica – di farsi portatrici di sperimentazioni di lavoro a distanza, il
sindacato potrebbe contribuire alla riduzione della mobilità privata con conseguente
riduzione dell’inquinamento ambientale, al calo del costo pubblico dei trasporti (i risparmi
potrebbero essere dirottati verso obiettivi sociali), al supporto alle popolazioni delle zone
meno accessibili (isole, montagna) o economicamente depresse (alcune aree del sud), al
supporto a persone disabili e con limitata mobilità personale. Oltre che, naturalmente, al
sostegno alla conciliazione di madri e padri con bambini piccoli e di lavoratori con familiari
bisognosi di cure.
4. Con le tecnologie Ict, la cultura del lavoro e della sua rappresentanza deve, e
può, tenere il passo con i tempi Se all’inizio un atteggiamento di rifiuto dell’evidenza – “da noi non è come altrove, il
lavoro è soprattutto socialità, quindi da noi il telelavoro non si diffonderà ” - era giustificato
dalla novità, adesso il potenziale tecnologico e organizzativo che hanno di fronte molte
delle occupazioni che una volta si potevano fare solo in fabbrica o in ufficio, è bene
evidente. Non ha senso quindi per il sindacato rimuovere lo scenario di un lavoro sempre
più frammentato e, almeno apparentemente, difficile da organizzare. Il problema è piuttosto
vedere quanto le nuove tecnologie potrebbero essere un supporto importante per la
organizzazione e la rappresentanza dei lavoratori “frammentati”: contatti capillari, in tempo
reale, processo informativo agevole, blog di discussione sui temi contrattuali, incontri face-
to-face solo quando serve.
Suggerimenti ai lavoratori e alle lavoratrici, dipendenti e
free-lance
1. Il telelavoro non è una panacea adatta a tutti Nello studio, abbiamo raccolto giudizi di grande soddisfazione da parte dei lavoratori e
delle lavoratrici che hanno partecipato alle sperimentazioni o che usano questa modalità nel
loro lavoro quotidiano: molte lavoratrici e lavoratori hanno trovato nel lavorare a distanza,
in parte o in tutto, non solo un modo per equilibrare meglio i propri impegni ma anche il
modo per organizzarsi meglio e essere più concentrati; molti considerano la socialità
importante ma non vogliono limitarla ai colleghi di lavoro (anche il vicino di casa, il
giornalaio e la gente del quartiere possono essere piacevoli relazioni) e, d’altra parte, vivono
in un mondo dove molta della socialità passa proprio attraverso le tecnologie. Tuttavia, non
è detto che lavorare a distanza vada bene per tutti: per molti e molte, il luogo di lavoro è un
9 Per quel che si riesce a capire la diffusione di accordi informali di telelavoro specialmente per personale qualificato
e nell’area ICT è già molto ampia: per esempio, in Alcatel di Vimercate lavorano in telelavoro una cinquantina di
persone sulla base di accordi verbali, che si rinnovano ogni sei mesi.
32
posto dove si conoscono persone e si instaurano relazioni, dove ci si concentra di più nel
proprio lavoro, dove si apprende, dove si è più motivati perché si avverte il controllo del
capo. A volte per una donna o un uomo che hanno impegni di cura, lavorare a distanza può
essere anche solo una risposta temporanea ad un bisogno, una soluzione accettabile solo in
rapporto ad una alternativa peggiore: lasciare il lavoro, ridurre il proprio reddito, etc. Gli
studi dicono che alcuni reagiscono alla autonomia nel lavoro con l’aumento della
motivazione, mentre per altri risulta solo dispersiva. Per queste ragioni, riteniamo che
lavorare a distanza in parte o in tutto, per un breve periodo o per sempre, vada considerata
niente altro che una preziosa opzione in più tra cui scegliere.
2. C’è bisogno di allenamento Soprattutto nel caso del lavoro mobile – che prevede anche flessibilità degli orari - non è
facile abituarsi alla cultura della autogestione del lavoro: non timbrare il cartellino può
essere un sollievo ma le scadenze possono mettere più ansia dell’occhio del capo, il senso di
colpa quando si stanno facendo altre cose “mentre quelli che sono in ufficio lavorano” è
sempre in agguato, per non parlare, soprattutto nel caso di lavoro autonomo, del lavoro che
si ingoia tutta la giornata perché “bisogna portarsi avanti” o anche semplicemente perché
piace, e non c’è più l’ufficio che si svuota a dirti che è ora di andare.. Tutti questi aspetti ci
dicono che anche lavoratrici e lavoratori che lavorano a distanza hanno bisogno di coaching
e accompagnamento. In azienda possono essere organizzati formazione, gruppi di ascolto,
monitoraggio delle esperienze e dei risultati. Fuori dalle aziende, in attesa che si diffondano
le esperienze e comincino a delinearsi dei modelli di autorganizzazione del lavoro a
distanza, bisogna andare per tentativi, sperimentare, tenersi in contatto, discutere via blog.
33
LE SCHEDE DELLE ESPERIENZE
E L’ELENCO DEGLI INTERVISTATI
Provincia di Milano – Progetto e.work (2006-in corso)
Responsabile progetto: dr.ssa M. Cecilia Scaldalai, responsabile servizio Formazione.
Telelavoro legato ad esigenze di conciliazione
Un accordo aziendale stabilisce gli aventi diritto: dipendenti con figli fino ai 3 anni nella prima
fase (sperimentazione) e fino agli 8 anni nella seconda fase (messa a regime stabile)
Adesione volontaria
Partecipano 10 dipendenti, tutte donne
modalità: lavoro mobile (tecnologie leggere: pc portatile, collegamento in posta elettronica,
cellulare)
normativa: lavoro multilocalizzabile, parziale (obbligo ad alcune giornate in ufficio), reperibilità
dall’ufficio in fascia oraria giornaliera
documentazione: Figli, sì grazie, CPO Provincia Milano
Provincia di Torino – progetto Friendly (2003-in corso)
Responsabile progetto: dr. Enrico Chiais, dirigente
Telelavoro legato ad esigenze di conciliazione
Un accordo aziendale stabilisce gli aventi diritto: dipendenti con figli piccoli, con familiari
anziani e disabili conviventi, con elevata distanza dalla sede
Adesione volontaria
Partecipano 10 dipendenti (8 donne e 2 uomini)
Modalità: telelavoro homebased totale (non applicato) e lavoro in telecentri (attivati 4 nella
provincia)
Normativa: la stessa del lavoro dipendente in sede (compreso orario di lavoro)
Documentazione: Friendly 2, Strumenti per la conciliazione delle responsabilità del lavoro e le
responsabilità familiari, Provincia di Torino
Inail – progetto Eowyn (2003- in corso)
Responsabile progetto: avv. Antonella Ninci, presidente CPO Inail
Telelavoro legato ad emergenze di conciliazione
Un accordo sindacale stabilisce gli aventi diritto: dipendenti con figli piccoli, con familiari
anziani e disabili conviventi, con elevata distanza dalla sede
Adesione volontaria
Hanno partecipato finora circa 600/700 dipendenti
Modalità: telelavoro homebased on-line
Normativa: temporaneo (max 1 anno), progetti ad-hoc (in genere di arretrato), fascia di
reperibilità dall’ufficio di due ore
Documentazione: CPO Inail
34
Università di Verona – progetto Iride (1999-in corso)
Responsabile progetto: prof. Donata Gottardi, ordinario Diritto del Lavoro
Telelavoro inizialmente legato ad emergenze di conciliazione, ora allargato a dipendenti con
problemi mobilità (distanza dal lavoro)
Accordi sindacali stabiliscono gli aventi diritti
Adesione volontaria
Hanno partecipato finora oltre alcune decine di dipendenti
Modalità: homebased, anche off line
Normativa: temporaneo, parziale (max tre giorni la settimana)
Documentazione: http://centri.univr.it/iride/
Astrazeneca – progetto telelavoro (2002-in corso)
Responsabile progetto: dr.ssa Patrizia Fabricatore, Direttore Risorse Umane Astrazeneca
Telelavoro legato ad esigenze di salute e di conciliazione
Un accordo sindacale stabilisce gli aventi diritto: disabilità, figli minori di 8 anni, familiari
conviventi, bisognosi di cura, maggiore tempo di percorrenza dalla sede; stabilisce anche le
posizioni telelavorabili: 11 profili professionali (segreteria, customer service, pianificazione
produzione, gestione dati, formazione, contabilità, etc.)
Adesione volontaria
Partecipano 24 dipendenti, 20 donne e 4 uomini; anche a tempo determinato
Modalità: telelavoro homebased, off line, collegamento Adsl
Normativa: parziale (alcuni giorni in azienda, alcuni a casa in accordo flessibile col
responsabile), autonomia nella organizzazione del lavoro e dell’orario (ma 8 ore giornaliere),
reperibilità 10-12 e 14-16
Documentazione:
Solvay – progetto Armonia (1999- 2002)
Responsabile progetto: dr.ssa Sborlino, consulente esterna
Telelavoro legato ad esigenze di conciliazione
Un accordo sindacale stabilisce gli aventi diritto: neo-madri e neo-padri durante il periodo del
congedo parentale
Individuate dall’azienda le posizioni telelavorabili
Adesione volontaria
Hanno partecipato alla fase sperimentale 7 neo-madri (50% delle maternità del periodo), 2
proseguono
Modalità: lavoro homebased con postazioni collegate in rete; poi lavoro mobile esteso a tutti i
venditori con tecnologie leggere
Normativa: parziale (rientri settimanali), fascia di reperibilità
Documentazione: Main/Consiel
35
Cna Bologna – progetto Work-Life balance (2008- in corso)
Responsabile progetto: dr. Francesco Ferrari, Responsabile Sviluppo Organizzativo e Risorse
Umane
Telelavoro legato ad esigenze di conciliazione
Un accordo sindacale stabilisce gli aventi diritto
Individuate dall’azienda le posizioni telelavorabili: addette alle segreterie e posizioni di back
office (anche ricostruite appositamente) in area fiscale, paghe, amministrazione
Adesione volontaria
Partecipano: 9 persone (7 donne e due uomini)
Modalità: lavoro homebased, on-line
Normativa: parziale, ma con diverse articolazioni: 1quasi-totale (assiste familiare malato o
handicappato), altri parziali: alcune ore al giorno o alcuni giorni la settimana (non più di uno o
due)
Documentazione: direzione del personale (primo report monitoraggio prossimo settembre).
Boehringer Ingelheim Italia – progetto telelavoro (2006- in corso)
Responsabile progetto: Direzione del personale
Telelavoro inizialmente legato a ragioni di conciliazione poi esteso a tutti (a richiesta dei
dipendenti e verifica del responsabile)
Un accordo sindacale stabilisce gli aventi diritto per ragioni di conciliazione: neo-madri di
rientro dalla maternità e neo-padri che hanno usufruito di almeno 3 mesi di congedo
Posizioni telelavorabili: di volta in volta, si fa analisi della percentuale di telelavorabilità delle
attività relative alla job-description richiesta
Adesione volontaria
Partecipano: alcune decine di persone in ruoli aziendali diversi
Modalità: totale (con rientro ogni quindici giorni) o parziale (”verticale”: alcuni giorni della
settimana)
Normativa: contratti annuali rinnovabili
Documentazione: direzione del personale
36
Le persone intervistate
Vanessa Acquaviva (Servizio Pari Opportunità e Politiche dei Tempi, Provincia di Torino)
Clara Bassanini (consulente, Pari e Dispari)
Enrico Chiais (dirigente, Provincia Torino)
Alessandra di Luca (consulente, Cna Bologna)
Patrizia Fabricatore (responsabile risorse umane, Astrazeneca)
Francesco Ferrari (responsabile sviluppo organizzativo, Cna Bologna,)
Alessandra Giacobbe (risorse umane, Boehringer-Ingelheim)
Donata Gottardi (docente Università di Verona)
Antonella Ninci (presidente CPO, Inail)
Valeria Sborlino (consulente, Butera e associati)
Maria Cecilia Scaldalai (responsabile formazione, Provincia Milano)
Christian L. (dipendente da un’azienda italiana di servizi)
Fiorenza D.P. (progettista cooperazione internazionale, partita Iva,)
Franco G., (informatico dipendente, società di produzione di software)
Pier Enzo W, (dipendente, multinazionale chimica)
Rosanna M. (assistente di direzione, Cna Bologna)
Sabina D., (dipendente, azienda di spedizioni)
Sono state inoltre riportate le dichiarazioni
Roberta Cocco (responsabile marketing e progetto futuro@lfemminile, Microsoft Italia),
comunicazione al convegno “Donne e tecnologia mobile”, 4/02/09
Rodolfo Landini (dirigente Accenture), Corriere della Sera, 18/01/09
1
WORK-LIFE BALANCE AND INDUSTRIAL RELATIONS IN
ITALY
Anna M. Ponzellini, University of Bergamo
pubblicato in: European Societies, vol. 8, n. 2, 2006
Abstract
This article examines the work-life balance system in Italy, with particular regard to the
role played by extra-statutory arrangements and provision – extra leave, benefits and
allowances for parents provided by employers, in-company crèches, family-friendly
working hours, etc. – originated from collective bargaining and industrial relations at
company-level. The Italian pattern of welfare state and women employment is
characterised by weak state support, a relevant role of intergenerational solidarity, one
of the lowest fertility rate and still low women’s activity rates. As for human resource
management and industrial relations’ contribution to work-life balance, empirical
evidence shows that a certain number of extra statutory arrangements and provision
has been implemented at company level. Though, they are not enough to fill the gap
with countries where state social protection is higher. The articles argues that
industrial relations may play an important role in fostering a better work-life balance,
on condition that a priority is given to decentralised collective bargaining and new
“territorial pacts” involving a wider range of social actors – not only unions and the
companies but also families, local governments, caregivers and the cared-for.
Particularly for unions, this could be a possible response to unionisation decline.
2
1. Women work, the family and the welfare model
It is impossible to entirely understand the issue of work-life balance in Italy case
without a brief description of its socio-economic environment, with particular regard to
women employment, welfare and the family culture. The most relevant characteristics
of this environment are:
- a low female participation in the labour market and a lack of part time employment
opportunities
- the unequal distribution of household and family chores within the couple
- the rather insignificant part of overall welfare expenditure devoted to family
services.
- the increasing female immigrant workforce employed as housemaids
- a very low fertility rate
The continuing weak position of women in the labour market
Up to recent years, the labour market in Italy was closely centred on the ‘male
breadwinner model’ in which women, young people and atypical workers in general
constitute a minority (Bettio and Villa 1997). More recently this situation has changed
and at present most young women enter into the labour market. Yet the employment
rate of Italian women, while increasing, is still very low: with 47.7 %, Italy lies more
than fifteen points below the European average (Eurostat 2003). Part-time employment
has, moreover, always been very scarce in Italy: in 2001 it was only 8.6% (18% the
female one) against the 17.9 (34%) of the European average (Eurostat 2002). Although
more recently the situation has changed somewhat, especially where new hiring is
concerned, the lack of part-time jobs may be one of the reasons why a number of
women with family responsibilities have still not entered the labour market or give up
their work when they cannot transform their full-time job into part-time after maternity.
We should say however that a civil servant’s working schedules are quite comfortable
since most of them do not exceed 36 hours a week and are mainly scheduled in morning
time (8 to 14) and teachers’ schedules do not exceed 30 hours a week. This is obviously
the main reason why in public administration and in public services most employees are
women.
An unequal distribution of household chores and care work within the families
Many statistics tell that Italian women still take most of the domestic work on their
shoulders A very noisy debate was originated by data distributed at the UN Conference
in Beijing in 1995 highlighting that Italian women were the last in the world in the
ranking of care-work distribution within the couples. What is worse, in last years the
gender asymmetry in care work has not changed at all: the last Istat Indagine
Multiscopo sulle Famiglie (survey on families of the Italian national institute of
statistics) tells us that 48.4% of women in households with children aged up to thirteen,
usually work (professional and care work) 60 hours a week (against 12% of men in the
3
same situation). In general, the female workload can be estimated as still six hours a
week more than that of the male (ISTAT 2001).
Little help from care services and parental leave provisions
The offer of services for child and elderly care is very scarce and expensive in Italy.
The Italian welfare system has been described – in opposition to Northern countries
system - as "heavy in transfers and light in services" (Esping Andersen 1995). In fact,
according to a government commission on the welfare system situation, public family
services represent only 3% of total welfare expenditure (Relazione Commissione Onofri
1999). While schools for children from ages three to six cover the majority (98%) of the
demand coming from families, the service supply (public and private) for children aged
up to three does not reach 10% (CENSIS 2002) and it has not been balanced by the
recent government measures to support the creation of in-company and private crèches.
Besides this, in comparison with other European countries, prices paid by families for
public crèches are the highest in Europe1. This shortfall in care services together with
the scarcity of part-time jobs defines the so-called “Mediterranean model of female
labour supply”, which is characterised by a weaker participation in the work force and a
higher propensity to leave employed work in middle age (Esping Andersen 1990, 1999,
Del Boca and Tanda 1996, Del Boca and Pasqua 2004).
On the other hand, welfare transfers to families have traditionally been allocated to the
breadwinners, under the form of pensions or lay-off allowances. Benefits for parents
have so far not received similar attention. The maternity legislation has been
traditionally generous, assuring a good wage protection to mothers for the pretty long
(five-month) compulsory maternity leave, while the new law on parental leave (Law
53/2000) introduces only small incentives for fathers, while allowance remains rather
low (30% of pay) and, with few exceptions, is only provided until the child is three.
Being frequently the male’s income higher, low paid or unpaid leave may have the
unintended consequence of strengthening the male-breadwinner model, since mothers
will be much more likely to exercise the right to parental leave (Bruning and Plantega
1999). And this is exactly what is happening now in Italy: according to INPS (Italian
national institute of social insurance) during 2002, in Lombardia – considered one of the
most advanced regions in the country - only 1 father in 40 among the entitled took
parental leave of any duration.
The substantial role of grandmothers and immigrant housemaids
In this situation, a private solution is often the only one available in order to reconcile
work and family life. Precious help for childcare and elderly care comes from relatives:
in 1998 more than 61% of households with children and 42% of households with
elderly to be cared for, used only the help of “relatives and/or friends” (ISTAT 2001).
The involved relative in this inter-generational solidarity is likely to be a woman. For
childcare they are usually non-employed or early-retired grandmothers, who in the last
1 According to Esping Andersen calculation, in the middle of 1990s for a family with two 0-3 years old
children ,they represented the 39% of the budget, against the 9% of France, 11% of US and Denmark,
28% of UK (Oecd 1995, Esping Andersen 1999).
4
decades without any clamour (and sociological consideration) have been, in Italy,
probably the most important pillar for the work-life balance of their daughters and
daughters-in-law. Yet, the increasing participation of women in the labour market
means this figure will disappear in the future.
When mothers and mothers-in-law are still part of the labour market, it may often
happen that the only solution is the most censurable. Italy is now the country with one
of the largest female immigrant workforces employed as full-time live-in housemaids,
especially for elderly care (a considerable part of them may moreover, not be working
legally). This archaic kind of employment is having an important role in allowing the
increasing participation of Italian women in the labour market (Reyneri 2002). Yet, it is
also subjecting them to strong criticism by feminists: Jacqueline Andall (2000) argues
that Italian women are becoming emancipated “inside” the family rather than “from” the
family. We would rather say that a certain number of Italian women - as other working
women of the First World who are faced by a strong men’s refusal to share domestic
burden – ended by being the blameless cause of that contradictory phenomenon which
has been called the “drain of care” from the Third World (Ehrenreich and Hoschschild
2002).
The continuing central role of the family in the economy
Households still play a crucial role in the Italian economy. Being influenced by a
traditional culture which puts great emphasis on the central role of the family in society,
the overall welfare system in its origins was built around the family and up to now has
been largely based on the family (Esping Andersen 1990). Despite the great ongoing
social change, especially in terms of transformation of housewives into working
women, Italian families still maintain two important economic tasks. The first is the
protection of their young unemployed members, giving them economic help while any
unemployment allowance is provided by state and keeping them at home until they
become independent (often until their thirties). The second is to carry out most
household and care work inside the family. Family plays therefore the roles on the one
hand of a “social buffer” and on the other hand of free service provider. The protective
role of the family and the gender asymmetry in care work have important implications
for two characteristics of Italian society: that of the lowest birth rate in the world (see
below) and of the widespread strategy among young people to remain inside the family
for a long time and to put off marriage and the birth of a first child. Both these
characteristics have a serious impact on the lives of women – either daughters or
mothers – on their employment prospects, on their daily workloads and on work-life
balancing strategies.
A symptom of malaise: one of the lowest fertility rates
In a paradoxical way, considering the very central role held in Italy by the family, in the
last decade it has been the country with the lowest birth and fertility rates. Despite the
slight increase in last few years, in 2001 the Italian fertility rate was 1.25 children per
woman in child bearing age (only Spain, with 1.22, had a lower rate). The decreasing
fertility rate in Italy was first associated with the difficulties in work-life balancing for
5
new women entering the labour market. Now that international data showed that
countries with a higher female participation rate had also a higher birth rate (OECD
2001), the Italian case – where the increase of female participation has gone hand in
hand with the lowering fertility rate – probably requires some more explanation.
Actually, many other variables are likely to be involved in the general picture
influencing both women’s participation in the labour market and parenthood decision
making, such as education, part-time job supply, provision of care services (Villa 2003).
For instance, as far as education is concerned, we might say that a certain polarisation
among working women can be observed in recent years: highly qualified ones tend to
remain in the workforce even when they have children while lesser qualified ones are
faced with a dry choice between working and childbirth (Reyneri 2002). Nevertheless, it
is hard to predict how female employment and fertility will combine in coming years.
Still the “second shift”
As we have seen above, in Italy, more than anywhere else, there is a complex
relationship between societal culture, the welfare system and women's opportunities to
enter (and to stay in) the labour market. Since all young girls now demand the right to
enter the labour market, the traditional welfare system, based on a large production of
services within the families and, in particular, on the important contribution of
housewives to the economy, cannot survive any longer.
Yet no serious substitution is in sight. The well-known crisis in public finance makes it
almost impossible to apply the Keynsian strategy followed by Northern countries fifty
years ago to our own country, although some authors are persuaded that providing care
services whilst creating more jobs for women would be feasible and useful at an
economic level, in terms of social investment, as well as desirable at a social level
(Esping Andersen 2004). Rather far from this kind of consideration, the current Italian
government is managing the ongoing crisis of the welfare system solely under the
aspect of a pensions reform and is relegating the issue of services-to-families to a
matter of creating a synergy among public childcare, market services and the so-called
“company welfare”, mainly consisting in crèches within firms (Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali 2003).
A relevant step forward could be provided by significant change in distribution of care
work within the families. Yet, although some change is occurring among younger
generations, the redistribution process of care work between women and men seems to
be advancing far more slowly than the redistribution of market work (Saraceno and
Naldini 2001). Therefore, Italian women life is still characterised by the so-called “dual
presence”, since they are citizens of two worlds, that of the family and that of work
(Balbo 1978, Saraceno 1991). Differently from working men, they maintain a full-time
responsibilities in each, so the issue of work-life balance appears to be a private female
problem rather than a real social problem. For this reason, at present most Italian
working women face in solitude the challenge of keeping both the role of “home
queens” that strong family tradition has shaped on them (a sovereignty that some of
them would surprisingly hold on) and that of their professional fulfilment.
6
2. Human Resource Management and Industrial Relations’
contribution to the work-life balance
Work-life balance more and more takes on the shape of a systemic issue,
contemporarily dealing with different interrelating systems: societal and family cultures,
welfare systems, private service supply, labour market regulation, corporate cultures. As
seen above, Italian women do not yet receive, either from their partners or from public
care services, any significant support in caring. Are they likely to receive some help at
the workplace, in terms of new ways of organisation of work, new scheduling, in-
company caring services, leave and other benefits addressing parents? Will company
Human Resource practices take care of their diversity? Will labour relations and
collective bargaining provide a better balance in their life?
Family-friendly human resource management and the women employment
In Italy, most probably like anywhere else, women’s presence in the labour market is
especially concentrated in the service sectors, in a few high-segregated manufacturing
occupations, in small business, in atypical and unregistered jobs. Except for public
administration and banking which are rather “protected” sectors, where high guarantees
and are still provided, women’s position in the labour market and their working
conditions tend to be more flexible and less protected than the male ones.
Despite the emerging polarisation among occupations in terms of qualification (Reyneri
2002), women’s employment persists weaker:
- the low-qualified majority of them are segregated in low-productivity service sectors
such as retail, family services, call centres, tourism, cleaning, etc; in these sectors
unregistered and atypical jobs are widespread, like fixed-term contracts in tourism, part
time in retail, agency work in call centre.
- a high-qualified minority, mainly consisting of well-educated young women, are
employed in full-time jobs in computer servicing, media, publishing and editorial
services, internet, etc.; in these sectors free-lance work is becoming more and more
common.
From the point of view of gender equality and work-life balance issues, actually, both
these parts of the labour market are far from reaching a fair regulation.
As for the low-qualified female occupations, companies are unwilling to spontaneously
introduce equal opportunity measures or whatever else might help mothers in their
family responsibility, since this workforce is easily substituted. Only in two specific
sectors – retail and call centre – something different is happening in very recent times,
where some WLB measures have been introduced in order to contrast the high turnover
of mothers with small children.
As for the high qualified occupations, companies usually still prefer males. For this
reason, female employees are often the first to deny their family problems – or to try to
privately solve them - in order to avoid discrimination in their career. Moreover, the
current company culture does not recognise the fathers’ responsibilities in caring,
7
discourages them and sometimes even laugh at fathers who take parental leave to stay
with their children.
Although some authors maintain that employers that help their employees to balance
their work with their lives see an improvement in their business performance (Scheibl
and Dex 1998), the profitability for firms of family-friendly policies is still under
discussion. A recent review on WLB economic literature suggests that slow growth of
family-friendly practices in the face of growing need might be due to many different
factors, as market failure associated with human capital, unemployment, asymmetric
information and externalities (Hardy and Adnett 2002).
Employers going beyond strict economic considerations, are likely to be even less
common in Italy than elsewhere, since most of the economy is characterised by very
small or small businesses where human resource management culture is not so
widespread. This kind of employer does not usually make use of sophisticated tools for
retention and development of human resources. As for women workers, in most cases
employers and managers of SMEs are simply engrossed in facing maternity leave
substitutions and in worrying about the increasing absenteeism of working mothers.
These workplaces are obviously the most at risk, because even transforming a full-time
job into a part-time one or allowing a daily flexi-time may result in heavy costs for the
business. Therefore post-maternity resignations are higher in small companies.
HRM practices are more frequently adopted by large companies. Even in this case,
equal opportunities and work-life balance issues cannot be taken for granted. By the
way, when innovative HRM tools have been adopted – i.e. allowing a greater autonomy
in working hours to employees, introducing “management by objective” system instead
of a boss’s strict supervision at work, changing career systems, taking into account an
employee’s private life and problems, etc. – evidence from research show they had a
positive influence both on gender equality and on reconciling work and family life for
employees (Bombelli 2000).
Union approach to workers' WLB needs
While presenting results of research into the employment patterns of women with young
children in five countries (Sweden, Germany, the Netherlands, Great Britain and Japan),
some authors point to the fact that in recent years trade unions have been active - either
through bargaining collective agreements or campaigning for government policies – “in
moving societies in the direction of shared breadwinning and shared parenthood”
(Gustafsson and Kenjoh 2004).
Actually, the current position of Italian unions towards workers’ family caring problems
and, even more, towards equal role sharing seems not to be that advanced. In Italy,
unions still seem to benefit the male breadwinner against working mothers. We could
say in general that trade unions have shaped themselves on the male Fordist model,
where wages and career rather than working hours or the quality of life are the most
important bargaining issues. The trade-unionists work culture, moreover, is likely to be
a typical “macho” culture since a majority of them usually work very long hours, have
late-evening meetings and consider their job the prominent activity in their life.
8
Anyhow, more than one objective difficulty certainly exists for unions in fully
representing working women’s issues. The structure of Italian collective bargaining
provides the presence of two different bargaining levels that may operate jointly: the
national industry-based labour contracts and the company-level agreements. Working
hours, the organisation of work, flexible arrangements and other issues concerning
work-life balance and the quality of working life are usually bargained at decentralised
level. Whilst the bargaining coverage is very high as far as national industry-based
contracts are considered, the coverage rate of decentralised collective bargaining is
rather low, especially in businesses of up to 10 employees, where a majority of women
are concentrated: currently, only 10% of total workers benefit from a decentralised
collective agreement. In the most fragmented and female sectors – retail trade, hotels
and restaurants, business services, cleaning, small and micro manufacturing
undertakings – company-level bargaining has been formally replaced by a ‘territorial
bargaining’ system that should group together several firms in the same sub-sector and
allow unions to reach even those workers in very small undertakings. Yet, territorial
bargaining has so far found many difficulties to be addressed and, when they have been
addressed, bargaining has been still focussed predominantly on wages. Therefore,
women’s and caregivers’ needs are not likely to be adequately fulfilled through current
collective bargaining.
It may be no accident that Italian women are not so willing to join unions. Over the last
two decades Italian union membership has been steadily declining (from a 49% in 1980
to a 35% in 2000), due to the crisis in the stronghold of large factory workers, which
was not balanced by a parallel increase in the new areas of work (office staff, small
enterprises, the services sector) (Ebbinghaus and Visser 1999). The decline has been
particularly evident, actually, in the retail trade and personal services sector, which are
typical female sectors. The overall negative trend has been imputed to the lower amount
of trade-union control legally and organizationally permitted in this area of small and
very small firms and to the shorter duration of employment relationships stemming
from the high mortality rate of small firms and to the increase of atypical jobs. Yet,
according to some authors, this is also due to the greater weight in the labour force of
categories which in Italy traditionally resist unionization: women, young people, and the
well-educated (Feltrin 1999). Women plainly feel that unions are unable to represent
their needs through collective bargaining.
WLB, the future of trade unions and "a new project of social citizenship"
As seen above, the Italy case confirms the relevance of current debate on the
opportunity of renewal and modernisation of unions in order to better meet the changed
composition of workforce (Zoll 1995, Valkenburg 1995). As a matter of fact, unions
still continue to operate from a “male, full-time, native-born worker” (Hyman 1994)
point of view. Historically, they “benefited the male breadwinner career to detriment of
working mothers" (Gustafsson and Kenjoh 2004). Yet, at present, the need to give
women, young people, immigrants and other diverse groups a better representation in
decision-making structures and amongst negotiators has been recognised as one of the
most relevant challenges for unions in all Western countries (Waddington, Hoffman and
9
Lind 1997, Dickens 2000) while, from a more specific feminist viewpoint, fighting the
“active male resistance” within trade-unions has been emphasised as a means to face
union decline (Cockburn 1991). Likewise, collective bargaining as been mostly gender-
blind insofar. Collective agreements on equal opportunities or aimed at helping women
combine work and family “remains very limited or indeed marginal” (Kravaritou 1997)
while some author warns against merely introducing “women’s measures” in existing
bargaining agendas and underlines that measures which rather focus on the problems
posed by organisation to both parents are more likely to “shake the existing gender
order" (Dickens 2000).
Anyway, from a wider point of view, we must consider that the non-universalistic,
fragmented and changing nature of WLB interests is raising serious difficulties to
unions’ traditional ways of bargaining. Caring strategies and, subsequently, WLB
demands are very diverse among workers, depending on structural factors (number and
age of children, family income, present working hours, public childcare supply, etc.) but
also on very subjective ones, as beliefs about childcare or the ideology of family and
motherhood (Hattery 2001). Therefore, they are needs difficult to be rationalized,
planned and reduced to collective norms. Nevertheless, leaving them to individualised
labour relations may end up making mothers (and care-sharing fathers) even weaker on
the labour market.
According to some IR and women-studies authors, one of the most important challenge
for unions currently consists in designing different and more effective ways of
representing and negotiating women’s needs and interests (Cockburn 1991, Dickens
2000). Involving in their action “a wide range of stakeholders, including not only
workers and employers but also local governments, services, carers, the cared-for and
the whole society” has been indicated as a possible way (European Foundation 2002).
As a matter of fact, WLB interests are not just a workers’ affair, nor a company one.
Care work is a wider social issue and it necessitates bargaining at a wider level. First of
all, it requires a renegotiation of a “new moral order” inside the family between men
and women in order to better balance personal autonomy with caring for others (Gerson
1998). Then, at community level, it requires the implementation of a “new paradigm of
work and family for women and men” which puts the lives and the interests of people
first (Friedan 1997). It necessitates a restructuring of the economy confronting the needs
of families that can’t be ignored in a labour market where women now equal men in
number and more and more men share the parenting responsibilities. Labour relations
should open out at the level of the whole society, where a “new project of social
citizenship” should be established in order to reconcile company aims, workers’ aims
and the aims of society (Muckenberger 1996). Trade unions could be the major actor of
this new project for the quality of life, putting together the rights of working caregivers
and the rights of children and the other people being cared for.
3. An overview on company work-life measures in Italy (1990-2001)
10
Two different surveys (AA.VV. 1999, Ponzellini and Tempia 2003) have investigated
measures aimed at fostering work and family balance that have been introduced in
Italian companies during nineties, both through company collective agreements and
through direct HR practices. Measures in this domain has been classified as follows:
- flexible working hours
- in-company childcare and services to families
- extra leave, allowances and special rights for caregivers
- aids to working parents’ careers
A similar classification has been used in a recent international survey (Oecd countries),
where four main types of family-friendly arrangements have been defined: leave for
family reason; change in work arrangements for family reason; practical help with
childcare; provision of training and information (Evans 2001).
Analysing family friendly arrangements
Follows a detailed description of these extra-statutory arrangements.
Flexible working-hours
Working-hour measures are certainly the main group of measures which were
introduced by companies in order to better their employees’ work-life balance. In
fact, in recent times flexible scheduling has become very common in Italian
enterprises in order to face market competition and to fulfil productivity needs by
means of new systems of production (such as just-in-time production). Yet, in
some cases, this has given the opportunity for redesigning work organisation and
the working hours of employees while also taking into account workers’ needs.
New working hours also based on employee preferences mainly consist of different
forms of part-time work, such as half-a-day part time, week-end work, annualised
part time. Part-time working is now rather wide spread in white collar
environments (public administration, health care, banks and insurance, telephone
companies, call centres) as well as in the fast-food and large-scale retail trades. The
resistance of manufacturing companies to part-time is still a fact, since it adapts
itself with some difficulty to production activities. Otherwise job-sharing schemes
have been introduced in a few manufacturing contexts, both in metalwork and food
sectors.
Daily flexi-time is also now quite common among white collars – both in public
administration and in private jobs – whilst it meets organisational constraints in
production activities and in front-line services which obviously require more rigid
schedules.
In retail, the most interesting flexible-hours formula now being experienced is the
so-called “isole-cassa” system, a system whereby every group of check-out clerks
(“isola”) can self-manage their weekly shifts. The widely bargained “banks of
hours”, a system allowing employees to save their overtime hours and to spend
them when needed, has, on the other hand, not been as successful as was expected.
The two main reasons are that people with family responsibilities usually do little
overtime and that little autonomy is actually given to workers in order to make use
of their own saved time.
Against all expectations, teleworking is now common among highly qualified men
rather than among low-qualified women. In any case, as regards WLB practices,
11
few interesting experiences of teleworking arrangements took place, especially
aimed at mothers returning from maternity leave.
The ongoing experiments in “positive” working-time change show that the time
needs of workers can usually be satisfied even at zero cost to companies: as with
many innovations, the only cost consists in the effort required to devise and
introduce them. They show, as well, that certain categories of workers are willing
to accept non-standard working hours if these enable them to reconcile some
personal and family needs with work more satisfactorily than was the case with
traditional working time schedules.
In-company childcare and services to families
At the beginning of the industrialisation process, large Italian companies – also
including large public utilities - traditionally provided many services to employees,
such as houses, nurseries, summer camps for children, entertainment and cheap
tourist accommodation, etc. More recently, these “paternalistic” aids to workers
have been disappearing. Yet, in very recent times, a new flourishing of company
crèches and baby-parking is ongoing especially in some workplaces where women
are the majority of the workforce such as call-centres, hospitals, insurance
companies and, even more rarely, in manufacturing companies too. Sometimes, an
agreement exists with local government for the opening of the crèche to other
families living in the area; and while only a few of them are free of charge, most of
them are less expensive than the existing ones, either public or private. These
services have probably been thought up above all as HR tools for retention of staff,
in a situation where the excessively high turnover of young women of childbearing
age can jeopardise corporate efficiency and quality of service. They may represent
a social answer to the shortfall in public supply of childcare for children aged 0-3
years. Yet, only large companies can invest in providing them which is problematic
in the Italian economy where small and micro enterprises are predominant.
Besides, although company crèches usually do not formally exclude atypical
workers amongst whom many women are, obviously they are not the proper
answer neither to contingent workers (they cannot change crèches every time they
change workplace..) nor, for different reasons, to part-time workers.
Other kinds of services are slightly more wide spread. Some of them consist of
after-school activities or in-town summer camps for school children. Some other
are aimed at supporting household chores, such as a company providing take-away
meals for their employees. Some other services are targeted towards families with
difficulties, such as counselling services for maternity and social and psychological
assistance.
Extra leave, allowances and special rights for caregivers
This kind of aid is very traditional, yet in recent times they are not largely
widespread. Grants for children’s education and home-buying loans or loans for
other relevant family expenses used to be rather common in old large Italian
companies. Other kinds of common allowances to families consist of integration to
the maternity allowance provided by the law. In a few cases employees sent away
for business are given a reimbursement for nursery costs (or baby-sitting or elderly
care costs). Yet benefits and allowances, as in general all the extra-wage measures,
are less and less common.
Special rights are also recognised to employees with caring responsibilities which
mainly consist in leave for various family problems, such as paternity leave, leave
12
for the caring of sick, disabled or drug addicted relatives and leave for death in the
family. In a few cases, specific leave for assisting a child at nursery during the
initial period of attendance is provided. Yet most leave is not paid.
Aids to working parents careers
Some kind of help is sometimes given to women or to parents of small children in
order to avoid risk of marginalisation after career breaks due to maternity or
parental leave. Many companies have established the right to come back to the
same position held before leave and to benefit from paid training for skill updating.
A few others have introduced specific measures in order to keep employees in
touch during their leave, through newsletters, e-mail information about training
opportunities or calls for internal job posting and promotions. A very few
companies run an in-house service for legal and contractual advice to mothers and
fathers. Despite being interesting, the measures taken to support the careers of
caregiver employees are still rare, in so far as they require companies to have a
certain “diversity management” culture and particular sensitivity to social issues.
Comparing Italian results to the international research
Very relevant similarities can be observed between results of these Italian surveys and
those coming from international studies, particularly from a qualitative point of view.
As for type of measures being implemented, also data gathered in Australia, Japan, the
United Kingdom and the United States show that working-hours arrangements are
everywhere the most common practice while extra family leave or in-company crèches
are more rarely mentioned. Moreover, evidence from both Italian and international
survey shows that these arrangements are more common in large companies and public
services, in those firms where measures of equal opportunity have been already
implemented and/or where human resource management practices are more widespread.
Another, rather surprising, common output concerns little evidence of significant
growth over time in family-friendly company arrangements, being observed both in the
Italian case and in the international survey (Oecd 2001).
Italian surveys’ results are also consistent with European industrial relations literature.
A recent review of articles of the national centres of the European Industrial Relation
Observatory underlines that new forms of work organisation and working time
flexibility together with special leave are “in the core of industrial relations” in most
European countries, while other work-life arrangements – as agreements on pregnant
workers, childcare and elderly support - are less considered (Eiro 2002).
Anyway, as for the spreading of these arrangements, we have to consider that the
measures highlighted by the two Italian surveys, while quite interesting and even
amazing at a qualitative level, are still of little relevance from a quantitative point of
view. Many among them are still rather isolated experiences, provided by a few, open-
minded employers. They matter simply as “best practices”. An estimate has been made
that not more than a 3.5% of private companies having negotiated a collective
agreement during the period, introduced any WLB measure (Ponzellini and Tempia
2003), which may be considered a signal that Italian social partners are not sensitive
enough to this problem. Therefore, it is quite surprising that the Second European
Survey on Working Condition of the Dublin European Foundation rates Italy (in 1995-
13
96) amongst the top five countries as for extra-statutory employer-provided family-
friendly practices, taking on account two specific factors: extra family leave and
company provision/subsidies for childcare (European Foundation 1997). The correct
explanation of this optimistic evaluation may come from an Oecd analysis on the same
data, when it concludes that “firms in countries with high levels of statutory provision
tend to rely almost entirely on that provision”, while where national provision is low –
this is the Italy case, especially as for public childcare – extra-statutory provision is
somewhat higher but “firms do not appear to have filled the gap” (Oecd 2001).
Employer and union behaviour
Also in-depth company case studies show relevant difficulties and obstacles in
collective bargaining of work-life arrangements, coming both from trade unions and
employers.
As for trade unions, collective bargaining failure may firstly depends on unions’ being
less present precisely where there are more women: in atypical jobs and in small and
micro undertakings. By the way, this might also be a reason for unions being little
aware of work-life balance problems. Secondly, old prejudices towards any kind of non-
standard employment (i.e part-time working and teleworking) and individualised
working conditions – such as individualised hours - still persist in union work culture.
As a matter of fact, wages are still the central issue for trade unions, while quality of
working life, work-family reconciliation and the planning of social times are not issues
so far featuring on union agendas. A reason might be that workers’ needs for a better
life are not universalistic demands. They are quite different, in fact, as far as life aspects
involved and solutions required, they may vary across gender, across groups, across
ages and they may even raise conflicts among workers. Therefore it is rather difficult to
collectively represent and bargain for them.
As for employers, evidence from research show that most of them are more aware about
costs than about potential benefits (improvement of morale and commitment, reduction
of absence, better retention rates) by their paying more attention to the work-life balance
of their employees. Furthermore, most companies appear to resist cultural and
organisational innovation that might guarantee employee better quality of life. Many
constraints still seem to exist to a wider propagation of part-time work, teleworking and
other flexible schemes within business, despite their low cost or even the benefits
coming from their implementation. One of these is the continuing reluctance to innovate
personnel evaluation systems by transforming working-time based control into a
performance-based one, a transformation which could make life easier for employees by
giving them more autonomy over working hours.
Nevertheless, research also show that in a few companies the human resource practices
– and WLB arrangements amongst them - appear to have quite a relevant role. Although
the majority of new family friendly arrangements have been collectively bargained with
unions, some interesting practices (i.e. new company crèches) rather than coming from
union initiatives, actually seem to originate from businesses. Large multinational
companies, utilities and public services and a few especially locally rooted national
companies are taking the most active part in this field. Anyway, these companies appear
14
to be moved by different aims and interests. Three different approaches have been
singled out. In the first group - the “pragmatic” approach - WLB measures (especially
part time work, self-managing of working shifts, teleworking arrangements, crèches,
etc.) are clearly aimed at a wider control of the internal labour market and at a reduction
of the personnel turn-over and absenteeism. In the second group - the “social
responsibility” approach - WLB measures (in particular family-oriented traditional
benefits like crèches and other open-to-community services) are driven either by the
purpose of a wider participation in the community life or by the culture of corporate
social responsibility. While a few other companies – which can be classified under the
“marketing” approach - consider that having a family-friendly image may be a means
for reaching better business goals: this is, for example, the case of companies producing
baby-care goods which are usually willing to experiment any kind of family-friendly
arrangements (Ponzellini and Tempia 2003).
4. Concluding remarks
The Italian work-life balance system keeps some typical characteristic of the
Mediterranean countries - low opportunities for part-time working, lack of public
childcare, family leave provision which are still inadequate to effectively promote an
equal sharing of care work – so preventing from a speed decline in the male breadwinner
model (Figart and Mutari 2000; Hardy and Adnett 2002).
On the other hand, the Italian employment regulation system rests on collective
bargaining rather than on legal regulation. That is the reason why, in addition to a
medium-low level of WLB statutory provision, a certain number of bargained
arrangements exist at company level helping parents to better balance their work with
family life. Unfortunately they are not enough to fill the gap with countries having high
welfare provision (like Nordic countries) and to ensure women a full participation to
paid work and equitably shared care work.
Many constraints still affect industrial relations and social partners’ behaviour in this
field. Employers resist cultural and organisational change. Moreover they are not aware
about potential benefits to their business coming from a more family-friendly human
resource management. On the other hand, unions still continue to operate from a “male"
point of view. When facing work-life balance needs, they tend to emphasise on
protection of mothers rather than on changing organisation of work for both parents and
pay scarce attention to measures enhancing the share of caring responsibilities...
Therefore, some change in industrial relations appears necessary. The important role
played by collective bargaining in the employment regulation in Italy may represent a
chance for the Italian case, since a good WLB system, in order to match collective
representation and fragmented interests, often requires local enforcement and specific
articulation of centrally formulated rules and provision which collective bargaining
might provide for. Yet, local enforcement of statutory regulation and provision (i.e.
articulated rules for part time working, flexible working and family leave as well as
local integration to public childcare) requires more decentralised bargaining structure
15
and social dialogue. Specific norms and arrangements might be negotiated both through
already existing company-level collective agreements in large firms and through new
experiences of territorial-level bargaining, better suiting the small size of most Italian
firms. Moreover, as a WLB system contemporarily depends on statutory provision,
national and local service policies and company family-friendly arrangements, the new
experiences of social dialogue at decentralised level now ongoing in Italy (“territorial
pacts”) might be an interesting direction to take. Especially, when involving not only
employers and unions but also the wider range of social actors at community level –
families, employers, unions, local government, services, caregivers and the cared-for -
who share the issue of care work. For unions and the industrial relations system might
be the right opportunity to initiate a renewal process. Otherwise, they – without women,
without working caregivers – may come up against a severe decline.
References
AA.VV. (1999), Riprogettare il tempo. Manuale per la progettazione degli orari di lavoro,
Edizioni Lavoro, Roma
Accornero A., Di Nicola P. (1996) “La flessibilità degli orari di lavoro”, in G. Galli (eds.), La
mobilità nella società italiana, Edizioni Confindustria, Roma
Andall, J. (2000), Gender, Migration and Domestic Service: The Politics of Black Women in
Italy, Aldershot, Ashgate, London
Balbo L. (1978), “La doppia presenza”, in Inchiesta, n.32
Balbo L. (1987), Time to care. Politiche del tempo e diritti quotidiani, Franco Angeli, Milano.
Bettio F., Villa P. (1997), Changing patterns of work and working time for men and women.
Italy, Manchester School of Management Eds.
Bombelli M. C. (2000), Soffitto di vetro e dintorni, Etas, Milano
Bordogna L., Ponzellini A.M. (eds.) (2004), Qualità del lavoro e qualità del servizio negli
ospedali, Carocci, Roma
Boulin J.Y. (2001), “Working Time in a New Social and Economic Context”, in Transfer, vol.7,
n.2
Boulin J.Y., Cette G. (1999), “Temps de travail et emploi en France: entre production
réglementaire et innovations dans l’entreprise”, communication à la Conference Working Time
in Europe, Helsinki, October 10-11th
Bosch G. (1999), “Working Time: Trends and New Issues”, in Revue International de Travail ,
vol.138, n.2
Bruning G., Plantega J. (1999), “Parental Leave and Equal Opportunities: Experiences in Eight
European Countries”, in Journal of European Social Policy, 9 (3)
CENSIS (2002), Rapporto sulla situazione sociale del Paese, Roma
Chiesi A. M. (1995), “Le trasformazioni dei contenuti del lavoro”, in A.M.Chiesi, I. Regalia, M.
Regini, Lavoro e Relazioni industriali in Europa, NIS
de Lange W. (1999), “Working Organisation and Working Time”, Paper presented at the
Conference Working Time in Europe, Helsinki, October 10-11th
Cockburn L. (1991), In the Way of Women, Macmillan, Basingstoke
Del Boca D., Tanda P. (eds.) (1996), “Costs of Children and Family Decisions”, in Labour,
vol.10, n.3
16
Del Boca D., Pasqua S. (2004), “Labour Supply and Fertility” in T. Boeri, D. Del Boca, C.
Pissarides (eds.) Women in the Labour Market: An Economic Perspective, Oxford University
Press, Oxford
Dickens l. (2000), “Collective bargaining and the promotion of gender equality at work:
opportunities and challenges for trade unions”, in Transfer, n. 2
Ebbinghaus B., Visser J. (1999), Trade Unions in Western Europe since1945, MacMillan,
Oxford
Ehrenreich B., Hoschschild A.R. (eds.) (2002), Global Woman: Nannies, Maids and Sex
Workers in the New Economy, Henry Holt and Co., New York
European Observatory of Industrial Relations (2002), Reconciliation of work and family life and
collective bargaining. An analysis of EIRO articles, European Foundation for the Improving of
Living and Working Conditions, Dublin
Esping Andersen G. (1990), The Three Worlds of Welfare Capitalism, Polity Press, Cambridge.
Esping Andersen G. (1999), Social Foundations of Post Industrial Economics, Oxford
University Press, Oxford-New York
Esping Andersen G. (2004), Why We Need a New Welfare State, Oxford U.P.
European Commission (2002), Employment in Europe 2001, Luxembourg
European Commission (2003), Employment in Europe 2002, Luxembourg
Evans J. (2001), “Firms’ Contribution to the Reconciliation Between Work and Family Life”, in
OECD Labour Market and Social Policy Occasional Papers, n. 48
Feltrin P. (1999), “ A volte ritorna. Il dibattito sul sindacato come organizzazione”, in Stage, n.3
Figart D., Mutari E. (2000), “Work Time Regimes in Europe: Can Flexibility and Gender
Equity Coexist?”, in Journal of Economic Issues 34 (4)
Freyssinet J. (1998) “France: a recurrent aim, repeated near-failures and a new law”, in
Transfer, vol.4, n.4.
Friedan B. (1997), Beyond Gender, The John Hopkins University Press, Baltimore and London
Gauvin A., Silveira R. (1999) “La flexibilitè du temps de travail au féminin”, in G. Bosch, D.
Meulders, F. Michon (eds.), Working Time: New issues, New norms, New measures, Edition du
Dulbea
Gerson K. (1998), “Moral Dilemmas, Moral Strategies and the Transformation of Gender”, in
Gender and Society, vol.16, n.1
Gustafsson S., Kenjoh E. (2004), “New evidence on work among new mothers. What can
unions do?”, in Transfer, vol.10, n.1
Hakim C. (1991), “Grateful Slaves and Self-Made Women: Fact and Fantasy in Women's Work
Orientations”, in European Sociological Review, n. 7
Hardy S., Adnett N. (2002) , “The Parental Leave Directive: Towards a Family-Friendly Social
Europe?”, in European Journal of Industrial Relations, vol. 8, n.2
Hattery A. (2001), Women, Work and Family. Balancing and Weaving, Sage Publications,
Thousand Oaks
Hochschild A.R. (1989), The Second Shift. Working Parents and the Revolution at Home, Avon
Books, New York
Hochschild A.R. (1997), The Time Bind: when Work Becomes Home and Home Becomes Work,
Metropolitan Book, New York
Hyman R. (1994), “Changing trade union identities and strategies”, in R. Hyman and A. Ferner
(eds), New Frontiers in European Industrial Relations, Blackwell, Oxford
ISTAT (2001), Indagine Multiscopo sulle Famiglie, Roma
Kravaritou Y.(1997), Equal Opportunities and Collective Bargaining 2. Exploring the Situation,
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Luxembourg.
17
Lehndorff S. (1999) “From collective to individual reduction in working time? Trends and
experience with working time in the European Union”, in Transfer, vol.4, n.4
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2003), Libro bianco sul Welfare. Proposte per
una società dinamica e solidale, Roma
Muckenberger U. (1996), “Reflections pour une redéfinition des relations de travail”, in Revue
Internationale du Travail, vol 135, n.6
OECD (2001a), Starting Strong. Early Child Education and Care, Paris.
OECD (2001b), “Balancing Work and Family Life: Helping Parents into Paid Employment”, in
Employment Outlook, June
Ponzellini A.M. (2003a), “Worker Participation in Negotiating Working Time in Italy”, in
M.Gold (ed.), New Frontiers of Democratic Participation at Work, Ashgate, London
Ponzellini A.M. (2003b), “Sindacato e imprese nella contrattazione della qualità della vita”, in
Diritto delle Relazioni Industriali, n.4/XIII
Ponzellini A.M., Galetto M. (2004), “La contrattazione aziendale del part time”, in M. Samek
Lodovici, R. Semenza (eds.), Il lavoro part time. Anomalie del caso italiano nel quadro
europeo, Franco Angeli, Milano
Ponzellini A. M., Provenzano E. (2001), “Italy: the Service Sector - Towards a More Inclusive
and Flexible Labour Market?”, in J.E. Dolvik (ed.), At your Service, P.I.E Peter Lang, Brussels.
Ponzellini A. M., Tempia A. (2003), Quando il lavoro è amico. Aziende e famiglie: un incontro
possibile, Edizioni Lavoro, Roma
Reyneri R. (2002), Sociologia del mercato del lavoro, Il Mulino, Bologna
Rubery J.(1998), “Working time in the UK”, in Transfer, vol.4, n.4
Sanne C. (1998), “The working hours issue in Sweden”, in Transfer, vol.4, n.4
Saraceno C. (1991), “Change in life-course Patterns and Behaviour of Three Cohorts of Italian
Women”, in Signs: Journal of Women in Culture and Society, vol.16, n.3
Saraceno C., Naldini M. (2001), Sociologia della famiglia, Il Mulino, Bologna
Scheibl L., Dex S. (1998), “Would More Family-Friendly Working Arrangements Benefit
Business and Families”, in ESRC Working Papers n.106
Supiot A. (ed.) (1999), Au de la de l’emploi, Flammarion, Paris
Tempia A. (1993), Ricomporre i tempi, Ediesse, Roma
Villa P. (2003), “Family and Work Can Be Made Compatible? The European Experience”,
mimeo
Valkenburg B. (1995), “Individualization, Participation and Solidarity”, in European Journal of
Industrial Relations, n.1
Waddington J., Hoffman R., Lind J. (1997), “European trade-unionism in transition? A review
of the issues”, in Transfer, vol.3, n.3
Zoll R. (1995), “Failing to modernize?”, in European Journal of Industrial Relations, n.1
1
“Work-life balance e relazioni di lavoro” di Anna M. Ponzellini (Università di Bergamo)
paper presentato al Seminario dell’Associazione Italiana di Sociologia “Il lavoro nella quotidianità. La quotidianità nel lavoro” Venezia, 18-19 aprile 2005 Di recente, molte indagini hanno messo in evidenza le esperienze positive realizzate in alcune aziende per migliorare la conciliazione tra lavoro e famiglia: asili-nido aziendali, flessibilità degli orari, supporti per la maternità e la paternità, eccetera. Tuttavia, quando abbandoniamo il (consolante) approccio descrittivo delle “buone prassi”, il panorama che, soprattutto in Italia, ci offre la rilevazione quantitativa di tali esperienze appare estremamente preoccupante. Sono infatti pochissime - non oltre il 3%, secondo una stima avanzata da una indagine recente sulla contrattazione aziendale - le aziende dove negli ultimi anni sono state introdotte norme sul lavoro classificabili, anche in senso lato, come misure favorevoli alla conciliazione. Nel paper si propone di trovare spiegazioni al mancato, o comunque insufficiente, riscontro nella esperienza contrattuale – e, più in generale, nella esperienza delle relazioni tra organizzazioni sindacali ed imprese – di bisogni sociali che pure, dal momento dell’ingresso di massa delle donne nel mercato del lavoro, sono diventati evidenti ed urgenti. Una carenza che potrebbe addirittura costituire la ragione della scarsa propensione delle lavoratrici italiane – in controtendenza rispetto al resto d’Europa – ad iscriversi al sindacato. Per fare questo, si fa un’analisi delle oggettive difficoltà delle parti sociali – in particolare, del sindacato - a regolare contrattualmente e estendere all’insieme del mondo del lavoro esigenze differenziate, mutevoli nel tempo e “costose”, come quelle di cui sono portatori e portatrici i dipendenti con responsabilità familiari e di cura. Si ipotizza però anche la possibilità che le relazioni industriali che conosciamo siano - per tradizione, cultura e struttura - inadatte a recepire e a tradurre in regole contrattuali questi nuovi bisogni, al di fuori di un percorso di reale innovazione. Tra vita e lavoro: strategie differenziate ed equilibri mutevoli Lo specifico equilibrio tra lavoro e vita che ciascuno immagina per sé è molto diverso tra persona a persona: dipende dal carico delle responsabilità familiari, dall’età dei figli, dalla distribuzione dei ruoli in famiglia, dal grado di investimento nella realizzazione professionale, dalla situazione dei servizi sul territorio, dalle reti familiari e di vicinato ma anche
2
da aspetti meno razionali e meno facili da analizzare – eppure con potenti influenze sulle scelte esistenziali – come il sistema di valori di riferimento. Per le donne in particolare, nella scelta della modalità con cui partecipare (o non partecipare) al mercato del lavoro, oltre alle consuete variabili socio-economiche, sembra avere un grande peso l’ideologia della maternità. Una ricerca empirica americana ha recentemente tentato di ricostruire le diverse strategie delle donne nell’”equilibrare e intrecciare” (balancing and weaving) il lavoro con la famiglia, anche alla luce della variabile “ideologia” e non solo ha evidenziato quanto siano diversificate le combinazioni possibili dei diversi fattori che sono coinvolti nelle scelte – reddito, ore lavorate, ore dedicate personalmente alla cura, ore di cura condivise col partner, ore di cura acquistate sul mercato o ottenute dai servizi pubblici, etc. - ma anche quanto poco l’equilibrio raggiunto risponda ad un razionale calcolo costi-benefici: per esempio, molte donne decidono di non lavorare o di lavorare solo poche ore anche in presenza di un reddito familiare basso mentre, all’opposto, redditi anche molto elevati dei mariti non sono una ragione per molte donne per rinunciare ad un impiego a tempo pieno…. Tali strategie si rivelano anche poco prevedibili soprattutto perché, come argomenta la stessa ricerca, l’equilibrio è il risultato più che di una scelta decisa una volta per tutte di un “processo decisionale” che si confronta contemporaneamente con aspetti soggettivi, ideologici ed emotivi - l’idea della maternità, il grado di fiducia nella capacità educativa del servizio pubblico o della baby-sitter, la percezione dei propri bisogni economici - ma anche con aspetti oggettivi e pratici – la possibilità di ottenere un lavoro ad orario ridotto, di lavorare da casa, di pagare una baby sitter, di suddividere con il partner il lavoro di cura - che possono cambiare nel tempo (Hattery 2001). L’evidenza della grande varietà degli equilibri di conciliazione mette in guardia nei confronti dei tentativi di ridurre gli atteggiamenti e le aspettative delle donne con famiglia a modelli sociali preconfezionati e stabili (seppure di straordinario potere esplicativo), come quello che suddivide le donne che lavorano in due semplicistiche macro-categorie, quella delle “self-made women” che vogliono soprattutto realizzarsi nel lavoro e quindi non rinunceranno al tempo pieno e alla carriera e quella delle “grateful slaves” che si sentono soprattutto realizzate nella famiglia e che quindi opteranno per il part time e non si cureranno di fare carriera (Hakim 1996). L’esistenza di una larga gamma di opzioni negli equilibri tra vita e lavoro può spiegare la scarsa tenuta dei modelli di partecipazione delle donne al mercato del lavoro e anche, almeno in parte, la difficoltà ad interpretare con certezza la domanda di riferimento per le politiche di welfare o per le misure aziendali. Più in generale, evidenzia la dubbia efficacia di risposte troppo standardizzate, come sono ad esempio gli orari rigidi degli asili-nido o il part time inteso come “lavoro a metà tempo per le donne”.
3
Scarse risposte dall’organizzazione del lavoro tradizionale: alcune evidenze empiriche La domanda di innovazione dei modi di lavorare espressa dalle donne viene spesso descritta genericamente come richiesta di “flessibilità”, ma questa definizione non rappresenta la complessità e la varietà delle esigenze avanzate dalle lavoratrici né, ove ve ne siano, le linee di preferenza su cui si dirige il cambiamento. Molta ricerca empirica condotta negli ultimi anni ci dice che piuttosto che verso specifiche misure flessibili, la domanda di cambiamento si orienta in generale verso il raggiungimento di una maggiore autonomia personale, di una più ampia possibilità di scelta rispetto al “dove”, al “quanto” e al “quando” lavorare (AA.VV.1999). L’obiettivo di fondo di chi ha responsabilità familiari sembrerebbe quello, a partire dalle proprie differenziate preferenze ideologiche, di allargare la gamma delle opzioni organizzative per poter meglio costruire la propria specifica “combinazione di conciliazione”. Non a caso, gli equilibri vita-lavoro che Hattery nel suo lavoro definisce “innovativi” includono una molteplicità di intrecci – personalizzati ed autogestiti - di reddito-spazio-tempo: lavorare molte ore e pagarsi un aiuto in casa, lavorare fuori casa durante il tempo che i figli sono affidati ad un servizio educativo o ad una baby sitter e in casa per il restante tempo, lavorare full time ma in turno diverso dal partner, intraprendere una attività di cura di bambini presso la propria abitazione, etc. (Hattery 2001). Tuttavia, più in generale si può osservare che le preferenze delle lavoratrici e i lavoratori con carichi familiari si orientano ricorrentemente verso alcune ben individuate caratteristiche dell’orario di lavoro: orari meno lunghi, possibilmente compatti (senza intervalli) e prevedibili con certezza (Ponzellini, Tempia 2003). Sfortunatamente, i tentativi di conciliare la famiglia con il lavoro si confrontano ancora oggi in molti luoghi di lavoro con una one-best-way dell’organizzazione della prestazione lavorativa che, com’è noto, ha a suo tempo esteso il modello efficiente della concentrazione spaziale e temporale del lavoro – ovvero il modello della fabbrica - a molti impieghi dove ciò non era affatto necessario (ad esempio, alla gran parte degli impieghi amministrativi, tecnici e creativi). Va un po’ meglio nei settori non raggiunti dal fordismo come quelli dei servizi, dove la grande modularità degli orari di lavoro offre significative opportunità per chi è alla ricerca di un proprio specifico equilibrio vita-lavoro ma dove spesso, al contempo, l’elevata variabilità dei flussi di clientela viene trasferita tout court sul lavoro, attraverso richieste di veloci adattamenti degli orari (straordinari, cambio turni) che entrano in contrasto con i bisogni di conciliazione… Le poche indagini quantitative sulla introduzione nelle aziende di normative e condizioni di lavoro favorevoli ad un miglior equilibrio tra lavoro e vita confermano questa insoddisfacente situazione generale in termini sia di scarsità delle misure introdotte, sia persino di rallentamento del processo di innovazione. Due ricerche attuate congiuntamente da Fondazione Seveso e da Gender sulle misure di conciliazione in azienda –
4
la prima riferita al periodo 1990-96 e la seconda al periodo 1996-2001 – mostrano una incidenza molto bassa delle norme di conciliazione nella contrattazione aziendale. Nella seconda indagine - che ha vagliato ben 1300 accordi aziendali stipulati in tutti i settori produttivi e in tutto il territorio nazionale e raccolti nell’Archivio nazionale del Cnel e in altri archivi locali e settoriali sulla contrattazione aziendale - norme sul lavoro classificabili, anche in senso lato, come misure favorevoli alla conciliazione risultano introdotte solo in 180 aziende. Anche se una manciata di queste misure, quelle più innovative, può essere considerata nel novero delle “buone prassi”, la stragrande maggioranza risulta costituita da norme banali, come l’introduzione di qualche tipo di permesso (in genere, non retribuito) o dell’elasticità in entrata ed uscita per gli impiegati… Quasi assente il telelavoro, pochissime le norme di specifici supporti alle carriere dei caregiver.. Se poi ci riferiamo all’unica raccolta sicuramente completa, quella degli accordi firmati nel settore metalmeccanico in Lombardia tra il 1995-e il 2001, su 480 accordi solo 17 (il 3%) contengono norme o provvedimenti classificabili come misure di conciliazione. Per giunta, nel corso della seconda indagine, il riesame di alcune buone prassi analizzate in precedenza ha mostrato come in molte aziende, nei cinque anni tra le due indagini, tali misure erano state abbandonate a causa dei motivi più vari: difficoltà applicative, problemi economici, turn over dei responsabili aziendali o delle RSU (Ponzellini, Tempia 2003). Allo stato attuale, dunque, sembra che le aziende non siano in grado di dare risposte efficaci ai bisogni di conciliazione. Da un punto di vista prettamente organizzativo, sono soprattutto due le ragioni ipotizzabili. La prima è che consegnare ai dipendenti una più ampia autonomia nella organizzazione del loro lavoro comporterebbe per le imprese introdurre strumenti per il controllo e la valutazione della prestazione più sofisticati e costosi di quelli attuali, che sono ancora sostanzialmente basati sul tempo di presenza al lavoro. La seconda è che, per tutti i lavori che restano “vincolati” (al contatto col cliente, alla macchina, alla presenza di altre persone), l’allargamento delle opzioni di presenza attraverso una più o meno spinta modularizzazione degli orari – operazione in via di principio non impossibile - significherebbe rendere il sistema organizzativo aziendale molto più complesso da gestire e quindi costoso. Per converso, i vantaggi del poter contare su dipendenti più equilibrati e soddisfatti della propria vita privata non sono ancora entrati nella contabilità dei bilanci aziendali… Tuttavia, le insufficienze della razionalità organizzativa non spiegano del tutto la persistente “invisibilità” che nei luoghi di lavoro hanno i bisogni dell’altra faccia della quotidianità. Per capirne meglio le ragioni, si rende necessario un punto di osservazione meno schematico, che analizzi tutte le fasi del processo di espressione, rappresentanza e negoziazione di questi nuovi bisogni.
5
Poca “voice” e molta “exit” nella rappresentanza dei bisogni di conciliazione? Nell’arena delle relazioni di lavoro, il processo attraverso cui un’istanza del lavoratore ottiene una riposta dall’impresa passa per almeno tre stadi: il momento in cui il bisogno si esprime, quello in cui acquista una voce collettiva e viene rappresentato da parte di un sindacato, quello in cui viene negoziato ed ottiene una risposta dal datore di lavoro. Nel caso dei bisogni di conciliazione, finora è stato dato molto risalto alle difficoltà e ai cattivi risultati dell’ultima fase, quella della contrattazione collettiva, ma forse sarebbe utile prestare qualche maggiore attenzione anche alle altre due. Innanzitutto, la domanda di conciliazione richiede di essere segnalata, resa visibile. In pratica, questo avviene molto raramente nei luoghi di lavoro: perché? E’ stato spesso detto che le donne fanno fatica a rendersi visibili nella società, ad incidere nel contesto politico e anche a “negoziare una cittadinanza nel lavoro” (Gherardi 1995). Forse questa difficoltà non deriva dal fatto che le donne sono disavvezze, o disinteressate, al discorso politico bensì dal fatto che “tutte le domande che riguardano i bisogni personali, la vita affettiva, il benessere psicofisico fanno fatica ad essere ammesse nel discorso politico” (Melucci 1994). L’esempio di ciò che succede nelle relazioni di lavoro può essere illuminante anche per altri contesti. Quel che si può osservare è che le donne che lavorano – e i maschi a maggior ragione – hanno spesso difficoltà ad esprimere nei luoghi di lavoro i bisogni che riguardano la loro vita personale e familiare. Un effetto di scoraggiamento viene direttamente dalla cultura delle imprese: è noto, per esempio, che le donne che occupano posizioni professionalmente importanti o che comunque hanno ambizioni di carriera parlano pochissimo della loro vita personale e famigliare, in quanto hanno capito che è controproducente per il loro successo professionale mostrare una immagine di sé non del tutto committed al lavoro. Ma ci sono anche altri effetti di scoraggiamento più ambigui, che fanno sì che la domanda di conciliazione sia difficile da esprimere anche tra gli stessi lavoratori o al sindacato. Come abbiamo visto sopra, l’equilibrio vita-lavoro che ciascuno vuole raggiungere fa riferimento a scelte basate anche su opinioni e assunti ideologici personali, che riguardano il valore che si dà alla maternità e alla paternità, l’interpretazione dei ruoli familiari e della condivisione del lavoro di cura ma anche, per converso, il significato che si da’ all’esperienza lavorativa e il grado di committment al lavoro che si è scelto... Questi aspetti del privato si intravedono inevitabilmente quando si avanzano richieste che attengono l’equilibrio lavoro-famiglia e non sempre si è in grado o si vuole metterli in discussione. In questo senso certamente, l’assemblea sindacale – che costituisce il luogo deve tradizionalmente i lavoratori fanno sentire la voce delle proprie opinioni e delle proprie esigenze e ne chiedono la rappresentanza, dove si discute delle rivendicazioni collettive, dove si stendono le piattaforme contrattuali - non appare lo spazio adatto
6
a far emergere esigenze così più specifiche, frammentate e “private”. Per di più, la componente ideologica influenza anche il sindacato: esso infatti non agisce esclusivamente come tramite neutrale dei bisogni dei lavoratori e negoziatore di questi nei confronti delle aziende ma li filtra alla luce della sua strategia politica, spesso legata a rappresentazioni stereotipate di quelli che “dovrebbero essere” i bisogni dei lavoratori. Insomma, il sindacato ha una sua ideologia attraverso cui legittima – o non legittima - i bisogni. Pensiamo per esempio al part time, che per molti anni il sindacato ha osteggiato, considerandolo (in parte anche a ragione, ma comunque del tutto indipendentemente dalla domanda crescente da parte delle lavoratrici) una forma di lavoro “insufficiente a garantire alle donne indipendenza economica e quindi emancipazione sociale”. Pensiamo anche al telelavoro rispetto al quale, almeno inizialmente, la risposta del sindacato è stata ugualmente ostile, perché “ricacciava le donne dentro le pareti domestiche”. Oltre agli effetti di scoraggiamento culturale ed ideologico, vi sono motivi di ordine più strutturale che ostacolano il processo di rappresentanza della domanda di conciliazione all’interno delle tradizionali istituzioni delle relazioni industriali. Come abbiamo visto, si tratta di bisogni molto differenziati e mutevoli, quindi difficili da portare a sintesi e ricondurre all’interno della contrattazione collettiva. Non esiste infatti una flessibilità-che-va-bene-per-tutti da sostituire alla vecchia routine-standard-maschile del mondo fordista…ma molte esigenze diverse che chiedono di avere risposte, a volte anche personalizzate e, in questo senso, l’emergere della domanda di conciliazione si collega alla spinta verso una maggiore autonomia nel lavoro e alla parallela crescente individualizzazione delle relazioni di lavoro che caratterizza in generale il lavoro nella cosiddetta “società della conoscenza”: nuove soggettività, lavori non-standard, lavoratori di alta qualificazione. Questa difficoltà per le istanze delle donne e in generale per i bisogni personali ad emergere, essere legittimati, acquistare una dimensione collettiva – per dirla alla Hirschman (1970), ad utilizzare l’opzione “voice” – potrebbe essere una delle ragioni per cui questi soggetti scelgono spesso la via dell’”exit”. Il fatto che il tasso di sindacalizzazione femminile sia più basso di quello maschile, soprattutto in Italia (Ebbinghaus, Visser 1999; Feltrin 1999) potrebbe essere un segnale di disaffezione da parte delle donne nei confronti di una rappresentanza che non risponde adeguatamente alle loro attese. Anche il fatto che – come denuncia lo stesso sindacato – spesso i dipendenti che hanno qualche problema familiare si rivolgano direttamente alle direzioni del personale, può essere considerata una opzione “exit” nei confronti della rappresentanza.. Nelle relazioni industriali, la discussione su quale risposta dare alla individualizzazione delle domande dei lavoratori è aperta da tempo e già interroga il diritto del lavoro e gli attori sociali su come sia possibile rendere tra loro compatibili libertà individuale e sicurezza sociale (Muckenberger 1982), su quali nuove forme di solidarietà siano percorribili
7
per il lavoro non-standard (Volkenburg 1995, Cella 1999), su come aumentare lo spazio di autonomia dei lavoratori senza pregiudicare la rappresentanza collettiva degli interessi (Accornero 2001). Il compito futuro del sindacato su questo tema potrebbe essere quello di contrattare l’allargamento delle opzioni professionali e/o di intreccio vita-lavoro possibili o anche quello di stabilire soltanto una cornice normativa generale entro cui i singoli individui possano negoziare le proprie condizioni di lavoro o infine - quando i bisogni, come quelli di conciliazione si intrecciano ad altri aspetti del sociale - quello di spostarne la rappresentanza al di fuori dei luoghi di lavoro su tavoli di governance territoriale. Bibliografia Accornero A, (2001), “Post –fordismo, terza Italia e il lavoro che cambia”, in G.P. Cella , G. Provasi (a cura di), Lavoro, Sindacato, Partecipazione. Scritti in onore di Guido Baglioni, Franco Angeli, Milano AA.VV. (1999), Riprogettare il tempo. Manuale per la progettazione degli orari di lavoro, Edizioni Lavoro, Roma Cella G.P. (1999), Il sindacato, Laterza, Bari Ebbinghaus B., Visser J. (1999), Trade Unions in Western Europe since 1945, Macmillan, Oxford Feltrin P. (1999), “A volte ritorna. Il dibattito sul sindacato come organizzazione”, in Stage, n.3 Friedan B. (1997), Beyond Gender, The John Hopkins Un. Press, Baltimore and London Gherardi S. (1995), Gender, Symbolism and Organisational Cultures, Sage, London; trad. it. (1988), Il genere e le organizzazioni, Cortina, Milano Hakim C. (1991), “Grateful Slaves and Self-Made Women: Fact and Fantasy in Women's Work Orientations”, in European Sociological Review, n.7 Hattery A. (2001), Women, Work and Family. Balancing and Weaving, Sage Publications, Thousand Oaks. Hirschman A.O. (1970), Exit, Voice and Loyalty: Reponses to Decline in Firms, Organisations and States, Harvard Un. Press, Mass.; trad it. (1982), Lealtà, defezione, protesta, Bompiani, Milano Melucci A. (1994), Passaggio d’epoca, Feltrinelli, Milano Muckenberger U. (1996), “Reflections pour une redefinition des relations de travail”, in Revue Internationale du Travail, vol 135, n.6 Ponzellini A.M. (2003a), “Worker Participation in Negotiating Working Time in Italy”, in M. Gold (ed.), New Frontiers of Democratic Participation at Work, Ashgate, London Ponzellini A.M. (2003b), “Sindacato e imprese nella contrattazione della qualità della vita”, in Diritto delle Relazioni Industriali, n.4/XIII Ponzellini A. M., Tempia A. (2003), Quando il lavoro è amico. Aziende e famiglie: un incontro possibile, Edizioni Lavoro, Roma Volkenburg B. (1995), “Individualization, Participation and Solidarity”, in European Journal of Industrial Relations, n. 1
1
Sindacato ed imprese nella contrattazione della qualità della
vita
Anna M. Ponzellini
Una versione rivista è stata pubblicata in: DIRITTO DELLE RELAZIONI
INDUSTRIALI, n.4/XIII, 2003
1. Come dice C. Dejours nel saggio “L’ingranaggio siamo noi. La
sofferenza economica nella vita di ogni giorno”, una delle principali
difficoltà che incontra il sindacato nella nuova cosiddetta “società della
conoscenza” è quello della lettura e della traduzione negoziale dei bisogni
espressi dalle nuove soggettività del lavoro1. Il tipo di domande che il
sindacato sembra attualmente più in difficoltà a raccogliere sono proprio
quelle avanzate dai lavoratori per migliorare la qualità della loro vita
quotidiana, richieste che ormai da alcuni cominciano ad essere considerate
più importanti degli stessi aumenti salariali o di un passaggio di carriera. Al
centro ci sono i bisogni legati ad un migliore equilibrio tra le due più
importanti dimensioni della vita della stragrande maggioranza degli
individui: il lavoro e la famiglia.
Questo problema, a lungo confinato nei dibattiti sulla cosiddetta “doppia
presenza” - nel lavoro di cura e nel lavoro per il mercato - delle donne, ha
tutte le caratteristiche per diventare una questione cruciale per l’insieme del
mondo del lavoro, di pari passo con l’aumento della occupazione femminile
e con il conseguente, seppur lento, modificarsi della cultura della
ripartizione delle responsabilità famigliari all’interno delle coppie, che sta
producendo l’inevitabile allargamento di questa condizione di sdoppiamento
dei ruoli anche ai maschi con responsabilità di cura (principalmente in
quanto padri, ma non solo).
D’altra parte, il rapporto tra famiglia e lavoro è cambiato nel tempo. Se una
volta i capifamiglia maschi portavano nei luoghi di lavoro soprattutto le
preoccupazioni legate al reddito familiare, lasciando tuttavia che i due
mondi – quello della fabbrica e quello della casa - procedessero
parallelamente e con confini ben precisi (tanto quasi sempre a casa c’era
una donna a presiedere alle necessità di organizzazione e di cura),
1 C. Dejours, L’ingranaggio siamo noi. La sofferenza economica nella vita di ogni giorno,
il Saggiatore, Milano, 2000. L’autore, che è psichiatra e psicanalista, considera “la
riluttanza del sindacato ad analizzare la soggettività e la sofferenza nel rapporto col lavoro”
e il fatto che “gli oggetti di preoccupazione indicati da quelle organizzazioni non
corrispondono più al vissuto delle persone che lavorano” tra le ragioni principali della
desindacalizzazione avvenuta in Francia.
2
attualmente per le coppie che lavorano lo “sconfinamento” tra le due
dimensioni è inarrestabile, sia in termini di tempi - perché i tempi del lavoro
e della cura sono spesso rigidi ed è difficile impedire che si sovrappongano
creando difficoltà da una parte o dall’altra - sia anche in termini di quelle
preoccupazioni legate all’organizzazione della vita quotidiana che
soprattutto le donne con figli finiscono inevitabilmente per portare nei
luoghi di lavoro (quando non direttamente a gestire “a distanza”, nei casi in
cui è possibile, ascoltando al telefono i figli, programmando le attività,
controllando che tutto vada bene…).
La complessità di questa problematica nel nostro paese è particolarmente
acuita dalla presenza di un sistema di welfare da sempre poco prodigo di
sostegno alle famiglie, in quanto fondato originariamente proprio sul
presupposto che le donne si facessero carico dei servizi familiari: un sistema
non a caso basato su trasferimenti ai capifamiglia, piuttosto che su servizi
alle famiglie2. Come si vede, il tema purtroppo tocca le politiche sindacali
anche in termini di riequilibrio tra sistema pensionistico ed altre politiche di
welfare… (ma su questo non ci soffermeremo).
2. Una migliore conciliazione tra lavoro e vita familiare è soprattutto una
questione di equilibrio di tempi, quello dedicato al lavoro e quello
extralavorativo, e tocca dunque innanzitutto la tematica degli orari di lavoro.
Cosa si può dire a questo proposito delle tendenze della contrattazione e del
dibattito in corso? Da un po’ di tempo ormai in Italia la contrattazione degli
orari di lavoro ha lasciato la strada della riduzione generalizzata3 per
percorrere, in tutte le sue possibili articolazioni, quella della flessibilità4.
Della flessibilizzazione degli orari di lavoro si è già detto molto e, in genere,
in modo critico e preoccupato, visto che indubbiamente la necessità di
adattare il tempo di lavoro alle esigenze sempre meno prevedibili
dell’organizzazione della produzione e dei servizi, ha portato parallelamente
confusione e sconcerto nei tempi sociali. La “società incessante” di cui
parlava già dieci anni fa il Censis costringe indubbiamente moltissimi
lavoratori a lavorare il sabato, la domenica e la notte, cosa abbastanza
inaspettata nel vecchio ordinato mondo del fordismo. E molti (in parte,
2 Così G. Esping Andersen in “Il welfare state senza lavoro. L’ascesa del familismo nelle
politiche sociali dell’Europa continentale”, in Stato e Mercato, n.45, 1995. 3 Sul fatto che in Europa il dibattito sulla riduzione dell’orario di lavoro e sui suoi possibili
effetti occupazionali sia arrivato ad un punto morto e sulla necessità di rilanciarlo attraverso
un confronto tra le parti sociali che superi le posizioni ideologiche e analizzi le esperienze
concrete, si veda G. Bosch, “Working Time: Trends and New Issues”, in Revue
International du Travail, vol. 138, n.2, 1999. 4 Sul passaggio dalla contrattazione della riduzione generalizzata come politica per
l’occupazione alla contrattazione della flessibilità come risposta alla duplice spinta delle
esigenze delle imprese e dei bisogni di cura, si veda A.M. Ponzellini, “Orari di lavoro:
riduzione, flessibilità e conciliazione tra lavoro e vita”, in Quaderni di Rassegna Sindacale,
n3, 2002.
3
giustamente) si chiedono se ciò non rappresenti un peggioramento
sostanziale della qualità della vita.
Se non fosse che, accanto al macroscopico fenomeno della domanda di
flessibilità proveniente dalle aziende per far fronte all’avanzare del processo
di globalizzazione – saturazione degli impianti, produzione just in time,
aperture prolungate dei servizi – progressivamente si sono incominciate a
manifestare anche le richieste provenienti dai lavoratori (e soprattutto dalle
lavoratrici) di adeguare gli orari di lavoro ai tempi delle cure familiari,
attraverso la ricerca di corrispondenze maggiori, nella quotidianità, tra orari
di lavoro, tempi di pendolarismo, orari delle scuole e dei servizi per
l’infanzia, tempo per stare con i figli, etc.. Queste richieste, emerse
direttamente dai luoghi di lavoro e dai bisogni quotidiani piuttosto che dai
dibattiti degli organismi delegati alla predisposizione delle piattaforme
contrattuali del sindacato e qualche volta addirittura rivolte direttamente al
management senza passare dal sindacato, hanno dato luogo ad una
contrattazione minore e non raramente informale, fatta da continue, piccole
modifiche del tempo di lavoro: part time, permessi per la cura, orari elastici
in entrata/uscita, riduzione dell’intervallo-mensa, ferie programmate,
recuperi ad utilizzo individuale, turni scambiati, che hanno via via eroso il
grande modello “fordista-sindacale-maschile” di orario di lavoro.
Questa domanda di una migliore conciliazione dei tempi fa leva
contemporaneamente su almeno tre dimensioni del tempo di lavoro5.
Innanzitutto, la “durata” dell’orario, che si esprime attraverso la crescente
richiesta di lavori a part time, tanto che da parte di qualcuno è stata avanzata
l’ipotesi che il passaggio dalla riduzione collettiva alle riduzioni individuali
degli orari sia ormai un trend condiviso da tutti i paesi europei6. Dove i part
time richiesti solo preferibilmente quelli lunghi – 30 o 32 ore – che
consentono di non ridurre troppo il reddito7. In secondo luogo, la
“collocazione” dell’orario, che si esprime attraverso la possibilità di avere
margini di scelta sul quando lavorare, per esempio attraverso orari elastici
su base giornaliera o settimanale, banche delle ore, lavoro solo in alcune ore
dalla giornata, o in alcuni giorni della settimana o in alcuni periodi
dell’anno. Infine, l’“assenza” per la cura, in quanto diritto da esercitarsi in
particolari situazioni, come la maternità e le cure parentali, la necessità di
accudire familiari ammalati o handicappati.
Un terzo aspetto da considerare – accanto alle nuove domande di flessibilità
che vengono dal mondo delle imprese e dal mondo delle famiglie - sono i
cambiamenti del senso e dell’organizzazione del lavoro che si stanno
5 Queste tre dimensioni sono analizzate nella ricerca Riprogettiamo il tempo (vedi dopo) 6 Si veda S.Lehndorff, “From Collective to Individual Reduction in Working Time? Trends
and Experience with Working Time in the European Union”, in Transfer, vol 4, n.4, !999. 7 Come si evince da molti sondaggi sulle preferenze d’orario e, anche recentemente, dalle
preferenze emerse nelle scelte di part time negli enti locali (che vedono privilegiato il part
time 4/5).
4
verificando nella società con l’avvento della cosiddetta economia post-
industriale e che sembrano produrre una nuova costruzione sociale del
rapporto tra lavoro e non lavoro le cui principali caratteristiche sono, da un
lato, la maggiore autonomia del lavoratore ma, dall’altro, anche più
frequenti sovrapposizioni ed interferenze tra vita lavorativa e vita privata
(con home-computer, laptop e cellulari ad accompagnare la transizione tra
un mondo e l’altro). Rappresenta molto bene la dimensione di questi
cambiamenti una modalità di lavoro che è attualmente sperimentata
soprattutto dai cosiddetti “lavoratori della conoscenza” ma che si sta
diffondendo in molte organizzazioni, ovvero il lavoro per progetto. Il lavoro
per progetto, infatti, sovverte, almeno potenzialmente, il sistema del
controllo del lavoro, che passa dall’essere basato sul tempo di presenza al
lavoro ad essere basato sul risultato del lavoro. La scadenza del progetto,
anziché il cartellino, diventa il riferimento temporale fondamentale e si
combina con le altre forme di controllo interiorizzate dagli stessi lavoratori.
Pur accompagnato dalla rigidità delle scadenze (e, non di rado da ritmi più
pressanti) il lavoro per progetto aumenta lo spazio per adattamenti personali
nella gestione dei tempi di vita, adattamenti che invece non sono possibili
dove sono presenti altri vincoli, come gli orari degli impianti o quelli di
presidio al cliente. Osservando il fenomeno del diffondersi del lavoro per
progetto, qualcuno ha sostenuto che gli orari di lavoro tenderanno in futuro
ad avere un andamento meno quotidiano e più ciclico, con periodi più o
meno lunghi in cui si avvicenderanno una maggiore e una minore intensità
di lavoro o il riposo8. Questo è già in parte visibile con la tendenza alla
annualizzazione degli orari, che comincia ad essere contrattata anche in
Italia, ma è ancora più visibile nei paesi nordici, in Belgio ed in Francia con
l’importanza crescente – e la crescente durata temporale - dei congedi
familiari e formativi. Anche su questo piano, dunque, l’alternanza tra tempo
di lavoro e tempo di vita è destinata a comporre un nuovo scenario: la vita
familiare ha infatti, oltre ad una dimensione quotidiana di compiti domestici
e di cura a cui già danno qualche risposta le varie formule di part time
giornaliero e l’orario elastico, una dimensione ciclica su base annuale che
ripercorre il calendario delle scuole e dei servizi per l’infanzia e a cui dà una
risposta ancora solo parziale l’avvicendamento del lavoro con i periodi di
ferie e, infine, una più ampia ciclicità legata alla vita riproduttiva e quindi,
sul versante del lavoro, alle interruzioni di carriera per congedi di maternità
e di cura, a cui dà una risposta ancora piuttosto modesta – vista la scarsa
tutela del reddito - la nuova disciplina dei congedi parentali.
3. La variabile tempo – per quanto sia la più importante - non è la sola
implicata nella questione della conciliazione tra lavoro e vita familiare, né la
sola che abbia implicazioni con l’organizzazione aziendale. 8 Si veda J.Y Boulin, “Working time in the new social and economic context”, in Transfer,
vol 7, n.2, 2001.
5
Si riversano infatti sul tempo di lavoro una serie di carenze e di
contraddizioni che provengono dalla scarsissima organizzazione e tutela
sociale delle attività di cura che caratterizza il nostro paese. Anche se vale il
principio che neppure un buon sistema di servizi per bambini e ragazzi, per
disabili e anziani – del tipo di quelli esistenti nei paesi nordici, per
intenderci - può sostituire completamente le cure familiari ed amicali, va
sottolineato che la grave carenza di servizi per i bambini fino ai tre anni9,
nonché l’elevatissimo costo di quelli che ci sono10, sono tra le principali
ragioni delle difficoltà delle donne italiane a presentarsi sul mercato del
lavoro, a restarvi dopo la nascita di un figlio11 e comunque ad avere una
decente qualità della vita quando continuano a lavorare.
In questo quadro, non stupisce più di tanto che le stesse imprese comincino
a prendere in considerazione l’idea di giocare un ruolo propositivo. Non a
caso, le teorie sulla responsabilità sociale dell’impresa – che stanno avendo
qualche rilancio in questi ultimi anni, anche sulla spinta della Commissione
europea - sollecitano le aziende a considerare i dipendenti tra i propri
stakeholder e quindi ad assumerne gli interessi in quanto persone e non solo
in quanto lavoratori: ciò include una maggiore attenzione alla dimensione
personale e famigliare dei lavoratori. Recentemente inoltre, alcune
sollecitazioni alle imprese a fare la loro parte, diventando “nuovi attori del
sistema di welfare”12 sono venute anche dai governi, tramite misure di
sostegno alla flessibilità degli orari, contributi per la realizzazione di asili
nido nei luoghi di lavoro13, etc. Non c’è dubbio però che, al di là di qualche
incentivo pubblico o delle spinte di ordine etico, le aziende si sentono
sollecitate ad intervenire anche da concrete ragioni di controllo del mercato
del lavoro: trattenere dipendenti su cui sono stati fatti investimenti
formativi, aumentarne la affezione all’azienda, il senso di identità, il
commitment rispetto agli obiettivi aziendali, la motivazione al lavoro.
9 L’offerta di asili-nido pubblici in Italia non supera il 6% (dati Censis 2002). 10 Secondo alcune stime (G.Esping Andersen, I fondamenti sociali delle economie post-
industriali, il Mulino, Bologna, 2000), il costo netto (dopo tasse e trasferimenti) di un asilo
nido per una famiglia di reddito medio con due figli, alla metà degli anni novanta era pari in
Italia al 39% del reddito, contro il 9% della Francia, l’11% di U.S. e Danimarca, il 19%
della Germania, il 28% della Gran Bretagna. D’altra parte, le tariffe di asilo pubblico a
Milano per l’anno 2002-03 variano da 103 a 465 euro mensili a seconda del reddito (la
fascia più alta è facilmente raggiunta dalle famiglie con due redditi, che comunque, in virtù
di questa condizione “privilegiata” difficilmente hanno accesso a questo servizio). 11 I dati dell’Ispettorato del Lavoro sulle lavoratrici che hanno lasciato il lavoro entro l’anno
dalla nascita di un figlio mostrano un aumento di oltre il 30% negli ultimi tre anni.. 12 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Libro bianco sul welfare, Proposte per
una società dinamica e solidale. Febbraio 2003, Roma. 13 Si veda l’art.9 della Legge 8 marzo 2000, n.53 “Disposizioni per il sostegno della
maternità e della paternità, per il diritto alla cura e per il coordinamento dei tempi delle
città” e più recentemente il Fondo di rotazione previsto dalla Finanziarie 2002 e 2003.
6
4. A pochi anni di distanza l’una dall’altra, due ricerche della Fondazione
Pietro Seveso sulle misure introdotte dalle aziende per migliorare
l’equilibrio tra lavoro e vita familiare dei dipendenti, hanno cercato di
sondare quali aspetti della crescente domanda di qualità della vita espressa
dai lavoratori e dalle lavoratrici avesse ottenuto risposte dalla contrattazione
aziendale e, più in generale, dalla introduzione nei luoghi di lavoro di nuove
forme organizzative, nuovi servizi, specifici supporti per i dipendenti con
impegni di cura.
La prima ricerca, Riprogettare il tempo, pubblicata nel 1999, si è occupata
sostanzialmente di orari di lavoro, esaminando la contrattazione aziendale
dal 1990 al 1996 e facendo un censimento di tutte le formule di flessibilità
degli orari che potessero essere considerate “direttamente o indirettamente
favorevoli ad una migliore conciliazione tra lavoro e vita familiare” 14.
La seconda ricerca15, di cui si riferisce in questo articolo, Quando il lavoro è
amico, pubblicata nel 2003, si è proposta l’obiettivo di non censire soltanto
gli interventi di flessibilizzazione “positiva” degli orari di lavoro ma di
verificare se anche in ambiti diversi da quello degli orari – quello dei servizi
aziendali, per esempio, o quello delle indennità monetarie e dei benefit in
natura, o anche tra le norme che tutelano la maternità e i congedi o che
regolamentano le carriere, etc. – fosse possibile trovare misure orientate ad
alleggerire le responsabilità familiari dei dipendenti o ad aiutare
direttamente i figli o altri familiari. Anche in questo caso, si è deciso di
considerare tutti i tipi di misure, sia introdotte attraverso la contrattazione
sindacale, sia anche informalmente e unilateralmente dalle aziende.
La raccolta di queste “misure aziendali di conciliazione” è stata realizzata a
partire da un questionario postale inviato a 190 aziende già segnalate come
aziende “sensibili” alle problematiche della conciliazione e a 40 Cral di
grandi aziendale. Ma sono stati soprattutto vagliati circa 1300 accordi
aziendali, stipulati in tutti i settori produttivi e su tutto il territorio nazionale,
nel periodo 1996-2001, attingendo all’archivio della contrattazione
aziendale del Cnel e, su scala più ridotta, all’archivio del sindacato dei
metalmeccanici della Lombardia.. Alla fine, sono state rinvenute 310 misure
aziendali di conciliazione, classificate secondo quattro tipi: “orario e
telelavoro”, “servizi aziendali”, indennità e benefit”, “supporti nella
interruzione di carriera”.
4.1 Orari di lavoro a dimensione di famiglia
Le 215 misure di “orario e telelavoro” che sono state rinvenute sono
risultate comunque il tipo più diffuso di misure di conciliazione (70%). Esse
riguardano soprattutto molti tipi di permessi retribuiti o non retribuiti per
14 M. Piazza, A. M. Ponzellini, E. Provenzano, A. Tempia, Riprogettare il tempo. Manuale
per la progettazione degli orari di lavoro, Edizioni Lavoro, Roma, 1999. 15 A.M. Ponzellini, A.Tempia , Quando il lavoro è amico. Aziende e famiglie: un incontro
possibile, Edizioni Lavoro, Roma, 2003.
7
diversi problemi familiari (permessi per i padri in occasione della nascita di
un figlio, permessi di cura per familiari malati, figli handicappati o
tossicodipendenti; permessi per lutto, permessi retribuiti per l’inserimento
dei bambini all’asilo-nido o alla scuola materna) e in secondo luogo part
time di vario tipo (orizzontale, verticale, solo week-end, modulato sulle
vacanze scolastiche, etc.), tra i quali anche alcuni schemi di job-sharing
orizzontale e verticale, applicati anche in produzione. Non mancano però
accordi sugli orari elastici in entrata e in uscita; norme che prevedono
l’introduzione del sistema della banca delle ore (sistema di accantonamento
degli straordinari da recuperare in base alle esigenze personali); soluzioni di
telelavoro per le lavoratrici che rientrano dalla maternità.
4.2 Asili-nido, altri servizi per la cura di bambini e ragazzi e servizi di aiuto
alla gestione domestica
Le 34 misure di “servizi aziendali per le famiglie” che sono state rilevate
dall’indagine rappresentano una quota decisamente più modesta (circa
l’11%) dell’insieme delle misure censite. Tuttavia sono sembrate molto
interessanti soprattutto perché rappresentano un curioso mix tra vecchio e
nuovo. Da un lato, diversi asili, colonie, case-vacanza, spacci, etc. spesso
creati già nella prima metà del novecento nelle grandi aziende sensibili ai
problemi sociali o nei servizi di pubblica utilità (Enel, Sip, grandi
municipalizzate, etc.) e sopravvissuti a quella fase di disinteresse sindacale
e/o di abbandono per costo eccessivo, che ha caratterizzato queste
esperienze a partire dagli anni settanta. Dall’altro, però, nuovissimi nidi e
baby-parking spuntati qua e là, nel giro degli ultimi due anni, specialmente
in Lombardia, in aziende ad alta densità femminile come ospedali, call
centre, società di assicurazioni (ma anche in aziende di prodotti
manifatturieri a manodopera femminile). Alcuni di questi nidi sono aperti,
tramite convenzioni con i Comuni, anche alle alte famiglie presenti sul
territorio, alcuni nidi sono gratuiti, più spesso sono a pagamento ma
prevedono in genere tariffe più basse di quelle dei nidi pubblici. Sono state
rilevate anche soluzioni meno costose ma molto utili, come spazi di
animazione e doposcuola, vacanze in città per bambini e ragazzi. E anche
qualche servizio innovativo e “intelligente” per supportare il lavoro
domestico – come una mensa che confeziona pasti serali che i lavoratori
possono portare a casa - o per assistere le famiglie in difficoltà – come
servizi interni di assistenza.
4.3 Indennità, benefit e altri supporti economici per i dipendenti, i figli e le
loro famiglie
Si tratta di un gruppo di misure rilevante (55, pari al 18% del totale). Anche
questo tipo di misure ha radici lontane nel tempo quando la maggior parte
delle grandi aziende per consuetudine, forse ancora prima che per norma
contrattuale, prestava aiuti straordinari ai dipendenti in difficoltà
8
economiche o che sceglievano di far studiare i figli: ecco allora le borse di
studio o i rimborsi delle tasse universitarie, presenti ancora in alcune grandi
aziende. I prestiti per la casa restano comunque la misura più diffusa, anche
se ora è prassi comune fare riferimento agli anticipi del Tfr. Seppure la
maggior parte di queste misure erano originariamente dirette ad alleggerire
le preoccupazioni economiche dei “capi-famiglia”, alcune tuttavia erano già
allora mirate alle lavoratrici, come le integrazioni della indennità di
maternità o il rimborso delle rette degli asili-nido: di questi ultime indennità
ne abbiamo trovate ancora diverse ma vengono menzionate nella
contrattazione più recente solo quando, su richiesta dell’azienda, viene
stabilito un tetto massimo alla quota di rimborso. In compenso, compare
qualcuna misura nuova, più mirata alle esigenze attuali dei dipendenti-
genitori, come quella prevista da una azienda che rimborsa le spese di cura
(baby-sitter, assistenza anziani) ai dipendenti che vengono mandati in
trasferta di lavoro.
4.4 Supporto ai dipendenti in occasione delle interruzioni di carriera dovute
a maternità o congedi parentali
Tra queste misure volevamo censire gli interventi messi in atto dalle aziende
per limitare gli svantaggi nella carriera che subiscono coloro che fanno
lunghe assenze dal lavoro in occasione della nascita di un figlio. Quindi in
primo luogo le madri ma anche – e per fortuna sempre più frequentemente,
anche se in numero ancora statisticamente poco rilevante – i padri che si
avvalgono del diritto ai congedi parentali. Di queste misure ne abbiamo
trovate poche, solo 6 (2%). Una in particolare, comunque, sembra
interessante ed è stata replicata in un certo numero di aziende diverse:
prevede la creazione di una specifica figura aziendale - il “consulente per la
maternità e paternità” – adibita a tenere i contatti con i dipendenti durante
l’assenza e insieme percorsi di tutorato e di aggiornamento per i dipendenti
al rientro dal congedo di maternità o dal congedo parentale.
5. I risultati dell’indagine ci consentono di esaminare meglio due aree
problematiche: la prima relativa alle tendenze generali della contrattazione
della flessibilità positiva degli orari e delle misure di conciliazione, la
seconda relativa al diverso ruolo degli attori sociali rispetto a questa
tematica contrattuale.
Sembra innanzitutto importante sottolineare che le misure emerse, seppure
varie ed interessanti (in qualche caso addirittura sorprendenti) dal punto di
vista qualitativo, risultano sul piano quantitativo ancora poco significative.
Per avere una idea dell’incidenza di questa tematica nella contrattazione
possiamo prendere ad esempio uno degli archivi più completi tra quelli che
abbiamo utilizzato come fonti, che è quello degli accordi aziendali del
settore metalmeccanico lombardo: sui 480 accordi stipulati nel periodo
1996-2000 soltanto 17 contengono norme o provvedimenti classificabili,
9
anche in senso lato, come misure per la conciliazione: e siamo in Lombardia
e nel settore metalmeccanico, che comunque anche a livello nazionale
presenta il maggior numero di misure di questo tipo (circa il 21% delle
misure censite).
In particolare per quanto riguarda le misure di flessibilità positiva degli orari
di lavoro - rispetto alla quale è possibile fare un confronto con l’indagine
del 1999 – la ricerca evidenzia una situazione di stallo dal punto di vista
quantitativo e anche una sostanziale assenza di misure nuove. Volendo
trarre un bilancio più articolato, ci sembra che elasticità in entrata e uscita e
part-time comincino ad essere piuttosto diffusi negli ambienti impiegatizi
ma che vi siano ancora grossi vincoli organizzativi per introdurli in
produzione e nelle attività di presidio alla clientela (casse, sportelli). In
queste ambiti più difficili, le esperienze sono davvero poche e
pionieristiche: di job-sharing (posto di lavoro diviso) ne abbiamo trovati
solo in due o tre realtà operaie mentre una modalità di lavoro analoga a
questa - le “isole-casse” nella grande distribuzione (dove la ripartizione dei
turni viene decisa dallo stesso gruppo di addetti ) – è ancora in via di
sperimentazione. Anche il telelavoro si sta diffondendo più lentamente del
previsto, mentre la concreta applicazione delle banche delle ore – la vera
grande novità degli anni novanta - non sembra avere avuto un grande
successo: come è emerso dalle analisi di caso, lo scambio non è sempre
risultato sufficientemente attraente per i dipendenti, che trovano ostacoli da
parte del management aziendale ad utilizzare le ore accantonate quando ne
hanno realmente bisogno.
6. Venendo quindi a considerare il ruolo delle parti sociali, è soprattutto
nell’azione svolta dalle imprese che ci sembra si possano riconoscere alcune
iniziative interessanti ed innovative, particolarmente da parte di aziende
multinazionali (Avon, Sony, Du Pont, Whirlpool, Ikea, Zanussi Electrolux,
Royal Insurance etc..) e aziende pubbliche ed ex-pubbliche (Telecom,
Banksiel, Ferrovie Nord, Atm Milano, Università di Verona, Ospedale
S.Carlo, Banca Italia), oltre che da parte di qualche azienda nazionale
particolarmente radicata nel territorio (Peg Perego, Martini e Rossi, Tod’s,
etc.).
Abbiamo rilevato con qualche delusione, tuttavia, che restano ancora
ostacoli organizzativi ad una piena implementazione del part time e del
telelavoro, di cui pure la sperimentazione in questi anni ha dimostrato il
costo modesto, o addirittura i vantaggi per le imprese, nel caso di talune
attività. La lentezza con cui si diffondono queste modalità di lavoro e di
orario è sintomo della resistenza che manifestano ancora molte aziende a
cambiare i propri consolidati schemi di organizzazione del lavoro e forse
ancora di più ad individuare nuovi sistemi di valutazione della prestazione,
non più basati esclusivamente sulla presenza e sulla supervisione del capo:
nuove forme di coordinamento e controllo potrebbero consentire a molti
10
lavoratori e lavoratrici (quelli che già ora svolgono attività non vincolate
agli impianti o ai clienti) di organizzare in relativa autonomia il proprio
lavoro e sarebbero uno strumento importante per ridurre le difficoltà di
conciliazione dei tempi.
Va aggiunto tuttavia che – almeno nel confronto col sindacato - le imprese
non sembrano giocare un ruolo così secondario nelle politiche di
conciliazione: le misure che abbiamo censito – soprattutto, ma non solo,
quelle relative ai servizi aziendali, come i nuovi asili-nido – sono infatti più
frequentemente introdotte per iniziativa del management piuttosto che per
iniziativa dei rappresentanti sindacali. In alcuni casi, l’iniziativa aziendale è
motivata da strategie di gestione delle risorse umane in mercati del lavoro
tipicamente femminili – quello della grande distribuzione o dei call centre,
per esempio – finalizzate a ridurre alcuni specifici costi di questi mercati,
come l’elevato turn-over o l’assenteismo. In qualche altro caso si può però
osservare che l’intento dell’impresa è più “gratuito”: quasi un desiderio da
parte di alcuni imprenditori di darsi un ruolo o una visibilità sociale –
soprattutto quando l’azienda ha un discreto rapporto col territorio - non solo
legati alla creazione di profitti. Ciò è evidente soprattutto nei casi di
creazione di asili-nido, organizzazione di spazi di animazione o vacanze per
i ragazzi o altri servizi per le famiglie, iniziative rispetto alle quali il
rapporto con la comunità circostante risulta più significativo.
7. Per contro, come appare dal fatto che in una parte di queste esperienze la
contrattazione è assente, risulta piuttosto deludente il ruolo del sindacato. Le
esitazioni dei rappresentanti dei lavoratori sono probabilmente dovute al
fatto che i bisogni di conciliazione e di qualità della vita hanno
caratteristiche di maggiore individualizzazione e tendono quindi a spostare
la sua azione di rappresentanza da una dimensione collettiva, universalistica
– com’è per esempio quella salariale o dei diritti dei lavoratori – ad una
dimensione più frammentata, individualistica. I problemi di conciliazione,
infatti, non toccano tutti i dipendenti, possono persino essere fonte di
divisioni tra i lavoratori, quindi è più difficile assumerli e portarli a sintesi
nella contrattazione collettiva.
Analizzando meglio le diverse tematiche coinvolte in questa area di
contrattazione, dalla ricerca emerge innanzitutto che continuano a pesare sul
sindacato i vecchi pregiudizi nei confronti dei lavori non-standard, come il
part time - verso il quale il sindacato è stato a lungo ostile (e che anche ora
si ostina a tenere sotto controllo con le norme del “tetto massimo” di aventi
diritto) - o anche il più recente telelavoro. Mentre il sindacato appare un po’
più attivo nel contrattare l’elasticità giornaliera e settimanale degli orari e le
banche delle ore: soluzioni applicabili, non a caso, senza intaccare
l’organizzazione del lavoro standard. Oppure nel contrattare i vari tipi di
permessi, nell’affermazione quindi di alcuni diritti aggiuntivi per i
11
lavoratori, come sono appunto i diritto “all’assenza” per particolari motivi
legati alle proprie responsabilità familiari.
La ricerca ci dice soprattutto che è nella introduzione dei servizi che il
sindacato brilla per la sua assenza: praticamente tutti i casi di asilio-nido
solo stati ideati e realizzati dalle imprese (l’accordo sindacale, quando c’è, è
stato fatto successivamente). Il sindacato probabilmente non crede – e in
parte a ragione - che questi servizi possano sostituire la responsabilità del
welfare pubblico, ma certamente in questo modo finisce per non cogliere
l’opportunità di giocare il proprio ruolo di attore sociale in un ambito più
ampio di quello dei luoghi di lavoro, per esempio come integratore a livello
territoriale delle diverse risorse necessarie per la soluzione di problemi
sociali concreti. In questo modo le organizzazioni di rappresentanza del
lavoro sembrano marcare una discreta distanza da quel modello di
modernizzazione delle relazioni di lavoro che U. Muckenberger – uno dei
teorici della umanizzazione del lavoro - ipotizzava nella forma di un
“significativo aumento dei diritti individuali di partecipazione”, in modo che
i lavoratori “si vedano riconosciuti, sia sul luogo di lavoro che fuori, dei
diritti a gestire le loro esistenze....”, secondo un progetto di nuova
cittadinanza sociale in grado di conciliare gli obiettivi dell’impresa, quelli
dei lavoratori e quelli dell’insieme della società16. La domanda che deve
rappresentare il sindacato e raccogliere la contrattazione collettiva è quindi
una domanda – anche individuale e diversificata - per una migliore qualità
della vita che, tradotta in termini di orario di lavoro, significa in definitiva
una maggiore autonomia per i lavoratori nella scelta del quanto e quando
lavorare. Ma il sindacato può anche andare oltre, spingendo la
contrattazione collettiva – anche a partire dalla conquista di diritti di assenza
dal lavoro, servizi di supporto anche aziendali, sostegni finanziari, etc. - alla
costruzione di modello sociale in cui trovino spazio nuovi più ampi diritti di
cittadinanza, che includano da un lato il diritto ad essere curati ed educati
dei bambini, dei ragazzi e di tutti quelli che hanno bisogno di cure, dall’altro
il diritto a curare, ad assistere e ad educare delle madri, dei padri e di tutti
quelli che hanno responsabilità sociali e di cura.
16 U.Muckenberger, “Reflections pour une redefinition des relations de travail”, in Revue
Internationale du Travail, vol.135, n.6, 1996.
1
Worker Participation in Bargaining on Working Time. Italy
Anna M. Ponzellini
Testo uscito in M. Gold (ed.), New Frontiers of Democratic Participation, Ashgate, London, 2003
Introduction
The issue of working time is currently high on the collective bargaining agenda in Italy.
However, with the passing of time, both the issues under discussion and the bargaining
levels have changed
For a long period – at least for the whole of the 1980s – negotiation centred on the
“generalized reduction of working hours” under the slogan “Lavorare meno per lavorare
tutti” (“Work less so that everyone can work”) launched by Pierre Carniti, secretary of
the CISL trade-union confederation. The results were marginal, however: the working
week still amounted to 40 hours and the modest reduction in working hours was mainly
achieved by increasing the number of days off.
In the past ten years (in some sectors for even longer) – and generally as a result of
pressure applied by employers – the focus of bargaining has progressively shifted to
‘working hours flexibilization’, giving rise to a wide variety of plant utilization schemes
and differentiated working hours schedules, almost always tied to the specific nature of
the technology concerned and of product markets. This growing de-standardisation of
working hours has increased the importance of company-level bargaining: indeed, in
recent years this issue has been the most frequent subject of bargaining after negotiation
on the wage.
Latterly, moreover, new, interesting forms of bargaining have arisen which seek to
combine the granting of “flexible hours according to firms’ needs” with “flexible hours
according to employees’ needs’” and in particular to arrangements that enable workers
to balance work with their family and personal commitments more easily.
2
The interesting feature of this new wave of bargaining on working hours is that it is
driven from the bottom up – by the concrete everyday needs of workers (and especially
of female workers) – rather than by long-term strategies devised by the trade-union
confederations at the central level.
This essay will examine bargaining on working time in Italy during the last ten years,
dealing in particular with flexible working hour arrangements negotiated at the
company level. The first and second section will discuss the evolution of trade-union
policies in recent years as part of the dialectic between the “generalized reduction” and
the “flexibilization” of working hours. It will also examine the impact of those policies
on industrial relations and on the bargaining structure (and especially the emergence of
the company level as the main arena of working hours negotiation). The third section
will concentrate on the different – and sometimes conflicting – meanings assumed by
the term “working time flexibility” depending to whether it is used by employers or by
workers. It will also analyse the organizational implications of the destandardization of
working hours, from the points of view of both the organization of production (or of the
service produced) and the working conditions of employees. The fourth section will
concentrate on the new policies for “reconciling work and family life” promoted by
both the trade unions and a number of family-friendly firms. Examples will given of
interesting company experiments in the organization of working hours designed to
harmonize the firm’s needs with the personal/family needs of its workers.
1. Reduction or flexibility? The debate on the reduction of working
hours in Italy
In Italy, as in all the European countries, the debate on reducing working hours and on
its possible effects in terms of employment seems to have come to a standstill.i.
After a period, between the end of the 1970s and the second half of the 1980s, when the
policy of “work less so that everyone can work” aroused great interest, especially
among one of the trade-union federations (Cisl), the issue was largely set aside for a
number of years, during which industry collective bargaining achieved minor benefits in
the form of extra days of paid leave but left the official working week substantially
3
unchanged at 40 hoursii. Compared to the target of 35 hours – amounting to a 12%
decrease in average working time – the reduction actually achieved during the 1980s
and 1990s in the private sector did not amount to more than 5-6%. A modest result,
which as regards industrial workers was annulled by a simultaneous and more than
proportional increase in overtime.iii
The half-failure of the strategy to reduce working hours in that period were due in part
to the opposition raised by employers, and perhaps also in part to the scant impetus
given by the unions to the policy, which was never popular with workers. The unions’
decision to advance moderate and incremental claims (instead of a big campaign) as
regards reduced working hours found little consensus among workers, who were
reluctant to give up their potential pay increases, in a period for that matter of wage
restraint, in exchange for a reduction of a few minutes in their daily hours! And the
meagre results were also due in part – at least for some years – to splits in the trade-
union front, with the Cgil unwilling to make working-time reduction the central issue of
bargaining when national industry agreements were renewed.iv
As regards instruments to increase employment, moreover, throughout the 1970s and
1980s, the preference of the unions clearly lay with early retirements and the consequent
hiring of young people, rather than with the employment creation that would result from
a substantial reduction of working time (although, from many points of view, early
retirement can be considered a form of working-time reduction).
The issue of a generalized reduction of working time recently returned to the agenda
when, in 1997, the Italian government pledged, following the French example, to
introduce a law restricting the statutory working week to 35 hours. Somewhat
surprisingly (and unlike in France), this undertaking – prompted by the government
coalition’s need to placate its most radical left-wing component (Rifondazione
Comunista) – provoked the opposition not only of the employers’ associations
(traditionally hostile to reductions in working hours) but also of the trade-unions
themselves. More than reasons of substance, given that the unions had declared
themselves in favour of a progress reduction of working hours, their opposition was
grounded on reasons of method. The most important of the latter was the reluctance of
the unions to cede an area that had always been within the purview of the social partners
to the executive and to the parties. It was probably more because of the stance taken up
4
by the unions, rather than events within the majority, that the government’s pledge to
reduce working hours was eventually shelved.
It may also be that this episode can be interpreted – after years of discussion between
the social partners and also internally to the unions themselves – as resulting from
general scepticism as to the employment creation potential of generalized policies for
working-time reduction. Various commentators have pointed out that, although
working-time reduction is undeniably a means to improve the life-conditions of workers
and to protect jobs, how it can be implemented in practice is still unclear – that is,
without creating problems of costs and therefore of competitiveness for firms, without
giving rise to increased overtime by skilled personnel, and without generating labour-
market tensions in areas of full employment, with the attendant risk of exacerbating,
rather than resolving, the traditional north/south dualism of the Italian economy.
Some commentators have also emphasised that in a country like Italy – characterized by
the large-scale presence of small and very small firms to which a law introducing an
across-the-board reduction of working hours would be inapplicable, with a large amount
of irregular employment, and with a public administration in which the working week
has been 36 hours or less for years – the number of workers affected by the reduction
would be too small to produce significant results in terms of new employment.v
As regards practical aspects, with the passage of time it has grown increasingly clear
that an automatic and undifferentiated reduction of working time could once have been
achieved easily in a Fordist organization, with its predictable production flows and high
interchangeability of labour. But it is much more difficult to implement today, in
conditions of flexible production, consumer-driven markets, and the increasing
differentiation of skills.
Interesting light is shed on this aspect by studies on the application of “solidarity
contracts” (agreements reached in cases of company crisis and financed out of a public
fund). The attempt to redistribute work in accordance with the law, by applying the
same reduction in hours to all workers in the company has failed in the majority of
cases. It has clashed, in fact, with the existence in internal labour markets of a demand
for highly specific labour in terms of the tasks to be performed and, conversely, with the
scant substitutability of skills present in the company.vi
5
With the option of a statutory reduction in working hours discarded at least for the time
being, the goal of job creation together with favouring female work has been partially
resumed by the Italian government – following the example of Holland – by providing
incentives for part-time contracts. In all EU countries, the increasing importance of part-
time work has been interpreted as a shift from collective to individual working time
reductionsvii. Anyway, it should be pointed out that part-time has been traditionally little
used in Italy; a country, like all those of southern Europe, characterized by low labour-
market participation by women, which is off-set, however, by the absence of the
male/female polarization in terms of working hours that generally characterizes the
Nordic countries (and which gives rise to some concern among commentatorsviii).
Following these recent government measures, part-time employment has increased in
the services sector and, to some extent, in the public administration. Although the
overall percentage of part-time workers is still rather low (just over 10%).
2. Reduction plus flexibility. The emergence of an “Italian way”?
Two phenomena have instead led to renewed bargaining on working time since the end
of the 1980s, taking the place of the original objective of a generalized reduction in
working hours.
The first consists of the new market and production requirements generated by the
advent of the so-called ‘post-Fordist’ economy and the onset of globalization, factors
which have compelled firms to intensify the use of plants and to adjust their production
(and service) rates to the exigencies of their customers.
The second phenomenon – to date the less evident of the two – is the emergence and
legitimation, in a period of relative affluence and increasing female participation in the
labour market, of the need of male and female workers to achieve a better balance
between their work and their personal and family lives, amongst other things by means
of flexible working-time arrangements.
Both these phenomena have shifted the focus of bargaining to flexibility – albeit often
in different directions – rather than a wholesale reduction in working hours. However,
the Italian experience of the last fifteen years has shown that working-time flexibility
6
and working-time reduction are not incompatible. Nor are flexibility and new
employment.
This is also the case with regard to ‘more difficult’ flexibility, or the flexibility required
by the needs of production or service. Actually, acceptance of the working-time
flexibility by the unions has also entailed their acceptance that working-hours policies
may be appropriated by firms. In fact, whilst the policy of work reduction has a
markedly social connotation, that of flexibility requires close attention to be paid to the
costs and organization concerns of firms, and therefore to the technical solutions
proposed by management.
On the other hand, the unions’ agreement to negotiate on differentiated and flexible
working hours has opened the possibility that a policy of working-time reduction can be
resumed in more viable form – if it is true, as a European Commission report declared
ten years ago – that “policies to reduce working time can only be effective if they are
closely linked with the reorganization of production.”ix The entitlement acquired by
worker representatives through the negotiation of flexibility to involve themselves in the
technical aspects of various working-hours arrangements, and to choose the one best
suited to a particular plant or a particular market, enables them to advance proposals for
reductions in working time which firms find acceptable in terms of costs.
Accordingly, the Italian model of bargaining on working time in recent years can be
regarded as positive. In Italy, in fact, bargaining on production flexibility – especially in
the form of extra shifts, an extension of production to include the weekend, and variable
weekly working hours according to the seasonal production cycle – has been under way
since the early 1980s, and therefore began earlier in Italy than in other countries.x In a
period when the generalized reduction of working time had mediocre results, the Italian
unions negotiated hundred of agreements in the manufacturing sector which conceded
production flexibility in exchange for reductions in working hours (which in numerous
companies fell to 36 – or even 32 – hours a week on average for shift workers) and
worker autonomy in the use of rest days (by means of the “hours account system)xi – in
short, a working-time policy which combined flexibility and reduction.
With respect to what has been depicted as the European trend in working hours over the
last twenty hours – the shift from ‘collective’ reduction to ‘individual’ reductions of
working time in the form of part-time workxii – the Italian case seems somewhat
7
different, and perhaps intermediate between the two instances. And this is not only
because the incidence of part time is still low in Italy (which may be only in a phase
somewhat behind the other countries), but also because a great deal of the working-time
flexibility that has been negotiated has received collective reductions in working time in
return, although these have been restricted to certain companies and/or occupational
groups (and therefore not ‘generalized’). The Italian experience also highlights the
importance of the company level for bargaining on working time. It is in fact at this
level that it is possible to define the working hours schedules and their duration (which
cannot be standardized) best suited to the technology, the type of market, and the needs
of the customer.xiii At the company level, moreover, it is easier to identify the differing
needs of male and female workers and to obtain a more beneficial exchange between the
demand and supply of working-time flexibility.
3. What flexibility? The confrontation between the needs of companies
and those of workers
When, in the mid-1980s, talk began in Italy on “flexibility” – of working hours but also
more generally of employment relationships – between unions and employers, but also
among workers themselves, there ensued what was sometimes a heated debate.
The notion of flexibility that began to spread soon acquired a political significance – the
relaxing of union rigidities – and only subsequently did attention shift to its technical
aspect - firms must change their organization in order to respond rapidly to changing
markets. As for the quality of workers’ lives – an aspect obviously affected by the
flexibilization of working hours – this was seen by unions in only negative terms as a
possible worsening of work conditions, and not as a possible improvement in the
relationship between work and the rest of a person’s life.
That period was rather difficult for unions. Whilst companies discarded, albeit slowly,
the bureaucratic model of corporate organization, the unions found it difficult to
imagine a model of work other than the standard one: permanent employment for forty
hours a week, for eleven months a year, for the entire period stretching from completion
of school to retirement.
8
For their part, firms sought to monopolize the flexibilization of working hours, giving
overriding priority to their technical and commercial needs. This forced the unions on
the defensive as they sought to keep their control over labour, despite the fact that the
labour market was becoming enormously differentiated, especially as a result of entry
by women and highly-educated workers – two categories which demanded new forms
of employment. The stubborn resistance raised by the Italian unions against part-time
work for all the 70s and the 80s is indicative of how they failed to understand the
changes then in progress.
By the end of the 1990s, however, the attitude of the unions to flexibility had shifted
considerably and in recent years “bargaining flexibility” has become one of the main
issues in collective agreements and in labour market policies.
Firms’ flexibility: cost cutting, just-in-time, customer orientation
Until the mid-1980s, there were two main means available to the Italian firms which, in
order to adjust to changing markets, were obliged to make flexible use of their
workforces in terms of working hours: overtime and the temporary redundancy fund.
Requested by companies in periods of surplus demand, overtime – very well paid and
therefore welcomed by a large part of workers, especially males – became a practice
that the unions found increasingly difficult to control. By contrast, when production
declined because of crises (but also and increasingly to seasonal trends in output),
companies could rely on a typically Italian arrangement: the “cassa integrazione
guadagni” (temporary redundancy fund), which permitted large-scale temporary lay-
offs of workers, who received supplementary benefit. In this way contractual
(“theoretical”) working hours were still rigidly applied - so that the principle was
preserved - while the hours actually worked tended to differ substantially among
workers.
It should be pointed out, however, that already in the 1980s the use of another flexibility
measure – rotating shifts, often including night work – was more frequent in Italy than
in the rest of Europe.xiv
With time, this traditional model of flexibility in the Italian production system has
changed, mainly because of the restrictions imposed on the use of the wages integration
fund by the public finance, but also because of the proliferation and increasing
9
complexity of flexibility needs brought about by the changed workings of markets and
the fierce competition provoked by globalization.
What, therefore, are the factors that currently induce firms to pursue flexible working
time arrangements, and what have been the responses forthcoming from collective
bargaining?
There are three main organizational objectives, sometimes tied specifically to the
product/service, and sometimes coexistent in the same type of production: (a)
optimization of the use of plant in order to reduce costs; (b) extension of opening hours
to the public or of the service, as a customer-orientation strategy (for companies in the
private and public services sector); (c) the modularization of production in order to cope
with seasonal trends or as a strategy to respond rapidly to fluctuations in the demand for
certain products (just-in- time production).
Workers’ flexibility: new (and old) social needs for time
What sort of working hours do male and female workers want? Do they envisage an
‘ideal’ system? Surveys conducted mainly on female workers, but also analysis of
bargaining agendas,xv show that there are three main patterns in the needs expressed by
workers as regards the reconciliation of work time and care time: (a) more time
available for family life or other personal activities (the need to act on the “duration” of
working time); (b) more choice as to when to work, while performing the normal
amount of hours, so that work does not overlap with other commitments (the need to act
on the “distribution” of working hours in the daytime or in the week-time); (c) the right
to take time off in specific circumstances: maternity, small children, family members to
look after, in-service training, university examinations, etc.).
In all three cases, the requests of workers differ markedly by sex, age of children,
household income, training programmes, the place of work in individual strategies, etc.
This finding tells us two things: the first, that in the future the standard work schedule
(i.e. 8 hours a day for 5 days a week) will be little more than a benchmark; the second,
that it will be impossible to identify specific working hours for groups of workers (for
‘mothers’, ‘for young people’, and so on) because the possible combinations of work
and personal circumstances/choices have proliferated in contemporary society.
10
Actually, workers have very different requirements as regards working time, and their
needs alter as their circumstances or life-strategies change. Accordingly, the most
innovative aspect of the present phase of negotiation on working hours is that it is no
longer possible to assume that there is one working time that applies to all workers
indiscriminately. The ‘personalization of working hours’ – what the French call ‘temps
choisi’ – is therefore an objective of extraordinary interest for female and male workers.
However, the proposal might cause difficulties for the unions, which have traditionally
based their action on the devising of ‘collective’ solutions.
Working time, “free time”, time to care
The idea of working time used to be very clear, while that of ‘free time’ (or as
intellectuals of the left prefer ‘freed time’) was rather vague. It evoked some sort of no
man’s land that might be filled with pastimes (preferably popular ones like fishing),
with vocational re-training (although this preferably took place during working time and
was paid for by firms), or by social relations (in the generic sense), but which should be
principally devoted to rest. There is no doubt that as long as the amount of time that
workers could devote to rest appeared insufficient, social policies targeted on the
progressive reduction of working hours enjoyed their greatest success. But thereafter –
as testified by dozens of surveys, in Italy and other European countries, on the
preferences of workers between reduced working hours and pay risesxvi – the policy of a
generalized reduction of working hours went into critical decline, always subordinate to
the more impelling demand for increased remuneration.
However, a further change of scenario can be discerned. In last decades, growing in
parallel with increased labour-market participation by women, free time has assumed a
more precise connotation, being identified – to a large extent even if not totally – with
‘time to care’xvii or time devoted to family activities and relations, which includes care
for children, the elderly and the ill. Unlike free time, care time is more rigid and more
difficult to compress. And it may also be less easy to barter for pay increases.
This need for time has increased in parallel with the growth of female employment –
because the time that women traditionally devoted to taking care of their families must
in some way be replaced – but it concerns both female and male workers: in fact, the
11
progressive redistribution between women and men of ‘work for the market’ also makes
the redistribution of ‘work for the family’ necessary – as well as fair.
The social demand for care-time is first and foremost a demand for reduced working
hours. But it also expresses the desire of male and female workers for greater power to
decide ‘when’ to work: during the day, during the year, across the life-course. In this
sense it concerns a dimension of work that goes beyond the simple issue of working
time and which is bound to be of increasing importance for firm/worker relations in the
future: namely, the autonomy of work.
New workplace-level collective bargaining aimed to matching the needs of enterprises
and workers
As we saw, firms’ flexibility goals are often different from those of persons.
Harmonizing the two types of need is desirable but by no means easy.
Analysis of company-level bargaining in Italy over the last ten years has shown that – at
least to date – the most frequent reasons for the destandardization of working hours
have concerned the technical-productive requirements of firms. As a consequence they
have not always, and not necessarily, been to the advantage of workers. Indeed, in the
case of increased shifts, weekend work, and the greater use of overtime work, it may be
that the working conditions of the latter have worsened.
However, in some cases the changes in working hours desired by firms for their own
ends have had the ‘indirect’ outcome of being advantageous to workers, especially
when their introduction has been negotiated by the trade union in exchange for specific
concessions in terms of time for the workers (and no longer in terms of monetary
benefits, like increased overtime rates, shift allowances, etc.). As we have seen, the
most typical exchange in such cases of ‘bargained flexibility’ has been between the
introduction of new shifts and the reduction of weekly working hours (to 32 hours in
cases where work has been extended to Sundays). Also of great interest is the negotiated
exchange of flexible annual hours for increases in weekly working time according to the
production tempo decided by the firm – under which arrangement workers may
themselves decide when to recoup the hours (the well-known system of the ‘hours
bank’).
12
However, certain innovations in working hours have been ‘invented’ for the express
purpose of improving the quality of work life, making it easier for employees to
reconcile their jobs with family commitments. For the moment there is only a limited
number of such cases – a few but valuable ones – but they appear to be increasing, for
two distinct reasons. Firstly, the unions are growing more sensitive to the issue of
reconciling work and the family (whereas until only a short while ago union bargaining
was concerned solely with job protection and wages). Secondly, firms are paying closer
attention to the social dimension and to the life-conditions of their employees, given
that this is also a means to obtain greater commitment to work and closer identification
with the company.
These experiences are discussed in the next section.
4. Reconciling work and families. Best practices of bargained
“positive” flexibility
Electrolux-Zanussi: ‘Rosa al lavoro’
The groups has several plants manufacturing domestic appliances in Italy. One of them
is the Susegana factory, where this experiment was launched.
‘Rosa al lavoro’ is perhaps the first case in Italy of an agreement intended to help
women workers reconcile their work time and ‘care time’. The case is well known and
has been widely discussed, not least because – although the solution found by the
company was technically unobjectionable – the company’s female employees initially
showed little interest in the innovation, or indeed were hostile to it.
The flexibility scheme was introduced in a department where employees worked an
average of 38.30 hours a week on three 6-hour shifts for 6 days a week. Before the
agreement, rotation through the three shifts was compulsory: so that a worker spent one
week on the first shift (from 5:45 to 12:00), one week on the second (from 12:00 to
18:15), and one week on the third (from 18:15 to 1:00).
The recent agreement offers two possible arrangements:
(a) ‘fixed shifts’. The worker may choose a shift and work only that shift henceforth
(always in the morning or in the afternoon or in the evening). Shifts can be exchanged
13
for one day, one week or one year, but only provided that there are two other persons
willing to forgo the changeover.
(b) ‘rearranging the shift duration’. Apart from total weekly working hours (which
cannot vary), women workers may agree among themselves to adjust their shifts. For
example, one of them may work one hour less per day, while two of her colleagues on
the other two shifts work for an extra half hour. A worker may work less for a day, a
week or a year as long as there are other female workers willing to make up the hours
not covered.
These hours schemes have been negotiated with the trade-unions and the concrete
implementation of the project has been assigned to a joint management-union
committee.
It should be noted that, although very liberal, these innovations were not initially
greeted with any great enthusiasm by female workers, who commented ‘Besides doing
the work now we’ve got to organize it as well!”. Only subsequently did the agreement
begin to work, but its implementation has shown that, although the self-management of
working hours is still an important objective, it causes difficulties for workers: new
organizational duties, the assuming of responsibility, and the mediating of disputes not
only between firm and workforce but also among workers with different needs.
The Zanussi agreement has introduced the principle that a worker is entitled to decide
on his/her own both the duration and scheduling of his/her work, albeit amid certain
constraints. The main constraint is the need for internal agreement among the members
of the work team. It is this issue that has created most difficulties among workers,
although it also highlights the feasibility of a particular form of worker participation: the
self-managed work unit.
From the point of view of reconciling work with family commitments, arrangements
which give workers greater freedom to schedule their working hours are more
significant, and they mark an important innovation – one, for that matter, central to
debate on working hours in numerous countries. The social objective of giving workers
greater leeway in deciding their working hours is no longer restricted solely to ‘how
many hours’ to work – a possibility often granted to women in the form of part-time
employment – it also comprises the possibility of rearranging (in qualitative as well as
quantitative terms) all their various ‘times’ in order to attenuate conflicts among them.
14
Work time is no longer the independent variable around which a person’s organization
of his/her time rotates; rather, it is only one of the variables in play.
Banca Commerciale Italiana: ‘Long part time and emergency part time’
The BCI is an important banking group with branches in every part of the country. In
June 1995, the trade union signed an agreement on part-time work which has served as
a model for numerous other agreements in the banking sector.
It should be pointed out that, until the mid-1990s, part-time employment was relatively
rare in Italy (still today the country records one of the lowest percentages in Europe). In
the banking sector too, despite its high level of femalization, part-time employment was
only possible for a limited number of workers until a few years ago. It was only
available for standard working hours (4 or 6 hours a day) and was not permitted for
middle and senior managers.
The new company agreement has introduced substantial innovations and highly
articulated forms of part-time work: ‘horizontal’ (some hours a week) and ‘vertical’
(some days a week). It is also possible to obtain part-time jobs of differing durations,
and which are therefore as personalized as possible: from a minimum of 15 hours a
week to maximum of 32.5.
The agreement has the merit of addressing a number of issues of major concern to
people who choose part time. The first is that working a reduced number of hours may
overly compromising a person’s income. Numerous studies have shown, in fact, that the
majority of female workers with family problems who opt for part time would prefer the
so-called ‘long part time’ arrangement of between 30 and 40 hours a week. The
standard system of half-time, in fact, significantly reduces a worker’s earnings. It is now
possible to work 32.5 hours a week at Banca Commerciale – thereby solving problems
to do with childcare, for instance being at home during the afternoons – while still
earning 86% of one’s salary.
The second issue is that of obtaining an immediate and substantial reduction in working
hours in order to deal with an unexpected personal or family problem (for example, the
illness of a family member). The 15-hours-a-week solution – dubbed ‘emergency part
time’ – meets this need very well, for, at very short notice, it allows employees to work
only five hours a day for three days a week if necessary. The arrangement is
15
automatically reversible (after six months) unless the employee asks for an extension (in
other cases of part-time, by contrast, the law states that the return to full time is not
automatically guaranteed but is subordinate to the company’s requirements).
This new system has been a great success: more than one thousand employees have
opted for these forms of employment in the first year of its implementation. Moreover,
the proportion of male employees who have asked to switch to part-time is substantially
above the national average (17%).
Tim: ‘Tim Mamma’
Tim is one of the largest mobile telephony companies in Italy and has around 10
thousand employees. Since its creation only a few years ago, the company has applied
all possible forms of flexibility in its use of workers: shifts, part time, telework,
temporary agency work, etc.
The declared aim of the company’s management is to deliver customer services around
the clock, but also to have a satisfied workforce, because – as the head of human
resources put it – “If you’re going to be good on the phone, you’ve got to be satisfied
with your job”.
Tim has a very young workforce (the average age is 31), and the proportion of parents
with small children is particularly high. For this reason, among various projects of a
social nature – for handicapped employees, worker-students, ex-prisoner cooperatives,
women aged over 40 wanting to return to work – the company has set up a project for
working mothers known as ‘Tim-Mamma’.
This project, negotiated with the unions in 1997, divides into two levels. The first
provides on-line updates (or in the form of a periodic newsletter) for women workers on
maternity leave. The aim is to keep them constantly abreast of events in the company –
changes in organization charts, introduction of new computer programs, contract
renewals, etc. – so that even while they are absent they feel involved in the corporate
climate.
The second level consists of working-hours facilitations for parents with children under
the age of 8. It should be pointed out that, at the time of the agreement, Italy did not yet
have a law on parental leave, only one on maternity (later extended to fathers) which
allowed time to be taken off work to care for children only in the case of illness, and
16
only until the child was three years old. The Tim agreement is therefore a major step
forward, and it has in some way served as a stimulus for approval of the recent law on
parental leave (law no. 53/2000).
The agreement introduces a package of 14 hours a month (around 150 hours a year) –
unpaid (but which can be recouped in the form of overtime) – for employees so that
they can deal with urgent or less urgent problems concerning their children’s welfare.
Certificates do not have to be produced to justify leave for this purpose, and permission
can be granted even at very short notice. The ‘hours credit’ can be used for even
minimal periods of time (a half hour). The ‘hours debt’ must be redeemed within three
months. Time ‘transactions’ are recorded on a sort of personal current account
possessed all the workers covered by the agreement.
The system does not give rise to direct costs for the company apart from the minor
problem of organizing substitutions, and it considerably enhances the life-quality of the
workers. As a female worker said, “You’re more relaxed in your work: every so often I
can go and pick up my son from school, and that makes a big difference”.
This agreement too – like the one at Zanussi – has introduced the innovative principle
that individual workers themselves may organize their work time, whereas working
hours were previously the same for all workers and were regulated externally by means
of the law or the work contract, which imposed their uniform application.
Whirlpool Italia: ‘Evening part time’
The company manufactures domestic appliances and has several plants in Italy, with a
total workforce of around 3500 employees.
This casexviii is interesting because, unlike the previous ones, it concerns, not a working
hours arrangement introduced for the benefit of workers but rather (as more frequently
happens) a form of flexibility to meet specific technical-productive needs of the
company. Nevertheless, the agreement was welcomed by the workers and is now
considered to be a good example of flexible working hours harmonized with the needs
of employees.
It should be pointed out that Whirlpool is a company that is unconventional in its work
organization, and it has introduced a variety of atypical forms in its plants: weekend
contracts, fixed-term contracts, highly diversified shift schedules, niche working hours,
17
multi-period time schedules, etc. But it is also a company that has traditionally taken
pains to provide decent working conditions and a positive corporate climate for its
employees, and it has always been sensitive to the social issue of reconciling work and
family life.
Every plant has a joint company-union committee – consisting of the foremen and the
union representatives – which manages the “new working hours schedules”, seeking to
ensure that they work efficiently and to find an appropriate match between individual
needs and production requirements.
The working time schedules presented here concern two forms of part-time evening
work. The first is applied at the company’s plant in Cassinetta and consists of 20 hours
per week organized into 4 hours a day for 5 days a week worked from 20:00 to 24:00.
The second, applied in the Siena factory, consists of 30 hours per week organized into 6
hours a day for five days, from 17:00 to 23:00.
Under both schemes, employees work on fixed shifts at non-standard times of the day
(what used to be called ‘antisocial hours’). By this means, the company has achieved its
objective of raising production without increasing the number of shifts (which would
have generated extra costs due to the wage increments paid to shift-workers).
A survey of the company’s employees, however, has shown that the majority of them
like – or at least do not dislike – these atypical working hours (atypical in terms of both
duration and, especially, scheduling). Evening work is particularly suited to university
students (who can attend lectures during the day), to female workers with small children
(who alternate with their husbands), workers caring for elderly and sick family
members, and workers with other jobs (in small-scale retailing). Those who find late-
evening work most burdensome are the parents of school-age children (because they
almost never see them), or persons for whom affective relations are important (because
it usually in the evening that people go out with friends or fiancés).
These atypical working hours are assigned to newly-hired employees, because they are
willing to accept any schedule in order to obtain a job. Some of them, however, even
when they could have switched to the normal schedule of eight hours on alternating
shifts, have preferred to continue working in the evenings, because they regard this
arrangement as a better fit – in terms of number of hours as well as scheduling – with
the organization of their lives.
18
Commentary
The four experiments just described are among the best known and most closely studied
in Italy, and it is to be hoped that they will not remain isolated cases. Some of these new
types of time schedule have been in operation for a number of years, and it is probable
that in their quality as ‘good examples’ they are spreading to other workplaces as well.
However, they remain emblematic and highlight a number of features.
From the point of view of the organisation of work, the experiments discussed
emphasise that the time needs of workers can be satisfied at even zero cost to
companies: as with many innovations, the only cost consists in the effort required to
devise and introduce them. And they also show that certain categories of workers are
even willing to accept unsocial working hours, if these enable them to reconcile certain
personal and family needs with work more satisfactorily than was the case with
traditional working time schedules.
From the point of view of the labour relations, they confirm that company-level
bargaining is the best arena in which to achieve positive results in the flexibilization of
working hours. It is at this level that better account can be taken of the firm’s specific
‘compatibilities’ and also of the differing needs of the workforce: not all solutions are
applicable, or necessary, everywhere.
They also show the existence within firms of broad spaces for participation by the
unions in the definition of work organization and the fact that sometimes firms are
indeed happy to share decisions on working hours with the unions. And they also show
that firms view workings hours as an issue on which it is crucial to obtain the
involvement and consent of the workers concerned.
5. A challenge for the unions. Combining differentiation and
participation
The end of standard working hours
In recent years, working hours – to even a greater extent than wages – have become one
of the major components in the redefinition of work. There are by now significant
differences – in income, life quality, the importance of work – between full-time
19
workers and part-time workers, between daytime-workers and shift-workers, between
workers who do overtime and workers who do not, between workers on fixed schedules
and those able, at least to some extent, to decide their own working hours.
The most interesting aspect is undoubtedly the fact that many jobs no longer require the
physical presence of the worker – as evidenced by the increasingly intense debate on
telework – and this, albeit gradually, is occasioning a shift from ‘time-based’
managerial systems of work assessment to ones based on ‘results’.
On the other hand, an increasing number of occupations, especially in services, require
the work to be performed at non-traditional times of the day, even at ones which used to
be called ‘antisocial’, like evenings, nights or weekends.
These changes are coming about when increasing labour-market participation by
women, and also the slow but steady redistribution of family tasks within the couple,
induce many people – both men and women – to advance specific demands as regards
both the duration and scheduling of their work time, so that they can better reconcile
their work and family responsibilities.
All this is exerting increasing influence on the organization of working hours in
companies, both manufacturing and tertiary, both private and public. These changes,
moreover, have revived the unions’ interest in the issue of working hours from a
standpoint different from the more traditional one of their generalized reduction.
The next few years will probably see the end of the standardized work schedule. The
rigid timetable envisaged by the traditional model – what we may call the ‘Fordist-
union-male’ one – no longer suits the requirements of firms; neither, it seems, is it in the
best interests of the workers. This radical change may cause some problems for the
unions by hampering their representational action (as is also happening with the spread
of other forms of atypical work), but it will enhance company-level bargaining and its
ability to provide individualized responses to workers’ needs.
The across-the-board reduction of working hours is still the goal of trade-union action,
but it should not be set in antithesis to the flexibilization and destandardization
demanded by firms and workers. And for the trade unions in any case, accepting and
promoting the ‘positive’ flexibility of working hours – flexibility, that is, which enables
the balancing of family and work responsibilities – is by no means at odds with their
20
objective of employment growth. Indeed, it is the best means available to encourage
women to enter the world of work.
Participation in the definition of working hours
The general scenario and specific experiences described in previous sections raise major
problems for trade-union action and for workforce participation.
The management of working time is increasingly at the crux of important questions for
both the economy of firms and the quality of life of workers. These are questions in
which the unions must necessarily be involved if they are to avert the risk of a
polarization between stronger workers able individually to bargain an advantageous
flexibility of their working hours and weaker ones forced to accept any arrangement
whatever.
In recent years in Italy, changes in working hours seem to have come about mainly on
the initiative of firms, which have asked workers to accept schedules increasingly more
onerous and/or less predictable than traditional ones but have sometimes also been able
to grant better opportunities to reconcile work and non-work commitments through part-
time, leave, elastic hours and other forms of ‘positive’ flexibility in working hours. The
unions for their part – after some uncertainty and an initial propensity to obstruct
flexibilization – now pursue the more pragmatic option of company-level bargaining
over flexible and differentiated working hours.
One important reason for this courageous strategy by the unions, apart from their
willingness to contribute to firms’ economic results and competitiveness in the world
market, is their decision to represent the emerging aim of employees (particularly of
women, whose participation in the labour market is increasing rapidly) of finding a
better harmonisation in their working and personal life. In this way, for the first time in
many years, the Italian unions have endeavoured to cater more closely to the everyday
needs – personal and diversified – of workers.
The participative forms in which this strategy has been pursued are located as close as
possible to the needs of firms and workers. In fact, while the general rules on working
hours are established at European, national and industry level, it is within the individual
firm that the specific conditions for their application can be defined.
21
Participation to decision-making on working hours therefore takes place through a mix
of workplace-level agreements – which are widespread in Italy and aimed at defining
specific working hours systems for each company and plant – and through many union-
management co-operation forms provided by industry-level collective bargaining
(information and consultation practices, permanent consultative bodies, had-hoc
technical committees, etc.). Particularly, the presence of union representatives in the
joint company-union bodies for consultation on working hours (together with equal
opportunities for women workers committees) has been introduced in some larger
companies and enable the unions to take part in decisions relative to the organisation of
work, the devising of work schedules, the improvement of the opportunities for women.
These two forms – collective bargaining and participative management – are not
mutually exclusive.
Moreover, as was seen in the case of Zanussi (one of the most advanced companies in
this respect) the issue of working hours has also prompted experimentation with
innovative forms of direct participation by workers, through the self-management of
working time by production teams.
Notes
i G.Bosch (1999) ii Except in the public sector, where employees generally work a 36-hours week. iii As argued by G. Olini (1994). A similar phenomenon occurred in the United Kingdom during the same
period (J. Rubery 1999). iv The Cgil changed its position after the Congress of 1989, when it set the introduction of a 35-hour
working week within the next 15 years as one of its objectives (with which the PCI was also in favour). v G. Olini, Cesos (1999). vi These conclusions were reached by the Cesos (1994) survey on solidarity agreements. vii S.Lehndorff (1998) viii See e.g. as regards the United Kingdom, J. Rubery (1999). ix D. Taddei (1989) points out that “a reduction in working time cannot be generalized and
undifferentiated; rather, it should be tied to the reorganization of production. It this way the saving
deriving to the firm from better use of its capital can be exchanged for greater wage stability”. x See the comparison between Italy and Germany using Eurostat data in Cnel (1993). xi On more recent bargaining, from 1990 to 1995, see the database on working-time bargaining in Piazza
et al. (1997). xii C. Sanne (1998) e S. Lehdorff (1998). xiii That company-level negotiation is the most appropriate has also emerged from the debate on the
application of reduced working time in other countries: see e.g. on France J. Y. Boulin (1999) and J.
Freysset (1998). xiv Cnel (1993) xv ibidem xvi See, among others, S. Lehndorff (1998) xvii L. Balbo (1987) xviii Fondazione Seveso-Gender (1998) ‘Il caso Whirlpool’.
22
References
A. Accornero, Di Nicola P. “La flessibilità degli orari di lavoro”, in G. Galli (ed.) La mobilità nella
società italiana, Edizioni Confindustria, Roma, 1996.
L. Balbo, Time to care. Politiche del tempo e diritti quotidiani, Angeli, Milano, 1987.
F.Bettio, P. Villa, Changing patterns of work and working time for men e women. Italy., Manchester
School of Management Ed., Manchester, 1997.
L. Bordogna, “La contrattazione decentrata nell’industria”, in Cesos (Eds.), Le Relazioni Sindacali
in Italia. Rapporto 1996-97, Roma, 1998
J.Y. Boulin, G. Cette, “Temps de travail et emploi en France: entre production reglementaire et
innovations dans l’entreprise”, communication à la Conference Working Time in Europe, Helsinki,
October 10-11th,, 1999.
G. Bosch, Working Time: Trends and New Issues, in Revue Internationale du Travail, vol.138, n.2,
Geneva, 1999.
Cesos Ed., L’esperienza dei contratti di solidarietà: costi e benefici sul piano economico,
occupazionale, organizzativo., Roma 1994
A.M.Chiesi,,“Le trasfromazioni dei contenuti del lavoro”, in A.M.Chiesi, I.Regalia, M.Regini,
Lavoro e Relazioni indsutriali in Europa, NIS, 1995.
CNEL, “Tempo di lavoro e flessibilità dell’orario”, in Documenti Cnel, n.29, Roma 1993.
W. de Lange, “Working Organisation and Working Time”, Paper presented at the Conference
Working Time in Europe, Helsinki, October 10-11th, 1999
G. Esping Andersen, The Three Worlds of Welfare Capitalism, Oxford Polity Press, 1990.
Fondazione Regionale Pietro Seveso, Il caso Whirlpool. Mimeo, Milano, 1998.
J. Freyssinet, “France: a recurrent aim, repeated near-failures and a new law”, in Transfer, vol.4, n.4,
1998.
A. Gauvin, R.Silveira, “La flexibilitè du temps de travail au féminin”, in G.Bosch, D.Meulders, F.
Michon (eds.), Working Time: new issues, new norms, new measures, Edition du Dulbea, 1999.
S. Lehndorff, “From collective to individual reduction in working time? Trends and experience with
working time in the European Union”, in Transfer, vol.4, n.4, 1999.
G. Olini , “Anni ottanta, lavorando meno solo sulla carta”, in Politica ed Economia, n.1, 1994.
G. Olini, La questione delle 35 ore: tra politica e dibattito culturale, in Cesos (ed) Le relazioni
sindacali in Italia. Rapporto 1997-98, Roma, 1999.
M.Piazza, A.M.Ponzellini, E.Provenzano, A.Tempia, Riprogettare il tempo. Manuale per la
progettazione degli orari di lavoro, Edizioni Lavoro, Roma, 1998.
A.M. Ponzellini, “Riduzione degli orari e sistemi di solidarietà nelle crisi aziendali. L’esperienza
italiana”, Paper presentato alla Conferenza Orario di lavoro ed organizzazione sociale del tempo in
Europa, Milano 17 settembre, 1996.
23
A.M. Ponzellini, “Tempo di lavoro: dalle donne una soluzione per tutti”, in Il Progetto, n.17,
sett./ott.1997.
C. Sanne, “The working hours issue in Sweden”, in Transfer, vol.4, n.4, 19987.
A.Tempia, Ricomporre i tempi, Ediesse, Roma 1993.
D. Taddei, “Conseguenze economiche e sociali del tempo di lavoro nella comunità”, mimeo, 1989,
citato da Olini, L’orario di lavoro, in Cesos (eds), Le Relazioni sindacali in Italia. Rapporto 1989-90,
Roma 1991.
J.Rubery “Working time in the UK”, in Transfer, vol.4, n.4, 1998.