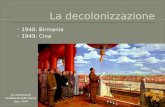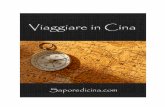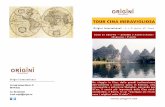2003-11-05 Cina
Transcript of 2003-11-05 Cina

LA REPUBBLICA 37MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 2003
(segue dalla prima pagina)
Pechino
Anche ai nostri giorni, comenel millennio scorso, assi-stiamo all’entusiasmo di chi
scopre la Cina, ne esalta gli straordi-nari progressi e vi vede un immen-so, appetitoso mercato; e al con-tempo assistia-mo alla paura dichi la vorrebbeinvece isolare,perché slealeconcorrente deinostri prodotti eimminente po-tenza mondialedi cui diffidare.E’ rituale lo spet-tacolo dell’im-prenditore occi-dentale che, sul-le sponde del fiu-me Huangpu,davanti ai gratta-cieli di Pudong, aShanghai, o al-l’ombra del ri-tratto di Mao Ze-dong appeso allaporta della Tia-nanmen, a Pe-chino, si abban-dona a un incon-dizionato elogiodel miracolo ci-nese. Ed è altret-tanto rituale ladenuncia asso-luta, senza ap-pello, delle vio-lazioni dei dirittidell’uomo e del-le disuguaglian-ze economiche,in particolare tracittà e campa-gne. Disparitàattribuite al con-nubio tra il ca-rattere totalita-rio del comuni-smo ufficiale e illiberismo delrampante capi-talismo reale.L’equazione èinsolita: è il pri-mo, il comuni-smo politico, apromuovere ilnuovo corsoeconomico, a favorire l’esatto op-posto della sua ideologia originaria.
Per illustrare l’atteggiamento oc-cidentale verso la Cina, un rispetta-bile sinologo, Jonathan D. Spence,cita come esemplare il colloquio traKublai Khan e Marco Polo immagi-nato da Italo Calvino in “Le Città In-visibili”. Dopo avere ascoltato lestraordinarie descrizioni del viag-giatore veneziano, il capo mongolodiventato imperatore cinese glichiede se una volta ritornato in pa-tria ripeterà alla sua gente i raccon-ti di quel che ha visto. Marco Polonon risponde direttamente alla do-manda. Dice che serve a poco parla-re, perché tanto chi ascolta recepi-sce soltanto le parole che si aspetta.Chi comanda è l’orecchio, non lavoce. Questo vale spesso anche perla Cina d’oggi. Ognuno vi legge quelche vuole.
La Cina può apparire, in verità,enigmatica, e, al tempo stesso, mol-to più a portata di mano, più deci-frabile, di quando Marco Bellocchiola definiva tale nel titolo di un suofilm, rimasto emblematico dell’e-poca maoista: “La Cina è vicina”.Oggi è senz’altro più vicina di quan-to sia mai stata, ma non per questoci risparmia le sorprese. Ci lasciaperplessi o affascinati. Spesso in bi-lico tra questi due stati d’animo. Lametamorfosi del regime è senzaprecedenti. E’ una trasformazioneda collocare anzitutto nel tempoper capirne l’eccezionalità. Essa sisvolge con successo, ed è tutt’ altroche finita. Il galoppo trionfale conti-nua, travolgendo i pronostici nega-tivi di legioni di esperti, più di diecianni dopo il crollo del comunismonell’Unione Sovietica e nell’Europaorientale. Prosegue senza frenare lo
slancio un quarto di secolo dopo lostorico terzo plenum dell’undicesi-mo Comitato Centrale, che dette ilvia al nuovo corso. Il plenum che, al-la fine del 1978, sotto l’impulso diDeng Xiaoping, riconobbe di fatto ilfallimento del sistema economicomaoista (il Grande Timoniere eramorto da appena due anni) e la ne-cessità di lasciare un certo marginedi iniziativa al libero mercato, attra-verso riforme economiche rivelate-si di un’audacia mai vista in un pae-se che si dichiara ancora con solen-nità marxista-leninista.
La Cina resta infatti una Repub-blica popolare in cui le redini del po-tere sono nelle mani di un partitocomunista che si identifica ufficial-mente in una ideologia e funzionaattraverso strutture in larga parteereditate da Lenin e da Stalin. Il Pae-se si modernizza a una velocità chemozza il fiato, sviluppa sempre dipiù l’economia di mercato, importacapitali e metodi di gestione occi-dentali, cambia i paesaggi urbaniispirandosi ai modelli americani, e aquesti stessi modelli adegua nontrascurabili aspetti della vita quoti-diana, ma conserva un sistema po-litico che figura già nella storia comeun fallimento. Si definiscono anco-ra comunisti paesi come la Coreadel Nord, il Viet Nam e Cuba. Ma,pur essendo assai diversi tra di loro,non mi sembra che essi abbiano, inquanto tali, un futuro radioso. La si-
tuazione del Viet Nam non è certoparagonabile a quella disperata, an-gosciosa, della Corea del Nord. Nul-la è tuttavia comparabile alla cresci-ta economica cinese, cominciatanegli anni Ottanta; e al conseguentemiglioramento del livello di vita del-la popolazione, nonostante lo scar-to sempre più ampio tra città e cam-pagna. Uno scarto, in favore dellecittà, che sottolinea il rovesciamen-
to provocato dal nuovo corso ri-spetto al maoismo originale, cheenfatizzava il ruolo della campagna.
Oggi è come se ci fossero due Ci-ne: quella urbana in piena espan-sione e quella contadina alle sueporte, nell’attesa di usufruire ungiorno dei vantaggi che le sono ne-gati. Molte restrizioni che impedi-vano la mobilità sono state formal-mente abolite. Adesso milioni di
persone si spostano da una provin-cia all’altra. Ma gli ostacoli indirettiche impediscono o frenano l’inur-bamento della popolazione rurale(in cui si valuta a trecento milioni ilnumero dei disoccupati) sono tut-tora numerosi: ad esempio la man-canza di abitazioni, l’esclusione daogni forma di assistenza, l’alto costoper ottenere i permessi di lavoro e diresidenza (“huku”), l’impossibilitàdi ottenere crediti ....In un regimenato da una rivoluzione che avevacome obiettivo l’uguaglianza, le di-suguaglianze sono profonde. Vi so-no uomini e donne ammessi conpieni diritti nella città; ve ne sono al-tri che vi vivono in modo precario,senza diritti, a titolo provvisorio; edaltri ancora, la stragrande maggio-ranza, che sono tenuti ai margini.Esclusi. La riserva di mano d’operaè immensa. Quel che un giorno po-trebbe essere il detonatore di una ri-volta sociale, tra città e campagne,oggi rappresenta un incalcolabilevantaggio per i meccanismi produt-tivi. Non c’è mercato del lavoro piùflessibile di quello cinese. Ma va an-che ricordato che nell’ultimo quar-to di secolo, da quando il comuni-smo cinese, pur restando “lenini-sta”, ha imboccato la strada di unsuo specifico capitalismo, circaquattrocento milioni di cinesi sonostati strappati alla povertà o alla mi-seria. Poco meno di uno su tre.
Il ritratto di Mao Zedong domina
sempre la piazza della Pace Celeste,la Tienanmen, dove sorge anche ilmausoleo in cui si trova il suo corpoimbalsamato, ma il pensiero emer-gente, anzi che riemerge, è un altro.E’ quello che si ispira a Confucio: ilfilosofo della tradizione, della sag-gezza e dell’obbedienza, che Mao,cercando di dominare la storia,
strappò dallaprofondità deisecoli per avereun rivale degnodella propriagrandezza. Un ri-v a l e - s i m b o l odell’antica Cinada abbattere.Mao è sempre su-gli altari ma atrionfare è l’es-senza delle risor-te idee di Confu-cio. Del qualenon ci sono im-magini sulle mu-ra della Cittàproibita.
I riti e il lin-guaggio del par-tito comunistarestano, immu-tabili, come sefossero un anco-raggio. Fannopensare a quelloche era un tempoil latino nellaChiesa cattolica.Non si tratta sol-tanto di una fe-deltà alle origini.Se quei riti ces-sassero forsecrollerebbe i lpartito stesso. Laloro sopravvi-venza non impe-disce di praticareuna politica, so-prattutto econo-mica, che va nelladirezione oppo-sta. Più che unacontraddizionepuò apparire unaprova di saggez-za. L’Unione So-vietica è naufra-gata perché tentòuna riforma poli-tica che spezzò lasua spina dorsa-
le, il partito. Fu un suicidio. La Cinariforma invece l’economia ma nontocca il partito. Il cui potere tuttaviacambia sotto la pressione dell’eco-nomia. La sua influenza sulla so-cietà non è infatti più quella di untempo. Non interviene più, non èpiù omnipresente, nella vita quoti-diana degli individui. I quali non so-no più ossessionati dai suoi control-li. Possono ignorarlo, e concentrar-si sui propri affari, e trovare deimezzi di sussistenza fuori dai cir-cuiti ufficiali. Questo non significache possono ignorare del tutto loStato-Partito, poiché la burocraziaresta onnipresente e senza una pro-tezione o una mancia è difficile ot-tenere i permessi indispensabili.Ma in generale si può sfuggire allavita politica. Benché il sistema giu-diziario si sia sviluppato e moder-nizzato, non esiste nessuna istitu-zione giuridica che possa avere unruolo di freno, o di contrappeso, alpotere dello Stato-Partito.
Questa Cina studia e imita l’Occi-dente ma non rinuncia mai al suosconfinato orgoglio. Evoca ritual-mente il suo passato, che è la storiadella nazione più antica, e si vede,con ragione, come uno dei massimiprotagonisti del XXI secolo. Aldilàdei condizionamenti della nostralogica, possiamo scoprire anche noiun chiaro filo conduttore, una coe-renza, in quelli che a noi sembranoenigmi e paradossi. Non è forse ilpartito una dinastia che sceglie ecambia strategia, nell’interesse del-l’impero? E lo fa senza rinnegare leproprie origini: che sono quelle diuna rivolizione anzitutto naziona-le. I riti? Quelli imperiali, nella Cittàproibita non cambiavano mai, omolto di rado.
DIARIOdi
UN PAESE VITALE E CONTRADDITTORIO MINACCIA L’OCCIDENTE?
La sfida che ci fa pauraBERNARDO VALLI
FRANÇOIS JULLIEN
Mao è sempre suglialtari, ma a trionfaresono le risorteidee di Confucio
Come è possibile cheun paese comunista dia
vita a una forma dicapitalismo sfrenato?
CINA
Scegliere - o accettare - la battaglia: questo il significato dei duecaratteri cinesi oggi usati insieme per intendere “sfida”. A sinistra,
abbiamo il radicale di mano, nel secondo abbiamo il segno dilancia. Sono segni “fonetici” ma sempre rappresentativi dellarealtà perché la scrittura cinese è essenzialmente figurativa.
“ACCETTARE LA BATTAGLIA”
CINA
IN OCCIDENTE l’efficacia è qualcosa che sirealizza direttamente. Nel nostro mondo il problema èsempre quello di trovare i mezzi che portano diretta-mente e nel più breve tempo possibile allo scopo cer-cato. L’efficacia cinese viceversa è indiretta. Il suo ef-fetto si ricava dalla situazione, cioè dal corso stesso del-le cose. Si tratta di una prospettiva culturale radical-mente diversa. Quando le nostre aziende esigono daipropri manager di essere efficienti, in sostanza gli stan-no chiedendo di essere visibili e di raggiungere rapida-mente i risultati prefissi. Non è casuale che noi colle-ghiamo l’idea di efficacia a quella di spettacolo teatrale.E ciò vale indiscutibilmente anche sul piano politico. LaCina ci dice invece che la vera efficacia è un’azione chesi mimetizza talmente bene con il corso delle cose danon potersi percepire.
“
“
CINA.

38 LA REPUBBLICA MERCOLEDI 5 NOVEMBRE 2003
I LIBRI
LE TAPPE
PRINCIPALI
LA LUNGA MARCIA
Nell’ottobre del 1934 circa centomilacomunisti accerchiati nel Sud del paese dainazionalisti si muovono alla volta delloShanxi. Il “lungo viaggio” dura un anno e incorona Mao leader del Pc cinese
L’OFFENSIVA DI PECHINOANGOSCIA GLI AMERICANI
LA PAURA VISTA DA OCCIDENTE/ UN COLOSSO ECONOMICO CHE TURBA IL MONDO
FEDERICO RAMPINI
‘‘
,,
La macchinadell’industria cinesemacina risultatiimpressionanti. Aquando il sorpasso?
San Francisco
La scelta del simbolo è stataperfetta: mandare il primocinese in orbita — e annun-
ciare che la prossima tappa saràla luna — proprio mentre lo spa-ce shuttle americano è inchioda-to a terra per il tragico incidentedell’ultima navetta. Negli StatiUniti è riaffiorata la memoria diun altro shock, il sorpasso sovie-tico nella corsa allo spazio, con loSputnik e poi con il primo astro-nauta in orbita 42 anni fa, YuriGagarin. Il messaggio non pote-va essere più chiaro: il ruolo cheun tempo fu di Mosca — la gran-de rivale egemonica — oggi sicandida a occuparlo Pechino. Lasua prodezza tecnologica nondeve stupire: l’Ocse rivela che laCina ha superato perfino la Ger-mania negli investimenti in ri-cerca scientifica (60 miliardi didollari l’anno scorso).
Di colpo torna d’attualità la vi-sione che George Bush rivelò sul-la Cina tre anni fa, appena si can-didò alla Casa Bianca. In campa-gna elettorale, rompendo conuna tradizione diplomaticatrentennale (stabilita anche dalpadre, che era stato ambasciato-re a Pechino) Bush si impegnò a«fare qualunque cosa per aiutareTaiwan a difendere la propria in-dipendenza», ivi compresa dun-que la guerra nucleare controuna nazione di 1,3 miliardi diabitanti. Per giustificare uno sce-nario così estremo Bush adottòla visione dei falchi neoconser-vatori, definendo la Cina il “nextchallenger”, il prossimo sfidantedella superpotenza Usa; quindil’unico paese al mondo la cuiascesa può rimettere in discus-sione l’assetto unipolare. Nell’a-prile 2001, con la tensione diplo-matica alle stelle per l’incidentedell’aereo spia americano cattu-rato dai cinesi, la profezia sem-brò avverarsi in tempi rapidi. Loscenario di una nuova guerrafredda dislocata nell’area del Pa-cifico era alimentato dal riarmocinese (+18% di spese militari inun anno) e dalle proiezioni del-l’intelligence di Pechino, secon-do cui entro 16 anni la Cina po-trebbe raggiungere metà del po-tenziale militare degli Stati Uniti(un traguardo straordinario, te-nuto conto che oggi la forza bel-lica Usa supera quella dei suc-cessivi undici paesi messi assie-me). L’11 settembre cambiò ilclima: Washington si concentròsulla guerra al terrorismo, Pechi-no offrì abilmente la sua collabo-razione, fu subito disgelo.
Adesso la minaccia cinese tor-na a dominare l’orizzonte degliStati Uniti. Ma si è trasferita su unaltro terreno: l’economia, i rap-porti di forza industriali, gli effet-ti profondi della concorrenza ci-nese sul tessuto della societàamericana. L’Europa è il passa-to, l’America è il presente, la Ci-na è il futuro, ha sentenziato il Fi-nancial Times: una sintesi delpresentimento che turba gli Sta-ti Uniti. Con una crescita del Pilche da molti anni viaggia a ritmidell’8%, il colosso asiatico è di-ventato la nuova locomotiva del-l’economia mondiale. Il peso del“made in China” sul commerciomondiale (5,3%) distanzia vec-chie nazioni industrializzate co-me Inghilterra e Italia; entroquesto decennio può raggiunge-re il Giappone.
L’emergenza-Cina entra diprepotenza nel dibattito politicoamericano, aggiunge nuovi vele-
GAO
XINGJIAN
La montagnadell’animaRizzoli, 2002
YU HUA
Cronache diun venditoredi sangueEinaudi, 1999
HONG YING
Figlia delfiumeMondadori,1997
CHANG
JUNG
Cigni selvaticiTea, 1998
BEI DAO
SperanzafreddaEinaudi, 2003
MARCO
POLO
Il Milione
PAUL
THEROUX
Il gallo di ferroBaldini eCastoldi, 2001
MARCEL
GRANET
Il pensierocineseAdelphi, 1971
JACQUES
GERNET
Cina ecristianesimoMarietti, 1984
JEAN-LUC
DOMENAC
Doce va laCina? DaTienanmen aoggiCarocci, 2003
CATALDO
RUSSO
(a cura di)Cao Xueqin. Ilsogno dellacamera rossaTranchidaEditore, 1997
LEONARDO
ARENA
La filosofiacineseRizzoli, 2000
LUIGI
TOMBA
Storia dellaRepubblicaPopolareCineseBrunoMondadori,2002
«L’Occidente teme sempre la concor-renza. Per eccesso di narcisismo,non sopporta che altri paesi diven-
tino grandi, vuole dominare sul piano econo-mico come su quello culturale. Nel resto delmondo, invece, la grandezza dell’Occidente èaccettata normalmente. Capisco però che unoccidentale si possa sentire spaesato e oppres-so di fronte l’immensità della Cina e della suapopolazione, specie quando non se ne cono-scono la lingua e la cultura.
Il sentimento di paura nasce anche dall’igno-ranza della storia di un paese che ha conosciu-to molte invasioni, ma non ha mai mostrato vo-lontà espansionistiche. La Grande Muraglia,oltre che per difendersi, serviva a delimitare ilproprio territorio. Da un certo punto di vista eraun modo per contenersi.
La Cina non è mai stato un paese conquista-
tore, in compenso ha sempre saputo far frutta-re i contributi delle altre culture. Attraverso lesue frontiere occidentali è stata sempre in con-tatto con il mondo esterno. Così, mentre espor-tava la seta, importava dall’India il buddismo,trasformandolo in una religione universale. Equesta disponibilità verso ciò che viene da fuo-ri ha consentito alla Cina di non essere un pae-se xenofobo. Solo quando è ferita, la Cina puòdiventare xenofoba, per reazione.
La Cina non è dunque una minaccia per il re-sto del mondo. Ciò che dobbiamo temere èpiuttosto la mancanza di democrazia, l’arbitrioe la corruzione presenti nel paese. Ma l’Occi-dente può aiutare la Cina ad imboccare senzareticenze la strada che porta ad un sistema de-mocratico, evitando di compiacere i dirigenticinesi in nome degli affari. Non si può conside-rare la Cina solo come un immenso mercato, bi-
LA REPUBBLICA POPOLARE 1949
A febbraio i comunisti entrano a Pechino ecostringono Chang Kai-shek a riparare aTaiwan sotto la protezione Usa. Urss eInghilterra riconoscono la neonataRepubblica popolare
GRANDE BALZO IN AVANTI 1958-62
La strategia di sviluppo agricolo di Maopoggia sulla creazione di cooperativepopolari e su una martellante campagnapropagandistica. L’esperimento fallisce. LaCina rompe con l’Unione sovietica
CONFUCIO E IL TAO, RADICIDI UNA DEMOCRAZIA POSSIBILE
I PREGIUDIZI OCCIDENTALI VERSO I VALORI CINESE
La Cina era ritenutaimmensa e impotente;atroce e filosofica;patriarcale e corrotta.E siccome nonsapevamo comecatalogarla, lacollocavamo inun’altra sfera, nellacategoria di ciò che è altempo stesso reale eincomprensibile
Da “Sguradi sul mondoattuale”, Adelphi 1994
PAUL VALÉRY
BRUCE CHATWIN
La civiltà cinese sorsedalle rive dei grandifiumi. L’Imperatoreera la SupremaAutorità delle Acque; ilsuo governo, unamacchina per ilcontrollo dellamanodopera; i suoigranai, la BancaNazionale, con il poteredi affamare il popolo
da “Che ci faccio qui”Adelphi 1990
RIVOLUZIONE CULTURALE 1966-71
Un movimento di contestazione prende dimira i moderati e chi si oppone al disegnomaoista. La lotta delle Guardie rosse duradue anni ed è piena di eccessi. È lo stessoMao a frenare le spinte più radicali
ni alla campagna per le elezionipresidenziali. Dopo tre anni dicrisi economica che hanno di-strutto tre milioni di posti di la-voro, negli Stati Uniti la caccia alcolpevole ha trovato un bersa-glio grosso. «Un milione e mezzosono disoccupati per colpa delloyuan», sentenzia la Manufactu-rers Alliance, associazione con-findustriale, alludendo alla mas-siccia delocalizzazione di postidi lavoro verso una Cina dove lamanodopera costa un decimo.Non più solo operai, ma anchetecnici e dirigenti vengono licen-ziati in America e assunti in Cinada Ibm o Intel. La moneta sotto-valutata dà un vantaggio sleale al“Made in China”, questa è la li-nea ufficiale dell’Amministra-zione Bush ma anche dell’oppo-sizione democratica: tutti uniticontro il nuovo “pericolo giallo”che ha sostituito il Giappone de-gli anni Ottanta. All’accusa dimantenere sottovalutato loyuan se ne aggiungono altre: i sa-lari da fame nelle fabbriche cine-si dove i lavoratori non hanno di-
ritti sindacali; l’industria dellacontraffazione che inonda i mer-cati di falsi (dal software Win-dows alle sigarette, dai Dvd aicomputer); perfino sull’inqui-namento la Cina viene messasotto processo, benché l’Ammi-nistrazione Bush non abbia sot-toscritto il Trattato di Kyoto.
La macchina dell’industria ci-nese macina risultati impressio-nanti. Le sue esportazioni negliStati Uniti sono triplicate in me-no di dieci anni, creando nel2003 un buco di 100 miliardi didollari nella bilancia commer-ciale Usa. Ma la Cina è stata mol-to più abile del Giappone, chenegli anni Ottanta provocò negliStati Uniti una tale sindromed’assedio da scatenare misure diritorsione, dazi e contingenti al-le importazioni. Lanciare unaguerra protezionista contro Pe-chino è impossibile. Anzituttoperché i due terzi delle esporta-zioni cinesi verso gli Stati Unitiappartengono a multinazionaliamericane. Chiudere le frontierevorrebbe dire danneggiare Mo-
torola, Dell, Nike, il Big Businessche ha delocalizzato le sue fab-briche sull’altra sponda del Paci-fico. Il “Made in China” è anche ilmigliore alleato del consumato-re americano: gli ipermercatiWal Mart, celebri per i prezzi po-polari, assorbono da soli il 10% ditutte le importazioni americanedalla Cina. E nonostante le accu-se sulla contraffazione (fonda-te), nell’insieme la Cina è un gio-catore meno scorretto del Giap-pone: il suo mercato interno èaperto ai prodotti stranieri, il ce-to medioalto è avido di prodottidi marca europei e americani. Leauto straniere non hanno maisfondato a Tokio; in Cina Gene-ral Motors e Volkswagen sonostate accolte a braccia aperte. In-fine la crescita americana dipen-de dai risparmi asiatici: quei 100miliardi di dollari di attivo com-merciale della Cina rifluiscononegli Stati Uniti sotto forma di in-vestimenti in buoni del TesoroUsa. Più Bush fa debiti, più il suobilancio viene finanziato dai ri-sparmi del gigante asiatico. Po-lemiche e frizioni protezionisti-che sono il rumore di fondo diuna campagna elettorale. Rivalegeopolitico inevitabile per gliStati Uniti nel lungo periodo;Bengodi per le multinazionaliUsa nell’immediato, e generosafinanziatrice dell’American wayof life: la Cina è riuscita ad attira-re la superpotenza mondialenella ragnatela di un rapportosimbiotico, dal quale gli ameri-cani non possono liberarsi.
Foto di Marc Riboud (Magnum/Contrasto)
FRANÇOIS CHENG

LA REPUBBLICA 39MERCOLEDI 5 NOVEMBRE 2003
“NON SAPETE NULLA DI NOIPER QUESTO CI TEMETE”
LA PAURA VISTA DA ORIENTE/ INTERVISTA A ZHANG LUN
RENATA PISU
‘‘
,,
Ai vostri occhi dioccidentali sembriamoun unico bloccoSbagliate, provate astudiarci meglio
transizione, la transizione post-comunista e quella della moder-nizzazione di una civiltà mille-naria. Non è facile, sarà un pe-riodo lungo e difficile, per tutti.Ma io insisto: si tratta di unatransizione il cui esito finale in-fluenzerà, per il meglio o per ilpeggio, anche il vostro futuro.Già, forse è per questo che avetepaura di noi… L’emergere dellaCina sarà per il vostro meglio oper il vostro peggio? Ma non do-vreste pensare un po’ anche anoi cinesi?»
Eppure, serpeggia questapaura, la minaccia della Cina, lasfida…
«Sì, ma di quale Cina avetepaura? Ci sono tante Cine, tantiattori, diverse poste in gioco, al-l’interno la situazione è com-plessa, in ebollizione. Il Poterepotrà sopravvivere soltanto seaccetterà il gioco delle moltepli-cità. Certo, ora in Cina c’è un’e-conomia di mercato, grandi in-vestimenti stranieri, per cui nonsiamo più nella fase in cui, percrescere, si deve sfruttare la pro-pria gente come all’epoca diMao. Ora però c’è un altro tipo disfruttamento, quello dei quadridi partito corrotti fino alle mi-dolla, dei funzionari locali cheimpongono balzelli iniqui aicontadini. C’è una Cina poveris-sima. Avete paura anche di quel-la?»
Probabilmente sì, ma in mo-do confuso, irrazionale.
«Oggi, una nuova generazio-ne di economisti cinesi, sta stu-diando quali siano stati gli effet-ti delle riforme economiche, av-viate in sordina nel 1978, all’in-terno della Cina. Quel che ne ri-sulta è la frattura geografica trala fascia costiera e la Cina inter-na, una frattura che impensieri-sce perché il margine per arriva-re a una compensazione è moltoesiguo, a meno che non si verifi-chino dei grandi cambiamenti».
Per il meglio o per il peggio?«Chi può saperlo? Tutto anco-
ra dipende dal Partito comuni-sta, ma le analisi sono contrad-dittorie. C’è chi punta per il futu-ro sulla sua stabilità e la sua ca-pacità di governare il paese e chi,invece, ne mette in luce tutte ledebolezze».
Per esempio?«Le parrà strano ma molti
analisti, in Cina, oggi come oggi,ritengono che il pericolo mag-giore sia l’indebolimento delcontrollo che, prima, era assolu-to. Già se ne vedono le conse-guenze, cioè aumento vertigi-noso della criminalità e dilagaredella corruzione. Tutti concor-dano sul fatto che il Partito potràsopravvivere soltanto se operaun cambiamento ma non si au-gurano che ciò accada, almenoper il momento. Questo perchénon si sa se il cambiamento por-terà al meglio o al peggio».
E il peggio, una Cina indebo-lita, sarebbe meglio o peggioper noi?
«Per voi sarà sempre il peggiose non riuscirete a superare lapaura della Cina. Non si può vi-vere nel XXI secolo senza sapereniente della Cina. Non vi pareassurdo? Sarebbe come non sa-per nulla dell’America. Ripeto,quello che sta succedendo danoi è importante, ma voi avetepaura, invece dovreste per lomeno conoscere i vari scenariche si stanno profilando in Cina,le scelte che i cinesi sono chia-mati a fare, per il meglio».
LA CINA È
VICINA
Critica dellemitomaniedeigruppuscoliextra-parlamentariDi MarcoBellocchio(1967)
CHUNG
KUO-CINA
MichelangeloAntonionigirò ildocumentariosenza colori,fatto salvo ilrosso“comunista”(1972)
L’ULTIMO
IMPERATORE
Incoronatonel 1906 a treanni Pu Yivive finoall’età adultachiuso nellacittà proibitaDi BernardoBertolucci(1987)
LANTERNE
ROSSE
Ogni sera lequattro moglidi Chenaspettano disapere conquale di loroil maritopasseràla notte Di ZhangYimou (1991)
LA TIGRE E
IL DRAGONE
Lacontrastatastoriad’amore della giovanee nobile Jenespertain artimarzialiDi Ang Lee(2000)
LE BICICLETTE
DI PECHINO
Guo Lianglavora comefattorinocon la bicima, quandogli vienerubataperde illavoro Di XiaoshuaiWang(2001)
I FILM
sogna aiutarla ad evolvere, perché solo una Ci-na equilibrata e pacificata dalla democrazianon farà più paura. Certo, c’è chi sostiene che ivalori democratici sarebbero estranei alla tra-dizione cinese.
Secondo me, però, questo non è vero. Sebbe-ne storicamente la Cina non abbia mai cono-sciuto la democrazia, nella sua cultura nonmancano i valori universali perfettamentecompatibili con la cultura democratica. Confu-cio, il cui insegnamento si rivolge a tutti senzadistinzione di razza o di casta, ha predicato laresponsabilità di ogni individuo di fronte alla
società. Mentre il taoismo fa appello alla libertàdell’individuo e predica la comunione totalecon la natura. In queste due grandi correnti dipensiero, che propongono valori universali eun’esigenza etica molto marcata, nulla ostaco-la la democrazia.
Confucio, inoltre, ha sempre difeso il dialo-go, anche perché solo tramite esso è possibiletrovare la via del giusto mezzo. Non a caso, og-gi, nonostante tutte le difficoltà che il paese haattraversato, sul suo territorio convivono paci-ficamente tutte le grandi religioni. E gli intellet-tuali cinesi sanno che la cultura si rinnova solonel dialogo, il quale naturalmente non è sem-plice imitazione della cultura altrui. Lo scam-bio implica sempre rielaborazione. In questomodo la Cina farà propri gli stimoli culturaliprovenienti dall’Occidente, ma soprattuttosarà in grado di proporre all’Occidente un con-tributo culturale di segno universale».
(testo raccolto da Fabio Gambaro)
Una stampa che riproduceun maestro di calligrafiacon un’allieva
“Gli americani nondevono temere i cinesi.Ai cinesi interessanosolo potere e denaro.L’America ha piùpotere e denaro di tutti.E i cinesi avrannosempre bisogno dellasua amicizia”. Erachiaro che parlava conla disperazione piùnera
Da “Il gallo di ferro”Baldini&Castoldi 2001
PAUL THEROUX
GAO XINGJIAN
Mi tornano in mente icontadini della miainfanzia. Lavoravanoalle ruote ad acquanudi. Come vedevanopassare una donnaintonavano canzoncinesporche, ma senzacattive intenzioni…Quelle scene ora sonoscomparse dalpanorama
Da “La montagna dell’anima”Rizzoli 2002
NIXON A PECHINO 1972
All’inizio degli anni Settanta il primo ministroChou en-Lai decide di usciredall’isolamento internazionale. La nuovalinea politica è sancita dalla visita delpresidente americano Nixon a Pechino.
TIENANMEN 1989
La notte tra il 3 e il 4 giugno l’esercito cineseinterviene con i carri armati contro la folla distudenti in Piazza Tienamen, a Pechino:320 morti secondo le fonti ufficiali, 1.300per Amnesty International
JANG ZEMIN 1993
Jiang Zemin diventa primo segretario delPcc e poi presidente della Repubblica.S’inaugura una nuova fase: il partitos’avvicina alla società e il paese va verso uninserimento nel mercato mondiale.
CONTRO IL TERRORISMO 2001
Dopo gli attentati dell’11 settembrela Cina esprime la sua solidarietàagli Stati Uniti ma quest’anno s’èpronunciata contro l’interventoamericano in Iraq.
La vie intellectuelle en Chinedepuis la mort de Mao, il li-bro di Zhang Lun, in esilio
a Parigi dal 1990, affronta unavastissima gamma di questioni,sociali, politiche ed economi-che. E’ un saggio che ha avuto inFrancia un grande successo e hasviluppato intorno a sé un viva-ce dibattito. Abbiamo incontra-to Zhang Lun per rivolgergli al-cune domande.
Perché oggi noi Occidentaliabbiamo paura di voi cinesi?
«Perché non ci conoscete.Non conoscete niente della sto-ria e della civiltà cinese, la Cina viappare come un immenso bloc-co, un macigno incombente. Danoi c’è una maggiore conoscen-za dell’Occidente, tra le élitesovviamente. Sono più di centoanni che vi studiamo per tentaredi diventare “moderni”. Ma lavostra paura, secondo me, è so-prattutto psicologica, fatta di re-miniscenze lontane, di “perico-lo giallo”. Io però dico che do-vreste fare uno sforzo per stu-diarci, capirci, conoscerci… Pervoi la Cina è un buco nero, anziun buco giallo».
D’accordo. Oggi però questobuco si sta riempiendo di merci“Made in China” che ci inonda-no…
«E pensate davvero che lemerci siano l’avanguardia del-l’invasione? No, guardi, non èdetto che la storia si ripeta, non èdetto che una Cina sviluppatasegua per forza le orme degli Oc-cidentali e diventi una potenza
imperialista. Inoltre, voi non te-nete conto del fatto che la Cina,per crescere, sfrutta il suo stessopopolo, non gli altri. E questa èdavvero una tragedia, crea ten-sioni all’interno che è difficile ri-solvere.
«Io penso che la vostra pauradel Gigante Cina derivi anche daun’altra constatazione, cioè voiavete ancora impresse nella re-tina le immagini del giugno1989, della repressione di Tie-nanmen, i carri armati, gli stu-denti uccisi… Insomma, voi vidite: qui abbiamo a che fare con
un paese immenso, una popola-zione straripante, un regime to-talitario. E non vi fidate, giusta-mente, anche se oggi il regimenon è più totalitario ma, piutto-sto, autoritario».
Dopo Tienanmen c’è stataquindi anche una riforma poli-tica?
«Non si tratta di una vera rifor-ma, si è semplicemente atte-nuato il controllo sulle vite pri-vate, si può fare quello che sivuole purché non ci si occupi dipolitica. Comunque, la Cina stavivendo un periodo di doppia
GLI INTERVENTIFRANÇOIS Jullien, che firma il sillabario, è uno deipiù grandi sinologi europei. In Italia è noto per Iltrattato dell’efficacia (Einaudi, 1996). Zhang Lun èun intellettuale cinese che dal 1990 vive in esilio aParigi. allievo di Touraine ha pubblicato da pocoper Fayard La vie intellectuelle en Chine depuis lamort de Mao. Infine François Cheng, scrittore e cri-tico, eletto l’anno scorso accademico di Francia.Tra i suoi libri: L’ecriture poétique chinoise e Vide etPlein (entrambi editi da Seuil)

ALVOHXEBbahaajA9 770390 107009
31105
CHDFDFDODT SEDE: 00185 ROMA, Piazza Indipendenza 11/b, tel. 06/49821, Fax06/49822923. Spedizione abbonamento postale, articolo 2, comma 20/b,legge 662/96 - Roma.
PREZZI DI VENDITA ALL’ESTERO: Austria € 1,85; Belgio € 1,85; Canada $ 1; Danimarca Kr. 15; Finlandia € 2,00; Francia € 1,85; Germania € 1,85;Grecia € 1,60; Irlanda € 2,00; Lussemburgo € 1,85; Malta Cents 50;Monaco P. € 1,85; Norvegia Kr. 16; Olanda € 1,85; Portogallo € 1,20 (Isole
€ 1,40); Regno Unito Lst. 1,30; Rep. Ceca Kc 56; Slovenia Sit. 280; Spagna€ 1,20 (Canarie € 1,40); Svezia Kr. 15; Svizzera Fr. 2,80; Svizzera Tic. Fr.2,5 (con il Venerdì Fr. 2,80); Ungheria Ft. 300; U.S.A $ 1. Concessionaria di pubblicità: A. MANZONI & C. Milano - via Nervesa 21, tel. 02/574941
Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Ezio Mauro
Anno 28 - Numero 260 € 0,90 in Italia (con “LA PELLE” € 5,80) mercoledì 5 novembre 2003
■INTERNET
www.repubblica.it A B
È in edicola a soli€ 5,70 in più
•Cosa c’é •Toffee
•Dormi, dormi
...e altri mitici successi
VASCO ROSSICOSA SUCCEDE IN CITTÀ
VERSIONE
ORIGINALE
La sfida cinese all’Occidentedal nostro inviato
BERNARDO VALLI
PECHINO
LA CINA suscita da secoli, afasi alterne, una straordi-naria varietà di sentimenti:
rispetto, timore, affetto, rifiuto,ammirazione, sospetto. Accen-de facilmente le passioni occi-dentali. Le preziose esperienzeindividuali, come gli inevitabiligiudizi generici, sfiorano appe-na, il più delle volte, una realtàampia e composita.
SEGUE A PAGINA 37CHENG, JULLIEN
PISU e RAMPINIALLE PAGINE 37, 38 e 39
Oggi “La pelle”di Curzio Malaparte
A richiestaa soli 4,90euro in più
Enciclopediain edicolail 10° volumee le ristampedel 4° e 5°
CON REPUBBLICA
L’enigma Putine la democrazia
azzoppataPAOLO GARIMBERTI
«CHI non si dispiace per ilcrollo dell’Unione So-vietica non ha cuore.
Ma chi vuole ricrearla non ha cer-vello». Bisogna partire da questafrase, che gli procura sempre gran-di ovazioni quando la ripete inpubblico, per capire le due facce diPutin, più che mai sovrapposte inqueste ultime due settimane, du-rante le quali – con l’arresto delmagnate del petrolio Mikhail Kho-dorkovskij e le dimissioni del capodi gabinetto del Cremlino Aleksan-dr Voloshin – ha reciso ogni legamecon la “famiglia” politica eltsinia-na e ha portato la fragile e incom-piuta democrazia russa molto vici-na al confine con l’autoritarismo.
Lasciamo perdere i paragoni,suggestivi o impertinenti, ma co-munque devianti, con “Ivan il Ter-ribile” (El Pais), o “Vlad l’impalato-re” (The Economist). Vladimir Pu-tin è quello che i russi chiamano un«gosudarstvennik», un uomo diStato e di apparato, che pone la sta-bilità e la crescita della Russia so-pra qualunque altra cosa, anchedelle norme del codice e delle leggidella politica. È un pragmaticofreddo, a-ideologico (in questo sidifferenzia non solo da Gorbaciov,ma anche da Eltsin), che vede losviluppo della Russia radicato nel-l’Europa e in un rapporto specialecon gli Usa. Ma, prima di tutto, nelrestauro di un ordine perduto, cheè post-sovietico come cornice po-litica, ma è sovietico nei metodi direalizzazione. Olga Kryshtanov-skaja, la più nota sociologa russa,ha pubblicato recentemente unostudio dal quale risulta che la pro-porzione dei siloviki (comune de-nominazione per i ministeri e gliapparati della forza, dalla polizia aimilitari e ai servizi derivati dal vec-chio Kgb) è aumentata ai verticidello Stato russo di 12 volte negliultimi 15 anni: era il 4,8 per cento aitempi di Gorbaciov, è il 58,3 percento oggi. A livello regionale 5 su7 rappresentanti speciali del presi-dente sono ex militari o uominicresciuti nel Kgb, come lo stessoPutin.
SEGUE A PAGINA 15
IL CASO
Quel pugno di anarchiciche inquieta il Viminale
IL RETROSCENA
LE LETTERE
DIARIO
Champions a rischio per i romani
La Lazio crollacon il Chelseail Milan passa
a Bruges
LA LUNGAMARCIA
DELLA DESTRAITALIANA
EZIO MAURO
DUNQUE la lunga marciadella destra italiana perfuoriuscire definitivamen-
te dall’eredità del fascismo e dallesue persistenze è davvero finita?Lo ha affermato solennementeGianfranco Fini, nel dialogo con ilpresidente dell’Unione delle Co-munità ebraiche italiane AmosLuzzatto che si è svolto a Repub-blica e di cui il nostro giornale hadato conto ieri. Per il leader di Anla revisione è conclusa, il destinodella destra si è compiuto, tutte leparole che definiscono il prima e ildopo sono state pronunciate. Va-le la pena ragionare su questa af-fermazione, anche per l’impor-tanza che Fini e Luzzatto hannoattribuito alla loro pubblica di-scussione, sotto l’aspetto prima ditutto simbolico. Un incontromancato per cinquant’anni – enon per caso – nella storia repub-blicana: che per la prima volta ve-deva dialogare direttamente, co-me ha detto Mario Pirani, il rap-presentante della comunitàebraica italiana con l’erede, siapure aggiornato e revisionato, delmovimento fascista.
Fini rifiuta questa eredità. Al-leanza Nazionale, ricorda, non èfiglia diretta di Salò, ma del Movi-mento Sociale, dunque l’ascen-denza è mediata, non diretta, e fulo stesso leader, a Fiuggi, a ricor-dare al partito in lacrime che biso-gnava “uscire dalla casa del padrecon la certezza di non farvi più ri-torno”. Ma Fini sa di essere, oltreche il presidente di An, anche l’ul-timo segretario del Msi. Questonodo di rottura e di discendenzalo lega organizzativamente, poli-ticamente e culturalmente a quel-la eredità e lo carica di un doppiopeso, comune del resto ai post-co-munisti della sua generazione: es-sere nello stesso tempo autore diuna svolta e di una trasformazio-ne, e reggere comunque l’ingom-bro di una tradizione immane,con cui non si possono non farecontinuamente i conti.
Per questa ragione, credo, Fininon si è sottratto alle domandeinevitabili sulla “natura” del suopartito e sulle contraddizioni diquesta natura. Poiché oltre cheleader di un partito è anche vice-presidente del Consiglio, nomi-nato dopo aver vinto le elezionicon la Casa delle Libertà, avrebbepotuto rivendicare anche per séquella speciale “unzione” del votopopolare in cui si immerge perio-dicamente Berlusconi per cercar-ne la fonte di un potere supremo,sciolto dai contrappesi e dai con-trolli tipici di uno Stato di diritto.
SEGUE A PAGINA 15
Inviati altri due plichi, uno è esploso a Roma ferendo un carabiniere. Pisanu: dietro le Br agiscono gruppi eversivi minori
L’incubo dei pacchi-bombaBerlusconi: manifestiamo contro il terrorismo con i sindacatiROMA — Due pacchi bomba,uno esploso in una stazione dicarabinieri a Roma ferendo unmilitare, un altro disinnescatoalla questura di Viterbo. Tornal’incubo del terrorismo con dueazioni. Le prime indagini indivi-duano una pista che porta aglianarco-insurrezionalisti. L’or-digno (una videocassetta conesplosivo inviata per posta) hastaccato di netto due dita dellamano destra e dilaniato la sini-stra al maresciallo Stefano Sin-dona. «Il Paese deve esprimeresenza divisioni di parte la suachiara ripulsa degli atti e delleidee dei violenti», è l’appello diBerlusconi. «Ben vengano leadesioni anche del centrodestraalla manifestazione del 19 no-vembre, il terrorismo è un nemi-co comune», replica il segretariogenerale della Uil, Luigi Angelet-ti. E intanto il ministro dell’Inter-no Pisanu avverte: «Dietro le Bragiscono gruppi eversivi minori;non abbassiamo la guardia».
ALLE PAGINE 2, 3 e 4
Centrata la “zona verde” a Bagdad. Bush: “Dietro gli attacchi c’è Saddam, ma lo prenderemo”
Iraq, razzi sul quartier generale UsaGIAMPAOLO CADALANU A PAGINA 11
CARLO BONINI
ROMA — Alle più ovvie delle domande sollecitate dalsangue di viale Libia – chi e perché? – gli uomini dell’An-titerrorismo danno in queste ore una risposta che somi-glia a qualcosa la cui consistenza, se è assai meno di unaprova, certo suona più solida di una semplice congettu-ra. Utile – lo vedremo – a sciogliere le parole consegnateda Pisanu al Parlamento. Comunque buona per tenerein piedi un’ipotesi investigativa cui assicurare prece-denza. Che riduce il raggio della ricerca delle responsa-bilità non solo alla matrice anarco-insurrezionalista in-dicata dal ministro, ma ad un pugno di nomi «verosimil-mente confinati» tra quanti, dal 18 ottobre scorso, van-no rumorosamente chiedendo la scarcerazione di Mas-simo Leonardi, ventinovenne anarchico del collettivoantagonista di Viterbo, detenuto a Rebibbia, perché ac-cusato di aver partecipato all’aggressione di un carabi-niere in borghese negli scontri del 4 ottobre a Roma, du-rante la Conferenza intergovernativa.
SEGUE A PAGINA 5
I soccorsi al maresciallo ferito dal pacco-bomba
Pensioni, Tremonti sconfessa la Ragioneria. Governo battuto sulla leva. Sì alla libertà di costruire dopo gli incendi
Tra Fini e Bossi scontro più duroFinanziaria, immigrati, arresto europeo: Polo diviso su tutto
ROMA – Ricomincia il “corpo acorpo” tra An e Lega. Alle mi-nacce di Bossi, che parla di crisise dovesse essere approvato ilmandato d’arresto europeo o ilvoto agli immigrati, ha ribattutosubito Fini: «Noi non ci fermia-mo – ha detto il vicepremier – edel resto Bossi ha cambiato ideavarie volte». Sull’euromandato itempi stringono: entro fine di-cembre l’Italia dovrebbe met-tersi in regola con la Ue, e l’Udcalza la voce: il sottosegretarioVietti critica il ministro Castelli esollecita il rispetto dell’impe-gno preso in Europa. E nelle vo-tazioni sulla leva il governo vie-ne battuto proprio dai voti dellaLega che si unisce all’Ulivo. In-tanto la maggioranza ha rein-trodotto la possibilità di costrui-re sulle aree colpite da incendi.Sulle previsioni sugli incentivinella riforma delle pensioniTremonti sconfessa i tecnicidella Ragioneria generale.
ALLE PAGINE 7 e 26
MASSIMO D’ALEMA
CARO direttore, mi sono chiesto co-me avrei risposto al quesito – cosìmal posto – del sondaggio europeo
che tanto fa discutere e indigna. L’unicarisposta giusta sarebbe stata non rispon-dere. Personalmente non accetto l’ideache uno Stato, un singolo Paese, possa es-sere considerato di per sé una minacciaper la pace. La considero un’idea figlia diquella concezione degli stati-canagliache è all’origine del manicheismo neo-conservatore americano e della stessadottrina di guerra preventiva. In questosenso, un quesito ambiguo può persinoalimentare l’idea che la sola esistenza diun determinato Stato costituisca una mi-naccia per tutti gli altri.
SEGUE A PAGINA 14
Assurde accuse a Prodiper il sondaggio della Ue
NANNI MORETTI
CARO direttore, veramente moltounitaria questa lista dell’Ulivo perle elezioni europee! Tre partiti den-
tro e quattro fuori. Non mi sembra chel’appello di Prodi andasse in questa dire-zione. E la stessa domanda di unità cheviene dall’elettorato di centrosinistraesprime una richiesta semplice e precisa:trovare un modo per stare tutti insieme,intorno a un programma capace di indi-viduare temi forti e condivisibili. Questeelezioni potrebbero offrire al centrosini-stra l’opportunità di unirsi su valori che locontraddistinguono: legalità internazio-nale, pace, difesa dello stato sociale, tute-la dell’ambiente, difesa del pluralismodell’informazione.
SEGUE A PAGINA 14
Una lista di tre partitinon rilancia l’Ulivo
Romano Prodi
SERVIZI
NELLO SPORT