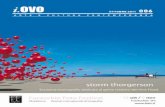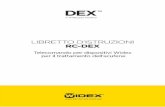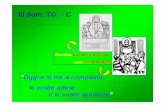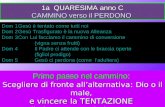006 DOM 07-01-01
-
Upload
oscar-sanguinetti -
Category
Documents
-
view
218 -
download
3
description
Transcript of 006 DOM 07-01-01

IL FOGLIOANNO VI NUMERO 6 DIRETTORE GIULIANO FERRARA DOMENICA 7 GENNAIO 2001 - L. 2000
REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: LARGO CORSIA DEI SERVI 3 - 20122 - MILANO quotidiano TEL 02/771295.1 - SPED. ABB. POST. - 45% - ART. 2 COMMA 20/b LEGGE 662/96 - FIL. MILANO
Se la ricorda ancora quella manga-nellatura, nel bel mezzo delle mani-festazioni pacifiste di Comiso, anno
1983: non fu affatto piacevole, per una si-gnora di 53 anni, ritrovarsi ricoverata e inprognosi per due settimane e mezzo, pie-na di lividi. Chiunque altro, specie se co-sì in vista nel mondo della politica,avrebbe indossato i panni dell’eroe dellademocrazia pestato dal Potere. LucianaCastellina la prese come uno dei rischidel suo mestiere, il mestiere della rivolu-zionaria rompiscatole pronta a correredovunque per la causa.
Prima e dopo lo strappo del Manife-sto, delle rivoluzionarie d’Italia è stata lapiù bella e la più corteggiata, ma anche lapiù avventuriera e la più tormentata. Og-gi, a 70 anni, reduce da un intervento alginocchio che l’ha fatta un po’ soffrire(ma non quanto le legnate della polizia inSicilia), presiede battagliera Italia Cine-ma, un organismo pubblico che si occu-pa, con qualche affanno, di promuovereall’estero i nostri film. Una passione,quella per la cinematografia italiana, na-ta sui banchi di Strasburgo, dove fu alungo europarlamentare e presidente del-la commissione Cultura, che lei gestiscecon un certo piglio manageriale, oltre chepresenzialista. Il professor Orio Caldironle ha rimproverato, citando Fellini, unatotale “sconosciutezza della materia”, malei non se l’è presa più di tanto, impe-gnata com’è, in nome della cosiddetta“eccezione culturale”, a organizzare in-contri dovunque in Europa, a polemizza-re (e far pace) con Tinto Brass a PalmSprings, a frequentare feste, a pilotare ac-cordi con la Rai, a difendere anche a col-pi di comunicati il buon nome del nostroacciaccato cinema d’autore.
È possibile che il cinema sia, per lei,una continuazione della politica in altre
forme. Quella politica abbracciata vora-cemente e precocemente, che già avent’anni la portò a farsi arrestare, gene-rosa e battagliera, dopo l’attentato a To-gliatti. Comunista sin da allora, ma anchespregiudicata e scandalosa, grazie alla suabellezza prepotente: gli occhi perentori, icapelli portati corti, le gambe lunghe eaffilate, il seno gonfio da pin up (“un ci-licio, una maledizione, impossibile da oc-cultare”, dirà più tardi, “neppure i mieidiscorsi più impegnativi riuscivano a di-strarre lo sguardo degli interlocutori, chefiniva sempre lì”).
Proprio su Sette, il magazine del Cor-riere della Sera, di qualche settimana fauna sua fresca fotografia giovanile, scat-tata dall’amico e futuro regista FrancescoMaselli, la ritrae studentessa del mitico li-ceo Tasso di Roma: già grintosa, ma an-che lusingata di aver ricevuto dai compa-gni di classe il titolo di “Signorina 103”,dal numero dell’autobus che prendeva al-la mattina per arrivare a scuola. “Le vin-se lì le sue prime elezioni”, commenta
Vittorio Zincone, e chissà che non ci siadel vero.
Di sicuro quella di Luciana Castellinaè una singolare vicenda, densa di avven-ture, viaggi, amori, figli, invidie, rotture eanche solitudini: prima nella Fgci, poi nelPci, poi tra i fondatori del Manifesto, poitra gli animatori del Pdup, poi pacifista aoltranza con la rivista Pace e Guerra, poidi nuovo nel Pci di Alessandro Natta (lostesso che aveva pronunciato la requisi-toria contro gli eretici del Manifesto nel1969), poi con Rifondazione comunistaper dirigere il settimanale Liberazione
(ma fu contro Bertinotti all’epoca del go-verno Dini), infine di nuovo vicina agliex compagni del Pci, nel frattempo dive-nuto Pds e poi Ds.
Diversa da Rossana Rossanda, algida,sofisticata e ultraintellettuale, LucianaCastellina porta sin dall’inizio nel suo im-pegno un furore militante che sembraperfino stridere con le origini altobor-ghesi, o che forse invece ne discende ar-moniosamente. Conosce le lingue, saguardare politicamente oltre i ristretticonfini italiani, è benestante; ma è ancheuna ragazzaccia indipendente che, adascoltare chi la conosce, detesta i riti diuna certa sinistra aristocratica. Basta da-re uno sguardo alla sua biografia, riper-corsa qualche anno fa dal giornalista Fi-lippo Ceccarelli, per scoprire episodi biz-zarri, che anticipano il suo modo irruen-te, appassionato, a tratti ingenuo, di in-tendere la politica.
Da ragazza si mette in testa di aderirealle “Brigate del lavoro” nella Jugoslaviadel maresciallo Tito e, in attesa di arri-varci in autostop con tre compagni ingle-si, finisce a Praga, al Congresso interna-zionale degli studenti, dove irrita il pudi-co Enrico Berlinguer con le sue mutandee i suoi reggipetti appesi nella stanza. Piùtardi finisce in questura per aver manife-stato contro il film “Rommel, la volpe deldeserto”. Viene arrestata, incinta, peraver distribuito un volantino senza auto-rizzazione, si becca un processo per gliincidenti di Piazza Santi Apostoli, vola inGrecia dopo il golpe dei colonnelli e si ri-trova trattenuta per qualche giorno daigendarmi del posto.
Di sicuro una donna che non si rispar-mia. Anche in amore. Più nasconde leforme prorompenti, più risparmia in sor-risi e modi gentili per aderire ai clichémaschili, più i suoi compagni di partitoperdono la testa per lei. Quasi una male-dizione. A un congresso di studenti uni-versitari, dove partecipa in veste di diri-gente della Fgci, viene accolta da un boa-to, al grido di “Passerella! Passerella!”.Di lì a poco sposa, sotto lo sguardo nien-te affatto beneaugurante di Togliatti inpersona, il giovane dirigente ingraianoAlfredo Reichlin, con il quale farà due fi-
gli: Pietro e Lucrezia. Che il Miglioreavesse ragione? Il matrimonio, le cui dif-ficoltà vennero seguite con una certa ap-prensione dentro Botteghe Oscure, siconclude con una separazione clamoro-sa, anche perché nel frattempo Lucianaha conosciuto l’altro uomo della sua vita,Lucio Magri, bellissimo come lei, forsepiù abbronzato, sebbene ancora giovanedemocristiano di sinistra. Lui la seguirànel Pci, e insieme finiranno con l’essere
radiati dal partito, con l’accusa di frazio-nismo, per aver dato vita, con Rossana,Luigi Pintor, Valentino Parlato e altri, al-l’esperienza del Manifesto.
Ricorda Bruno Gravagnuolo, all’epocagià diplomato ma egualmente tra gli ani-matori dei Collettivi di base del Tasso.“Io, Daniele Cini, Mirko Bevilacqua civedevamo a casa sua, in via San Valenti-no, per organizzare la protesta studente-sca. In realtà eravamo tutti innamorati diLucrezia, che rivaleggiava in bellezza conla madre. Purtroppo Lucrezia stravedevaper un certo Toni Biggio…”. Apparta-mento caldo e ospitale, pieno di libri eoggetti di pregio, proprio di fronte all’at-tico di Edda Ciano. E in quelle riunioniconfuse, velleitarie, piene di fumo, ognitanto si affacciava Luciana. Discreta. “Ilsuo era un estremismo del cuore corret-to dalla pratica politica”, cesella Grava-gnuolo. “Per certi versi, la bellezza ci ap-pariva come la conferma delle sue idee:possedeva un’eleganza nitida, ben rico-noscibile, carismatica”.
Filocinesi, libertari, comunisti di sini-stra, Castellina e gli altri del Manifesto
vizi e virtù
Luciana Castellina, laragazza con la valigiadella sinistra glamourMichele Anselmi
continua in quarta pagina
È sempre di corsa, scende e saledagli aerei, si batte contro
piccole e grandi ingiustizie: inAfrica finisce trattenuta dai
sudafricani dell’apartheid sullerive dello Zambesi, a Roma
si fa chiudere a chiavenell’ambasciata cecoslovacca
Comunista sin da allora, ma anche spregiudicata
e scandalosa, grazie alla suabellezza prepotente: gli occhiperentori, i capelli portati
corti, le gambe lunghe e affilate, il seno da pin up
(“un cilicio, una maledizione”)
• • • •
Razionalità“Guardi, sono del segno dellaVergine, ascendente Leone, e daquello che mi hanno detto unpaio di astrologi sono per natu-ra troppo razionale e analiticoper credere in queste cose”.Keanu Reeves, attore. Alla Re-pubblica.
• • • •
Riservatezza“Nella mia vita tutto è espostoallo sguardo altrui. Almeno ilcorpo vorrei tenerlo nascosto”.Maria Grazia Cucinotta, attrice.Al Messaggero.
• • • •
Narcisismo“Succede a certi politici in cari-ca, da ambedue le parti, quelloche capita ai ballerini. Si guar-dano troppo allo specchio. È undanno terribile. Un ballerinopuò servirsi dello specchio. Mase vi si guarda troppo, beh, allo-ra è finito”. Carla Fracci, balleri-na. Al Giorno.
• • • •
Epica“Soprattutto se si pensa a quan-to erano state altisonanti le pro-messe di un anno fa, suggeritedalla scadenza millenaria e dal-l’epica suggestione di apparte-nenza a una svolta epocale”. Mi-na Mazzini, opinionista. SullaStampa.
• • • •
Verità“Uomini pubblici che abbianodavvero a cuore l’accertamentodella verità non si rivolgono auna ditta privata che disattiva lemicrospie, ma a noi”. GerardoD’Ambrosio, procuratore capo.Al Corriere della Sera.
• • • •
Inconsapevolezza“Vuole la verità? Sono semprestata inconsapevole del mio po-tenziale sessuale”. FrancescaDellera. A Panorama.
• • • •
Inesperienza“Ero ingenua, inesperta: era fa-tale che finissi vittima degli scal-tri e dei cinici”. La stessa. AlGiornale.
• • • •
Prostituzione“Ho lasciato quella succursale dimacelleria e prostituzione (il ci-nema). Ingmar Bergman, già re-gista. Al Giorno.
• • • •
Melomania“Mi provo a immaginare un per-sonale mio suicidio con fono-grafo”. Guido Ceronetti. SullaRepubblica.
• • • •
SoddisfazioneLa coltellata è quella che dà piùsoddisfazione, un tempo si usa-vano le costate del capretto,sembrava proprio di infilzarecarne umana. Oggi con il latticedi Salvietti si ha la stessa sensa-zione”. Dario Argento, regista.Alla Repubblica.
• • • •
Sprovvedutezza“Il più bel capitolo del mio pri-mo libro lo diedi da leggere aLuigi Manconi, il senatore, e nonl’ho più visto”. Francesco Guc-cini, cantautore. Al Giornale.
• • • •
Bellezza“Non ero bello. Avevo una fac-cia da bambino. Ma ero carino.Così carino che le attrici non vo-levano lavorare con me”. RogerMoore, attore. Al Daily Tele-graph.
• • • •
Esperienza“La mia vita di coppia è così fe-lice che ho temuto di non saperinterpretare il personaggio delfilm e tirare fuori la rabbia e lefrustrazioni che la storia richie-deva. Fortuna che alcune espe-rienze sentimentali mi sono sta-te molto utili”. Michelle Pfeiffer,attrice. All’Espresso.
• • • •
Eleganza“Sono talmente brutti (i politici,ndr) che chi se li piglia. ForseRutelli vale la pena, è un bel-l’uomo, si veste bene. Ma non sofino a che punto”. Antonella DelLago, pornostar. Al Giorno.
• • • •
Preveggenza“Non credo, e vorrei tanto sba-gliarmi, che le grandi questioniaperte nel mondo troverannouna soluzione”. Maurizio Co-stanzo, opinionista. Sul Messag-gero.
• • • •
Paura“Con Shakespeare bisogna la-sciare l’ego fuori dalla porta. Èuna cosa che spaventa un po’”.Daniel Craig, attore, al daily Te-legraph.
• • • •
Concentrazione“L’esercito quotidiano di miliar-dari da quiz, cui non è chiesto diessere capitalisti borghesi e nep-pure intellettuali ribelli, ma solodi saper scegliere tra smorfie diconcentrazione pensierosa traCalcutta, Bergamo, Parigi e Ro-ma, quale sia la capitale italiana(e se leghisti, guai a dirgli cheBergamo non è la risposta giu-sta)”. Natalia Aspesi, giornalista.Sulla Repubblica.
Quelli del Manifesto: Luciana Castellina, rivoluzionaria spericolata. La piùbella del liceo che divenne la più bella del partito. Bob Denard, bucanieredi Bordeaux, mercenario in Africa per amore d’avventura e di de Gaulle.Valentino Zeichen, cultore della pratica asociale della poesia con moltiinviti a cena e nessun editore di riferimento. Vincenzo Cardarelli a Parigi,un po’ amico e un po’ insofferente di “Silvio” Gualtieri di San Lazzaro.Le fotografie: sulle tracce della cristianità con Abbas, reporter iraniano

ANNO VI NUMERO 6 - PAG 2 IL FOGLIO QUOTIDIANO DOMENICA 7 GENNAIO 2001
L’incedere claudicante da gentiluo-mo âgé enfatizza il passato damercenario, tutt’uno con l’epo-
pea della “Françafrique”, l’Africa france-se. Con i suoi settantuno anni portati nébene né male, Bob Denard è perfettonella parte dell’avventuriero in pensione,ha due baffoni bianchi da degustatore dibuon Bordeaux e un accento girondinoche tradisce un Dna da bucaniere. C’ètutto, insomma: il passato coloniale e la“retraite” agiata a una manciata di chilo-metri da Parigi; l’avventura per i settemari e la campagna francese. Le scorre-rie dell’Olonese e il fioretto di Cirano. Lasua terra, ci tiene a sottolinearlo, è terradi corsari e lui ha fatto valere, con le suegesta, quasi un diritto ereditario. A quin-dici anni ha imbracciato un fucile per laprima volta. È il 1945 e i tedeschi sono infuga. Si accoda alla Resistenza sotto le in-segne della Croce di Lorena e partecipaa qualche scaramuccia finale, senza infa-mia e senza lode, nelle paludi del bordo-lese. De Gaulle fu il suo primo amore,non lo dimenticherà mai. Ancora oggi neparla con trasporto, lasciando capire cheanche lui, nel suo piccolo, “una certaidea della Francia” ce l’ha ancora. Infondo le sue scorribande hanno sempreavuto il fascino discreto dell’interesse na-zionale e il retrogusto acidulo della cor-rosione imperiale.
Marò in Indocina, a poco più divent’anni è a bordo degli Lcm che solca-no il Mekong, dà la caccia ai viet-minhtra le foreste di mangrovie. Cresciuto sul-le rive dell’Oceano, è orgoglioso dellasua divisa da marinaio con il berretto dalpompon rosso. Il ghigno canaglia e l’in-tesa cameratesca con gli amici, come inun film di Belmondo da giovane, affiora-no da una foto sbiadita in bianco e nero.Sembra un presagio. Una sera di liberauscita, Bob e gli altri bevono un po’, nonresta che sfasciare il locale di un cinesepoco ospitale. L’incidente va a sommarsia qualche episodio di insubordinazione egli stronca la carriera. Congedato.
Ma per un tipo a cui piacciono cazzot-ti e guasconate c’è molto da fare in que-gli anni. La Francia chiama, lui si arruo-la nella polizia e parte per il Marocco an-cora sotto il protettorato francese. Poi ilMarocco ottiene l’indipendenza, fine diun’altra avventura. Per qualche mesepasseggia con le mani in tasca per i vialidi Parigi, non batte chiodo. Intanto l’Al-geria occupa a caratteri cubitali le paginedei giornali. Ma Bob Denard ha sempreavuto il fiuto per tenersi fuori dai guaiveri. Se ne resta lontano, c’è già puzza dimarcio, e poi ci sono anche una moglie eun figlio cui pensare. Ma quando deGaulle decide di tornare in campo e fi-nirla con la Quarta repubblica, ecco chei vecchi superiori in Marocco e in Indo-cina si fanno vivi, lo assoldano per qual-che servizio da militante a tempo pieno.Fa l’autista, il fattorino e impara a cono-scere la politica e soprattutto i futuri po-litici. “È successo tutto per caso, non mi
rendevo conto che un giorno molti diquesti ex combattenti sarebbero diventa-ti deputati e alti funzionari”.
C’è da credergli, e infatti lascia prestola politica e si mette a fare il rappresen-tante di elettrodomestici: “Il primo colpoè stata la vendita di una stufa a mia zia,pensai che fossi tagliato per fare il vendi-tore”. Gli affari vanno bene, la simpatialo aiuta. Ma le stradine della Franciaprofonda e i negozietti cominciano astancarlo. Guadagna bene, ma non nepuò più. “Tornai a frequentare i vecchiambienti, mentre sui giornali leggevo delCongo, di Lumumba e di Ciombè. Nonconoscevo l’Africa nera, ma cominciai asentire il desiderio di visitarla”. Sui gior-nali ci sono inserzioni in cui si cerca “unnuovo tipo di soldato volontario”. L’Al-geria è una ferita aperta e l’opinione pub-blica è stanca, non si possono mandaretruppe regolari o la Legione straniera inogni angolo del globo. Ma qualcuno perfare la guerra ci vuole sempre, è la “rai-son d’Etat”. Bob parte, destinazione Ka-tanga. “Sono stato un volontario europeoe l’ho fatto per avventura e per ideale, hocombattuto per la Francia e contro il co-munismo”. Ecco perché la parola “mer-cenaire” con cui l’hanno bollato non gligarba. Denard visto da Denard è tutt’alpiù un combattente autonomo che hasempre avuto la sensibilità patriottarda el’accortezza di servire gli interessi nazio-nali. Con de Gaulle, ma anche con Pom-pidou e poi con Giscard d’Estaing.
Racconta François-Xavier Verschave,autore di un libro che ha fatto epocacontro la politica africana della Francia,che Parigi ha sempre delegato i suoi ma-neggi post coloniali a Jaques Foccart, po-tente creatura di de Gaulle e gran pro-tettore di Bob Denard. Un sistema benoliato di diplomazia segreta, i cosiddetti“réseau”, una palude dai confini incertitra legge e illegalità, grandi affari e cor-ruzione. Ci sono di mezzo gli interessieconomici, petrolio e altro, e quelli geo-politici di una Francia disposta a tuttopur di non perdere la partita in Africacontro l’incalzare anglosassone o sovieti-co. Disposta anche a mollare in quattro equattr’otto amici di vecchia data.
La sua carriera da soldato di venturaDenard la deve soprattutto a Mobutu Se-se Seko, che durante la guerra in Congogli affidò una buona parte delle sue ar-mate. Denard si distinse in combatti-menti da manuale contro i simba e i ba-luba che si battevano ebbri di canapa ealcol. Contribuì non poco al successo po-litico di Mobutu e a rassicurare con lesue gesta belgi, portoghesi e francesi. LaCia non si tirava indietro e forniva i C-130 per il trasporto dei mercenari. Era il1964, colpo su colpo Mobutu costruiva ilsuo potere. In tre anni di combattimenti
sanguinosi, guerriglia nella giungla e av-venture galanti in uno scenario colonialeda letteratura decadente, Denard fu unodegli artefici del personaggio Mobutu.Nasce quasi un’amicizia, modellata dagliinteressi occidentali. “Mi ricordo di unafesta in cui Mobutu mi si avvicinò strin-gendomi la mano, mi aveva da poco no-minato maggiore e mi considerava il suomigliore ufficiale. A quell’epoca avevoinvitato anche mia moglie Giselle a rag-giungermi in Africa e vedendomi in rap-porti così stretti con un leader nero daprima pagina del Figaro, mi disse che eramolto orgogliosa di me”.
Ma nel 1967 scatta il meccanismo cheper tutta la vita ha fatto di Denard unquasi eroe da tragedia greca: il fato della“servitude militaire”. A muovere i fili,però, non ci sono gli dèi dell’Olimpo mai funzionari di Rue de Grenelle, il regnodel potentissimo Foccart dove si decido-no i destini degli “Affaires Africaines etMalgaches”. È qui che Denard scopre,suo malgrado, che Mobutu è diventatoscomodo per Parigi, troppo filoamerica-no per potersi fidare: “Mon chère De-nard, bisogna cambiare registro”. Biso-gna puntare su Moïse Ciombè, il leaderseparatista del Katanga e acerrimo nemi-co di Mobuto. La faccenda lo fece im-pallidire, ma Denard dovette inghiottireil boccone e voltare le spalle all’amico diKinshasa: “La politique (et la France),d’abord”. La partita si chiude però maleper i francesi. La battaglia di Kisangani èuna piccola Waterloo, Denard rimediauna brutta ferita alla testa e deve abban-donare il campo. Addio al Congo, manon al patriottismo: ci saranno altre oc-casioni, e l’Eliseo presto chiamerà.
È così che dopo i katanghesi veri, De-nard se la deve vedere con i katanghesidella Sorbona. È il maggio ’68, c’è aria diComune, de Gaulle vacilla sotto i colpidegli studenti. I palazzi del potere ricor-rono a tutti i mezzi pur di contenere larivolta e l’anarchia crescente. Bob De-nard, eroe a mezzo servizio, lascia mitrae jeep per imbracciare secchio di colla emanifesti inneggianti a de Gaulle e al-l’ordine repubblicano. Si sposta con unaDS 21 rossa (la quintessenza dello statussymbol bourge) comprata ai tempi flori-di del Congo: “La volli rossa fiammantecome un tramonto africano”. È scortatoda un paio di “due cavalli” Citroën,quelli con le lamiere ondulate. Un ope-raio del legittimismo. Da eroe esotico aeroe piccolo borghese: fa attacchinaggi“réac” su e giù per i boulevard, mena unpo’ le mani al Quartiere Latino e senteun fremito nel vedere la sfilata della mag-gioranza silenziosa guidata da un Mal-raux che annega la rivoluzione.
Il presente di Denard è scrivere me-morie di battaglie vissute, inventarsi unsito Internet che si chiama Overseas ad-ventures, cantare la bellezza delle suemogli: l’esile vietnamita, conosciuta du-rante la guerra in Indocina, o la passio-nale ebrea sefardita, Giselle Riboh, spo-sata negli anni Cinquanta in Marocco aitempi del protettorato davanti a un rab-bino. Il matrimonio si fece solo alla mor-te del padre di lei, che non avrebbe maiaccettato un genero non ebreo. “Nonche fossi contento di quella morte, manon mi potevo dire neanche afflitto”. Madopo arrivano tante altre donne, biancheo nere, ma “tutte amate, rispettate e dal-
le quali ho avuto tanti figli. No, non misono dimenticato di nessuno. Non credodi aver fatto torto a nessuno, in fondo losapevano io sono fatto così, moi je...”.
Il passato è anche un tentativo di met-tere la testa a posto, un concessionarioCitroën a Bordeaux aperto negli anni 70.Ma non è tagliato per il piccolo cabotag-gio del business e in un paio di anni de-
ve vendere tutto. Meno male che c’èsempre qualcuno dello Sdece (i Servizisegreti) pronto a tirarlo fuori dai guai,come quando la polizia lo arresta con lapesante accusa di concorso in sequestrodi persona, per il rapimento di GeorgesHazan, potente amministratore delegatodella Phonogram. Fece giusto in tempo aidentificare tra le foto segnaletiche unavecchia conoscenza e a rispondere a unpaio di domande con una lampada pun-tata negli occhi, che i Servizi segreti lo fe-cero liberare in quattro mosse: “Avrestedovuto vedere la faccia dei poliziotti”.Ride, Bob Denard, ride composto nel bardel Novotel delle Halles di Parigi, accan-
to al centro Pompidou. Una risata bor-ghese, compiaciuta, nulla a che vederecon la grassa e sguaiata risata che unoStevenson farebbe risuonare nel buen re-tiro di un pirata dell’Isola del tesoro. Quinon scorre rhum a profusione, solo caffèalla francese, un po’ annacquato.
A volte la vita è ironica, chi l’avrebbemai detto che il baroudeur un po’ loscodei Servizi segreti potesse trovarsi a com-battere fianco a fianco con il padre nobi-le dell’intervento umanitario, il dottorBernard Kouchener inventore dei Medi-cins sans Frontières. Accadde in Biafra,alla fine degli anni 60. La Francia soste-neva la secessione del Biafra cristianodalla Nigeria islamica e “ben fornita diarmi da Londra”. Stavolta Parigi seppegiocare bene le sue carte, facendo passa-
re il tentativo secessionista degli ibo bia-frani per un caso umanitario, uno dei pri-mi della storia. Al nostro toccò organiz-zare l’aspetto militare, mentre il giovaneKouchener si fece le ossa come medico.Due eroi senza macchia e senza paura,per i giornali: il guerriero e il dottore checollaborano per salvare un popolo marti-re. Finì come le altre volte: nel ’69 laFrancia decise di mollare, Denard se netornò a casa con 100 mila dollari guada-gnati sul campo. Del Biafra si cessò diparlare, ma l’Africa offriva mille altre av-venture. La decolonizzazione diede lavo-ro ai mercenari per tutti gli anni 70. De-nard è in prima fila. Ormai “l’enigmaticocomandante Bob”, come lo chiamano igiornali, è una vera autorità: croce per lagauche, sempre pronta a scandalizzarsi,delizia per i media affamati di personag-gi da “bande dessinée”.
L’epopea di Bob l’enigmatico, di De-nard il corsaro si è conclusa nella prima-vera del 1999, in una sezione penale deltribunale di Parigi. Con l’imputazione diomicidio del presidente delle Isole Co-more, Abdallah. “Un’accusa ridicola,avevo organizzato io il golpe per farlo an-dare al potere, rovesciando un regimemaoista che stava divorando l’arcipelagodell’Oceano Indiano”. L’ultima impresadi Denard è un colpo di mano degno diKen Follet: siamo nel 1978, un gruppo dimercenari conquista la capitale dell’isola,rovescia il regime e insedia un presiden-te fantoccio, Abdallah, nelle mani di De-nard e di suoi, divenuti la “guardia presi-denziale”. Alla morte di Abdallah, nel1989, Parigi vorrebbe sloggiare Denard echiudere il capitolo, ma tra un imbaraz-zo e l’altro passa un lustro prima che l’or-dine parta davvero. “Non si può nemme-no parlare di resa: era naturale che ese-guissi gli ordini. Abbandonai le Comoree me ne tornai a casa”.
Anche nel ’99 qualche vecchio amicodel Quai d’Orsay l’ha tolto dai guai, il tri-bunale lo ha assolto per non avere com-messo il fatto. Bob Denard esce di scena,se ne va zoppicando: “Sono vecchie feri-te di guerra, ogni tanto si fanno sentire”.Sale su una Citröen Xantia rossa fiam-mante, come un tramonto africano.
Bob Denard, corsaroin Citroën rossa comeun tramonto d’AfricaSergio Cantone
“Sono stato un volontarioeuropeo e l’ho fatto per
avventura e per ideale, hocombattuto per la Francia e contro il comunismo”…La parola “mercenaire”
non gli garba. Denard visto da Denard è tutt’al più
un combattente autonomo che ha sempre avuto
la sensibilità patriottarda
Il ghigno canaglia e l’intesacameratesca con gli amici,
come in un film di Belmondogiovane, affiorano da una foto
sbiadita in bianco e nero…Per un tipo a cui piacciono
cazzotti e guasconate c’è moltoda fare in quegli anni

ANNO VI NUMERO 6 - PAG 3 IL FOGLIO QUOTIDIANO DOMENICA 7 GENNAIO 2001
Valentino Zeichen,poeta quasi postumoin baracca e sandaliCamillo Langone
“Ifunghi secchi non sanno più diniente, subiscono troppi lavaggi.Colpa della gente che non vuole
sentire la sabbia sotto i denti. Ma è pro-prio quella che mi piace: la sabbia dellaclessidra”. In lui, barocco postumo, laclessidra è metafora abituale. Altra me-tafora è il teschio. Altra ancora la colon-na romana giacente a terra, inerte perchétrattenuta “dalla forza/ di gravità storica/più potente dell’analoga/ legge della fisi-ca”. Valentino Zeichen è un nostalgicodell’Impero ma non di quello austroun-garico, proprio dell’Impero per eccellen-za morto e sepolto quattordici e passa se-coli prima della sua nascita. Sembra checerte appartenenze siano più tenaci fra ipoeti della frontiera, là dove incombel’appartenenza altrui. Zeichen è fiumano,vale a dire esule. Il cognome in tedescosta per segno e senza scomodare il no-men omen veste bene un poeta dal gestoattoriale rodato in decenni di letturepubbliche, di cui è riconosciuto campio-ne. Anche le sue poesie sono disegno, lacui secca morale disdegna il colore, inte-so come sentimentale.
Ma di sangue tedesco probabilmentenon ne ha una goccia. La madre, tantoper cominciare, era dàlmata di Spalato. Ilnonno paterno, per continuare, era unorfanello triestino a cui in anni asburgicivenne imposto un cognome tedescofono,forse di un benefattore o forse di inven-zione, puro contrassegno. Ancora piùgrottesco ne risulta il “Zaichen, si dice Z-a-i-c-h-e-n!” ringhiato dalla genia di queicritici che hanno letto tutto ma nulla san-no del criticato, con il quale non hannomai bevuto un bicchiere. E così, a forzadi pronunciarlo alla tedesca, si sono con-vinti che sia poeta mitteleuropeo. Certesue poesie militari hanno dato pretesto ademocratici che confondono Fiume conVienna e Vienna con Berlino di etichet-tarlo come nazista. Pronunciandolo inve-ce all’italiana, come si scrive, Zeichen vie-ne restituito alla sua vera dimensione diimperialista romano.
Nel 1945 molte cose a molte cose dis-sero addio. Sulle rive del Quarnaro, quel-l’anno, morirono sia la mamma sia l’Ita-lia, facendo del nipote dell’orfano triesti-no un orfano al quadrato. Deve sloggia-re, quindi, e scendere a Roma insieme alpadre che a Fiume aveva un vivaio (con-fiscato dagli slavi) e nell’Urbe si adatta afare il giardiniere comunale. Sceglie la li-bertà prima ancora della poesia e si ar-rangia con lavori saltuari, muratore, fat-torino, lavapiatti, verniciatore. Va a vive-re nella famosa baracca di via Flaminia,alloggio schifoso e indirizzo prestigioso,fra la Marina militare e la collina verde diVilla Strohl-Fern. Oggi è più famosa del-la Baita Segantini o della tenda di Nobi-le al Polo, visto che ogni articolo su di luicomincia con la descrizione del pittore-sco abituro. Il risultato è la riduzione acaso umano di un poeta che disprezzacome nessun altro l’umanità, l’umanitari-smo e forse anche l’umanesimo.
Gente che vive in appartamenti ben ri-scaldati ha osato dire che non deve esse-re poi così scomodo, il tugurio: “C’hapure il bagno”. Pariolini e olgiatari han-no messo in giro la voce che sia una scel-ta snobistica, che lo faccia apposta. Bastachiederglielo, il motivo, e lui risponde:“Vivo qui perché non ho soldi”. Conti-nuerà a farlo perché la Bacchelli non vie-
ne data ai poeti eroici, a chi ha sfidato icolleghi lamentosi con l’inno ai maiali in-cursori della Marina da guerra. E co-munque, nel caso, sono già pronti i ma-ramaldi: “Ci doveva pensare da giovane,invece di andarsene a spasso”. Ma Zei-chen non è un grafomane, non sarà maiun operaio dell’Olivetti. Crede nel versoperché è leggero, agile, veloce. È poetapuro come un cristallo, fa solo quello:non insegna, non pontifica sui giornali,non dirige collane, non ha stipendi né si-necure. È la dimostrazione vivente di co-me ci si riduca a fare davvero poesia.
Se ci fosse ancora un bambino che dagrande vuole fare il poeta la mamma do-vrebbe portarlo nella mitica baracca:
“Vedi cosa ti succede se non ubbidisci aigenitori, agli insegnanti, alla televisione”.Zeichen è un paria perché la poesia è unapratica asociale. E nell’editoria poetica,priva di mercato, si galleggia solo se sipossono ricambiare i favori. Tu pubblichime e io poi pubblico te (idem riguardo apremi e recensioni). Zeichen non può ri-cambiare niente e non pubblica più congli editori milanesi. “Ogni cosa a ogni co-sa ha detto addio” lo ha stampato Fazi enel ritorno a Roma del cantore della glo-ria atterrata di Roma ci si può vedere unsegno degli dèi. Non è neanche del tuttovero che non ricambi i favori: questo ar-ticolo mi ha già procurato un invito a ce-na, in baracca, dove ben coperti per viadel freddo si mangerà la pasta di cui vaorgoglioso, quella col sugo ai funghi, as-sieme a qualcuno dei suoi amici, poeti distanza o di passaggio: Daniele Bollea,Claudio Damiani, Lamberto Garzia.
Avendo fatto un’improvvisata oggi c’èsoltanto quella che lui chiama una rata-touille (più o meno una peperonata), daaccompagnare con un bottiglione di vinogiallo e un po’ rancido prodotto nel bas-so Lazio. Di solito, però, è lui a essere in-vitato. Sui giornali quando non gli si dàdel baraccato si punta il dito sullo scroc-cone. Ogni giorno partecipa a una cenadella Roma bene o semibene, in qualitàdi conversatore amabile e di bella pre-senza, oltreché poeta. Le padrone di ca-sa sanno che il suo arrivo alza il tono diqualsiasi serata, senza costare nulla a par-te un piatto di minestra. Le diecimila ce-ne, tante sono, risultano anche occasionedi poesia, come in Marziale. QuandoBarbara Alberti mette in tavola una bot-tiglia di champagne ecco che scrive: “Iconvitati lo assaggiano appena/ per nondanneggiare/ le loro facoltà mentali./ Iome la scolo quasi tutta/ alzando ulterior-mente/ il mio già elevato / quoziente in-
tellettuale”. Oltre ai satirici latini i suoiprecedenti sono secentisti come Ciro diPers, Giacomo Lubrano, Giuseppe Arta-le: “Sono un minore, vengo dai minori”.Pur avendo qualche amico nella poesiacontemporanea (i membri della Confra-ternita del Fungo Secco testé citata) nonha eguali né seguaci. Come Machiavelli aSan Casciano, come Kavafis ad Alessan-dria, Zeichen dialoga di preferenza con imorti. Si aggira per Roma ascoltando levecchie pietre, che a lui solo sembrano
poter dire ancora qualcosa. Le vuole di-fendere dai “neoromani”, indigeni o in-vasori che siano, in ogni caso ormai deltutto alieni: “Straniero, se ti aggiri/ den-tro al Circo Massimo/ guarda dove met-ti i piedi/ e non calpestare l’erba”. Queifili, per via animistica, potrebbero essere“ciò che rinasce/ dell’antica plebe”. Piùpassa il tempo e più vede con precisionela grandezza dell’impero. O ancor megliodell’idea imperiale, il contrario di quellanazionale “suolo e sangue”.
L’ultimo manifesto zeicheniano è “Dei-talianizzare la Romanità”, strappare all’I-talia immeritevole e restituire all’Europail sogno di una civiltà universale conun’unica lingua, un solo diritto e un grannumero di strade che disposte a raggieraconnettono la Capitale al mondo. “Viedel pensiero”, scrive nella dedica chetraccia una colleganza fra chi abita sullaFlaminia e chi abita sull’Emilia, primonucleo di una futura setta di residentisulle consolari. A questo punto anche ilpoeta a-sentimentale si fa prendere dalsentimento della fine e dell’impotenza:“Di un impero che è durato otto secoli,delle gesta e dei sacrifici di milioni di uo-mini, non è rimasto che qualche rudere”.
Affermazioni come questa spiegano ilmalocchio con cui viene guardato dellacritica di potere, che già aveva mal dige-rito “Pagine di gloria” e “Gibilterra”,raccolte fastidiose fin dai titoli. Come giàvisto per Ezra Pound si apprezza la poe-sia ma a patto di distinguerla dal poeta,intorno al quale si organizza una sorta dicordone sanitario. Ma se non vivesse inuna baracca, se non fosse così inerme ecosì misero, non gli perdonerebberoneanche i libri. Senza l’alibi della stram-beria sarebbe scattato il “ma chi si crededi essere”, lastra tombale che viene fattaprecipitare su ogni pensatore in proprio.Poeta francescano (famosi i suoi sandali),Zeichen sa che la libertà passa dalla po-vertà. Senza famiglia e senza impero, or-fano, postumo, esule, ormai può permet-tersi tutto. Parlare di politica internazio-nale, mass media, genetica mentre cercail peperoncino nel bugigattolo che fungeda cucina. Mescolare la verdura sul for-nello da campo e nel contempo elabora-re un nuovo detto che descriva la nostradecadenza: “Noi importiamo brevetti edesportiamo idee umanitarie”. Chiedereche gli si trovi, quando sente che uno vie-ne da Reggio Emilia, non una rara boc-cetta di balsamico ma un catalogo Ca-proni, sugli aerei da combattimento lassùprodotti durante l’ultima guerra. Pretestoper un discorso che dura per tutta la Fla-minia da casa sua a Piazza del Popolo,concluso tra le fontane del Valadier conun Balbo che era sì un eroe e un trasvo-latore e quant’altro ma di aeronauticanon capiva niente. Ah, se Italo avesse sa-puto che l’idrovolante era superato, seMarco Aurelio quell’anno non fosse an-dato a Vindobona, chissà, forse non tut-te le cose ci avrebbero detto addio.
Al Quartiere Latino, Cardarelli abi-tava in una stanzetta dell’Hoteldes Grands Hommes, in piazza
del Panthéon. Era contento dell’albergo,e soddisfatto dell’albergatore, con cuiaveva spesso delle discussioni che poi ri-feriva; commentandole. Per Cardarelli, laparola del suo albergatore era la vocestessa della Francia. Era come se la Prov-videnza, per fargli capire cosa fosse laFrancia, gli avesse mandato quel brav’uo-mo. Spiaceva a Cardarelli che ilPanthéon fosse veramente, in un paese
che si vantava di essere la patria della mi-sura, troppo grande, come l’arco diTrionfo dell’Etoile, gli faceva pensare aun monumento romano rifatto dagliamericani, il più grande in the world.
Il primo incontro con Cardarelli avevadeluso Silvio, il quale talvolta deploravain lui l’irritante vanità del capo ufficio,che dopo può farsi magari in quattro pervoi, ma, per darvi un’idea della sua po-tenza, non vi riceve mai subito. Con Car-darelli bisognava sempre aspettare ch’e-gli decidesse quando potesse o volesse ri-cevervi, e allora egli era come l’usciere dise stesso, uno di quegli uscieri d’una vol-ta, più inaccessibili dei ministri ai qualimontavano la guardia. Poi divennero in-separabili… Una sera raccontò a Silvio diaver ceduto il suo posto nell’autobus aun venerabile vecchio. Un momento do-po, un signore era sceso, lasciando liberoun altro posto, ma nessuno s’era mossoper occuparlo, anzi tutti lo avevano inci-tato con gli occhi a sedere. “Questa”commentava Cardarelli “è la famosa po-litesse francese: rispondere cortesementea una persona cortese. È una questionedi dare e avere, e nient’altro”. Silvioobiettò che questo fatterello poteva piut-tosto citarsi come esempio del senso giu-ridico, sviluppatissimo nei francesi: a
Cardarelli quel posto spettava di diritto,perciò nessuno aveva osato occuparlo. Ilpoeta riuscì a convincerlo che si trattavasoltanto di politesse. Qualche sera dopo,Silvio gli sentì raccontare lo stesso fat-to… “La famosa politesse” disse Silvioalla fine. “No” fece Cardarelli, “è il sen-so del diritto, sviluppatissimo in questifrancesi, che sono tutti avvocati”… Ognitanto, Silvio doveva soffrire di essere trat-tato malissimo.
Pareva allora che il poeta avesse pauradell’amicizia, e persino ribrezzo, come diuna bestia schifosa. “I suoi rapporti congli uomini sono sempre virili, però non sipossono dire freddi. Può sembrarepreoccupato di ristabilire le distanze, manon per vanità; quasi debba ubbidire, co-me un astro, alle proprie leggi di gra-vità”, avrebbe detto Jean.
A Parigi, come a Roma, Cardarelli eraun uomo notturno; a Parigi, poi, perquella sua lentezza pastorale, per quellasua aria esemplare e dimessa, pareva pro-prio una statua, scesa, sull’imbrunire, adiscutere coi vivi; la statua, naturalmen-te, di un grand’uomo, un po’ dimentica-to, forse, in una piazza alberata. E quelsuo indice sempre pronto ad ammonire,ordinava che gli si servisse un caffè inuna tazza, e non in un bicchiere, come siusava a Parigi. Dopo, a poco a poco, co-minciava a rivivere.
Una notte, sul boulevard Saint-Michelvidero una donna seduta su un banco ecome in agguato nell’ombra. Avvicinan-dosi, riconobbero che non si trattava del-la solita vecchia, con il cappellino allaToulouse-Lautrec, il volto tumefatto dal-l’assenzio e il fagotto di stracci sotto ipiedi; ma di una ragazza piuttosto bella.Poteva far pensare a una servetta scam-pata miracolosamente alla famosa trattadelle bianche, e perduta in un quartieresconosciuto; ma, da vicino, la sua miseriaappariva più profonda. Le rivolsero laparola, ma non riuscirono a capire checosa facesse lì, su un banco, a quell’ora.Era veramente una bella ragazza, ma lasua sporcizia, il suo modo di grattarsi legambe e il petto erano spaventevoli; istin-tivamente, sebbene qualcosa in lei atti-rasse fortemente, Silvio e Cardarelli si te-nevano a qualche passo di distanza. For-se era la sua stessa luridezza, veramentemisteriosa in una città come Parigi e inun corpo così fresco e piacevole. Carda-relli le diede qualche franco. Ma era mol-to turbato. Disse: “Io le donne le guardocome potrebbe guardarle un pittore, maun pittore che sapesse, come diceva ilTasso, contentarsi di ritrarre le apparen-ze. Non posso ammettere che si guardi-no in altro modo, le donne”.
Anche quella notte, verso le due o letre, finirono in un locale notturno delQuartiere Latino, tra l’Università e i vi-coletti ciechi e insalubri del sobborgo diS. Giacomo, a qualche passo dalla Borsadelle “cicche”.
Duri e quasi sbirreschi, i passi di Car-
darelli risuonavano sul selciato. Qualchefinestra si chiudeva in un freddo baleniodi vetri. (Una volta, nello stesso quartie-re, Silvio aveva avuto la giacca sollevata,strappata quasi, da un uncino misterioso:un “pescatore” di piccioni municipaliaveva ritirato in fretta l’amo dissimulatoin una grossa mollica di pane).
Ai Noctambules, Cardarelli attendevache si levasse il sole, per poter andarsi acoricare, e parlava della sua paura. Silviocercava di capire che cosa fosse esatta-mente questa sua paura. La sala era uncalderone; l’orchestrina si affannava amuovere in cadenza quella grossa polen-ta di smaniosi. E Cardarelli gli dicevache, la sua, era paura della morte, delfantasma del padre che l’attendeva ognisera sulla porta di casa. Ormai, da anni,non poteva più chiudere gli occhi chenella luce rassicurante dell’alba. A poco,a poco Silvio lo vedeva sbiancare, sul di-vano rosso, sotto gli affreschi della Car-magnola; e non era una sensazione lette-raria: quel volto veramente si disfaceva.A un tratto, e per quanto i suoi proposi-ti fossero più lucidi che mai, egli aveval’impressione di vegliare un morto. Lecoppie dei ballerini si fermavano a guar-dare meravigliate, e un poco anche inor-ridite, quella che, ai loro occhi già turba-ti dal vino e dal continuo rimescolio, do-veva apparire quasi una maschera di ges-so.
Poi risalirono lentamente il boulevard.All’imbocco della via Soufflot, Silvio eb-be l’impressione di lasciare un cadavere.“Voglio farle una confessione” disse ilpoeta, tendendogli la mano. “Se fossi sta-to solo, quella ragazza, nonostante il suosudiciume, me la sarei portata a letto.Nella sua luridezza, era più eccitante d’u-na principessina”.
“Non vuole tornarsene con me, a Ro-ma?” gli aveva chiesto qualche sera dopo
Cardarelli. “A Parigi se in certe cose puòcredersi momentaneamente all’avanguar-dia, in tutte le altre ha vent’anni di ritar-do sui suoi coetanei francesi, che hannosucchiato il genio della Francia dallepoppe materne. La sua felicità non saràmai piena, e così pure la sua infelicità, seè detto che ella debba essere infelice. Siricordi di Goethe: solo a Roma ci si sen-te qualcuno”.
Gualtieri di San Lazzaro, “Parigi era vi-va”, Mondadori
…gli diceva che, la sua, erapaura della morte,
del fantasma del padre chel’attendeva ogni sera sulla
porta di casa. Ormai, da anni,non poteva piú chiuderegli occhi che nella lucerassicurante dell’alba
È la dimostrazione viventedi come ci si riduca a faredavvero poesia. Se ci fosseancora un bambino che
da grande vuole fare il poeta la mamma dovrebbe portarlo
nella mitica baracca: “Vedi cosa ti succede se non
ubbidisci”… Zeichen è un paria perché la poesia
è una pratica asociale
Non è neanche del tutto veroche non ricambi i favori:questo articolo mi ha già
procurato un invito a cena, in baracca, dove ben copertiper via del freddo si mangerà la pasta di cui va orgoglioso,
quella col sugo ai funghi
Vincenzo Cardarelli,statua di grand’uomoinsonne e solitarioGualtieri di San Lazzaro
A Parigi, poi, per quella sua lentezza pastorale,
per quella sua aria esemplare e dimessa, pareva proprio
una statua… E quel suo indicesempre pronto ad ammonire,ordinava che gli si servisse un
caffè in una tazza, e non in un bicchiere, come si usava a Parigi. Dopo, a poco a poco,
cominciava a rivivere

ANNO VI NUMERO 6 - PAG 4 IL FOGLIO QUOTIDIANO DOMENICA 7 GENNAIO 2001
Luciana Castellina•
Nata a Roma nel 1929, è laureata inGiurisprudenza. Ha militato nella Fgci,è stata radiata dal Partito comunista nel’69 col gruppo del Manifesto, è entratanel Pdup, è rientrata nel Pci e infine èpassata a Rifondazione. Negli anni 80 èstata tra gli animatori del movimentopacifista. Giornalista a Paese Sera e alManifesto (membro della direzione), hasuccessivamente diretto Pace e Guerra eLiberazione dal ’92 al ’94. È stata de-putato ed è autrice di vari libri, tra cui“Famiglia e società” e “Che c’è in Ame-rica”. È parlamentare europeo.Michele Anselmi è nato nel 1955. Cri-tico cinematografico, ex giornalistadell’Unità, collabora con Panorama.
Bob Denard•
Nasce a Bordeaux nel 1929. A quindicianni è nella Resistenza, nei primi anni50 volontario in Indocina, poi poliziot-to nel Marocco del protettorato france-se. Torna alla vita civile nel ’58, fa ilmilitante a tempo pieno per i gollisti,poi il rappresentante di elettrodomesti-ci. Nei primi anni 60 si arruola comemercenario e combatte in Congo a so-stegno di Mobutu. Presterà i suoi servi-zi in Africa per un ventennio. Nel ’99 èstato processato per l’uccisione del pre-sidente delle Comore, ma è stato assol-to. Vive a pochi chilometri da Parigi. Sergio Cantone ha 36 anni. Abita aLione, dove è giornalista di Euronews.Si occupa di politica europea.
Valentino Zeichen•
È nato a Fiume nel 1938, vive a Romain una baracca (ormai famosa) sulla viaFlaminia. Negli anni 70 è stato uno de-gli iniziatori in Italia delle letture pub-bliche di poesia. Il suo primo libro diversi è del 1974, “Area di rigore”. Nel1979 esce la seconda raccolta, “Ricrea-zione”. Seguono tra gli altri “Museo in-teriore” (1987), “Gibilterra” (1991),“Metafisica tascabile” (1997). Ha pub-blicato anche un romanzo, “Tana pertutti”. È presente nell’antologia di poe-sia internazionale in lingua tedesca cu-rata da H. Magnus Enzensberger.Camillo Langone è nato a Potenza.Scrive per il Giornale e per la Gazzet-ta del Mezzogiorno.
Gualtieri di San Lazzaro•
Emigrò a Parigi nel 1924 per restare.Lavorò per brevissimo tempo come ga-loppino di un corrispondente di un quo-tidiano milanese. Condivise con gli ar-tisti la bohème di Montparnasse. Tentòsenza successo di diventare mercanted’arte. Riuscì meglio nell’editoria. Nelmarzo del 1938 pubblicò il primo nu-mero di XXe siècle, rivista d’arte desti-nata a fare epoca. Nel 1939 a Parigi siconcluse l’epoca delle riviste e dellabohème. Nel 1949 San Lazzaro vinse ilpremio Bagutta con un libro intitolato“Parigi era viva”. Vi raccontava in terzapersona la vita e la morte della comu-nità artistica di Parigi viste con gli occhidi un suo alter ego di nome Silvio.
Abbas•
Nasce nel 1944 in Iran. Si trasferisce aParigi, da dove parte per fotografare igrandi rivolgimenti politici e sociali delTerzo Mondo. Documenta il genocidio ela carestia in Biafra, la fame nel Ban-gladesh, la guerra in Vietnam, l’a-partheid in Africa del Sud. Dal 1978 al1980 segue in Iran la rivoluzione diKhomeini. Pubblica un libro, lo intito-la “Iran: La révolution confisquée”. Nel1981 entra alla Magnum. Nel 1987 par-te con il proposito di capire i motivi e imodi della rinascita dell’Islam nel mon-do. “Allah O Akbar (Dio è grande): AJourney through Militant Islam” diven-ta un best seller. Nel 1995 si rimette inmoto per dedicarsi al cristianesimo.
IL FOGLIO quotidianoORGANO DELLA CONVENZIONE PER LA GIUSTIZIA
DIRETTORE RESPONSABILE: GIULIANO FERRARACONDIRETTORE: LODOVICO FESTA
L’EDIZIONE DOMENICALE, DEDICATA AI RITRATTI DIPERSONA, È CURATA DA SANDRO FUSINA.
COORDINAMENTO REDAZIONALE: MAURIZIO CRIPPA
SEGRETERIA DI REDAZIONE: MARILENA MARCHIONNE
SOCIETÀ EDITRICE: IL FOGLIO QUOTIDIANO S.R.L. LARGO CORSIA DEI SERVI 3 - 20122 MILANO
TEL. 02/771295.1 - FAX 02/781378
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEPRESIDENTE: GIUSEPPE SPINELLI
CONSIGLIERE DELEGATO: DENIS VERDINICONSIGLIERI: GIULIANO FERRARA,
SERGIO SCALPELLI, LUCA COLASANTODIRETTORE GENERALE: MICHELE BURACCHIO
REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI MILANO N. 611 DEL 7/12/1995ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DELLA STAMPA N. 5160 DEL 29/5/96
TIPOGRAFIA: LITO SUD SRL - VIA DI TOR SAPIENZA 172 - 00155 ROMA;DISTRIBUZIONE SO.DI.P. SPA VIA BETTOLA 1820092 CINISELLO BALSAMO TEL. 02.660301
CONCESSIONARIA PER LA PUBBLICITÀ: MONDADORI PUBBLICITÀ SPACONCESSIONARIA INCARICATA: PRS - PUBBLICITÀ STAMPA EDIZIONI
VIA ENNIO 6/A MILANO, TEL 02.57962.1 - FAX 02.55.01.49.19SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE (45%)
ART. 2 COMMA 20/B LEGGE 662/96 FILIALE DI MILANO
ABBONAMENTI E ARRETRATI: STAFF SRL 02.45.70.24.15VERSAMENTI SU CCP N.43000207 INTESTATI A: STAFF SRL/GESTIONE IL FOGLIO
UNA COPIA L. 2.000 ARRETRATI L. 4.000 + SPED. POST.http://www.ilfoglio.it e-mail: [email protected]
ISSN 1128 - 6164
erano convinti che il Sessantotto fosse ungrande moto anticapitalistico capace dispostare a sinistra gli equilibri sociali. Illoro disegno non si è realizzato, ma biso-gna riconoscere alla pasionaria della ri-voluzione un’esuberanza lucida, e anche,nel fuoco di quegli anni scalpitanti, il co-raggio di misurarsi con un giornalismonon convenzionale.
È Luciana Castellina a intervistareHorst Mahler, il primo terrorista pentitodella Raf, lei a scrivere un libro sull’A-merica, lei a intrecciare le relazioni inter-nazionali più interessanti di un’intera sta-gione politica, con Yasser Arafat e WillyBrandt…
È sempre di corsa, scende e sale dagliaerei, si batte contro piccole e grandi in-giustizie: in Africa finisce trattenuta daisudafricani dell’apartheid sulle rive delfiume Zambesi, a Roma si fa chiudere achiave nell’anticamera dell’ambasciatacecoslovacca per sollecitare la concessio-ne del visto a due anziani coniugi di Pra-ga.
Questo suo attivismo esagerato le atti-ra addosso qualche ironia, c’è chi la rim-provera di essere una “presenzialista chemette insieme con troppa disinvoltural’estremismo gruppettaro e le vacanze aCortina, le spiagge africane e i movimen-ti di liberazione”, e qualcosa di vero for-se c’è; ma all’occorrenza paga di personaquella sua attitudine alla scissione, microo macro che sia, ma sempre sofferta.
Se sul finire degli anni Sessanta la sbat-tono fuori dall’Unione donne italiane(Udi) per aver criticato in un convegno lafamiglia, istituzione sacra anche nel mon-do comunista italiano predivorzista,quattro lustri dopo si ritrova attaccata dasinistra per aver detto: “Meglio stare acasa a fare figli che andare in fabbrica afare mattonelle”. Che cos’è: pentimento,inversione di rotta, piacere della provo-cazione? “Niente di tutto questo”, con-fessa a Sandra Petrignani di Panorama,“ho fatto un’affermazione banalissima,mai avrei creduto di suscitare un tale ve-spaio. Marx non ha mai sostenuto che illavoro fosse liberatorio. È un’idea grettae volgare, una distorsione banalizzantedegli ideali di sinistra pretendere che unadonna si liberi automaticamente andan-do a massacrarsi in fabbrica. Tutto qui”.E se le si chiede se è contenta di esserenata donna, risponde: “Penso che la miavita sarebbe stata più facile se fossi natauomo. Ma, senza togliere nulla alle gran-di conquiste dell’emancipazione, la verasvolta nella storia delle donne è stata l’af-fermazione della propria differenza. Sì,alla fine essere donna mi piace”.
Le piace talmente che, con il passaredegli anni, ritrova la voglia di abbigliarsicon una punta di civettuola femminilità:tailleur in stile Chanel, camicette rosa oviola, spille e collane, scarpe eleganti. Iltono di voce è sempre sbrigativo, comedi chi abbia l’agenda colma di impegni,fosse un tempo l’emendamento in chiaveanti Nato a una mozione congressualedel Pci (nel 1986 diede battaglia federa-zione per federazione, mettendo in diffi-coltà il segretario Natta alla vigilia di unsuo viaggio negli Stati Uniti) e più di re-cente la battaglia contro l’invadenza eco-nomica del cinema hollywoodiano allacommissione Cultura del Parlamento eu-ropeo (nel ruolo di se stessa recita anchein un film, fingendo di litigare con alcu-ni suoi colleghi eurodeputati).
Ma è probabile che anche l’instancabi-le Castellina abbia finito col sentire su disé l’untuosa presenza di un potere gover-nativo di centrosinistra che rifiuta l’uto-pia, i passaggi epocali, e pratica volentie-ri il piccolo cabotaggio o la retorica na-zionale, specie quando c’è da difendereai festival internazionali, a Cannes, Vene-zia oppure Berlino, le ragioni dei nostriautori cinematografici. “Sono delusa, vo-levo cambiare il mondo e non ci sonoriuscita”, diceva in quel film, il cui titolorecita, forse non a caso, “Ça c’est vrai-ment toi”. Fosse o no una battuta del co-pione, meglio di così non poteva rappre-sentarla.
segue dalla prima pagina