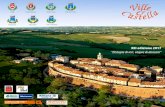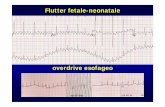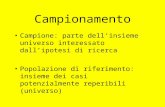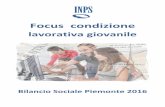· Web viewLa classe, numericamente ridotta e potenzialmente avvantaggiata da una sostanziale...
Transcript of · Web viewLa classe, numericamente ridotta e potenzialmente avvantaggiata da una sostanziale...

Liceo Scientifico di Stato "Nicolò Copernico"Viale Duca degli Abruzzi, 17 25123 Brescia
CODICE MIN. BSPS070005
Anno Scolastico 2017-2018
Brescia, 15 Maggio 2018
Documento del Consiglio della classe
Quinta B(art. 5, DPR 323/98)

INDICE
IL CONSIGLIO DI CLASSE
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE Distribuzione debiti formativiProfilo della classe - Evoluzione della classe
ELENCO ALUNNI
ATTIVITA ’ INTEGRATIVE NEL TRIENNIO - CLIL
SCHEDE PER SINGOLE MATERIE
Lingua e Letteratura Italiana Lingua e Cultura Latina StoriaFilosofiaLingua e Cultura Straniera MatematicaFisicaScienze Naturali Disegno e storia dell ’ arte Scienze motorie e sportive Insegnamento della Religione Cattolica – Attività alternativa SIMULAZIONE della terza prova
Griglia di correzione della Terza Prova
DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
PTOF (sul sito istituzionale del Liceo)
FASCICOLI PERSONALI DEGLI ALUNNI
PAGELLE

IL CONSIGLIO DI CLASSE
DOCENTE FIRMA DISCIPLINA INSEGNATA
CONTINUITÀ DIDATTICA
3^►4^ 4^►5^BORMIOLI GIOVANNI Italiano X X
BORMIOLI GIOVANNI Latino X XVENTURELLI MARIA ANTONIETTA Matematica X X
CURTI ELENA Fisica
PINSI CLAUDIO Filosofia X X
PINSI CLAUDIO Storia X
TERENZI BRUNO Scienze X X
TOSI CARLA Inglese X X
COMINELLI GIOVANNI Disegno X X
ROVIZZI GABRIELE Religione X X
ASCRIZZI VINCENZINO Scienze motorie X X
Per presa visione: i rappresentanti degli studenti
Nome e cognome: BOSIO ALEX NASCIMBENI PIETRO LUCIANO
Firme _____________________ _____________________
NOTE PARTICOLARI:
3

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Classe Numero alunni BES
Provenienti
da altro Istituto
Trasferiti Ritirati Non promossi
TERZA M
14
F
4 2
Totale QUARTA M
14
F
4
Totale
QUINTA M
15
F
4
Totale
PROFILO DELLA CLASSE
La classe, numericamente ridotta e potenzialmente avvantaggiata da una sostanziale continuità didattica nel corso di tutto il triennio, ha saputo sfruttare solo in parte tale situazione. Un gruppo consistente di studenti ha manifestato una ridotta motivazione e un interesse per lo più sporadico e/o settoriale, spesso finalizzato alla valutazione immediata. Pur in una generale correttezza nei confronti degli insegnanti, gli studenti hanno fatto mostra di una persistente difficoltà a creare al loro interno un clima veramente coeso e collaborativo, cosa che ha senz’altro contribuito, oltre alle cause sopra citate, a rallentare il lavoro in più discipline e ha portato anche ad un inevitabile ridimensionamento dei contenuti proposti, della qualità del lavoro svolto e degli obiettivi prefissati. Il profitto conseguito può definirsi senz’altro mediamente sufficiente, sia pure con alcune punte di eccellenza, ma le potenzialità della maggior parte degli studenti sicuramente non hanno avuto modo di affermarsi e valorizzarsi come auspicato all’inizio del corso di studi. Va altresì rilevato che, ad aggravare gli aspetti critici precedentemente richiamati, soprattutto negli ultimi due anni il proliferare di iniziative didattiche e istituzionali di vario genere ha causato una frammentazione e una dispersione dell’attività didattica, cosa che ha determinato ulteriori disagi nel lavoro quotidiano e portato ad una situazione che nell’insieme non ha certo aiutato ad affrontare con regolarità le problematiche emerse.
4

ELENCO ALUNNI
5
N° ALUNNO CREDITO SCOLASTICO 3^ 4^ 5^ Tot.
1 BARTOLOTTA GIORGIA 5 42 BELPIETRO CARLO 6 73 BETELLA RAZIO NICOLA 5 54 BORGHI GIOVANNI 7 75 BOSIO ALEX 4 46 BURLINI ANGELICA 6 67 EPIS MATTIA 4 48 FRASSINE DAVIDE 6 49 GATTA GABRIELE 4 5
10 MALCHIODI ELISABETTA 6 611 MANZONI MATTIA 7 712 MARCHIONI GABRIELE 6 613 NASCIMBENI PIETRO LUCIANO 6 614 NOVELLINI FABIO 5 515 ROSSI PAOLO 6 616 SIGNANI PAOLA 5 517 STATUTO ENRICO 6 618 VALZELLI PAOLO 6 719 ZHENG MATTEO 6 6

ATTIVITA’ INTEGRATIVE NEL TRIENNIO
a.s. classe Viaggi di istruzione
Visite guidate Mostre/eventi
2015/16 3 Settimana bianca
2016/17 4Siena, Monteriggioni, San Galgano e Volterra
2017/18 5 Valencia e Barcellona
CERN Ginevra
Attività di orientamento:
Attività di educazione alla salute: educazione stradale;
Partecipazione a concorsi, stage, attività integrative, ecc.: Laboratori di Biotecnologia Università degli Studi di Brescia;
Disciplina non linguistica in lingua straniera (CLIL): Biotecnologie;
Per il Consiglio di ClasseIl Docente Coordinatore
Prof. _____________________
6

METODI - STRUMENTI DIDATTICI – STRATEGIE DI RECUPERO
Nella tabella sottostante sono indicati con una X le metodologie, gli strumenti didattici e le strategie di recupero utilizzati in ogni disciplina in cui è sottinteso, comunque, l’utilizzo della lezione frontale e interattiva.
Ital
iano
Lati
no
Stor
ia
Filo
sofia
I^ li
ngua
II^ li
ngua
Scie
nze
Mat
emat
ica
Fisi
ca
Dis
egno
e
Stor
ia d
ell’a
rte
Scie
nze
Mot
orie
Relig
ione
METODOLOGIEDIDATTICHE
Lavori di gruppo
X X X
Attività di laboratorio
X
Altro * X XSTRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo X X X X X X X X X XMateriale multimediale
X X X X X X
Materiale fornito dal docente
X X X X X X X X
Laboratorio informatico
X
Laboratorio scientifico
X
Aula di disegno
X
Altro ** XSTRATEGIE DI
RECUPEROCorsi intensivi XPausa didattica
X X
Lavoro personalizzato
X X X
Studiamo insieme
X X
Altro *** X X X X
Altro * _______________________________________________________
Altro ** ______________________________________________________________
Altro *** studio autonomo
RELIGIONE CATTOLICA
7

PREMESSA SULL’INSEGNAMENTO DELLA DISCIPLINA
L'I.RC., con la specificità che gli è propria, condivide con le altre discipline l'obiettivo di promuovere il pieno sviluppo della personalità degli alunni. Gli obiettivi propri sono i seguenti: la comprensione dei fatti religiosi come espressione più tipica della naturale apertura umana al trascendente; la comprensione della necessità della traduzione del senso religioso in una specificaReligione; la capacità di impostare la riflessione su problematiche religiose ed etiche; la capacità di comprendere la complessità del fatto religioso e di esprimerlo con un linguaggio adeguato; la capacità di stabilire collegamenti con le altre discipline
Numero ore annuali previste: 33Numero ore svolte: 30
TESTO IN ADOZIONESolinas, Tutti i colori della vita, Sei ed. Encicliche papali
OBIETTIVI
Individuare il problema etico come orientamento della propria vita in rapporto avalori riconosciuti; conoscere gli orientamenti della Chiesa sull’etica personale esociale, sulla bioetica, sull’etica sessuale ed ambientale.
VERIFICHEUna relazione scritta a quadrimestre insieme con gli interventi in classe.
PROGRAMMA SVOLTONuclei tematici affrontatia) Fondamenti di morale: percezione innata, ancorché generica, della categoria del bene-male; necessità di formazione e di “ educazione “ ;virtù ed habitus ; coscienza , opzione fondamentale , libero arbitrio , legge morale ; differenza dalla legge positiva ; obiezione di coscienza ( es. la Antigone di Sofocle); condizioni della legge morale : l' oggetto e l' intenzione ; autonomiaod eteronomia del sistema morale; i tre postulati kantiani della Ragion pratica; morale laica – morale religios ; l ‘ orizzonte spirituale verso il quale si protende la morale b) Morale sessuale –familiare : il concetto di persona ; anima – corpo ; sessualità , genitalità , sesso ; la banalizzazione del sesso; sessualità e relazione affettiva ; il mito platonico dell’ androgino ; piacere- amore ; il matrimonio come inveramento dell’amore ; amore e progetto divino ; sacramentalità del matrimonio ; la famiglia come Chiesa domestica ; le caratteristiche dell’ amore coniugale cristiano : sensibile e spirituale , totale , fedele ed esclusivo , fecondo ; paternità responsabile ; inscindibilità dell’ unione e della procreazione nell’atto matrimoniale ; rispetto della natura e della finalità dell’ atto matrimoniale ;padronanza di sé ; vie illecite per la regolazione della natalità ; liceità dei mezzi terapeutici ; liceità al ricorso ai periodi agenesiaci ; natura e grazia ;permanenza del vincolo sacramentale nonostante la separazione; dichiarazione di nullità del matrimonio da parte dei tribunali ecclesiastici per vizi concernenti la forma, il consenso e le condizioni soggettive.
c) Bioetica : aborto , eutanasia – accanimento terapeutico , inseminazione artificiale , ingegneria genetica , legittima difesa , guerra giusta , pena di morte .
d) La dottrina sociale della Chiesa : questione operaia nel diciannovesimo secolo ; mercificazione del lavoro ; la posizione mediana della Rerum novarum di Leone XIII tra la visione atea mondanista e quella spirituale puramente ultramondanista : dignità del lavoro e del lavoratore , diritto alla proprietà privata , alla formazione di associazioni private , alla limitazione delle ore di lavoro , al legittimo riposo , al diverso trattamento dei fanciulli e delle donne , al giusto salario , al riposo festivo , monito allo Stato a favore dei più bisognosi e alla ricerca del bene comune : solidarietà sociale e via riformistica . Centesimus annus di Giovanni Paolo II: critica al liberalismo classico e al socialismo, adesione alla democrazia ispirata al raggiungimento della giustizia sociale,destinazione universale dei beni della terra, critica al consumismo, politica come religione secolare, sviluppo integrale dell’uomo , posizione etica sottesa alla questione ecologica , economia non come fine ma come strumento per il bene umano , ancoraggio della libertà alla verità, solidarietà e sussidiarietà , cambiamento dello stile di vita , pace e sviluppo sociale . ITALIANO
8

Numero ore annuali previste. 132 svolte: 122
PREMESSA SULL’INSEGNAMENTO DELLA DISCIPLINA NEL TRIENNIO
Grazie alla continuità didattica mantenuta per tutto il triennio, la classe ha potuto trovarsi nelle migliori condizioni di lavoro, purtroppo talora condizionate in modo non sempre positivo (in un’ottica strettamente relativa alla materia in questione) da fattori esterni, quali impegni di varia natura che hanno in vario modo e in misura crescente coinvolto gli studenti in orario curricolare. Il comportamento nei confronti dell’insegnante e, più in generale, della realtà scolastica è stato corretto, ma il lavoro è risultato improntato troppo spesso ad un interesse e ad un impegno piuttosto limitati e finalizzati per lo più alla valutazione immediata, senza adeguati sforzi di approfondimento e di assimilazione critica dei contenuti proposti. Ridotta in genere anche la partecipazione alle lezioni, ovviamente con le normali distinzioni legate ai singoli. Il profitto conseguito è, nell’insieme, sufficiente, anche se si evidenziano come al solito situazioni molto diverse da studente a studente, connesse soprattutto ad una differente motivazione allo studio. La classe pertanto non ha pienamente corrisposto nel complesso alle aspettative del docente e gli obiettivi didattici ed educativi prefissati possono dirsi mediamente conseguiti, anche se non nella misura sperata.
OBIETTIVI
CONOSCENZE: contenuti e linee di sviluppo della cultura letteraria italiana ed europea tra XIX e XX secolo; elementi di contatto con altri campi del sapere (arte, storia ecc.)
COMPETENZE: padronanza dei mezzi espressivi scritti e orali; sviluppo di un metodo di lavoro volto alla lettura, comprensione e rielaborazione dei contenuti proposti.
ABILITA’: capacità di leggere, comprendere e analizzare in modo autonomo un testo letterario e di Ricondurlo al suo giusto contesto storico-culturale; capacità di riflettere sui contenuti nella loro dimensione storica e in senso diacronico; interdisciplinarietà; sviluppo di una autonoma capacità di valutazione e di esposizione critica.
METODI
Lezione frontale e sollecitazioni al dialogo; riflessione sui testi, con particolare attenzione ai concetti relativi alla dimensione storica e umana degli stessi.
STRUMENTI
Libri di testo e materiale fornito dal docente; audiovisivi e strumenti informatici
VERIFICHE
Nel corso del triennio si sono utilizzate le abituali strategie di verifica scritta (fino a tre per periodo) e orale (una o due, con ricorso anche a prove mirate in forma scritta). In particolare, in vista anche delle prove dell’esame di stato, si è provveduto a presentare agli studenti, per quanto possibile, una vasta gamma di tipologie di verifica, variate sia nei contenuti sia nell’impostazione (analisi testuale, temi argomentativi di vario contenuto, saggi brevi, commenti ecc.), questo tanto in lavori assegnati a casa quanto nel corso dei compiti in classe. Al fine di valutare la conoscenza e la comprensione di determinati argomenti, si sono talora proposti alla classe anche testi di valutazione orale con risposta multipla e/o aperta.
Strategie di recupero adottate: - studio autonomo9

- Interventi individualizzati
Testo in adozione: H.Grosser, Il canone letterario, vol.3 Principato Editore
Altri strumenti didattici: materiale fornito dal docente; audiovisivi, strumenti informatici. Nel corso del triennio si sono fornite indicazioni di letture relative agli argomenti trattati e agli autori in programma.
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
o TRA SETTECENTO E OTTOCENTO (14 ore)
- Alfieri e il motivo anti-tirannico; aspetti del teatro alfieriano (cenni generali)- NEOCLASSICISMO: caratteri e contenuti della cultura neoclassica in Italia e in Europa; Winckelmann e la poetica del Bello Ideale- FOSCOLO: vita e opere; la poetica di F. tra Illuminismo, Classicismo; Pre-Romanticismo; la poesia delle illusioni; il tema della patria e quello del sepolcro; la poesia come immortalità.- da “Ultime lettere di Jacopo Ortis”: tutti i brani presenti sul libro di testo, in particolare: “Il sacrificio della patria nostra è consumato”; la lettera da Ventimiglia. - dai Sonetti: “A Zacinto”, “In morte del fratello Giovanni”, “Alla sera”- dal carme “Dei Sepolcri”: lettura antologica vv.1-25, 91-103, 151-195 e 230-295NB: nel corso della classe quinta si è affrontato in particolare lo studio del carme "Dei Sepolcri" e delle "Grazie"; gli altri argomenti sono stati ripresi come ripasso di quanto anticipato nella classe quarta.
o L’ETA’ DEL ROMANTICISMO (26 ore)
Origini, caratteri e contenuti della cultura romantica in Europa; individualismo, libertà e nazione; la poetica romantica; Il Romanticismo in Italia; la polemica coi Classicisti.
-W.Schlegel: “poesia universale e progressiva” - Mme De Stael: “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni” - P.Giordani: “La risposta di un italiano” - G.Berchet: “Lettera semiseria di G.Crisostomo (Ottentotti e Parigini)
LEOPARDI vita e opere; aspetti del pensiero di L. (razionalismo e ricerca del vero; pessimismo e idea di Natura; teoria del Piacere); la poetica leopardiana - dai “Canti”: “La sera del dì di festa”; “L’infinito”; “A Silvia”; “Il sabato del villaggio”; “La quiete dopo la tempesta”; “Canto notturno di un pastore errante”; “A se stesso”; “La ginestra”(lettura antologica vv.1-14, 37-51, 52-69 e 111-135) - dalle “Operette Morali”: 4 a scelta dello studente tra “Dialogo di Colombo e Gutierrez”, “Dialogo di Torquato Tasso…”; “Dialogo della Natura e un Islandese”, “Dialogo di un venditore di almancchi e un passeggere”,
10

"Cantico del Gallo Silvestre”, “Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie” MANZONI vita e opere; la ricerca del vero tra Illuminismo e Cristianesimo; vero storico e vero poetico; la poesia degli umili e la Provvidenza; caratteri del teatro manzoniano; genesi e contenuti del romanzo “I promessi sposi” -dalle “Odi civili”: “Cinque maggio” - da “Adelchi”: i due cori (“Dagli atri muscosi…” e “Sparsa le trecce morbide…”) -“Promessi sposi”: conoscenza generale dell’opera e dei suoi contenuti
o LETTERATURA DI ETA’ RISORGIMENTALE (3 ore)
Linee evolutive generali della letteratura italiana a metà Ottocento: romanzo e poesia; la crisi del Romanticismo: la Scapigliatura (definizione e contenuti generali)
o L’ETA’ DEL POSITIVISMO (12 ore)
Riflessi letterari del pensiero Positivista in Europa: Naturalismo francese e romanzo sperimentale; il rapporto arte-scienza; caratteri del Verismo italiano.
-VERGA: vita e opere; dal tardo Romanticismo al Verismo; i grandi temi verghiani: religione del focolare, ideale dell’ostrica, la “roba”; poetica della regressione e dello straniamento; il problema della lingua in Verga. Gli studenti dovranno conoscere almeno 5 novelle tratte dalle raccolte “Vita nei campi” e “Novelle rusticane” a loro scelta. Consocenza generale dei due romanzi maggiori (“I Malavoglia” e “Mastro don Gesualdo”) e dei brani riportati sul manuale
o IL DECADENTISMO (10 ore)
La crisi della società e della cultura a fine Ottocento; origine, definizione, caratteri e tendenze delle poetiche decadenti in Europa; il poeta veggente, l’estetismo._ Baudelaire: “Corrispondenze”, “L’ Albatro”PASCOLI la poetica delle “piccole cose” e il senso di mistero del mondo; innovazioni del linguaggio pascoliano; il “nido”- “Lavandare”, “Nebbia”, “L’assiuolo”, “X Agosto”, “Il gelsomino notturno”, “Alexandros” “Il lampo”- Il Fanciullino: la poetica pascoliana; conoscenza generale del brano e dei suoi contenuti
D’ANNUNZIO vita e opere; il rapporto arte-vita in D.; estetismo e superuomo; la poetica “immaginifica”
- da “Il piacere”: i brani riportati sul testo- dalle “Laudi”: “La sera fiesolana, “La pioggia nel pineto”, “I pastori”
SVEVO vita e opere; il nuovo romanzo: la figura dell’”inetto” e il concetto di “malatta”; Zeno e il paradosso dell’esistenza, aspetti della poetica di Svevo: il problema del dilettantismo.Conoscenza dei due romanzi: “Senilità” e “La coscienza di Zeno”; lettura dei brani riportati sul libro di testo.
11

PIRANDELLO vita e opere; relativismo e frammentazione della coscienza; la crisi dell’identità; il tema della mschera nella prosa e nel teatro pirandelliani; il concetto di umorismo.
-da “Novelle per un anno”: 5 a scelta dello studente- dal saggio “Sull’umorismo”. Il “sentimento del contrario”- da “Il fu Mattia Pascal”: i brani riportati sul libro di testo
o LA POESIA DEL NOVECENTO (12 ore)
Le Avanguardie e la ricerca di nuive modalità espressive; la “destrutturazione della poesia”
UNGARETTI: tecnica e poetica; “l’uomo di pena”, il tema della guerra e l’ansia di vita-“Veglia”, “S.Martino del Carso”, “I fiumi”, “Fratelli”, “Il porto sepolto”, “L’isola”
MONTALE il male di vivere e “l’anello che non tiene”; il senso del nulla; la poetica di M.-“I limoni”, “Spesso il male di vivere…”, “Non chiederci la parola”, “Forse un mattino…” “Ti libero la fronte dai ghiaccioli”, “La casa dei doganieri”, “Ho sceso dandoti il braccio”
IL FUTURISMO ( 1ora)Motivazioni, contenuti e finalità del movimento; il “Manifesto della letteratura futurista”;confronti con l’arte futurista ed esempi di “testi” della poesia futurista.
ERMETISMO (2 ore)Definizione e caratteri della poesia ermeticaQUASIMODO: “Vento a Tindari”, “Ed è subito sera”
DANTE Divina Commedia, ParadisoStruttura e contenuti generali della cantica.Lettura e analisi canti I-III-VI; i canti XV-XVII e XXXIII (causa riduzione del tempo disponibile rispetto alla programmazione iniziale) sono stati affrontati in modo sintetico, solo a livello di contentuti generali
IL ROMANZO DEL NOVECENTO Pavese e CalvinoLo studio degli autori si è limitato ad una presentazione generale dei contenuti e dei caratteri principali della loro produzione, anche sulla base delle indicazioni di lettura avvenute nel corso degli anni
LATINO
Numero ore annuali previste 66 svolte 56
12

PREMESSA SULL’INSEGNAMENTO DELLA DISCIPLINA NEL TRIENNIO
La classe ha goduto di continuità didattica per tutto il triennio, ma questo vantaggio non ha tuttavia consentito di rendere meno difficoltoso il lavoro e di conseguire pienamente gli obiettivi didattici ed educativi prefissati. L' impegno e l’ interesse per gli argomenti proposti sono apparsi per lo più limitati e discontinui, cosa che ha indotto l’insegnante a operare delle scelte precise, volte a cercare di rendere più accettabile una materia di per sé guardata talora con diffidenza, limitando ad esempio allo stretto necessario lo studio degli aspetti più strettamente linguistici e, nel corso dell’ultimo anno, lasciando decisamente più spazio allo studio degli autori in traduzione, restringendo la lettura dei testi in lingua agli esempi ritenuti più significativi. Il profitto medio risulta comunque più che sufficiente, con esempi anche di una rendimento decisamente apprezzabile, ricordando peraltro che gli studenti sono stati più volte impegnati in attività di istituto (anche importanti) rivolte a campi di studio completamente diversi, cosa che ha senz’altro in parte condizionato la continuità e la qualità del lavoro e dell’applicazione nella disciplina.
OBIETTIVI
CONOSCENZE: conoscenza degli aspetti fondamentali della lingua latina; figure e concetti principali della cultura latina in età imperiale; elementi di continuità con la cultura moderna; COMPETENZE: capacità di leggere, analizzare, comprendere (almeno in generale) e tradurre un testo latino; capacità di contestualizzare i contenuti nel relativo panorama storico- culturale ABILITA’: capacità di leggere e utilizzare in modo attivo e consapevole i contenuti di un testo letterario; capacità di stabilire confronti sincronici e diacronici; capacità di esprimere valutazioni critiche; interdisciplinarietà. METODILezione frontale e dialogica; interventi sollecitati e/o spontanei; analisi guidata dei testi. Utilizzati i libri di testo, con particolare attenzione ai brani in traduzione. Particolare attenzione è stata rivolta al contesto storico-culturale.
STRUMENTILibro di testo, materiali forniti dal docente; ampio utilizzo di strumenti informatici
VERIFICHETraduzioni dal latino per verifica delle competenze linguistiche (3), esercizi di analisi e comprensione del testo (3) domande a risposta breve per valutazione delle conoscenze (3)
Strategie di recupero adottate: - recupero in orario curricolare - studio autonomo e individualizzato
Testo in adozione: Togata gens, vol II; a cura di M.Bettini, La Nuova Italia
Programma effettivamente svolto
o LA CULTURA DI ETA’ GIULIO-CLAUDIA (3 ORE)
13

L’involuzione culturale della prima età imperiale: motivazioni e tendenze generali; la letteratura da Ottaviano a Claudio (inquadramento generale), tra conformismo e tecnicismo.
o LETTERATURA DI ETA’ NERONIANA (14 ORE)
Caratteri e contenuti della politica culturale di NeroneSENECA: vita e opere; la filosofia di Seneca tra impegno politico e ricerca della virtus; la riflessione sul tempo; l’idea di libertà; i “Dialoghi” e le Epistole a Lucilio; il teatro di Seneca: “Fedra” - dal de Clementia: “Uno specchio per il principe” p.52 in traduzione- dal de Brevitate Vitae: “Siamo noi che rendiamo breve la vita” p.71 in traduzione- “Servi sunt, immo homines” p.89 (paragrafi1-3); p.92 paragrafi 10-13- "Vindica te tibi" (Ep. A Lucilio 1.1) p.73 in latino
LUCANO: ideologia e poetica; il modello anti-virgiliano dell’epica lucanea; il titanismo. Caratteri e contenuti del poema “Pharsalia”-“ la maga Erittone”: la necromanzia p. 126 in traduzione
o IL ROMANZO LATINO (16 ORE)
PETRONIO: i precedenti greco-ellenistici; la questione petroniana Struttura, contenuti e problemi del Satyricon: realismo e parodia; la società di Petronio.-dal Satyricon: “La matrona d’Efeso”; episodi della cena di Trimalchione riportati sul testo; Il lupo mannaro; Dama e la lingua dell'ubriaco (in lingua)
APULEIO: vita e opere; il concetto di “magia” e le novità della cultura del II secolo; caratteri e contenuti delle opere principali (De magia; Metamorfosi); confronti con Petronio.- l’inizio del romanzo (in lingua); La favola di amore e Psiche: brani sul libro di testo
o LA SATIRA IN ETA’IMPERIALE (3 ORE)Caratteri e contenuti della produzione satirica imperiale; confronti con autori precedenti; Persio e Giovenale (in generale)-“Choliambi” di Persio
o CRISI DELL’ORATORIA E PROBLEMI DELL’EDUCAZIONE (8 ORE)La cultura a Roma e il ruolo della retorica; cause e conseguenze della crisi del sistema educativo; le risposte degli intellettuali attraverso le riflessioni di Petronio, Quintiliano, Persio, Tacito.QUINTILIANO e la Institutio Oratoria; contenuti, struttura e finalità dell’opera; il modello educativo di Quintiliano; il rapporto con la cultura greca.- vantaggi dell’apprendimento collettivo p.189 in traduzione- "L'insegnante ideale" - " Basta con le punizioni corporali" pag. 192 in traduzione- il giudizio sulla satira latina in lingua
14

o LA SOCIETA’ ROMANA TRA I E II SECOLO (10 ORE)Dagli imperatori Flavi agli Antonini: il nuovo volto dell’impero.
TACITO: vita e opere; caratteri e contenuti della storiografia di Tacito; la riflessione su Principato e libertà; il ritratto tacitiano; Roma e i barbari. -letture antologiche da “Agricola” e “Historiae” - "Finalmente si torna a respirare" (in lingua su file trasmesso agli studenti) - Agricola governatore della Britannia - Il discorso di Calgaco p.266 in traduzione - i discorsi di Galba (in traduzione), di Giulio Civile e di Ceriale (su file trasmesso agli studenti) - la “sincerità genetica” dei Germani p.270 in traduzione
o LA FINE DELLA CULTURA PAGANA (5 ore)Caratteri e tendenze della letteratura latina nel tardo impero (quadro generale); il confronto con il Cristianesimo: tendenze della cultura latino-cristiana (apologetica, patristica, poesia) e gli ultimi esempi della letteratura pagana (la disputa sulla Vittoria).Nel corso dell’anno si sono riservate alcune ore ad attività rivolte al ripasso e all’analisi di testi in lingua, nonché alla discussione di problematiche generali relative ad argomenti studiati (es. il carattere sovranazionale dell’impero, i rapporti con le altre culture, il metodo storiografico ecc.)
Il docente G.Bormioli
15

LINGUA E LETTERATURA INGLESE
Numero ore annuali :99Numero ore svolte: 80
STRUMENTI
Testi:- Only Connect .. New Directions edizione blu 1 -2- ed. Zanichelli-Dizionario monolingue e bilingue- Fotocopie con altri testi*
OBIETTIVI
-Listening: comprendere testi autentici, le presentazioni e le integrazioni dell’insegnante sulla storia della letteratura e sui brani letterari.-Speaking: trattare argomenti di carattere generale, relazionare su argomenti precedentemente trattati, saper analizzare testi noti, presentare gli autori, collocarli nel periodo storico e nel movimento letterario, saper operare collegamenti con altre discipline usando una lingua corretta ed appropriata.-Reading: comprendere testi letterari individuandone il senso globale e le informazioni secondarie.-Writing: saper redigere relazioni su argomenti trattati, parafrasi di testi poetici, riflessioni di carattere personale, usando una corretta impostazione grammaticale, esponendo il proprio pensiero in modo logico ed esauriente.
METODOLOGIA
L’attività didattica è stata svolta in lingua , ove possibile, e si è ricorso sia a lezioni frontali che ad attività di carattere comunicativo. Per le attività di ascolto e di lettura è stato utilizzato solo materiale autentico.Lo studio della letteratura è stato affrontato partendo dal testo e dalla sua decodifica, mettendolo in relazione con altri aspetti del sistema letterario anglosassone e non.
PROGRAMMA SVOLTO
LetteraturaAnalisi dei generi letterari e autori nel loro contesto storico:
THE ROMANTIC AGEHistorical and Social contextRomantic PoetryThe Gothic Novel
William Blake:LondonThe LambThe TygerThe Chimney Sweeper (from Songs Of Innocence)The Chimney Sweeper (from Songs Of Experience)
Mary Shelley:-Frankenstein, or the Modern PrometheusWalton and FrankensteinThe Creation of the Monster
William Wordsworth: DaffodilsComposed Upon Westminster Bridge
16

Samuel Taylor Coleridge:-The Rime of the Ancient Mariner:The Killing of the AlbatrossDeath and Life-in- DeathThe Water SnakesA sadder and wiser man
Edgar Allan Poe:The Tell-Tale Heart*Annabel Lee*
THE VICTORIAN AGEHistorical and Social context The Victorian AgeThe Victorian CompromiseThe Victorian frame of mindThe American Civil WarThe Victorian NovelAestheticism and Decadence
Charles Dickens:-Oliver Twist:Oliver wants some moreThe enemies of the System- From Hard Times :Coketown (only the text)
Robert Louis Stevenson:-The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde:The story of the door*Jekyll’s Experiment
Oscar Wilde:-The Picture Of Dorian Gray:Dorian’s death
THE MODERN AGEHistorical and Social contextThe Edwardian AgeTwo World Wars and AfterThe United States between the Two WarsThe Age of anxietyThe Modern Novel and the Stream of Consciousness
The War Poets- R. Brooke The soldier-W. Owen Dulce et decorum est-S. Sassoon Suicide in the trenches-I. Rosenberg Break of day in the trenches*
Wystan Hugh AudenRefugee Blues*
James Joyce:-Dubliners:EvelineShe was fast asleep (The Dead)
17

George Orwell:-Animal farm: Old Major’s speech
-Nineteen Eighty-Four:This was London*Newspeak
VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica informale è stata continua, attraverso il controllo dei compiti assegnati per casa ed attraverso l’osservazione sistematica delle attività svolte in classe.Le verifiche formali sono state conversazioni sugli argomenti letterari svolti , analisi e commenti di testi letterari attraverso questionari a risposta aperta, in totale 5 scritte e 3-4 orali.La valutazione ha tenuto conto dei seguenti criteri:Orale- correttezza fonetica- correttezza grammaticale- scioltezza dell’esposizione- comprensione di un testo autentico (globale e nei dettagli)- conoscenza nozionistica- capacità di analisi testuale e critica
Scritto- correttezza ortografica- correttezza grammaticale- competenza testuale- capacità di analisi testuale e critica
CRITERI DI VALUTAZIONELa seguente tabella fornisce una struttura di riferimento per una griglia di valutazione.
Voti Conoscenza Comprensione ApplicazioneCapacità di
comunicazione ed espressione
1/2/3Nessuna conoscenza
o conoscenze gravemente errate
Non ha alcuna capacità di comprensione
Non riesce ad applicare conoscenze minime
Si esprime in modo sconnesso o
gravemente errato
4Conoscenze
frammentarie e lacunose
Commette errori diffusi Commette gravi errori nell’applicazione
Si esprime con difficoltà ed usa un lessico improprio
5
Conoscenze carenti e superficiali
Commette qualche errore anche nell’esecuzione di
compiti semplici
Sa applicare le conoscenze in compiti semplici, ma
commette errori
Manifesta improprietà
linguistica ed incertezze
6Conoscenze
complete con qualche
imperfezione
Sa cogliere il senso ed interpretare correttamente i contenuti di informazioni
semplici
Sa applicare le conoscenze semplici senza errori
Espone in modo semplice, ma corretto
7
Conoscenze complete ma non
approfondite
Sa interpretare e ridefinire un concetto
Sa applicare le conoscenze anche in compiti complessi
ma con imprecisioni
Si esprime con proprietà linguistica
8 Conoscenze complete e
Sa cogliere implicazioni e determinare correlazioni,
Sa applicare i contenuti anche in compiti complessi
Espone in modo fluido e con proprietà
18

approfondite ma incorre in imprecisioni ed in modo corretto linguistica specifica
9/10
Conoscenze complete,
approfondite ed ampliate
Sa cogliere implicazioni e determinare correttamente
correlazioni
Sa applicare i contenuti anche in compiti complessi
in modo autonomo e critico con
approfondimenti
Espone in modo fluido e con un lessico ricco ed approfondito
L’insegnante Carla Tosi
19

STORIA
PREMESSA SULL’INSEGNAMENTO DELLA DISCIPLINA NEL TRIENNIO
La classe ha seguito le attività didattiche con attenzione e interesse non sempre costanti e lo studio è risultato a volte non ben curato. Il profitto è stato mediamente più che sufficiente e buono in limitati casi.Nello svolgimento del programma si è cercato anche di evidenziare i collegamenti con le vicende contemporanee).
Numero ore annuali previste: 66 (33 x N°2 ore settimanali della disciplina)
Numero ore svolte: 65 (comprese le ore destinate a verifiche e interrogazioni)
TESTO IN ADOZIONEA. F. M.Feltri, M. M. Bertazzoni, F. Neri: Chiarosuro, vol 3, Sei, Torino 2011.
OBIETTIVI- Conoscere e comprendere i contenuti disciplinari.- Sapere operare sui documenti per ricavare criticamente informazioni. - Comprendere la dimensione storica del presente, e saper usare l'esperienza acquisita con lo studio del passato per interpretare la complessità del mondo contemporaneo. - Acquisire sensibilità verso le differenze culturali e sociali, attraverso la conoscenza di altre epoche e altre visioni del mondo, anche fuori dal mondo occidentale.
VERIFICHEInterrogazioni orali (almeno una per periodo); test scritti a risposta aperta, (almeno una per periodo più eventuali recuperi)
MODALITÀ DI RECUPEROStudio autonomo
20

PROGRAMMA SVOLTO
I caratteri dell'ultimo quarto dell'OttocentoGrande crisi e rivoluzione industrialeLa società di massaIl colonialismo e la corsa alle coloniela società italiana in epoca liberale
L'età giolittianaLa politica di Giolitti (modernizzazione italiana)La guerra di LibiaIl suffragio universale e il ritorno dei cattolici in politicaLa crisi del sistema di potere giolittianoSalandra e la settimana rossa
Aspetti della politica internazionale agli inizi del secoloGuerra russo-giapponese del 1905La situazione dell'area balcanica
La Prima Guerra MondialeIl sistema delle alleanze e le cause della guerraDa Sarajevo all’estensione del conflitto. La guerra in trincea; le nuove armiL’intervento americano e il programma del presidente Wilson. La fine dell'impero Ottomano. La pace di Parigi e la nuova carta geopolitica. La Società delle Nazioni
L’Italia e la Grande GuerraIl Patto di LondraL’ingresso in guerra dell’Italia (neutralisti e interventisti)La spedizione punitivaLa disfatta di CaporettoVittorio Veneto
La Russia e la rivoluzioneL'arretratezza dell'impero russo e processi di modernizzazione dall'alto. Nicola II e la rivoluzione del 1905. Lenin, i soviet e il partito bolscevico.1917: da Febbraio a Ottobre. La presa del potere dei bolscevichi.La guerra civile.
L'Unione SovieticaIl Comunismo di guerra.e la NEP.L’ascesa di Stalin.La III Internazionale e i partiti comunisti.Il sistema del Gulag (eliminazione dei Kulaki)I piani quinquennali
Economia e società tra le due guerre: gli anni ventiGli Stati Uniti: dal governo democratico ai governo repubblicani La repubblica di Weimar dalla crisi alla stabilizzazione
Il primo dopoguerra in ItaliaCrisi del sistema giolittiano. L’impresa di Fiume. Il biennio rosso e l'occupazione delle fabbriche. I nuovi soggetti politici: il Partito Popolare, Il Partito Comunista e il movimento fascistaLa “rivoluzione parlamentare”
Il fascismoMussolini. Il Movimento di Piazza San Sepolcro (il manifesto del movimento).
21

Lo squadrismo. Il fascismo agrarioGoverno Facta e Marcia su Roma.Il delitto Matteotti e l'AventinoIl fascismo come regime. I rapporti con la Chiesa e i Patti LateranensiLa politica sociale e culturale del fascismo.Il fascismo e l’economia: dalla ‘battaglia del grano’ alla ‘quota 90’
La crisi mondiale e il nazismoLa speculazione, il grande crollo del ‘29 e la crisiLe prime misure liberiste contro la crisi in AmericaIl coinvolgimento europeo nella crisi (le difficoltà in GermaniaLa risposta alla crisi in Europa (liberismo interno e protezionismo esterno).Il New Deal di F.D. Roosevelt. L’ascesa di Hitler: il putsch del 1923 a MonacoEsiti delle votazioni dal 1918 al 1932La costruzione del regime nazista1933 - 1934. La politica interna La politica estera
Relazioni internazionali negli anni '30: verso il secondo conflitto mondialeL’imperialismo italiano; la guerra d’Etiopia e le sanzioniIl sistema delle alleanze da Locarno a Monaco.Il 7° congresso del Comintern e i fronti popolariLa guerra civile in SpagnaLa conferenza di Monaco 1938 e l’appeasement L’espansionismo nazista e il patto russo-tedesco.
La Seconda Guerra MondialeL’attacco alla PoloniaLa conquista dell'Europa occidentale e la Francia di VichyLa battaglia d'InghilterraL'attacco alla Russia (operazione Barbarossa). StalingradoGli Stati Uniti in guerra; Pearl Harbour e lo scontro con il GiapponeLo sbarco in Normandia e la sconfitta della GermaniaFine della guerra
L'Italia in guerraLa guerra parallela dell’Italia fascistaGli insuccessi nei Balcani e in AfricaLo sbarco in Sicilia e la caduta del fascismoL'8 Settembre 1943 (armistizio e fuga del re)Il regno del Sud e la repubblica di Salò La Resistenza italiana
L'antisemitismo e la ShoahL'antisemitismo: il boicottaggio delle attività degli ebreiLe leggi razziali in Germania e in ItaliaLa notte dei cristalli l'incontro di Wannsee e la Soluzione Finale.
Il Secondo dopoguerraGli incontri interalleati dalla conferenza di Casablanca a quella di PotsdamLa nascita dell’ONU. Conferenza di Bretton Woods 1944
Il mondo diviso: lo scontro tra i due blocchiFine della ‘grande alleanza’; la Cortina di ferroLa guerra fredda e la divisione dell’Europa (la sovietizzazione dell'Europa orientale)Dottrina del contenimento di Truman e piano MarshallIl primo blocco di Berlino (1948)Le due GermaniePatto Atlantico, NATO, Patto di VarsaviaGli anni della coesistenza pacifica: Kruscev, il XX congresso del partito comunista e Kennedy
22

1956: l'anno della prima crisi interna al sistema sovietico La seconda crisi di Berlino e la costruzione del muro)La crisi di Cuba e la salita al potere di BreznevGli anni della distensione e la primavera di PragaIl 1989: il crollo del sistema sovietico (la Polonia di Lech Walesa e la Cecoslovacchia di Vaclav HavelLa crisi dell'URSS: da Breznev a PutinGli USA e la seconda guerra fredda (il presidente Reegan)
Le decolonizzazione: linee essenzialiLa carta della colonizzazione europea in Asia e AfricaI primi movimenti tra le due guerreIntreccio di processi di liberazione nazionale e la Guerra FreddaLa decolonizzazione in Asia: India di Gandhi, la questione pakistana, Indonesia e Indocina (le due guerre del Vietnam)La decolonizzazione in Africa (diversità di condizioni, le tre aree del continente africano)Il terzo mondo e i l movimento dei paesi non allineatiProblemi dopo la conquista dell'indipendenza (neocolonialismo)
L’Italia del secondo dopoguerraL’Italia dopo la sconfitta: condizioni materiali e moraliLe forze politiche Nascita della repubblica. La Costituzione La crisi dell’unità antifascistaI periodi e gli eventi più significativi della storia repubblicana
23

FILOSOFIA
PREMESSA SULL’INSEGNAMENTO DELLA DISCIPLINA NEL TRIENNIO
La classe, alquanto vivace, ha seguito l’attività didattica con sufficiente attenzione e, in qualche caso, anche con un certo interesse. Si è privilegiato, considerate anche le caratteristiche della classe, un approccio alla disciplina più semplice e aderente al manuale. Sono state effettuate anche letture di passi antologizzati nel manuale o reperiti n internet. Infine una certa attenzione è stata dedicata alla ricostruzione biografica e storico contestualeL’applicazione allo studio degli argomenti disciplinari e il profitto sono risultati in media più che sufficienti, ma spesso non costanti.
Numero ore annuali previste: 99 (33 x N° 3 ore settimanali della disciplina)
Numero ore svolte: 78 (comprese le ore dedicate a verifiche orali e scritte)
TESTO IN ADOZIONEN. Abbagnano, N. Fornero, La filosofia, Paravia, Milano 2010, voll. 2B, 3A, 3B
OBIETTIVI- Conoscere e comprendere i principali contenuti disciplinari- Individuare la struttura argomentativa dei testi filosofici (contesto, problematica, proposte di soluzione, linee argomentative, implicazioni)- Saper confrontare modelli di risposta diversi- Sapere ricostruire percorsi tematici significativi- Impadronirsi di strumenti concettuali per interpretare razionalmente le diverse forme di dibattito scientifico, etico e politico contemporaneo - Realizzare la comprensione del linguaggio filosofico e della interdisciplinarietà da questo sottesa.
VERIFICHEAlmeno 5 verifiche (due nel primo periodo e tre nel secondo) distinte in:a) interrogazioni orali, almeno una per periodo; b) verifiche scritti a risposta aperta, almeno una per periodo più eventuali recuperi
RECUPEROstudio autonomo
24

PROGRAMMA SVOLTO
Introduzione alla filosofia dell’idealismo tedescoRomanticismo e idealismo (linee essenziali)
George W.F. Hegel Il giovane Hegel : la questione religiosa (ebraismo e cristianesimo ;
I capisaldi del sistemaLa Fenomenologia dello Spirito:
La struttura dell'opera (analogie con il romanzo di formazione, la coscienza come protagonista La coscienza: certezza sensibile, la cosa o la percezione, forza e intelletto L’autocoscienza: servo e signore, scetticismo, stoicismo, coscienza infelice La ragione osservativa: linee essenziali La ragione che agisce: linee essenziali
Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio la dialettica idea, natura e spirito: linee essenziali la dialettica: logica, filosofia della natura e filosofia dello spirito Filosofia della natura e scienze empiriche
I Lineamenti di filosofia del diritto: Lo spirito oggettivo : Il diritto astratto: contratto, violazione del contratto, pena La moralità (le critiche alla filosofia di Kant) L’Eticità: famiglia, società civile, stato.
Le Lezioni sulla filosofia della storia: ▪ La concezione generale della storia (confronti) ▪ Gli individui e l’astuzia della ragione ▪ Lo spirito del mondo
GLI ANTI HEGELIANIConsiderazioni generali Il rifiuto dell'astrattezza hegeliana e la rivendicazione del concreto, reale
1) Arthur SchopenhauerL’apertura al pensiero orientaleIl Mondo come volontà e come rappresentazione:
Influenze di concezioni dualistiche Il fenomeno come velo di Maya (apparizione come inganno) Dal velo di Maya alla volontà di vita tramite il corpo La volontà e le sue caratteristiche Il pessimismo cosmico. Le vie della liberazione e il ruolo dell’arte.
2) Soren KierkegaardL'anti- hegelismo: il rifiuto del sapere sistematicoIl programma filosofico (una filosofia per la vita)La questione della comunicazione indiretta (il ricorso agli pseudonimi e il metodo socratico)Gli stadi della vita (estetico, etico e religioso)Angoscia, disperazione e fede
3) Sinstra hegeliana e FeuerbachIl dibattito sull'eredità di Hegel tra sinistra e destra: la dialettica e la religione Feuerbach e l’Essenza del cristianesimo
le critiche a Hegel: il rovesciamento dei rapporti di predicazione25

la pars destruens: l'alienazione religiosa (caratteri, origini, funzione storiche, prospettive la pars costruens: materialismo, ateismo, umanismo, filantropia, sensazione e amore, relazione
con l'altro) la dimensione corporea
4) Karl Marx Il giovane Marx
La critica al misticismo logico hegeliano Le critiche all'economia borghese Le critiche a Feuerbach
I Manoscritti economico-filosofici Il lavoro estraniato (concetto di alienazione: filosofi a confronto)
Il ManifestoBorghesi e proletari (lettura integrale)
la concezione della storia il ruolo storico della borghesia la legge del rispecchiamento le contraddizioni del sistema capitalistico il proletariato e il suo ruolo rivoluzionario
L'Ideologia tedesca: La concezione materialistica della storia Modo di produzione, forze e rapporti di produzione Ideologia e mistificazione Struttura e sovrastruttura
Il Capitale, primo libro. La teoria del valore-lavoro Il plusvalore La caduta del saggio di profitto e la crisi.
Prospettive verso il futuro l'obiettivo finale (il socialismo) l'obiettivo intermedio (la dittatura del proletariato
IL POSITIVISMO: FILOSOFIA E SCIENZA 1 Caratteri generali:
Origini e significato del termine « positivo » Il compito della filosofia di fronte al sapere scientifico confronto tra Positivismo, Romanticismo e Illuminismo
2) August ComteIl Corso di filosofia positiva:
La legge dei tre stadi, La classificazione delle scienze, La sociocrazia.
LA MARGINALIZZAZIONE DELL'UOMO1) Charles DarwinIl concetto di Evoluzione e la sua storia in ambito biologico(Lamarck e Paley -teoria del disegno intelligente)I motori dell'evoluzione e il ruolo dell'ambiente (Malthus e la demografia) I limiti : l'ignoranza della geneticaLe implicazioni filosofiche :
naturalismo e rifiuto del creazionismo sovrannaturale antropologia : naturalizzazione dell'uomo e critica alla concezione del salto ontologico episteomologia : fondamento dell'esperienza, ipotesi ad hoc, valore della previsione, il neo
darwinismo, l'evoluzionismo come programma di ricerca
26

2) Friedrich NietzscheLa sperimentazione della scrittura (aforisma)a) La critica alla civiltà occidentale come chiave di lettura del pensiero di NietzscheLa Nascita della tragedia:
Spirito apollineo e spirito dionisiaco Socrate come fondatore della civlità occidenale
Sull’utilità e il danno della storia per la vita- L'uomo occidentale e il suo difficile rapporto con la storia (l'uomo, la pecora, sette capretti e il
greco antico)- i modelli di storia
La gaia scienza- L'esito della storia della civiltà occidentale: il nichilismo- La morte di dio (L'annuncio dell'uomo folle: analisi del testo)
Il crepuscolo degli dei- Come il mondo vero divenne favola (Lettura e analisi dell'aforisma)
b) Le dottrine positiveCosì parlò Zarathustra
- Oltreuomo (confronto tra le due espressioni oltreuomo e superuomo) - eterno ritorno e il superamento della concezione edipica del tempo (lettura e analisi La visione e l'enigma). - La volontà di potenza- Il prospettivismo e la scienza
3) Sigmund Freud e la psicoanalisiGli inizi: la scoperta dell'inconscioLa struttura dell'inconscio : prima e seconda topica e loro confronto (Lettura l'Es)L’Interpretazione dei sogni: l’accesso all’inconscioLa teoria della sessualità: la libido, le fasi di fissazione della libidoIl complesso di EdipoPsicoanalisi dell'arte: la sublimazioneLe nuove prospettive : Eros e thànatos, il disagio della civiltà
Karl PopperLa logica della scoperta scientifica: il criterio di falsificabilità, il metodo della scienza, il rifiuto dell’induzione
Matematica27

Premessa sull’insegnamento della Disciplina nel QuinquennioCome concordato nel Piano di lavoro comune del Dipartimento di Matematica di Istituto, poiché nell’educazione matematica è fondamentale porre problemi e prospettarne soluzioni, sin dalla Classe Terza, per ciascun argomento trattato, ho posto come naturale conclusione la modellizzazione della realtà. Al tempo stesso, però, ho voluto conciliare l’aspetto problematico con quello sistematico, intrecciando momenti in cui si proponevano problemi con ricerca di soluzioni ad altri momenti di mera esercitazione affinché gli studenti raggiungessero sicurezza e padronanza delle regole sintattiche del calcolo. Nella didattica ha avuto particolare attenzione il formalismo.
Numero ore annuali previste: 165 (33 settimane per 5 ore settimanali della Disciplina)Numero ore svolte sino al 15.05.18: 148 (di cui 5 di stage)Si prevedono, entro la fine dell’anno scolastico, ulteriori 17 ore di lezione.
Testi in adozione Leonardo Sasso – La Matematica a colori 4– Edizione BLU B per il Secondo Biennio - PetriniLeonardo Sasso – La Matematica a colori 5 – Edizione BLU per il Quinto anno - Petrini
Obiettivi
Gli obiettivi specifici di apprendimento individuati dal Dipartimento sono quelli espressi nelle “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento” per il Liceo Scientifico.Le competenze matematiche perseguite sono state: analizzare e interpretare dati e grafici, costruire e utilizzare modelli, individuare strategie ed applicare metodi per risolvere problemi, utilizzare tecniche e procedure di calcolo, argomentare e dimostrare.Nello sviluppo del Secondo Biennio e del Quinto anno, la Classe ha mantenuto un quadro generale sostanzialmente costante. Gli studenti attenti, rigorosi, impegnati hanno acquisito competenze e capacità importanti e complete, che li hanno portati anche a valutazioni brillanti con picchi di eccellenza. Un gruppo di discenti che, all’uscita del I Biennio, avevano dimostrato una conoscenza lacunosa, non ha saputo riorganizzare un metodo di studio autonomo e responsabile. Al crescere della difficoltà dei problemi proposti, corrispondente alla complessità delle richieste dei problemi e dei quesiti della seconda prova d’Esame degli ultimi anni, hanno messo in evidenza problematicità sempre più rilevanti. Un impegno costante, rigoroso e maturo, supportato anche dagli strumenti forniti dalla docenza e dall’Istituzione, avrebbero consentito ben altro percorso didattico. Si deve, infine, porre l’attenzione su tutti quei ragazzi che hanno preso consapevolezza delle loro difficoltà e che si sono applicati con serietà ed impegno consolidando le conoscenze e raggiungendo una sufficiente padronanza di concetti, tecniche e strumenti affrontati.Il programma è stato svolto in ogni sua parte ad eccezione degli approfondimenti di Dati e previsioni previsto nella Classe Terza.
Strategie di recupero adottate:Recupero in itinere, corsi intensivi, corsi di recupero in itinere, studio autonomo.StrumentiLibri di testo, materiale fornito dalla docente, modelli dinamici realizzati con il software GeoGebra, specifico per la matematica.Verifiche Nel Trimestre: sono state svolte 5 prove scritte e due prove orali per ogni alunno (una delle quali tratta da una valutazione di esercizi mirati scritti su uno specifico tema: Teoria delle funzioni)Nel Pentamestre: sono previste 7 prove scritte (escludendo dal conteggio la verifica scritta di recupero delle carenze del Trimestre) e due verifiche orali per ogni alunno (una delle quali tratta da una valutazione di esercizi mirati scritti su uno specifico tema: Calcolo di integrali indefiniti)Nell’arco dell’anno scolastico sono state somministrate verifiche scritte di tipo tradizionale (problemi ed esercizi), e altre con struttura di Seconda Prova contenenti cioè Problemi e Quesiti tratti da temi di Esame di Stato degli scorsi anni.
Programma effettivamente svoltoCalcolo delle probabilitàCalcolo delle probabilità secondo la definizione classica.Teoremi: probabilità della somma logica di due eventi, teorema della probabilità totale, teorema della probabilità condizionata e della probabilità composta, teorema di Bayes.
Relazioni e funzioni28

· L’insieme R : richiami e complementi· Funzioni reali di variabile reale: principali proprietà, dominio e studio del segno Limiti di funzioni e successioni· Limiti di funzioni a valori in R: definizioni· Teoremi di unicità del limite, del confronto, della permanenza del segno· Continuità di una funzione in un punto e in un intervallo· Algebra dei limiti· Forme di indecisione di funzioni algebriche e trascendenti; limiti notevoli· Funzioni continue; classificazione dei punti singolari. Teoremi delle funzioni continue· Asintoti orizzontali, verticali e obliqui· Limiti di successioni Calcolo differenziale· Derivata di una funzione e suo significato geometrico· Derivate delle funzioni elementari, algebra delle derivate; derivata della funzione composta e della funzione inversa,· Derivabilità e continuità· Applicazioni geometriche e fisiche del concetto di derivata· Differenziale di una funzione· Teoremi di Lagrange, di Rolle e di Cauchy· Funzioni crescenti e decrescenti: studio del segno della derivata prima· Teorema di Fermat e criteri per lo studio dei punti stazionari· Problemi di massimo e minimo· Teorema di De L’Hôspital· Andamento qualitativo del grafico della derivata noto il grafico di una funzione e viceversa· Funzioni concave e convesse e punti di flesso· Studio di una funzione e relativo grafico· Calcolo di una radice approssimata di un’equazione algebrica con il metodo di bisezione e con il metodo delle tangenti (di Newton) Calcolo integrale ed equazioni differenziali· Primitiva di una funzione e integrale indefinito· Primitive delle funzioni elementari; integrali immediati· Integrazione di funzioni razionali fratte, integrazione per sostituzione e per parti· Dal grafico di una funzione a quello di una sua primitiva· Integrale definito, suo significato geometrico e proprietà relative· Teorema della media integrale· Teorema fondamentale del calcolo integrale; calcolo di un integrale definito· Applicazioni geometriche degli integrali definiti; calcolo di aree e volumi di rotazione, calcolo del volume di solidi come integrale delle aree delle sezioni ottenute con piani ortogonali a direzione fissata· Integrali impropri· La funzione integrale· Applicazioni fisiche del concetto di integrale· Concetto di equazione differenziale e problema di Cauchy· Equazioni differenziali del primo ordine lineari e a variabili separabili· Equazioni differenziali del secondo ordine omogenee· Problemi che hanno come modello equazioni differenziali; risoluzione dell’equazione differenziale del secondo ordine che si ricava dalla II legge della dinamica Distribuzioni di probabilità· Variabili aleatorie e distribuzioni discrete: distribuzione binomiale e di Poisson· Variabili aleatorie continue e loro distribuzione: distribuzione normale e sue applicazioni· Definizione e interpretazione di valore atteso, varianza e deviazione standard di una variabile aleatoria
29

SCIENZE NATURALI
PREMESSA SULL’INSEGNAMENTO DELLA DISCIPLINA NEL QUINQUENNIO
Prima di procedere alla descrizione dettagliata del lavoro svolto, si ritiene opportuno sottolineare le metodologie utilizzate nel proporre la materia “Scienze” nei suoi molteplici aspetti nel corso del quinquennio. E’ stata prevalentemente utilizzata la lezione frontale nel corso della quale gli alunni sono stati costantemente stimolati al dialogo sui contenuti presentati. Le lezioni sono state rese più efficaci ed interessanti grazie al contributo sistematico di svariati supporti multimediali a cui è stata affiancata, per alcuni argomenti, un’attività di laboratorio.
OBIETTIVIOBIETTIVI COGNITIVI
1. Comprensione dei concetti fondamentali.2. Capacità di rielaborazione autonoma e capacità di effettuare collegamenti.3. Capacità di collegare i fenomeni studiati alla realtà attuale.4. Capacità espositiva.5. Saper usare in modo appropriato e sistematico il lessico disciplinare.
OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI
1. Saper descrivere i diversi processi biochimici e geologici.2. Saper spiegare le più importanti biotecnologie e le relative applicazioni alla luce delle
acquisizioni più recenti.
METODI Per la spiegazione degli argomenti è stata utilizzata prevalentemente la lezione frontale. Sono stati proposti problemi relativi alla dinamica dell’atmosfera ed alle implicazioni etiche di alcune biotecnologie. Le unità didattiche sono state accompagnate dalla proiezione di presentazioni. Nel corso della trattazione sono stati sottolineati, ove necessario, i collegamenti con la fisica. Per l’approfondimento delle conoscenze riguardanti la dinamica della litosfera, è stato anche proposto un documentario sulla deriva dei continenti e sulla tettonica delle placche. In laboratorio sono state realizzate esperienze relative alle fermentazioni e alla realizzazione di colture batteriche. Apparato respiratorio
Strategie di recupero adottate: Studio autonomo
Testi utilizzati: “Geografia generale” – Autori: Neviani, Pignocchino, Feyles - Editore SEI“Biografia” volumi 2 e 3 - Piseri, Poltronieri, Vitale - Editore: Loescher
STRUMENTIPresentazioni con diapositive Power point. Filmati. Laboratorio di biologia.
30

VERIFICHE
TIPOLOGIA OBIETTIVI NUMEROInterrogazioni orali Testare capacità di rielaborazione, uso del
lessico specifico e conoscenza dei contenuti 3Verifica scritta a risposte brevi(max \ 10 righe per risposta)
N.B. Per la suddetta verifica è stata valutata la parte della simulazione di terza prova
inerente la disciplina
Come sopra ma con modalità da terza provaCapacità di sintesi 1
Test scritto modulo CLIL A risposta chiusa o breve 1
Programma effettivamente svolto 1a UNITA’ DIDATTICA: GEOLOGIA E GEODINAMICA I vulcani. I fenomeni sismici. Il modello dell'interno della Terra; basi sperimentali del modello (studio della trasmissione delle onde sismiche); il calore terrestre; il campo magnetico terrestre; il paleomagnetismo; l’isostasia; teoria di Wegener; espansione dei fondali oceanici, tettonica delle placche; margini di placca (costruttivi, conservativi e di consunzione); prove a sostegno del modello. Orogenesi. Tettonica locale: dislocazione degli strati, faglie e pieghe, falde di ricoprimento.
2a UNITA’ DIDATTICA: L’ATMOSFERA Suddivisione dell’atmosfera. L’aria. L’effetto serra. I trasferimenti di energia all’interno del sistema Terra. La temperatura atmosferica e i fattori che la determinano. La pressione atmosferica e i fattori che la influenzano. L’umidità atmosferica. Aree cicloniche e anticicloniche. I venti: circolazione della bassa troposfera e dell’alta troposfera; Alisei; teoria classica e moderna sui Monsoni; brezze di mare, di terra, di valle e di montagna; effetto fohn. Circolazione generale dell’atmosfera. Correnti a getto. Cicloni tropicali ed extratropicali.
3a UNITA’ DIDATTICA: ENERGIA E METABOLISMO CELLULARE Enzimi e coenzimi, vie metaboliche, respirazione cellulare, fermentazioni, fotosintesi clorofilliana, Fotosintesi C4 e CAM.
4a UNITA’ DIDATTICA: GENETICA Genetica dei virus: caratteristiche e classificazione. I genomi dei procarioti e degli eucarioti. Regolazione genica nei procarioti e negli eucarioti. I trasposoni.
5a UNITA’ DIDATTICA: BIOTECNOLOGIEBiotecnologie moderne, tecniche ed applicazioni: DNA ricombinante, elettroforesi su gel, clonaggio molecolare, clonazione di organismi, PCR, sequenziamento del DNA, sonde molecolari, librerie genomiche, OGM, cellule staminali, profili genetici e codice a barre del DNA. Rapporto tra geni e cancro.
6a UNITA’ DIDATTICA: NEUROSCIENZE Cenni storici. Metodi e tecniche d’indagine (tradizionali, TAC, FMRI, PET). Il processo mentale della visione, la percezione degli stimoli tattili e del dolore.
MODULO CLIL (in inglese)
31

Titolo: Biotechnologies and healthTempi: 6 h
Metodo: partendo dall’analisi dei termini tecnici e del loro significato specifico si passa ad una lezione frontale con l’ausilio di slide e filmati.
Modalità di verifica: test scritto
Contenuti:
CLONING ORGANISMSKey wordsCloning in plantsMethods: cuttings and tissue cultureCloning methods in animalsEmbryo transplants - Fusion cell cloningAdvantages of xenotransplantationTransgenic clones for tissue and organ transplantation. Cloning human1. Health risks from mutation of genes2. Emotional risks3. Risk of abuse of the technologyTHE ANGELINA EFFECTThe connection between genes and cancer
DISEGNO E STORIA DELL'ARTE
PREMESSA SULL’INSEGNAMENTO DELLA DISCIPLINA NEL QUINQUENNIO
Le ore di lezione annuali previste erano 66. Le ore di lezione svolte dall’inizio dell’anno fino al 7/5/2018 sono state 48 (comprensive delle 3 destinate alle verifiche di Storia dell’arte), di cui 25 nel primo trimestre.
32

Testi in adozione: G. Cricco F.P. Di Teodoro; Il Cricco Di Teodoro -Itinerario nell’arte vol. 2- Da Giotto all’età Barocca – Terza
edizione – Versione verde; Ed. Zanichelli G. Cricco F.P. Di Teodoro; Il Cricco Di Teodoro -Itinerario nell’arte vol. 3- Dall’età dei lumi ai giorni nostri –
Terza edizione – Versione verde; Ed. Zanichelli Secchi Rolando, Valeri Valerio; Corso di disegno Architettura e arte; Ed. Nuova Italia.
Altri strumenti didattici: Proiezioni multimediali.
OBBIETTIVIGli obbiettivi didattici disciplinari generali, oltre a quelli dipartimentali riportati nel POF e a cui si rimanda sono: acquisizione delle tecniche, delle metodologie, e delle convenzioni specifiche della rappresentazione grafica
tradizionale, acquisizione di abilità nella contestualizzazione storica dei manufatti artistici, aquisizione di conoscenza, di base e critica, della produzione artistica intesa in senso lato (Architettura, Pittura,
Scultura e Arti minori).
METODILezioni frontaliEsercitazioni guidate di rilievo architettonico nell’area della sede scolastica.
STRUMENTILibro di testo, lavagna, aula da disegno, proiettore multimediale.
VERIFICHEa) Grafiche ( Rilievo architettonico con restituzione mediante tecniche di disegno tradizionale)Obiettivi:
- acquisizione di correttezza concettuale e precisione grafica dell'esecuzione;- acquisizione di corretto uso degli strumenti di misura e di disegno di volta in volta impiegati;- acquisizione di qualità del segno grafico e della presentazione degli elaborati;
b) Scritte e orali (storia dell’arte)Obiettivi:
- acquisizione di conoscenze storico-artistiche e relativa assimilazione dei corrispondenti concetti di fondo e della corretta terminologia specifica;
- acquisizione di abilità critico-rielaborative.
Strategie di recupero adottate: Indicazioni personalizzate fornite nel corso delle normali lezioni mediante continue revisioni dei concetti precedentemente spiegati.
Programma effettivamente svolto
Disegno Rilievo architettonico: teoria e presentazione di un lavoro professionale realmente eseguito. Realizzazione di n. 2
esercizi di rilievo di ambienti interni dell’istituto, comprensivi di operazioni di campagna e restituzioni grafiche. Le scale: concetti e convenzioni grafiche; realizzazione di n. 1 esercizio di rilievo di scale esterne dell’istituto, comprensivo di operazioni di campagna e restituzioni grafiche.
Storia dell’arte
Arte del primo ‘700: Architettura Tardo Barocca Caratteristiche generali e inquadramento storico . Filippo Juvarra: Concetti fondamentali e rassegna di opere significative (Basilica di Superga; Reggia di Stupinigi). Luigi Vanvitelli: Concetti fondamentali e rassegna di opere significative (Reggia di Caserta).
Arte del primo ‘700: pittura Tardo Barocca Caratteristiche generali e inquadramento storico . Giambattista Tiepolo: Concetti fondamentali e rassegna di opere significative (Banchetto di Antonio e Cleopatra;
decorazione dello scalone della residenza di Wurzburg; Sacrificio di Ifigenia). Pietro Longhi: Concetti fondamentali e rassegna di opere significative (Lezione di danza; Lo Speziale). Il Vedutismo (concetti fondamentali).
33

Giovan Antonio Canal detto il Cataletto : concetti fondamentali e rassegna di opere significative (Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo; Canal Grande verso Est da Campo San Vio; Eton College).
Francesco Guardi : concetti fondamentali e rassegna di opere significative (Molo con la Libreria verso la Salute, confrontato con l’opera di pari soggetto del Canaletto; Laguna vista da Murano).
Arte della seconda metà del ‘700: il Neoclassicismo Caratteristiche generali e inquadramento storico . Jacques-Louis David : concetti fondamentali e rassegna di opere significative (Giuramento degli Orazi, Morte di Marat,
Le Sabine arrestano il combattimento tra i Romani e i Sabini, Leonida alle Termopili, Marte disarmato da Venere e dalle tre Grazie).
Antonio Canova : concetti fondamentali e rassegna di opere significative (Teseo e il Minotauro, Amore e Psiche, Ebe, Monumento funerario a Maria Cristina d’Austria, Monumento a Paolina Borghese, Le tre Grazie).
Architettura : Scuola Inglese (concetti; Kedleston hall di Robert Adam). Scuola Tedesca (concetti; Walhalla dei Tedeschi a Ratisbona di Leo Von Klenze). Scuola Italiana: (concetti; Teatro alla Scala a Milano di Giuseppe Piermarini; Accademia delle Scienze a S. Pietroburgo di Giacomo Quarenghi). Scuola Francese (concetti; progetto della sala per l'ampliamento della Biblioteca Nazionale, progetto di un museo e progetto del cenotafio di Newton, di Etienne-Louis Boullée).
Arte del primo ‘800: il Romanticismo Caratteristiche generali e inquadramento storico .Pittura: Tendenze espressive nelle varie nazioni d'Europa (concetti). Scuola Tedesca (concetti); Caspar David Friedrich (concetti; Naufragio della Speranza). Scuola Inglese (concetti); John Constable (concetti; Studio di nuvole e cirro; La cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo); William Turner (concetti; Ombra e tenebre, la sera del Diluvo; Tramonto). Scuola Francese (concetti); Théodore Géricault (Corazziere ferito; Cattura di un cavallo selvaggio nella campagna romana; La zattera della Medusa; cinque ritratti di alienati). Eugéne Delacroix (concetti; La barca di Dante; La Libertà che guida il popolo). Scuola Italiana (concetti). Francesco Hayez (concetti; La congiura dei Lampugnani; Pensiero malinconico; Il bacio).
Arte del secondo ‘800 Caratteristiche generali e inquadramento storico . L’impatto della rivoluzione industriale sulle Civiltà e sui territori. La
nuova “libertà” dell’artista e la nascita del “libero mercato” dell’arte. Realismo : concetti fondamentali; Gustave Courbet (concetti fondamentali, Gli spaccapietre, L’atelier del pittore.
“Allegoria reale determinante un periodo di sette anni della mia vita artistica e morale”, “Fanciulle” sulle rive della Senna).
Macchiaioli Toscani: concetti fondamentali; Vincenzo Cabianca (Effetto di sole); Telemaco Signorini (Il ghetto di Firenze); Giovanni Fattori (concetti fondamentali, Campo italiano alla battaglia di Magenta, Rotonda di Palmieri, In vedetta, Bovi al carro).
Architettura e nuovi materiali industriali: concetti fondamentali. Le ragioni e gli ispiratori della "rivoluzione industriale". Il processo siderurgico integrale: dalla ghisa greggia all'acciaio ed ai suoi manufatti (concetti). La Scienza delle costruzioni e la nuova figura professionale dell'ingegnere in relazione a quella tradizionale dell'architetto. Rassegna di opere emblematiche: Ponte sul Severn a Coalbrookdale; viadotto ferroviario sul Firth of Forth presso Edimburgo. Palmenhaus a Vienna. Le realizzazioni delle Esposizioni "universali" (concetti; Palazzo di Cristallo di Paxton; Galleria delle macchine di Dutert; Torre Eiffel). Le realizzazioni in Italia (concetti; Galleria Vittorio Emanuele II a Milano).
Architettura, “conservazione” e “restauro”: le concezioni di Eugéne Viollet-Le-Duc, quelle di John Ruskin e la vera posta in gioco della pretestuosa, e ancor’oggi paralizzante, polemica.
Impressionismo: concetti. Edouard Manet (Colazione sull'erba; Olympia; Il bar delle Folies-Bergère). Claude Monet (concetti; Impressione: sole nascente; serie della Cattedrale di Rouen; Stagno delle ninfee con ponte giapponese). Edgar Degas (concetti).
Impressionismo: rassegna di opere di altri artisti (Degas, Renoir, Pissarro, Sisley, e Caillebotte). Postimpressionismo: concetti fondamentali e rassegna di opere di vari artisti (Cezanne, Seurat, Gauguin, Van Gogh).
Attualità Nell’81° anniversario (26 aprile 1937 - 26 aprile 2018) del bombardamento di Guernica: “Lamento en muerte del
torero Joselito”, alias “Guernica” di Pablo Picasso, in relazione al mito e alla verità storica dell’evento.
34

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
PREMESSA SULL’INSEGNAMENTO DELLA DISCIPLINA NEL QUINQUENNIO
L'aspirazione delle Scienze Motorie per la classe 5B e’ stata lo sviluppo armonico della personalità nei suoi aspetti sia socio-affettivi e cognitivi che corporei. Perciò, in aggiunta alla ricerca di un miglioramento delle qualità motorie, si è cercato di rendere i ragazzi responsabili del lavoro svolto, consapevoli del benessere non solo fisico, ma anche mentale e sociale che ottengono mediante l’esercizio fisico. Vorrei sottolineare che il documento finale redatto dalla sottoscritta , in quanto supplente temporanea, risulta da una consultazione effetuata con il prof Ascrizzi che è stato il docente della classe per 5 anni.
Numero ore annuali previste 66 (2 ore settimanali x 33 settimane)
Numero ore svolte 52
OBIETTIVI
FORMATIVI - TRASVERSALI E SPECIFICI:
attenzione generale e specifica;
rielaborazione degli schemi motori di base ed elaborazione di nuovi più complessi nel rispetto degli altri;
miglioramento della capacità condizionali organiche e neuro muscolari;
capacità di ascoltare, operare in gruppo, organizzare il tempo di lavoro e il tempo di recupero, di utilizzare l conoscenze specifiche in contesti paralleli;
consapevolezza di sè negli sport individuali e di squadra; nel rispetto delle diversità;
conoscenza e pratica della buona salute e del primo soccorso.
METODIGli alunni hanno conseguito e sperimentato con il proprio corpo un’ampia gamma di attività motorie e sportive: ciò ha favorito un equilibrato sviluppo fisico e neuromotorio. Inoltre gli studenti hanno raggiunto I piu' alti livelli di prestazioni motorie, stimolando le capacita' di coordinazione forza resistenza ,velocita' e flessibilita'.
35

STRUMENTI
Resistenza organica e muscolare;
lavoro sulla coordinazione motoria e la scioltezza articolare;
stretching;
preatletici generali e specifici;
ginnastica artistica;
potenziamento organico e muscolare;
fondamentali individuali e di squadra di pallavolo;
fondamentali individuali di pallacanestro;
corsa atletica, salti e lanci;
spiegazione di alcune nozioni teoriche afferenti specialità sportive e apparati del corpo umano.
Altri strumenti didattici:
palloni di pallavolo, pallacanestro, calcio; palla medica, panche, ostacoli, corde,
tappeti, coni, materassi, pesi.
VERIFICHE
Tipologia FORMATIVE:
L’osservazione soggettiva dei miglioramenti della tecnica, per l’aspetto qualitativo;
La misurazione mediante test, misure, tempi, schede, per quanto attiene la
prestazione dell’aspetto quantitativo.
Numero 4
Tipologia SOMMATIVE:
Attraverso l’analisi, obiettiva e/o soggettiva:
d’impegno (inteso come partecipazione alle lezioni con capacità d’osservazione e/o
intervento personale);
Interesse, attenzione e collaborazione, offrendo le proprie abilità ed esperienze,
interagendo con l’insegnante per l’eventuale integrazione delle proposte rivolte al
36

gruppo;
Partecipazione all’attività sportiva scolastica.
Numero 2
ALTRI STRUMENTI DIDATTICI
palloni di pallavolo, pallacanestro, pallamano, calcio; palla medica, panche, ostacoli,
tappeti, coni, spalliere, pedana e trampolino elastico, materassi, peso, disco.
PROGRAMMA SVOLTO Al temine del percorso liceale lo studente e' consapevole della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo, i valori dello sport sono consolidati e ha raggiunto una buona preparazione motoria, maturando un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo e cogliendo le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei diversi ambienti.
GINNASTICA EDUCATIVA:
esercizi di sviluppo a carattere generale, a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi, anche in coppia e a gruppi, circuito, stretching, test, andature, potenziamento muscolare generale anche in coppia.
ATLETICA LEGGERA:
preatletici generali e specifici, corsa di resistenza e velocità, salto in alto.
PALLAVOLO:
fondamentali individuali e di squadra, gioco.
PALLACANESTRO:
fondamentali individuali e gioco.
PALLAMANO:
fondamentali individuali e gioco.
NOZIONI:
regolamento e casistica di basket e salto in alto..
la docente Sorbello Claudia
37

SIMULAZIONE TERZA PROVA D’ESAME
In data 5 maggio 2017 si è effettuata la simulazione della terza prova dell’esame di stato, pluridisciplinare, in coerenza con l’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno, secondo le seguenti modalità:
- Tipologia B- Durata: due ore- Materie coinvolte: Inglese, Filosofia, Scienze e Fisica- Dieci righe di testo per ogni risposta
Di seguito si riportano le domande delle rispettive discipline somministrate agli studenti
INGLESE
1) “Refugee Blues” by W.H.Auden
There is a list of key words taken from the poem. Use them in a paragraph that reflects some of Auden’s main ideas: atlas, passports, consul, politely, daily bread, German Jews, politicians, human race, a thousand floors, soldiers, Hitler, thunder rumbling.
2) Coketown: write a short paragraph about the city (its features, life of the workers, what the other residents wish to change)
3) Explain the development of the Irish question.
FILOSOFIA
1) Com'è strutturata la psiche secondo la seconda topica di Freud?2) Confronta i concetti di "volontà di vita" e di "volontà di potenza".
SCIENZE
1 - A cosa serve la PCR? Descrivi il processo. 2 – Spiega a cosa servono ed in che modo vengono realizzate le librerie genomiche.
FISICA
1) Enuncia l'equazione di Maxwell inerente la circuitazione del campo elettrico nel caso statico e dinamico. Commenta il significato e l'importanza della modifica introdotta da Maxwell a tale equazione. Esprimi le caratteristiche del campo elettrico indotto.
2) Descrivi cosa sono le onde elettromagnetiche (senza spiegare il meccanismo di generazione delle onde stesse) e le loro caratteristiche fondamentali. Nella descrizione indicare la velocità di propagazione nel mezzo e nel vuoto , la densità media di energia trasportata e l'intensità. Scrivere le formule in modo che sia chiaro il significato dei simboli utilizzati
3) Un protone si muove all'interno di un acceleratore, in un tubo in cui è stato praticato il vuoto, a una velocità costante pari a 0,964 c. La lunghezza propria del tubo è 42,5 m. Calcola quanto tempo impiega il protone a percorrere il tubo nel sistema di riferimento del laboratorio e in quello solidale alla particella. Determina poi la lunghezza della distanza percorsa dal protone nel sistema di riferimento solidale alla particella. Chiarisci con un disegno i sistemi di riferimento e scrivi i risultati con il corretto numero di cifre significative.
38

Si allegano il modello della tabella di valutazione e della tabella di conversione in quindicesimi
GRIGLIA DI CORREZIONE TERZA PROVA
Alunno __________________________________ classe 5^__
indicatori punti Valutazione
CORRETTEZZA MORFOSINTATTICA e/o UTILIZZO DEL LESSICO SPECIFICO non corretto 1
parzialmente corretto 2
corretto 3
Corretto ed efficace 4
CONOSCENZE E CONTENUTI E/O PADRONANZA DELLE PROCEDURE nullo/gravemente lacunoso 1
insufficiente 2
parziale 3
Accettabile 4
completo 5
completo e ricco di spunti 6
COMPRENSIONE DEI QUESITI EPERTINENZA DELLE RISPOSTE
Non pertinente 1
Non del tutto pertinente 2
pertinente 3CAPACITÀ DI SINTESI Incerta 1
Adeguata 2
TOTALE
TABELLA DI CONVERSIONE/10 /1510 159 148 137 126 10/115 94 7/83 5/6
1/2 1/4
39

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA
Durante questo anno scolastico si è svolta 1 prova scritta pluridisciplinare, coerenti con l’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno Si allegano la prova effettuata e la griglia di valutazione utilizzata.
GRIGLIA di VALUTAZIONE della TERZA PROVA SCRITTA
ALUNNO/A: ____________________________________________ Classe 5 sez. ___
Indicatori Punti Valutazione
CORRETTEZZA MORFOSINTATTICA E/O
UTILIZZO DEL LESSICO SPECIFICO
non corretto 1
____ /4
parzialmente corretto 2
corretto 3
corretto ed efficace 4
CONOSCENZA DEI CONTENUTI E/O PADRONANZA DELLE PROCEDURE
nullo/gravemente lacunoso 1
____ /6
insufficiente 2
parziale 3accettabile 4
completo 5completo e ricco di
spunti 6
COMPRENSIONE DEI QUESITI E PERTINENZA DELLE RISPOSTE
Non pertinente 1____ /3
non del tutto pertinente 2
pertinente 3
CAPACITÀ DI SINTESIincerta 0-1 ____ /2
adeguata 2
Consegna in bianco: 1/15 VOTO ______/15
40