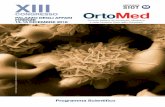Xiii
-
Upload
quaderni-ginestra -
Category
Documents
-
view
215 -
download
1
description
Transcript of Xiii


REDAZIONE
Direttore: Corrado Piroddi.
Vicedirettore: Anna Maria Ricucci
Redazione: Valeria Bizzari, Antonio Freddi, Giacomo Miranda, Teresa Paciariello, Lavinia Pesci, Corrado Piroddi, Anna Ricuc-
ci, Timothy Tambassi.
Collaboratori esterni: Marco Anzalone, Simona Bertolini, Mara Fornari, Donatella Gorreta, Federica Gregoratto, Francesco
Mazzoli, Giovanna Maria Pileci, Marina Savi, Cristina Travanini.
Direttore responsabile: Ferruccio Andolfi.

SOMMARIO
Figure dell’individualismo..............................................................................................................................................p. 6
L’individuo come residuo? Osservazioni interdisciplinari di Michela Bella e Matteo Santarelli..............................................................p. 7
Meditazioni filosofiche..................................................................................................................................................p. 18
Incubo (o visione) di filosofia di Fedro Andiotin....................................................................................................................................p. 19
Tra silenzio e stupore: l’esperienza filosofica in Wittgenstein e Florenskij di Livio Rabboni...................................................................p. 23
Cinema e filosofia............................................................................................................................................................p. 28
Viewers turned into partecipants: Dziga Vertov’s A Sixth Part of the World di Tatjana Sheplyakova................................................p. 29
Upstream Color di Sofia Bonicalzi. ......................................................................................................................................................p. 38

Letteratura e filosofia...................................................................................................................................................p. 42
La valle di Bamyan di Elisa Zimarri.....................................................................................................................................................p. 43
Crisi e direzioni di senso nell’esistenza. L’antropoanalisi di un dramma di Giuseppina Mazzei............................................................p. 51
Libri in discussione...................................................................................................................................................p. 56
Il liberalismo alla resa dei conti di Gianluca Cavallo..............................................................................................................................p. 57
From cooperation to liberal institutions di Onni Hirvonen.....................................................................................................................p. 60
Dal nuovo realismo al ritorno alla realtà di Timothy Tambassi.............................................................................................................p. 63

MIL (Federica Parizzi 1984-?)
Ormai convinta di essere un'incongruenza sulla linea spazio-temporale, si muove al ritmo della sua
irrazionalità emotiva. E' un'eterna spettinata, affascinata dall'effimero e dall'espressività della materia, che opera in una sorta di trance mistico-metallurgica, cercando di traslare in una dimensione tangibile
frammenti di fragili stati d'animo.
lecosedimil.wordpress.com [email protected]



Figure dell’individualismo
7
uesto breve articolo è diviso in due parti, nella prima parte si
cercherà di mettere a fuoco la concezione dell’individuo seguendo
l’approccio psicologico di un classico autore americano, William James
(1842-1910), nella seconda parte, l’attenzione sarà rivolta alla riflessione
della sociologia di matrice europea, con riferimento a Émile Durkheim
(1858-1917). Si tenterà di analizzare e chiarire le motivazioni e gli aspetti
critici di entrambi questi punti di vista che, rispettivamente,
attribuiscono l’uno un ruolo incisivo (attivo) all’individuo agente, l’altro,
al contrario, un ruolo residuale (passivo) per quanto ineliminabile.
I
William James è stato uno psicologo e filosofo americano, docente
ad Harvard, nonché uno dei padri fondatori della corrente filosofica del
Pragmatismo. Le riflessioni jamesiane risentono in modo evidente della
diffusione delle teorie evoluzioniste, delle scoperte della psicologia
sperimentale europea e ovviamente della cultura romantica che egli ebbe
modo di respirare fin dall'infanzia in famiglia, anche grazie alle amicizie
paterne, tra le quali spicca la figura R. W. Emerson.
William James è stato considerato un individualista, ma soprattutto si è
egli stesso definito tale in più occasioni. Nella sua ampia corrispondenza
si può leggere come egli scriva di sentirsi sempre più «pluralistic and
individualistic in my general views of things» o, altrove, di ritenersi
«intensely an individualist». Alcuni studiosi hanno parlato per James di
un individualismo etico, altri anche più recentemente di “individualismo
dinamico”. Sembra importante correlare queste due interpretazioni, cioè
quella che evidenzia il versante etico e quella funzionale-psicologica, perché è
proprio nella loro complementarietà che esse risultano indicative della
peculiarità del discorso di questo autore e del valore del suo contributo
al dibattito sulla relazione tra individuale e sociale. A tale scopo, è utile
analizzare un articolo di James dal titolo Great Men, Great Thoughts and
The Environment, del 1880, che fu materia di dibattito sulle pagine
dell’Atlantic Monthly per le dure repliche che ne seguirono da parte di
quei naturalisti interessati alla sociologia che James aveva più
apertamente contestato: Grant Allen e John Fiske. A costoro, a sua
volta, James rispose con un altro breve scritto intitolato The Importance of
Individuals (Open Court, 1890). Avvertendo i rischi di riduzionismo insiti
nelle assunzioni metodologiche degli studi sociali – nello specifico, quelli
derivanti da una lettura meccanicistica dell’influenza dell’ambiente
geografico e delle circostanze sociali sulla direzione degli avvenimenti storici –
Q
L’INDIVIDUO COME RESIDUO? OSSERVAZIONI INTERDISCIPLINARI
DI JOHANNES VOLKELT

Quaderni della Ginestra
8
James sottolinea, piuttosto, tutta la reale importanza dei grandi uomini
nell’evoluzione storica, riprendendo così un tema caro alla tradizione
letteraria di Carlyle e dello stesso Emerson, ma riformulandolo in vista
della salvaguardia di quelle istanze empiriche, quali la concretezza e la
qualità individuale, che egli sentiva fortemente messe a rischio entro il
nuovo panorama scientifico. In particolare, James rimane vigile sulla
pretesa di certa scienza – a suo avviso, in verità, poco scientifica e
surrettiziamente affezionata a una metafisica di stampo materialista e
determinista – di mettere il veto o tacciare di anti-scientismo ogni
posizione che, di fronte alle incertezze della ricerca, mantenesse aperta
la possibilità di credere nella libertà personale, nell’indeterminismo, nella
efficacia dei caratteri individuali. James ritiene, inoltre, che queste istanze
siano esigenze vitali proprie degli esseri umani e in quanto tali legittime e
inalienabili, tanto da costituire le motivazioni della sua riformulazione
pragmatica della nozione di esperienza e, in seguito, dell’indirizzo pluralista
e anti-intellettualista assunto dalla sua metafisica.
La domanda che viene riproposta nell’articolo del 1880, e a cui James
tenta di dare la sua personale risposta, è relativa alle cause a cui attribuire
i cambiamenti sociali che si riscontrano di generazione in generazione. Un
tratto importante dell’individualismo di James e del dibattito del tempo,
che qui ben emerge, è come esso cercasse la sua legittimazione
scientifica radicandosi in una lettura seppure differente dell’evoluzionismo.
Dalla proposta più marcatamente meccanicistica di Herbert Spencer e
degli studiosi che a lui facevano riferimento, appunto Allen e Fiske,
James prende le distanze sostenendo che a causare l’evoluzione storico-
sociale, per quanto necessarie, non siano sufficienti le sole condizioni
ambientali e sociali. Le mutazioni generazionali delle società sono infatti
anche e principalmente dovute, direttamente o indirettamente, alle
azioni o all’esempio di individui di genio e alle relazioni accidentali che questi,
in certi momenti, hanno modo di stabilire con l’ambiente sociale, così
da poter agire in esso come fermenti di novità. In questo modo, James si
faceva sostenitore di una posizione antiriduzionistica e riteneva peraltro di
rimanere più fedele alla teoria di Darwin, quantomeno all’aspetto più
originale dell’analisi proposta dallo studioso inglese. Darwin (1859)
tenne infatti a distinguere tra due cicli causali relativamente indipendenti tra
loro: da una parte, il ciclo fisiologico della natura nel quale egli rinveniva
le cause delle tendenze alla variazione spontanea e, dall’altra, il ciclo ambientale
in funzione del quale agiscono le cause della preservazione (la selezione
naturale e sessuale). Per quanto debbano essere tenuti in conto i
cambiamenti adattativo-funzionali, quindi quelle modificazioni legate alla
pressione diretta esercitata dall’ambiente sull’organismo – nei quali le
relazioni interne corrisponderebbero alla loro causa efficiente esterna –

Figure dell’individualismo
9
secondo James merito di Darwin è l’aver mostrato quanto maggiore sia
in realtà la massa di cambiamenti prodotti a livello ‘molecolare’, e
quanto le cause di questi ultimi ci rimangano quasi del tutto sconosciute.
Ovviamente si tratta di posizioni di fine Ottocento e la ricerca ha
fatto da allora moltissimi passi in avanti, soprattutto in campo genetico.
Quel che è interessante notare in queste posizioni è come, rispetto alla
sociologia, James cogliesse l’istanza antiessenzialista del darwinismo,
contribuendo a corroborarne la declinazione indeterministica che è
caratteristica del pensiero pragmatista in generale, e di quello di James in
particolare. Le variazioni che Darwin definisce “molecolari” sono infatti
novità interne, invisibili a occhio nudo, ma soprattutto accidentali. In altri
termini, James metteva sotto accusa le implicazioni riduzioniste delle pur
necessarie generalizzazioni metodologiche della sociologia, volte a
identificare i comportamenti e le reazioni della media degli individui a
dispetto della concreta varietà dei caratteri fisiologici e, soprattutto, delle
potenzialità individuali – anch’egli, in verità, senza preoccuparsi di
problematizzare le difficoltà di un diretto sviluppo della stessa analogia
tra il piano d’indagine biologico e quello sociale. Rispetto alla durezza di
Allen, che senza esitazioni ritiene che la scienza debba preoccuparsi di
spiegare la media-massa e non l’individuo, la replica di Fiske a James si
dimostra invece moderata e ricettiva al punto tale che, a questo
proposito, uno dei più noti seguaci di Spencer si trova a dover meglio
precisare la distinzione tra storia e sociologia. Venendo incontro al
legittimo timore di James di una storia quasi impersonale, cioè fatta dagli
eventi e non dagli individui o, detto in altri termini, di un possibile
collasso della storia in sociologia1, Fiske ridimensiona in quest’ambito quello
che dovrebbe essere l’apporto degli studi e della metodologia delle
scienze sociali.
È interessante notare come nella prospettiva di James, che legge
l’evoluzione in modo da valorizzare gli elementi innovativi e creativi
della società – i quali rimangono a suo avviso un portato individuale poi
selezionato e sostenuto dall’ambiente – egli finisca col valorizzare non
soltanto il contributo degli uomini di genio ma, a ben vedere, quello di
ciascun individuo. Infatti, sempre rimanendo nell’analogia bio-evolutiva,
ogni essere umano esibisce fisiologicamente variazioni seppur minime rispetto al
tipo ideale della media specifica e può essere considerato a sua volta una
variazione che, in quanto tale, dimostra un certo potere, seppure sempre
minimo, di condizionare in modo efficace il suo ambiente circostante e
con la selezione la stessa inclinazione della linea evolutiva.
Si può ben dire, quindi, che quello di James è uno scontro con il
determinismo degli studi sociali e, soprattutto, con i suoi esiti assolutistici.
Sarebbe, quindi, improprio leggere a sua volta l’indeterminismo di James in

Quaderni della Ginestra
10
termini assoluti: il ruolo dell’ambiente sociale rimane, infatti, un fattore
altrettanto determinante dell’evoluzione, contenendone le possibilità e
assicurandone la continuità. L’evoluzione sociale è definita da James come:
una risultante dell’interazione di due fattori completamente distinti – quello individuale, che deriva i suoi talenti particolari dal
gioco delle forze fisiologiche ed intra-sociali, ma che mantiene
nelle sue mani tutto il potere di iniziativa e di creazione; e, il secondo, l’ambiente sociale, con il suo potere di accettare o
rifiutare sia lui che i suoi talenti. Entrambi i fattori sono essenziali
al cambiamento. Senza l’impulso individuale la comunità ristagna. L’impulso muore senza il favore della comunità.2
Il punto è proprio la complessità della interazione tra novità e continuità.
Per quanto si diano condizionamenti storico-ambientali-sociali del
momento presente, e con essi si vengano a creare delle incompatibilità
che di fatto precludono una serie di possibili direzioni evolutive o ne
rendono altre ridondanti, ciò nonostante queste solo genericamente
determinano il singolo soggetto agente, cioè non ne determinano in
positivo lo specifico modus operandi : è nella critica dei rischi di questo
passaggio indebito, che in questo caso compirebbe la sociologia, che si
concentrano gli sforzi di James. L’evoluzione storico-sociale, come
quella biologica, rimane continuamente aperta grazie alla possibilità di
variazioni spontanee che sono legate a meccanismi genetici, non osservabili
e multifattoriali, i cui esiti concreti rimangono nella loro singolarità non
prevedibili. Le «living things», quali l’individuo e la comunità per James,
non sono soggetti soltanto all’influenza diretta dell’ambiente, ma
esibiscono uno spessore, una concretezza fisica e psichica che conserva i segni
del divenire storico, cosicché la loro evoluzione si va anche a scrivere sulle
stratificazioni che le scelte degli uomini e delle donne hanno formato e
conservato nel tempo, comportando una maggiore complessità e
incertezza dei risultati dell’interazione con l’ambiente naturale e sociale.
Dobbiamo notare, infine, che la posizione “individualista” di James
non è neanche compatibile con una teoria individualista forte, che
presupporrebbe una concezione più solida dell’Io. Accenniamo qui solo
brevemente all’indagine psicologica di James laddove, nel noto capitolo
X dei Principles of Psychology (1890), definisce l’Io proprio in termini plurali
e dinamici e ben riconosce la labilità dei confini del Sé e delle sue
relazioni interne. La proprietà e il possesso degli stati mentali non
definiscono l’identità in modo statico, essenzialistico, ma si osserva un
continuo succedersi di stagioni e di eredi proprietari (herdsmen) che si
trovano a dover rinegoziare e ridefinire continuamente le rispettive
capacità. James ritiene con T. Ribot che «l’unità psichica derivi da un
processo empirico graduale e non da un sottostante principio
metafisico»3. Così, anche nella sua descrizione del «campo di coscienza»

Figure dell’individualismo
11
che è costituito da margini e da un centro, egli nota come essi siano
modificabili, momentanei, continuamente soggetti al cambiamento. Il
centro è quello di cui siamo attualmente coscienti, ciò a cui prestiamo
attenzione, ma l’unità del Sé è precaria, non è mai assicurata o data una
volta per tutte. Una tale lettura psicologica del mentale rientra in quello
che si è cercato di rimarcare nel confronto con la nascente sociologia,
cioè nel fatto, ben rilevato da Francesca Bordogna, che l’anti-
essenzialismo era la ricetta «per ‘rivitalizzare’ e rigenerare la società
americana»4. Abbandonando l’idea di relazioni essenziali, statiche, definite
a priori, né per l’Io né per le relazioni sociali, si può parlare di relazioni
dinamiche, differenti, che possono cambiare, modificarsi nel tempo, e ciò
ha evidentemente una forte implicazione morale. Gli individui partecipano
con tutta la loro irripetibilità genetica, storiografica e con le rispettive
capacità creative al possibile miglioramento o peggioramento della società, un
cambiamento la cui evoluzione rimane relativamente aperta proprio per
la ‘natura ipotetica dell’individuo’ – come la definisce Sergio Franzese –
ovvero per l’irriducibilità della potenzialità individuale che James riscontra sul
piano fisiologico e psicologico e di cui traccia le conseguenze sul piano etico e
morale.
II
Prima di inoltrarci nell’articolazione alternativa rispetto a quella
jamesiana, è necessario chiedersi cosa significhi affermare che
l’individuo è un residuo. In una prospettiva filosofica e scientifica,
affermare che la componente individuale è residuale assume due
significati: in primo luogo, che essa è secondaria, che non svolge un
ruolo di primaria importanza; in secondo luogo, che di essa in qualche
modo non si può fare a meno. L’idea – un po’ brutale, a dire il vero – è
che il processo di elaborazione teorica non riesca a smaltire in pieno
l’individuo, in quanto esso rimane il residuo e la traccia irriducibile di
ogni processo di socializzazione. È questo l’esito a cui conduce una
certa impostazione sociologica che possiamo ricondurre idealmente a
Émile Durkheim.
Come noto, Durkheim è uno dei padri della sociologia
contemporanea. I suoi lavori fondamentali possono essere situati a
cavallo tra Ottocento e Novecento, e probabilmente pochi altri autori
possono essere altrettanto considerati come pensatori di frontiera tra i
due secoli. L’Ottocento è il secolo di Darwin e Spencer, ma anche il
palcoscenico su cui viene messo in scena il passaggio dalla folla alla
massa. Di fronte alla potenza di questo fenomeno, molti autori
nnnnnnnnn

Quaderni della Ginestra
12
MIL, TUTTO CHIUSO E IL VENTO DENTRO (PART.)
IO AMO CIÒ CHE NON SI DICE

Figure dell’individualismo
13
reagiscono in modo rigido, ossia proponendo una secca opposizione
che è assieme normativa e teorica5. In particolare, Le Bon, Taine e tanti
altri propongono una visione dicotomica costruita attorno a due mosse
decisive:
1) La netta distinzione tra individuo e massa
2) L’identificazione della sfera individuale con quella razionale, e
dei fenomeni della folla con la sfera impulsiva e irrazionale.
Nella società del progresso l’individuo è diventato capace di
controllare razionalmente se stesso e il mondo esterno. Se però
prendiamo lo stesso individuo e lo gettiamo in una folla ingiustamente
inferocita, anche lui diventerà inferocito. Questa doppia equazione
(individuo=razionalità, folla = irrazionalità), che è ovviamente in
connessione con il modello antropologico utilitarista, viene rifiutata da
Durkheim. All’origine di questo rifiuto non c’è tanto la rivalutazione
della folla o della massa, quanto piuttosto l’affermazione del primato del
sociale. Durkheim fonda la sociologia in quanto scienza esatta sul
primato metodologico e teorico del sociale: primato metodologico in
quanto l’oggetto specifico della sociologia non è l’individuo, le sue
sensazioni, le sue rappresentazioni, ma al contrario il fatto sociale. Nella
confusione e nella frammentazione della realtà esterna, il fatto sociale è
riconoscibile grazie a tre segni caratteristici:
1) L’esteriorità
2) La costrizione
3) La generalità.
Oggetto della sociologia sono dunque quei fenomeni collettivi,
irriducibili, esteriori rispetto agli individui, e capaci di esercitare su di
essi una forza costrittiva. Lo strumento pratico che permette la
separazione del fatto sociale dalle sue incarnazioni individuali è la
statistica. Pensiamo al celebre studio sui suicidi6. A Durkheim non
interessano i motivi psicologici o biografici che spingono una persona al
suicidio – “si è ucciso perché è stato lasciato dalla moglie”, e simili
motivazioni da televisione – , ma al contrario la sua analisi è focalizzata
sulla quantità aggregata di suicidi per anno in una determinata nazione e
sulla sua variazione storica, da ricondurre a cause collettive di natura
sociale. L’aspetto personale e individuale è insignificante in questo
senso.
La prospettiva di Durkheim è interessante perché in essa la metodologia
si traduce immediatamente in una teoria sul mondo. Durkheim dice che se

Quaderni della Ginestra
14
vogliamo costruire una sociologia che sia scienza vera e propria,
dobbiamo occuparci dei fatti sociali, i quali come gli oggetti delle
scienze naturali esistono oggettivamente, ossia a prescindere da ciò che
ognuno di noi pensa o percepisce. Se vogliamo riconoscere un fatto
sociale, se vogliamo cioè distinguerlo da un fatto non sociale, bisogna
considerare se esso presenta le caratteristiche dell’esteriorità, della
costrizione e della generalità. Ma così facendo, il discorso slitta in
automatico dalla metodologia alla teoria, o forse più precisamente
all’ontologia. Nel delineare come si possa riconoscere un fatto sociale,
Durkheim finisce inevitabilmente per indicare la struttura effettiva di un
fatto sociale, finisce cioè per descriverlo. L’aspetto interessante ai fini della
presente discussione, è che questa ricaduta descrittiva della scelta
metodologica di base riguarda non solo la definizione del sociale, ma
anche quella dell’individuale. Se il fatto sociale è dotato di potere di
costrizione sull’individuo, complementarmente l’individuo sarà
connotato come qualcosa che è in qualche misura predisposto alla
costrizione. Questa deduzione pare confermata dal seguente passaggio:
Sans doute, elles (i fenomeni collettivi, nda) ne peuvent se réaliser
que si les natures individuelles n’y sont pas réfractaires; mais
celles-ci ne sont que la matière indéterminée que le facteur social détermine et transforme. Leur contribution consiste
exclusivement en états très généraux, en prédispositions vagues et, par suite, plastiques qui, par elles-mêmes, ne sauraient prendre
les formes définies et complexes qui caractérisent les
phénomènes sociaux, si d’autres agents n’intervenaient.7
La ‘metodologia della discontinuità’, come l’ha definita efficacemente
Claude Gautier8, finisce così per risolversi in un vero e proprio dualismo,
il cui manifesto è il testo del 1914 Le dualisme de la nature humaine et ses
conditions sociales9. In questo articolo l’umanità viene descritta come il
teatro dello scontro tra due principi: da un lato il sociale, che include la
moralità e il pensiero, dall’altro l’individuale, che contiene la dimensione
impulsiva e biologica. Uno scontro ad armi impari, che si risolve
fatalmente nella vittoria del sociale sull’individuo. Una vittoria che può
essere sofferta, riconosciuta, addirittura desiderata, ma che rimane pur
sempre una vittoria predestinata e vincolata alla sproporzione delle
forze in campo.
Ora, il punto cruciale è che questa concezione residuale dell’individuo
finisce per generare un paradosso piuttosto significativo. Se si afferma
con Durkheim che il sociale è il primum, in quanto ad esso appartengono
i fenomeni nobili dell’umanità come il pensiero, la scienza e la morale, e
in quanto esso è capace di influenzare in modo decisivo e di formare la
sfera individuale, bisogna necessariamente spiegare:

Figure dell’individualismo
15
a) In che modo questa influenza si realizzi
b) Quale sia l’oggetto, la materia per così dire su cui il marchio
della socializzazione si imprime.
La via più breve verso la concezione residuale, ossia la via che
tendenzialmente segue e traccia Durkheim nei due testi sopra
menzionati, consiste nel concepire la socializzazione come un processo
unidirezionale che forma la materia plastica e indeterminata di cui è
fatta l’individualità. Da qui la natura residuale menzionata nel titolo: la
sfera individuale infatti diventa così una sorta di stato primitivo e vuoto
che noi dobbiamo necessariamente ipotizzare come materia precedente
l’opera di formazione e organizzazione prodotta dal sociale. Ora,
questa forma può anche essere individuale, in quanto un certo tipo di
individualizzazione può essere il prodotto di un certo tipo di
socializzazione. In particolare, la società moderna, caratterizzata dalla
divisione del lavoro sociale e dalla relativa segmentazione, è dotata di un
evidente potere individualizzante. Si crea così il seguente paradosso: c’è
un’individualità a monte che è plastica e indeterminata; su questa
individualità agisce il potere costringente della società, che in epoca
moderna produce e lascia emergere un’individualità stavolta situata non
a monte, ma a valle del processo di socializzazione. Al di là del
paradosso, è evidente come la prospettiva sia rovesciata rispetto a quella
di William James. Mentre in James la concretezza dell’individuo è la fonte
delle innovazioni sociali e della pluralità dei punti vista, in Durkheim al
contrario sono la differenziazione dei ruoli e la divisione del lavoro sociale a
permettere l’emergere dell’individualità. Mentre in James la fonte delle
variazione e delle innovazioni è rintracciabile nell’individuo, in
Durkheim i mutamenti della società si spiegano a mezzo di fenomeni
sociali. Pensiamo soltanto all’esempio dei ‘grandi uomini’. Se è vero che
sono state le cosiddette qualità individuali a far sì che Napoleone, e non
il suo vicino di casa in Corsica, sia diventato Imperatore, ciononostante
sono state le particolari condizioni storiche e sociali a far sì che in quel
preciso momento sia emersa l’esigenza di una figura carismatica e
accentratrice. Non solo: pensiamo soltanto a quanto sia contestuale la
definizione di una caratteristica apparentemente individuale quale il
carisma. I leaders carismatici di trenta anni fa non eserciterebbero lo
stesso fascino nel contesto politico attuale, e viceversa i leaders attuali
probabilmente risulterebbero ridicoli agli occhi della vecchia opinione
pubblica. Riconoscendo il ruolo di censura e selezione esercitato
dall’ambiente sulle variazioni individuali, una prospettiva jamesiana può
anche dare conto di un fenomeno del genere, ma il punto cruciale in
ultima istanza è un altro, ossia il potere causale. Nel caso di James,

Quaderni della Ginestra
16
l’individuo è dotato del potere causale di incidere sulla realtà sociale. Un
potere limitato, ovviamente, ma pur sempre decisivo. Nel caso di
Durkheim invece l’apporto dell’individuo sembra non avere spazio. La
sfera dell’individuale esiste, la sua irruzione è un fenomeno tipicamente
moderno; tuttavia, l’individuo esercita la sua influenza sul sociale
sempre per interposta persona, dove l’interposta persona è il sociale
stesso. La società moderna ha costruito “il mito dell’individuo”, afferma
Durkheim, in quanto questo era l’unico ideale collettivo possibile in un
contesto social frammentato e diviso.
In conclusione, l’impostazione durkheimiana ha il merito di far
comprendere come l’individuo sia il prodotto di un processo sociale e
storico, e non un’entità autosufficiente e completamente autonoma che
esiste aldilà delle relazioni sociali e personali. Inoltre, essa mette bene in
luce l’arbitrarietà dell’assunto secondo il quale la fonte dell’innovazione
e del cambiamento vada localizzata necessariamente nella sfera
individuale. Un’intuizione che sembra confermata da un certo dibattito
contemporaneo sulla teoria dell’evoluzione, in cui il piano su cui si
esercita la selezione naturale e in cui compaiono le variazioni impreviste
di cui parlava Darwin è sia quello individuale, sia quello genetico, sia
addirittura quello dei gruppi. Fatto salvo questo contributo positivo, è
evidente il paradosso che si crea una volta posti di fronte a due
individualità– una a monte, l’altra a valle, una socializzata e l’altra
presociale, una disorganizzata, l’altra strutturata e compiuta – che
appaiono come separate e irrelate.
In che modo è allora possibile evitare un simile paradosso, pur
partendo dall’assunto del primato del sociale? Si può portare il discorso
alle estreme conseguenze, arrivando così a negare in assoluto l’esistenza
dell’individuo. La materia su cui la socializzazione imprime il suo segno
è in realtà la dotazione biologica e innata, di per sé sprovvista di potere
di individuazione. Per quanto riguarda invece l’individualizzazione a
posteriori, essa può essere denominata così solo metaforicamente.
Difatti, il prodotto della socializzazione moderna è un soggetto
individuale vincolato ad un numero sempre crescente di ruoli e
aspettative, e quindi egualmente soverchiato da una pressione sociale
che ha cambiato il proprio volto rispetto al passato, ma non ha perso il
proprio potere costringente. Un’alternativa più promettente rispetto a
quella dell’estinzione dell’individuo, e al contempo capace di tenere
conto delle debolezze dell’individualismo jamesiano, consiste invece nel
considerare i processi di socializzazione e di individuazione nella loro
interconnessione e nel loro necessario intreccio. Questo fa sì che l’individuo
sia impensabile al di fuori di una rete di vincoli, aspettative e relazioni
sociali e simbolico-istituzionali, ma che allo stesso tempo il processo di

Figure dell’individualismo
17
socializzazione non avvenga su di una tabula rasa priva di contenuti e
organizzazione. Questi contenuti sono le aspettative innate con cui
l’individuo viene al mondo, la sua dotazione genetica intesa in senso ampio,
ossia cioè che entrando in contatto con il sociale fa sì che ogni processo
di socializzazione sia unico e irripetibile. Lavorando in una simile
direttrice è forse possibile aggirare i paradossi che fatalmente sembrano
avvolgere il rapporto tra individuale e sociale.
MICHELA BELLA
MATTEO SANTARELLI
1 S. Franzese, Darwinismo e Pragmatismo e altri studi su William James, Mimesis 2009, p. 77. 2 W. James, I grandi uomini e il loro ambiente, Edistudio, Pisa 1995, p. 63. 3 F. Bordogna, Inner Division and Uncertain Contours: William James and the Politics of the Modern Self , The British Journal for the History of Science, Vol. 40, No. 4 (Dec., 2007), pp. 505-536, p. 517 [nostra traduzione]. 4 Ivi, p. 526 [nostra traduzione]. 5 E. Laclau, La ragione populista, Laterza, Roma 2008. 6 E. Durkheim, Le suicide. Étude de sociologie (1897) Puf, Paris 1967. 7 E. Durkheim, Les Règles de la méthode sociologique, (1894) Puf, Paris 193, p. 105. 8 Claude Gautier, La force du social, Puf, Paris 2011. 9 E. Durkheim, « Le dualisme de la nature humaine et ses conditions sociales », Scientia, XV, 1914, pp. 206-221.

Meditazioni filosofiche

Meditazioni filosofiche
19
PAUL DELVAUX, LE DIALOGUE, 1974.
lungo ho sostato di fronte a questo dipinto, percependone la
vicinanza, quasi l’intimità. Non saprei che cosa questo tardo-
surrealista belga abbia realmente voluto esprimere o sfogare con esso.
Forse niente, lasciandomi così ampio margine ermeneutico: magari,
come suggerisce il mare sullo sfondo, si tratta solo della trasposizione
onirico-metafisica di una breve sosta turistica tra le bizzarre colonne
della moschea di Hassan. Quasi certamente non è così, ma ovviamente
mi sono ben cautelato evitando di leggere qualsiasi pagina di critica a
riguardo.
In realtà esteticamente non trovo quest’opera molto attraente, però
mi parla come raramente accade invece con i verbosi trattati filosofici
contemporanei. Soprattutto parla di me, ritrovato nelle sue colonne, così
inutili, così fini a loro stesse: che ruolo hanno in questo paesaggio, che
cosa sostengono? Non il cielo, troppo basse. Si direbbe proprio nulla,
solo loro stesse, volendo i loro capitelli. Non c’è traccia di travi o archi,
solo un paesaggio metafisico dove alle colonne si aggiungono soltanto
gradini e basamenti piastrellati, rivelando una prospettiva un po’
deformata nelle proporzioni. Eppure tanto il dipinto quanto la surrealtà
che rappresenta si direbbero finite, le colonne non sembrano
abbisognare di alcunché di ulteriore.
Esattamente tale paradossale compiutezza dell’incompletezza o
dell’inutilità ritrovo in gran parte delle cose che ho fatto e che vorrei
fare. Le colonne sono come le mie azioni, non contribuiscono ad un
progetto architettonico, non sono collegate ad un disegno complessivo
ulteriore. Lo stesso accade per i miei studi e le mie ricerche: si spingono
fino ad un certo punto, talora senza nemmeno giungere a “scolpire” un
bel capitello, e poi vengono abbandonati (da me!). D’altra parte dove
dovrebbero arrivare? Anzi perché dovrebbero arrivare? Per quale
ragione prediligere un’ottica finalistica? Baudelaire ha detto: “essere un
A
INCUBO (O VISIONE) DI FILOSOFIA

Quaderni della Ginestra
20
uomo utile mi è sempre sembrata una cosa squallida!”. In effetti come si
può “architettare” la propria esistenza, costringerla in un progetto, e
conservare la dignità della libertà? Come si possono seriamente
programmare e dosare le proprie azioni in vista di uno specifico
obiettivo, per quanto molti tentino l’impresa?
Ecco dunque sublimate in quest’opera, ovviamente surrealista, tali
mie riflessioni esistenziali, mi sono detto. Però, riflettendo meglio, mi
sono reso conto che l’analogia rinvenibile in questo quadro è ben più
ampia e universale della mia misera individualità e lambisce la filosofia
intera. Ovviamente non la filosofia in sè, ma piuttosto (se ancora serve
dirlo nel 2014…) la filosofia per me, in quanto rovina, apatia, inutilità e
incompletezza: peculiarità per le quali quest’opera dovrebbe intitolarsi
“la philosophie” ben più che “le dialogue”.
Il paesaggio del dipinto richiama senz’altro le rovine di un sito
archeologico, per quanto decisamente ripulito: i resti di un’area templare
o di una stoa presentano analoghe scheletriche schiere di colonne. Una
visione che, pur destando numerose sensazioni positive, si accompagna
solitamente alla desolazione, all’abbandono, all’idea di un passato ormai
immobile, solo sporadicamente animato dai rapidi guizzi delle lucertole.
Una “musealità” evidente anche nella filosofia accademica, le cui
orazioni e certamina richiamano spesso, per attualità e pertinenza con la
vita, i dialoghi delle mummie del Federico Ruysch di leopardiana
memoria.
Un’altra caratteristica lampante è l’apatia, sia come espressività vuota
sia come, a dispetto del titolo, a-dialogicità. Se le due donne sono
coinvolte in una conversazione, questa non sembra andare molto oltre
una già improbabile telepatia. Il loro è un dialogo monotono, incolore e
inespressivo come i loro volti; forse è un soliloquio, se non addirittura
una litania, un puro sussurro privo di semantica, magari un monologo
interiore. Come statue tra le colonne, neppure i loro sguardi, grandi ma
spenti, paiono creare relazioni. Analogamente la filosofia delle
conferenze (e non solo quella) è traboccante di pseudo-dialoghi, legati
ad un’apatica e breve coabitazione tra persone che condividono solo
uno spazio fisico (o editoriale) e che si spartiscono una sequenza
temporale di interventi, senza scambio reciproco, senza comunicazione
reale. Come non c’è intesa e contatto tra gli sguardi e le parole delle due
donne, così non c’è comprensione e sintonia tra i discorsi dei filosofi
attuali. Quante volte si assiste infatti a “polverosi” convegni in cui, dopo
che apatici relatori hanno letto interventi simili a tristi soliloqui, altri
sedicenti filosofi rivolgono domande non-domande per le quali
riceveranno risposte del tutto decontestualizzate: quanto più stringenti
le conversazioni condotte da Vladimir ed Estragon durante la loro attesa

Meditazioni filosofiche
21
di Godot!
Già ho detto dell’inutilità quasi impudente delle colonne, prive di
schema e finalità. La casualità dei loro allineamenti, la disparità delle loro
altezze e la disomogeneità dei loro capitelli evidenzia come fin dall’inizio
non siano state concepite per l’usuale scopo sostenitivo. Non meno
inutile è la filosofia contemporanea, ormai abbandonata e snobbata sia
dalle scienze teoretiche che da quelle pratiche. Tuttavia non si rassegna e
pare anzi più indaffarata a ritagliarsi uno spazio di improbabile utilità
che a proporre idee peculiari e del tutto innovative, come le
consentirebbe l’assenza del fardello dell’immediata applicazione. Così
come le colonne che, per quanto nel dipinto appaiano già piuttosto
“soddisfatte”, potrebbero altrove trovare dignitose applicazioni, così le
elucubrazioni della filosofia, qualora realmente originali, potrebbero
costituire un’ottima palestra per il pensiero critico nonché una ricca
strumentologia o un archivio di spunti per le proposte dialettiche e gli
sviluppi “vivi” di altri rami del sapere.
In ogni caso “inutile” non è affatto da considerare un giudizio
negativo, semmai troppo realistico. È infatti l’inutilità la vera realtà con
cui l’essere umano si confronta nel labor della sua vita, al di là di risibili
illusioni volitive: chi se non Sisifo, così come descritto da Camus,
rappresenta l’essere umano per eccellenza? Coazione ad agire, a ripetere
con disperato entusiasmo pur nell’assenza di alcuna utilità, ripartendo
sempre poi dall’inizio, senza progresso, senza un fine se non l’inizio
della successiva azione.
Un’altra possibile difesa è considerare l’evanescenza dell’inutilità, in
quanto analoga al disordine: entrambi acquisiscono significato solo a
partire da uno specifico punto di vista, da una specifica visione del
mondo, che fissi obiettivi e punti di arrivo. Così come il disordine può
essere considerato solo un’altra forma di ordine (si pensi al Bergson di
Materia e memoria) allo stesso modo perché non vedere l’inutile solo
come un “diversamente” utile? Non è data un’inutilità assoluta, né
tantomeno un’utilità. Quindi come preferire uno scopo ad un altro?
Meglio forse non considerarne alcuno.
Le dialogue rappresenta senz’altro un paesaggio incompleto, manca ciò
che le colonne dovrebbero sostenere, proprio non ve n’è traccia. Allo
stesso modo la filosofia: sempre difettosa, al di là delle frequenti
illusioni, non giunge mai a una conclusione, a “lanciare” un arco o una
trave che congiungano dialetticamente un discorso ad un altro. Riparte
invece ogni volta con un nuovo discorso (una nuova colonna), un po’
perché facile preda dell’ansia di distinguersi dal precedente, del tutto
ridicola se si considera la sua sisifica condanna alla ripetizione
(riecheggiata nella limitata gamma di stili architettonici delle colonne),

Quaderni della Ginestra
22
un po’ perché proprio di discorsi a sé stanti si tratta - in pratica i pezzi di
un Mikado. Mai, proprio mai, si cerca un superiore elemento di
connessione. Ogni filosofo giunge tutt’al più ad uno splendido
“capitello”. Solo l’idea di partenza (“ciò che stiamo facendo è filosofia!”
- Alias il pavimento…) e la propensione solipsistica li accomunano.
Però, anche in questo caso, regole grammaticali e logiche a parte,
quando o a quale punto del processo di sviluppo si può in assoluto dire
che qualcosa è completo o incompleto, considerando l’incessante
divenire? Si potrebbe magari considerare completo ciò che giunge a
soddisfare l’intenzione di partenza del parlante/scrivente, quindi nulla di
intrinseco: che ne direbbero però gli altri? In ogni caso, a proposito di
incompletezza, spero che nessun lettore sia stato così ingenuo da
aspettarsi che qui…
FEDRO ANDIOTIN

Meditazioni filosofiche
23
«La mia tendenza e, io ritengo, la tendenza di tutti coloro che hanno mai cercato di
scrivere o di parlare di etica o di religione, è stata di avventarsi contro i limiti del linguaggio.
Quest'avventarsi contro le pareti della nostra gabbia è perfettamente, assolutamente
disperato. L'etica, in quanto sorga dal desiderio di dire qualcosa sul significato ultimo della
vita, il bene assoluto, l'assoluto valore non può essere una scienza […]. ma è un documento
di una tendenza dell'animo umano che io personalmente non posso rispettare profondamente
e che non vorrei davvero mai, a costo della vita, porre in ridicolo.»
Ludwig Wittgenstein, Lezioni e conversazioni sull'etica, l'estetica, la psicologia e la
cedenza religiosa, Adelphi, Milano, 2005, p.18
«Le stesse percezioni del mondo che generano la Scienza e la filosofia sono inconciliabili
l'una con l'altra, sebbene nascano dalla stessa pulsione, la pulsione della realtà. Da tale
pulsione colpita, però, la filosofia, accoglie il movimento, quell'acuto sentimento di apertura al
novum che chiameremo stupore e, compresolo come desiderato, opera per vivere in esso. La
filosofia è il fiore che mai avvizzisce della meraviglia, essa è la meraviglia ordinata.»
Pavel Florenskij, Stupore e dialettica, Quodlibet, Macerata, 2011, p.52
potizzare o proporre un confronto tra il pensiero, le posizioni
speculative di Wittgenstein e di Florenskij alla ricerca di
convergenze, affinità o posizioni comuni sembra, a prima vista,
un'operazione poco plausibile, forse incompatibile con i canoni di una
letteratura rigorosa. L'evidenza sembra, nell'immediato, suggerire il
contrario, prospettare un'incolmabile distanza e mettere in luce le
differenze di orizzonti, di contenuti e di stile degli autori in questione.
Sono diversi, prima di tutto, il clima e i territori del pensiero che i due
autori esplorano all'inizio della loro ricerca: per Wittgenstein decide il
confronto con Frege e Russel, con le correlative ricerche sui fondamenti
logici della matematica, per Florenskij l'interesse scientifico curva,
da subito, in una prospettiva multidisciplinare in cui trovano spazio la
letteratura, le scienze dello spirito e la teologia. Sono diverse, inoltre, le
istanze di fondo che motivano l'avvicinarsi dei due filosofi all'attività
speculativa: in Wittgenstein domina un'esigenza di chiarezza, il tentativo
di rendere trasparenti le possibilità del linguaggio, delimitando gli ambiti
delle sue pretese di verità; in Florenskij è determinante una prospettiva
metafisica che si traduce nel recupero del platonismo e
nell'elaborazione di una philosofia prima in cui la dimensione del
sovrasensibile comprende quella del sensibile.
Anche lo stile dei due sembra prestarsi a facili contrapposizioni: da
I TRA SILENZIO E STUPORE: L’ESPERIENZA FILOSOFICA IN
WITTGENSTEIN E FLORENSKIJ

Quaderni della Ginestra
24
un lato la prosa scabra e definitiva, al limite dell'aforisma, di
Wittgenstein, dall'altro la lingua ricchissima di Florenskij, fitta di
rimandi, digressioni e citazioni.
Se, tuttavia, si guarda ad alcuni contenuti specifici del loro pensiero
con una particolare attenzione a certe sfumature, non è impossibile
rintracciare qualche punto di convergenza nelle traiettorie originate dalla
loro riflessione.
Se non si può parlare di una vera e propria aria di famiglia tra
Wittgenstein e Florenskij, si può cogliere la condivisione di una certa
tonalità del pensiero rispetto allo statuto epistemico della filosofia, al
rapporto tra filosofia e scienza e, più in generale, al senso dell'esperienza
filosofica. In particolare, nella riflessione di Wittgenstein e Florenskij,
aldilà dei diversi orizzonti speculativi, c'è un dato che emerge ed è la
convinzione che la filosofia rappresenti un'esperienza conoscitiva in
grado di rendere conto, o quantomeno, di fare chiarezza su quegli
aspetti dell'umano sui quali la scienza non può pronunciarsi. Il sapere
filosofico, inoltre, nella riflessione dei due autori in questione, si pone
come un sapere integrale e complesso capace di tenere insieme il
profilo razionale della parola e del discorso con quello metarazionale del
sentire, degli affetti e dei comportamenti. .
In questa prospettiva è collocato un testo di Wittgenstein pubblicato
solo nel 1965 e situato all'origine di quella fase della ricerca speculativa
del filosofo viennese che culmina nelle Ricerche filosofiche. Nel testo in
questione- una conferenza pronunciata davanti a un' associazione
studentesca tra il 1929 e il 1930- Wittgenstein pone in evidenza un dato
caratteristico delle nostre abitudini linguistiche. Quando parliamo di
etica, utilizziamo termini come giusto, bene/buono e valore in un senso del
tutto diverso da quello corrente. Questi termini, nel contesto etico
hanno un senso assoluto, mentre, nel linguaggio corrente hanno un
senso relativo.
La ragione – o, per usare le parole di Wittgenstein- l'essenza di tale
differenza ha a che fare con l'oggetto delle nostre asserzioni: nei giudizi
di valore relativi, nel linguaggio ordinario, ci riferiamo a dei fatti. Questo
non accade quando ci occupiamo di etica.
Per chiarire la propria posizione a sostegno della distanza tra le
proposizioni etiche e il mondo dei fatti, Wittgenstein porta un esempio
tanto chiaro quanto suggestivo: se in un ipotetico libro universale in
grado di contenere la descrizione di tutti i fatti del mondo , trovassimo
la descrizione di un delitto , completa di tutti i particolari che riguardano
gli aspetti fisici e psicologici, non ci troveremmo di fronte ad alcun
giudizio o proposizione etica.
Le nostre parole – prosegue Wittgenstein seguendo la direzione

Meditazioni filosofiche
25
mmmm
UN’AMOROSA QUIETE

Quaderni della Ginestra
26
inaugurata nel Tractatus- non sono in grado di formulare giudizi di valore
assoluto perché non si danno stati di cose come il bene assoluto che
chiunque dovrebbe necessariamente conseguire. La nostra esperienza,
tuttavia, mostra continuamente la tendenza a esprimere giudizi di questo
tipo soprattutto nelle affermazioni a contenuto etico e religioso. In tale
prospettiva Wittgenstein rafforza il proprio procedimento
argomentativo con ulteriori esemplificazioni in riferimento a due
modalità del sentire che appartengono all'esperienza di ciascuno e alla
loro declinazione assertiva: il sentimento di meraviglia e la sensazione di
essere completamente al sicuro. La scelta non è casuale: si tratta di stati
emotivi cui il filosofo attribuiva un'estrema importanza nel proprio
vissuto e che, più in generale, costituiscono , come tonalità emotive, i
presupposti di posizioni speculative filosofiche e religiose.
Non è difficile intravvedere, nel meravigliarsi per l'esistenza del
mondo quell'atteggiamento di stupore che una tradizione immemorabile
collega alla nascita della filosofia e, allo stesso modo, non è inopportuno
rintracciare le affinità tra il sentirsi assolutamente al sicuro di cui parla
Wittgenstein e il radicale sentimento di dipendenza dall'infinito in cui un
autore come Scheleiermacher ravvisa l'origine del sentimento religioso.
Le traduzioni linguistiche di tali aspetti emotivi sono considerate da
Wittgenstein in una duplice prospettiva: sono, da un lato, espressioni
prive di significato, ma, dall'altro, rappresentano una tendenza
dell'animo umano che l'autore non vorrebbe mai, a costo della vita, porre in
ridicolo.
Le considerazioni del filosofo formulate nel testo della conferenza
testimoniano il rispecchiarsi delle sue tensioni personali nella
dimensione teoretica: in una fase iniziale della propria riflessione
Wittgenstein sembra riconoscere come significativo il solo discorso delle
scienze, che opera nel mondo dei fatti, per orientare successivamente la
propria indagine alla pluralità delle forme di vita e alla coerenza interna
dei linguaggi che la descrivono. Cambia, in questa prospettiva, anche il
ruolo della filosofia: da garante del silenzio su quanto nel mondo dei
fatti non si può affermare ad apertura del pensiero e del linguaggio che
mostra la complessità dell'umano anche dove rinuncia alla descrizione.
Una modalità simile di concepire la peculiarità ed i limiti del
conoscere filosofico è ravvisabile in un breve scritto di Pavel Florenskij
del 1918, Stupore e dialettica, in cui l'autore mette a confronto l'indagine
filosofica e quella scientifica.
La scienza -osserva Florenskij deve necessariamente lottare contro
l'assenza di metodo che abita il senso comune – la visione comune del
mondo – cercando di dare ordine, e forma a un discorso, quello del
linguaggio ordinario, in cui non c'è chiarezza. Nel suo processo di

Meditazioni filosofiche
27
continua ridefinizione dei propri ambiti, il pensiero scientifico rischia di
rivelarsi inadeguato ed immobile rispetto a quella che il filosofo russo
chiama “la pienezza e il movimento del vivere”.
La filosofia, diversamente, riesce a restituire nella comprensione tale
pienezza poichè è un linguaggio costruito da una pluralità di descrizioni
che si fonda sul continuo movimento delle proprie strutture simboliche.
In una parola- afferma perentoriamente Florenskij- la filosofia è
dialettica, relazione viva con la realtà, esperimento ininterrotto su di essa
per giungere a comprendere I suoi strati più profondi.
La radicale diversità dell'esperienza filosofica rispetto a quella
scientifica riguarda, secondo il pensatore russo, anche le fonti. Seppure
la scienza e la filosofia nascano dalla stessa pulsione a comprendere, la
filosofia si pone come sentimento di apertura al nuovo , come stupore ,
come meraviglia ordinata.
Ed è proprio nella definizione della filosofia come apertura al non
ancora detto e all'indicibile che i destini speculativi di Wittgenstein e
Florenskij finiscono per incontrarsi, nell'idea comune che il compito
della filosofia risieda nel confronto interminabile ed inesauribile con la
vita e la sua complessità.
LIVIO RABBONI


Cinema e filosofia
29
I.
he complete victory of the factory of facts over the factory
of grimaces – that is what I expect from A Sixth Part of the
World.” In these words Dziga Vertov, the Soviet Russian avant-garde
filmmaker, refers to his new production in an interview for Kino
magazine in August 17, 1926. By saying this, Vertov reiterates his
ambition to reinvent the very concept of cinema. In order for cinema to
become active part in the process of creation of a new socialist society,
it had to be radically cut off from theatre and literature. This meant that
everything that belonged to film as fiction – the plot, the sets, the
actors, and the script – was to be rejected by Vertov and his
collaborators.
The members of Vertov’s group called themselves “kinoki,” a
neologism combining the Russian words “kino” for cinema and “oko”
for eye. By boycotting acted films, they wanted to show “life as it is,”
devoid of any theatricality and liberated from the “grimaces” of the
bourgeois world. The idea was to turn away from entertainment and
commerce towards a mental self-reflective construction of reality – the
reality of the revolution. This involved various experiments with modes
of perception and cognition, to an extent where vision was placed
under the impossible imperative to become homologous with the
incessantly moving and all seeing eye of the camera: “Freed from the
rule of 16 – 18 frames per second, free of the limits of time and space,
I put together any given points of the universe, no matter where I have
recorded them,“ – this was the revolutionary message of the so-called
“Kino-Eye“ manifesto from 1923.
The result was highly experimental films where reality and its
assemblage merged into political statements. Driven by the ambition to
decode the communist structures of the world, the cinematic “factory
of facts” sought to establish a new truly universal language of the film by
giving form to the material, by giving a “language” not only to the
people but also to things and machines. The political and philosophical
challenge consisted in uncovering the laws of their existence, of their
function and interrelations. By editing the filmed material into
successions of images, these laws were meant to be given a visual
expression.
II.
The Man With the Camera (1929) has come to be seen as most
“T
VIEWERS TURNED INTO PARTICIPANTS: DZIGA VERTOV’S A SIXTH PART OF THE WORLD
(1926) DI PETER CARRUTH

Quaderni della Ginestra
30
emblematic of Vertov’s strivings to establish a new language of the
screen. A Sixth Part of the World (1926), however, is in some respect even
more interesting to consider. Not only does it illustrate very well the
relationship between form and material in Vertov’s art as well as its
radical move away from theatre. The performative quality of the film
also makes us become aware of those elements of Vertov’s aesthetic
experiment that in the end put it at risk of failure.
A Sixth Part of the World was edited based on newsreel material shot
during ten expeditions in different parts of the USSR. The overall
material comprised 26,000 meters of film. The result is astounding: The
viewer witnesses “a six-reel camera race,” as Yuri Tsivian called it, while
the intertitles help to organize newsreel material into a film by giving it
rhythm and semantic unity. The film’s central theme is the
industrialization of the Soviet Union. Its basic line is simple: The film
shows the riches and the vast geographical space of the USSR, it shows
how goods are being produced as well as the process of their delivery
and exchange for the machines urgently needed in the process of
industrialization.
In A Sixth Part of the World nature and culture, the geographical and
the social spaces merge into the socialist project bigger than individual
life. The film shows landscapes – harsh conditions of life in the North,
the beauty of the South, the Caucasus Mountains, the Siberian taiga,
and the Arctic Ocean; it shows animals – horses, reindeers, and pigs,
and it is full of ethnographic details exposing the everyday life of the
people of different religions, customs, and languages. Without being
aware of being filmed, people act “as they are,” the film shows how
everyone of them – no matter whether orthodox, moslem or pagan, a
Samoyed eating raw reindeer meat, a shaman or a veiled women –
everyone without exception becomes integrated into the state trading
apparatus and, by virtue of that, into the new society. The film seeks to
prompt the audience to the conclusion that even “the most backward
peoples are involved in the construction of Socialism,” as it is indeed
stated in one of the intertitles.
Towards the end of A Sixth Part of the World a series of powerful
shots of the icebreaker “LENIN” is shown to epitomize the
revolutionary process. Within the composition of the filmic images the
icebreaker serves as a link between the present and the future, thus
becoming a symbol of social transformation. Not only does it move the
export goods to the West, it also paves the way for the country’s cultural
progress, for its emancipation from prejudices, superstition, and
illiteracy. Therefore after the icebreaker scene nothing remains as it was –
women “cast away” their veils and become members in the Komsomol,

Cinema e filosofia
31
we see Samoyeds, Buriats, and Mongols reading newspapers, Mongolian
children becoming Pioneers, images of reading halls and of the masses
listening to the radio-lecture appear on the screen. The chimney smoke
– an image that is repeatedly used throughout Vertov’s films – promises
a better future not only for the workers but also for the peasants which
“someplace still plough the earth with a stick” and now will be able to
use machines.
What gives shape to A Sixth Part of the World, however, is that it is
based on a sharp antagonism between the world of the Capital and the
reality of socialist construction. The core idea is to show how the old
world is doomed to be superseded by the new reality of socialism. This
new reality is shown as a collective body, vibrant and alive. By contrast,
the world of Capital is presented in a gaudy way by sketchy references
to alienated workers in enormous factories in the West and to the
colonies’ enslavement, by images of African Americans’ dancing for
entertainment, of the foxtrots in a drawing room, of a bourgeois
couple, and by images of a fur coat and a female’s necklace. The
quintessence is summed up in one of the intertitles’ declamation that
“on the verge of its historical perishing / Capital / is having fun.”
For these images of bourgeois and NEP pleasures, on the one hand,
and blindness towards severe injustice, on the other, Vertov used
footage material that was filmed by someone else, as if he took the
decision not to mingle his revolutionary “life off-guard”-style with
bourgeois realities. By this opening sequence, Vertov sought to unmask
the alienating, self-deceiving, and blindly calculating logic of capital but
also to arouse in the viewers the sentiment of condemnation at the
sight of it. This impression is, once again, reinforced by the intertitles:
“In the land of Capital / I see / the golden chain of Capital / the
foxtrot / the machines / and you / and you / I see you / and you / and
you / and you / it is you I see / in the service of Capital.”
In view of all this, it appears odd, to say the least, that A Six Part of
the World was commissioned by the State Trading Organization in order
to promote export goods trade, among them most importantly, grain,
hemp, the fish of the Caspian Sea, the tabacco of Abkhazia, the skins
of the wild animals of the North which then for instance, strangely
enough, go to the Leipzig Trade Fair to be displayed and sold. As Walter
Benjamin described it in his essay “On the Present Situation of Russian
Film” (March 11, 1927), the double message of the film was to show to
the foreigners that “we are not dependent on foreign countries and
natures – Russia is, after all, a sixth of the world! Everything in the
world is here on our own soil.” As captured very clearly in the
intertitles, the purpose of the film was to empower the people, all

Quaderni della Ginestra
32
people, to make everyone realize that “you Tatars / you Buriats /
Uzbeks / Kalmyks / Khakkass / mountaineers of the Caucasus / you,
Komi people / [...] and you, of a distant village / [...] / All of you are
the masters of the Soviet land / hold in your hands a sixth part of the
world.” The ideological purpose, in other words, was to fuse the
audience home and abroad with the enthusiasm for the reality of the
socialist revolution.
The film was controversially received, acclaimed by a number of
critics as “an authentic cinema symphony,” even compared to the poetry
of Walt Whitman (indeed a source of inspiration for Vertov) but also
severely criticized as “naive” and as a “failure” by others. Walter
Benjamin’s entry into his Moscow diary on January 5, 1927 also clearly
betrays some disappointment: “I went to see One-Sixth of the World (at
the Arbat cinema). But there was much that escaped me.” Two months
later, in his essay on Russian Film cited above Benjamin is more explicit
about what went wrong: “It must be admitted that Vertov, the director,
has not succeeded in meeting his self-imposed challenge of showing
through characteristic images how the vast Russian nation is being
transformed by the new social order. The filmic colonization of Russia
has misfired.” Despite the rich material, the director loses its aesthetic
object of the on-going revolution. – Why did that happen? What are the
reasons for that?
III.
The failure of the film is connected with Vertov’s own theoretical
assumptions on which it is based, in particular his strategic decision to
abandon the distinction between the “viewers and the spectacle.” For
Vertov, as he himself explains in the interview mentioned above, “ [t]he
very concept of this film and its whole construction are now resolving
in practice the most difficult theoretical question of the eradication of
the boundary between viewers and spectacle.” He develops this point
further by stating that “A Sixth Part of the World cannot have critical
opponents or critical supporters within the borders of the USSR, since
both the opponents and the supporters are also participants in the
film.”
This “theoretical question” how to fuse observers with the
participants is in itself unproblematic. We could even say that it is
clearly connected with the promise of democratization – the promise
that everyone can become part of art either by watching it or by being
filmed. This is one of the main emancipatory consequences resulting
from the kinoki project of replacing feature films by the newsreel.
Walter Benjamin, as the following passage from his essay The Work of

Cinema e filosofia
33
nnnnnnnn
nnnnnnnn
nnnnnnnn
nnnnnnnn
nnnnnnnn
nnnnnnnn
nnnnnnnn
Art in the Age of Mechanical Reproduction (1936) demonstrates, has
recognized very clearly why this shift was so significant: “[T]he newsreel
offers everyone the opportunity to rise from passer-by to movie extra.
In this way any man might even find himself part of a work of art, as
witness Vertov’s Three Songs About Lenin,” and then he adds
affirmatively: “Any person today can lay claim to being filmed.”
This notion of promoting the process of democratization by relying
solely on the permanence of the aesthetic revolution brings us very
close to Jacques Rancière’s understanding of what “artistic modernity”
actually means. In his recent study, Aisthesis (2013) Rancière claims that
art emerges as a recent phenomenon “when this hierarchy of forms of
life begins to vacillate,” it begins “by giving itself a new subject, the
people, and a new place, history.” In order to document this process,
Rancière writes a “counter-history of ‘artistic modernity’.” Spread out
in a series of Scenes from the Aesthetic Regime of Art this “counter-history”
demonstrates “how art, far from foundering upon these intrusions of
the prose of the world, ceaselessly redefined itself – exchanging, for
example, the idealities of plot, form and painting for those of
movement, light and the gaze [...].” Bearing this in mind, it is far from
being surprising that one of Rancière’s scenes is devoted precisely to
Vertov’s A Sixth part of the world. For Rancière Vertov’s films were able NUOVI SILENZI (PART.)

Quaderni della Ginestra
34
to show “the dynamism of collective forms that cuts across any
particular activity.”
This dynamism is indeed the source for enthusiasm that A Sixth part of
the world conveys. Yet, at the same time, there is a sense that something
went dramatically wrong. Cinema that negates the logic of theatre
seems to lose sight of an important element of aesthetic experience in
theatre, – an experience that is grounded on the aesthetic distance
between the audience and what is being performed on stage. By keeping
all theatrical elements away from film, Vertov seems to destroy the
aesthetic distance altogether. By erasing the distance between the
observer and the aesthetic object, however, Vertov also relinquishes the
critical potential that is crucial to any process of political and social
transformation.
Vertov goes as far as claiming that “this film has, strictly speaking, no
‘viewers’ within the borders of the USSR, since all the working people
of the USSR (130-140 million of them) are not viewers but participants
in this film.” The vision he has is that the viewers turned into
participants will all be bound by the force of the “emotional action”
from which the bourgeois world necessarily remains “isolated” and
therefore becomes “the enemy of the Soviet State.” The outcome is,
however, that what is called “emotional action” becomes
indistinguishable from a major self-deception: What the viewer is
confronted with is an investment of human labour and life – his own
labour and life – into a huge industrialization process devoid of any
meaning and blind towards its own future. Thus, to implicitly quote
Rancière, the “strategic will” of building a new social order literally
“loses its world.”
And yet, despite all this, the decisive question remains, the question
how to transform the “material” of this world, the raw data of facts, so
to speak, into political statements that are able to generate true
generalities. In other words, how is the cinematic language of facts to be
thought of that is capable of making visible the community of people and
things? Surprisingly, this idea can be best expressed when turning to
Kant. In a way, the Kantian “I think” – as a condition of possibility for
any act of cognition – has been replaced in Vertov’s art by the “I see.”
The purpose of the gigantic “I see” that is visualized by the intertitles is
“to fuse the film with its viewers” in order to make a new community
of men free and equal visible – a community that takes shape in the
sensible life. It seems that the problem residing here is distinctly
Kantian as it leads us to the question how ideas translate into reality.
In the 1980s Jean-François Lyotard in his lecture entitled
“Enthusiasm: The Kantian Critique of History” (1986) addressed this

Cinema e filosofia
35
problem by suggesting to focus on the “passages” between the realm of
ideas and the realm of experience in Kant’s philosophy, “passages that
to be sure are not bridges.” Kant’s concept of enthusiasm proved to be
vital for this analysis. Lyotard links this concept with the idea of the
sublime. Human sensitivity towards the sublime indicates that the
recipient of this specific type of affect is able to realize – against the
overwhelming but shapeless power of nature – that there is nothing
standing against moral destiny and human freedom. In its most radical
form, the capacity to set out purposes in the world, to determine
oneself freely and ultimately the capacity to culture (as the trace of
freedom in the world) is experienced as a felt paradox: Something that is
“formless” (for instance, a force of nature) makes us aware of
something lying outside of the experience, this “outside” is for Kant the
idea of the cosmopolitan society, the “weltbürgerliche Gesellschaft,”
that can neither be represented nor put into practice as such by entering
in the realm of experience but nevertheless reveals itself in the
culturally transformed nature of our affect. – For our thinking,
emancipatory events are always “cases,” as Lyotard following Kant
himself suggests calling them. As they fall out of the realm of necessity,
they possess an atemporal and coincidental character. They are “signs”
that make us sense the absolute goodness of the moral idea despite the
formless event in practice. Therefore Lyotard speaks of a “complex
hypotyposis” in which two incommensurable sentiments coexist. In
fact, enthusiasm is a strong indication of such passage between nature
and freedom.
The complex structure where incommensurable ideas are brought in
relation with each other in an unexpected way is, in fact, one of the
distinguishing features of the technique of dialectical montage Vertov
deploys. However, coming back to the notion of enthusiasm, the
difference between the Kantian concept of this significant emotion and
the strategy Vertov chose for A Sixth Part of the World is absolutely
striking: Kant speaks of enthusiasm when he describes the experiences
of a non-participating public watching the events of the French
Revolution as they unfold. The passive observers are nonetheless active
as they experience a complex emotion: As Lyotard sums up Kant’s view,
the emotional state of the spectator on the occasion of this event
oscillates between the “pathological” aspect of the feelings that the
revolution evokes (an aspect that is connected with the prospect of
utility of the coming new order), on the one hand, and the
fundamentally different aspect of this feeling – the tension that results
from the moral idea of the “absolute good,” on the other hand. By
contrast, to rely solely on the actors of the revolution who the audience

Quaderni della Ginestra
36
is supposed to completely identify with – as it happens in Vertov’s film
– means to betray the revolutionary potential of realization of political
freedom.
It is by this operation of identifying spectators with participants that
Vertov’s film loses its political quality and becomes indistinguishable
from mere agitation. To put this problem in Kantian terms, what occurs
here is the collapse of the distinction between “moral politician” and
“political moralist.” When the status of observers is lost, then
observation becomes part of the aesthetic production in such a way that
the latter does not aim at truth but claims itself to be true, to be the
reality of the revolution. By watching the films the spectators merge
with a utopian social practice.
At a closer look, however, it appears that this consequence clearly
betrays the very principle of Vertov’s “Kino-eye.” The gaze of the
“Kino-eye” becomes reflective only as it forces us to distance ourselves
from the everyday by virtue of images that open up the possibility for
new modes of perception. If there are moments of political “truth” in
art then they lie in opening up this potential to overcome any fixed or
pre-shaped structures of thought, in inviting the viewers to see
differently. This is what the technique of dialectical montage initially
stands for. Once the distance between production and reception
collapses, we find ourselves in the agitating propaganda that is only
capable to generate pseudo-generalities of images saturated with
emotions and meaning, – images that foreclose possibilities of human
emancipation. From the avant-garde project we seem to have been
relocated into a new trajectory – a trajectory that leads to a blind future
of socialist realism.
TATJANA SHEPLYAKOVA

Cinema e filosofia
37
REFERENCES
“A Sixth Part of the World – List of Intertitles,” in Lines of Resistance: Dziga Vertov and the Twenties, ed. with an introduction by Yuri Tsivian, Pordenone: Le
Giornate del cinema Muto, 2004, pp. 187-193.
Walter Benjamin, Moscow Diary, ed. Gary Smith, trans. Richard Sieburth,
Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1986.
Walter Benjamin, “’On the Present Situation of Russian Film’ (‘Zur Lage
der Russischen Filmkunst,’ Literarische Welt, vol. 3, no. 10, March 11, 1927, p. 6),” in Lines of Resistance, pp. 210-214.
Walter Benjamin, “The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction,” in Illuminations, ed. with an introduction by Hannah Arendt,
trans. Harry Zohn, New York: Schocken Books, 1969.
Immanuel Kant, The Conflict of the Faculties / Der Streit der Fakultäten [1798],
trans. and introduction by Mary J. Gregor, New York: Abaris Books, 1979.
Jean-François Lyotard, Enthusiasm: The Kantian Critique of History [1986],
trans. George Van Den Abbeele, Stanford, CA: Stanford University Press, 2009.
Jacques Rancière, Aisthesis: Scenes From the Aesthetic Regime of Art , trans.
Zakir Paul, London: Verso, 2013.
Yuri Tsivian, “Introduction,” in Lines of Resistance, pp. 1-28.
Dziga Vertov, “A Sixth Part of the World (A Conversation with Dziga Vertov),” in Lines of Resistance, p. 182.
Dziga Vertov, “The Council of Three, April 10, 1923,” in Kino-Eye: The Writings of
Dziga Vertov, ed. with an introduction by Annette Michelson, trans. Kevin O’Brien, Berkeley: University of California Press, 1984, pp. 14-21.
FILMOGRAPHY DETAILS: A SIXTH PART OF THE WORLD
A Sixth Part of the World. A Kino-Eye Race around the USSR: Export and Import by the State Trading Organization of the USSR (Shestaia chast’ mira. Probeg Kino-
Glaza po SSSR: Eksport i Import Gostorga SSSR)
A film poem. 6 reels. 1718 metres.
Produced by Goskino (Kultkino), Moscow, and Sovkino, Moscow, 1926. Released 31 December 1926.
Author-Leader: Dziga Vertov
Assistant Director: Elizaveta Svilova. Assistant to the Author-Leader and Chief Cameraman: Mikhail Kaufman.
Cameramen: Ivan Beliakov, Samuil Bendersky, Petr Zotov, Nikolai
Konstantinov, Aleksandr Lemberg, Nikolaii Strukov, Iakov Tolchan. Film Reconnaissance: Abram Kagarlitsky, Ilya Kopalin, Boris Kudinov.
[Taken from: “Vertov’s Silent Films: An Annotated Filmography,” in Lines of
Resistance, p. 408]

Quaderni della Ginestra
38
“Live in each season as it passes; breathe the air, drink the drink, taste the
fruit, and resign yourself to the influence of the earth.”
Henry David Thoreau, Walden
pstream Color. Il Ladro (the Thief) assale Kris di notte, all’uscita
di un Club. Le fa ingerire una droga che contiene un
esemplare vivo di nematoda, un verme cilindrico infestante estratto
dalle sue speciali orchidee blu. Il Ladro sfrutta la suggestione ipnotica
prodotta dalla droga per esercitare una forma di controllo mentale
sull’esistenza di Kris. La deruba e vive da lei per qualche giorno,
distraendola con elaborati espedienti. Privata di ogni cibo solido, Kris
ricopia su foglietti di carta, poi piegati e incollati in modo che formino
una ghirlanda ad anelli, le pagine del Walden di Henry David Thoreau.
Risvegliandosi nel proprio letto, ormai sola, Kris osserva una serie di
corpi estranei che si muovono sotto la superficie della sua pelle. Dopo
aver cercato vanamente di rimuoverli, autoinfliggendosi ferite con un
coltello da cucina, è irresistibilmente ricondotta verso una fattoria fuori
città. Qui, il Campionatore (the Sampler), dopo aver richiamato i
nematodi che vivono dentro Kris usando degli infrasuoni, rimuove i
vermi dal suo corpo convogliandoli in quello di un maiale. Tornata a
casa, Kris scopre di aver perso il lavoro. Il suo conto è stato prosciugato.
Non ricorda nulla. Un anno dopo incontra Jeff, un ex broker colpevole
di aver truffato alcuni clienti nel corso di una presunta psicosi.
Sentendosi misteriosamente attratti e scoprendo di condividere
memorie e frammenti percettivi/uditivi, Kris e Jeff iniziano a
frequentarsi. Tra di loro nasce una specie di amore. Le loro esistenze
scorrono in paradossale sintonia con quelle dei maiali allevati dal
Campionatore. Quando Jeff sente Kris mormorare alcune frasi del
Walden, i pezzi cominciano a ricomporsi.
Regista, sceneggiatore, operatore, produttore, montatore, e
compositore delle musiche dei suoi lavori, Shane Carruth è una delle
voci più interessanti del panorama nordamericano indipendente che si
dedica alla sci-fi. È arrivato al cinema dopo un major in matematica e un
passato da programmatore per simulatori di volo. I critici scrivono che i
suoi film, e soprattutto le storie che raccontano, non assomigliano a
quelli di nessun altro. Di film, Carruth ne ha girati soltanto due, per di
più usciti a quasi dieci anni di distanza l’uno dall’altro. Eppure il fattore
temporale non ha giocato a suo sfavore. Carruth tratta temi filosofici
con uno sguardo scientifico e temi scientifici con uno sguardo
U
UPSTREAM COLOR DI PETER CARRUTH

Cinema e filosofia
39
filosofico. Non cerca di farsi capire, preferisce complicare le cose. Il
primo film, Primer – comparso nel 2004, costato appena 7000 dollari, e
subito diventato un fenomeno di culto (più o meno) sotterraneo –
sviluppava alcuni paradossi della causazione attraverso il tema dei viaggi
nel tempo. Due giovani ingegneri – tra cui lo stesso Carruth, che
interpretava lo spavaldo Aaron – costruivano per caso una macchina
che consentiva di viaggiare nel tempo. All’inizio pensavano di arricchirsi
giocando in borsa, ma la faccenda finiva per sfuggire loro di mano
molto prima del previsto. Un meccanismo a orologeria che richiedeva
un adeguato tasso di concentrazione. Upstream Color – [la cui visione era]
“obviously, the thing to do this weekend” , per il critico del New Yorker
che ne scriveva a inizio aprile 2013 – è per certi versi più accessibile. Il
suo legame con teorie filosofico/scientifiche è più sfumato, più
suggerito ed evocato che chiamato direttamente in causa. Al tempo
stesso, il fatto che le immagini siano legate da un filo più emozionale
che logico, dove la sceneggiatura perde di consistenza e i personaggi si
muovono come in un sogno, ne rende più ineffabile il mistero. Se, con
Primer, la difficoltà era soprattutto appannaggio dello spettatore,
costretto a districarsi fra teorie fisiche e paradossi temporali, qui il
problema non è (solo) tecnico o teorico. Il mistero, qui, si cela nella vita
stessa, nella possibilità di coglierne la globalità e non solo i frammenti.
Salvo qualche svista, i personaggi del primo film stavano dietro gli
ingranaggi. Nel secondo, sono abbassati al livello degli spettatori,
altrettanto smarriti e persi. Il pragmatico ingegnere di Primer si trasforma
nel paranoico broker – il personaggio di Carruth in Upstream Color –, che
si rannicchia spaventato nella vasca da bagno.
Upstream Color è un film sull’identità diffusa, ove il principio
d’individuazione che marca ogni vivente si scioglie nell’equilibrio –
spontaneo o indotto – dei cicli chimico-biologici che legano fra di loro
gli esseri naturali. La figura del ciclo/cerchio, da rompere o da
ricomporre, ritorna di continuo in chiave simbolica (gli anelli di frasi
ricopiate dal Walden; lo strumento rotante, una specie di tornio, del
Campionatore). Ma non si tratta (solo) di facili metafore. Goethe
parlava di una pianta originaria (Urplanz), la forma elementare che,
attraverso giochi metamorfici, dà origine a strutture più complesse, per
poi tornare nella costituzione fisica degli esseri umani. Carruth ritrova
nel cerchio la forma base sulla quale costruire una narrazione ellittica,
metamorfica, solo apparentemente destrutturata, attenta a cogliere gli
stati emotivi dei suoi personaggi più che a ricostruirne le fila. Immagini
opache ed evanescenti, accostate per analogia interna, e percorse da
sonorità elettroniche e naturali (i rumori del vento e della pioggia), si
incardinano in una costruzione elaborata, ricorsiva, ove lo spettatore,

Quaderni della Ginestra
40
insieme ai personaggi, procede a tentoni, guidato a malapena o, spesso
sviato, da mezze frasi appena percettibili. Gli scenari urbani e rurali in
cui i personaggi si muovono perdono la loro sconvolta consistenza e
definitezza, mentre le levigate superfici geometriche dell’ufficio di Jeff
aumentano il senso di estraneità e distacco. Le vite dei quattro
personaggi principali – tutti in qualche modo atomizzati e misteriosi – si
incrociano come spinte dal caso e dal fato o, più semplicemente, da un
meccanismo naturale di attrazione e repulsione privo di volontà
cosciente.
L’identità è definita, al tempo stesso, come perimetro
necessario/gabbia salvifica dell’io, e come limite/barriera che rompe
l’interconnessione con l’altro. Svuotate da un meccanismo di controllo
mentale prodotto dal Ladro, le identità di Kris e di Jeff riappaiono come
macchie di colore, frammenti di storie in cerca d’autore, rumori che
emergono da uno sfondo indefinito. Se l’identità diventa quindi un
concetto sfuggente e opaco, il rapporto mente-corpo si rompe quasi
subito. Il corpo di Kris, vittima della manipolazione mentale del Ladro,
si riduce a un burattino privo di anima e di memoria – se non quella
puramente fisica, inscritta nelle ferite che si autoinfliggerà per liberarsi
dai corpi estranei. Tornata apparentemente in se stessa, la donna è
vittima di un inaspettato scollamento, che la porta a cercare il suo antico
LOVE IS NEEDING TO BE LOVED, (PART.)
io fuori da se stessa, ritrovandolo paradossalmente nell’altro.
Come lo sguardo del costantemente evocato Thoreau, quello di
Carruth coglie il trascendentale in ogni essere vivente. Eppure, in
Upstream Color, il trascendentale e il mistico non hanno nulla di
sovrannaturale, ma si incarnano e si fanno tangibili nella realtà materica
di piante, uomini e nematodi. C’è un po’ di Terrence Malick certo, ma
senza la sua estatica meraviglia o il suo afflato mistico. Il trascendentale
non si colloca, infatti, al di là dei viventi, ma nelle relazioni di

Cinema e filosofia
41
dipendenza, affinità e persino violenta opposizione che legano gli esseri
fra di loro. Apparentemente il messaggio che chiude il cerchio è una
promessa/invito di ritorno alla natura, con gli orchid harvester che
lavorano quieti nei campi e Kris che tiene in braccio un cucciolo di
maiale. Thoreau e l’utopia naturalistica, certo. Ma Carruth non ci lascia
con un messaggio lineare e immediatamente decifrabile. Non si tratta di
un enigma da risolvere, come in Primer, ma di un mistero che deve
restare al fondo irrisolto. Upstream Color non offre un messaggio morale
normalizzante, ma sviluppa una storia metafisica. Kris uccide il
Campionatore che l’aveva aiutata a liberarsi dei vermi, e non il Ladro
che l’aveva stordita e derubata. Uno sparo che segue una scena onirica.
Il cerchio si rompe, ma non si capisce bene che cosa accada e perché sta
accadendo.
SOFIA BONICALZI
SCHEDA FILM
Titolo originale Upstream Color
Nazione U.S.A.
Anno 2013
Durata 96’
Regia Shane Carruth
Cast Shane Carruth, Amy Seimetz, Andrew Sensenig, Thiago
Martins
Produzione ERBP


Letteratura e filosofia
43
’ antica Battriana1, (oggi Afghanistan) prende nome dalla città di
Bactra, oggi Balk, a 30 Km da Mazar- e-Sharif. A poca distanza, sul
sito di Tepe-i-Zirgaran, “la collina del metallo”, si trovano i resti della
fondazione di Alessandro Magno. Non lontano da qui a TaKht-i-
Rustam, il trono di Rustam, presso Samangan, sorgono le rovine di un
monastero buddhista con evidenti influssi indiani e uno stupa
monolitico di roccia calcarea non ultimato, e forse interrotto, per la
calata degli Unni Eftaliti nel 425 d.C. Lo stupa ricorda il sangharama,
(tempio) di Darunta nei pressi di Jalalabad. In tutto il paese, i siti
buddhisti sono diversi e molti interessanti materiali rinvenuti sono
conservati al Museo Guimet di Parigi e al Museo Nazionale di Kabul,
altri ogni giorno sono avviati al mercato clandestino. Tuttavia, il sito più
suggestivo e denso di testimonianze è la valle della città di Bamyan,
detta la valle degli Dei, situata in una conca a 2500 m., in una zona
fertile e alberata, protetta dalle alte vette circostanti dell’HinduKush. La
sua storia iniziò con il popolo nomade dei Kushana che raggiunse
l’apogeo con l’imperatore Kaniska nel I secolo d.C. Fu centro di
diffusione del pensiero buddhista e capitale di un regno feudale
indipendente, esteso dal Tagikistan alla Valle del Gange, fino alla
conquista islamica del 970 d. C. L’imponente complesso monumentale,
architettonico, artistico si sviluppò all’interno e all’esterno di una
falesia, lunga oltre due chilometri. Alle sue estremità furono scolpite
entro nicchie due colossali statue di Buddha rispettivamente di 35 e 53
m. d’altezza. L’arte prodotta nella regione e di soggetto buddhistico è
espressione dell’iniziale fusione culturale, filosofica, artistica operata da
Alessandro Magno tra Occidente e Oriente che trova espressione finale
nella cosiddetta arte del Gandhara dal nome di un sito presso Peshavar,
in Pakistan, dove si manifestò per la prima volta e, nel corso di un
processo d’espansione verso Occidente, raggiunse il Nord
dell’Afghanistan. Tale arte rappresenta la commistione di elementi della
cultura indiana, del pantheon greco, del buddhismo, del paganesimo
nomade delle steppe dell’Asia centrale. Essa si realizza in una
produzione di rilievi in pietra e in materiale plastico (argilla e stucco).
Quest’arte non è nata per generazione spontanea; è l’effetto di un
incontro tra gli ideali artistici e filosofici del mondo ellenistico, come
sopravviveva nelle province orientali dell’impero romano, e della
spiritualità buddhista. In queste contrade arrivava l’onda della religiosità
indiana e il Buddhismo si modificava, cercava di rendersi accessibile alle
diverse genti, si adattava a certe loro esigenze spirituali, al loro modo di
esprimersi, accoglieva con tolleranza le idee, le favole, le liturgie che non
L
LA VALLE DI BAMYAN

Quaderni della Ginestra
44
fossero del tutto inconciliabili con i suoi principi fondamentali. Nacque
così una nuova teologia e una nuova arte e una nuova filosofia nella
quale disparati indirizzi s’incontravano o confluivano l’uno nell’altro;
l’ellenismo classico, allusivo e narrativo, il partico, rigido e frontale,
l’indiano, morbido e sensuale. Kaniska fece coniare monete con figura
di Buddha stante e la legenda Boddo in caratteri greci. In questa fase il
Buddhismo non avrebbe potuto seguitare a parlare il linguaggio
monacale e ascetico delle scuole antiche se non a rischio d’isterilirsi. Si
trovava di fronte stirpi di diversa cultura, da un lato, i Greci abituati a
rendere in forme umane le proprie intuizioni religiose, dall’altro, gli
Iranici che insistevano sulla dicotomia tra bene e male, tra luce e
tenebra, opposizioni inevitabili fino a che dura il campo di battaglia che
è il mondo. Gli Iranici introducevano il mistero della luce come
identificazione di vita e coscienza, e ciò poteva innestarsi sul fotismo,
non estraneo alle antiche speculazioni indiane buddhiste, e suggeriva a
queste ultime simboli nuovi e più manifesti. I Kushana sanciscono, per
innata tolleranza e per paura di fronte alle irrequiete forze divine, la
maggior libertà di culto senza rinunciare all’esaltazione dei propri capi,
in un’implicita identificazione di questi con gli dei da cui si
consideravano protetti o discesi: la Luna, il Sole, Mitra, le divinità celesti.
Le loro interpretazioni sottili riscuotevano il favore crescente delle folle.
Gli strati più umili della popolazione pur accettando la nuova religione e
pur prestando ascolto alle parole dei suoi monaci, non potevano
dimenticare i culti antichi, retaggio di terrori, di stupori primordiali, di
culture in origine contrastanti e ora conviventi poiché erano cacciatori,
pastori, contadini. Avevano sempre vissuto intorno a loro: gli dei
potenti della montagna, le forze fecondanti convergenti verso Sciva e le
terribili dee volanti per l’aria, capaci di assumere forme animali e la
Grande Madre, che distribuisce con indifferente alternanza la vita e la
morte. Queste idee convivono, s’incontrano, si assorbono l’una nell’altra
e ne nasce un arricchimento di esperienze filosofiche e di pensiero
religioso, un rigoglio di riti e di miti che d’un tratto investe il Buddhismo
e lo costringe a reagire, non sempre opponendosi, ma più spesso
accettando e trasfigurando quel vastissimo mondo religioso. Per gli
stoici il logos era sostanza unica, supremo principio attivo regolatore
dell’Universo. Era identificato nell’elemento naturale del fuoco come
soffio igneo, anima di esseri e cose, collante e solvente dell’Universo.
Tale principio è riconducibile al sanscrito, rta, la verità, la preghiera, la
potenza cosmica, la luce ed equivale al termine iranico arta, da cui deriva
Asa, la divinità del fuoco della monetazione Kushana, connessa con la
potenza, la verità, la formula sacra. Attraverso una vasta speculazione
che collega Grecia, Iran, India l’equivalenza logos-anthropos si traduce nel

Letteratura e filosofia
45
GLI SPECCHI NON SONO GLI OCCHI DEGLI ALTRI
volto apollineo di Buddha che consente l’avvicinamento dell’immagine
umana al principio universale creatore–ordinatore nell’aspetto di verità.
Il fedele deve sapere identificare la mudra2, il sigillo che esprime in un
codice cinesico lo stato d’animo e la concentrazione meditativa
dell’immagine. Attraverso una particolare mudra Buddha valuta in quella
determinata concezione psichica la realtà apparente che lo circonda. Se
chi fruisce dell’immagine può riconoscere nella propria psiche la
categoria di stato del Buddha può rivivere in sé l’intero cammino verso
l’Illuminazione appoggiandosi su altre immagini che la descrivono.
Due colossali statue di Buddha, simboli del complesso e importanti
testimonianze del passato buddhista, datate rispettivamente al 507 e al
554 d.C, nel marzo 2001 sono state abbattute dai Talebani con gli
esplosivi perché considerati idoli preislamici. La tendenza al gigantismo
statuario ha una radice filosofica che rimanda ai racconti mitici della
richiesta della misurazione del Buddha che risulta immisurabile e alla
concezione cosmologica per cui Buddha è l’asse dell’Universo e
l’incommensurabile. Il Buddha di 53 m. Cosmocrator, signore del mondo
che tutto abbraccia, era contenuto in una grande nicchia con un soffitto
a volta decorato, sulle pareti laterali, con pitture rappresentanti molte
fasce di Buddha seduti (i 1000 Buddha di tutti i mondi e di tutti i tempi).
Al disopra sono ancora visibili divinità volanti che li cospargono di
fiori e di gioielli. Sulla volta si trovano numerosi Bodhisattva, (saggi
illuminati compassionevoli che rinunciano al loro livello per assistere gli
uomini e guidarli all’illuminazione), tra questi si trova una donna nuda

Quaderni della Ginestra
46
(per influenza indiana), forse una Shakti3. Secondo le fonti era difficile
ricostruire il mudra, l’atteggiamento di questo Buddha. Le immagini
sono supporti di meditazione e punti focali di potere soprannaturale.
L’iconogramma del Buddha è costruito da un’artista filosofo partecipe
della Grecia e dell’India. A Bamyan Buddha appare spesso nelle vesti del
filosofo docente assimilato al logos (altrove appare come Apollo o come
Eracle) e i testi buddistici considerano il Buddha consustanziale con il
Dharma, la legge ossia il logos. È interessante filosoficamente notare che
il simbolismo grecizzante, intellegibile ai greci-battriani, restituisce alla
figura umana un valore prossimo a quello espresso dai simboli. Buddha
ha spesso un valore apollineo di ordine e compostezza che riflette il
concetto astratto di armonia. I gesti della mano (mudra) esprimono, con
un linguaggio simbolico che ricorda la mimica dei danzatori, lo stato
psichico da cui il divino è pervaso. Il Buddha è rappresentato
soprattutto nelle vicende dell’ultima vita o nel suo apostolato dopo
l’Illuminazione, con compiaciuta fantasia per l’edificazione dei fedeli.
Sebbene il Buddhismo non sia mai stato appesantito dal dogma, anzi lasci
che ciascuno riviva nel proprio spirito, con piena libertà, le parole del
Maestro, la sua raffigurazione, una volta conformatasi, si tramanda
inalterabile nei secoli e nei luoghi. La dottrina diventa un dialogo tra la
predicazione remota e le nuove situazioni storiche e spirituali, si carica
di nuove esperienze, le parole assumono un altro significato o
contenuto, secondo la volubilità di tutto ciò che vive. La forma conclude
nella fissità di un simbolo immutabile la perduta immagine. Tuttavia,
intorno a quell’immagine immobile, si agitano secoli di vita: principi e
mercanti, signori ed ancelle che entrano nel racconto figurato. Ognuno
trasportandosi nel passato irripetibile s’immaginava spettatore partecipe
del miracolo antico e così il presente, per la spinta della devozione,
rifluiva verso il principio e conferiva all’arte valore terrestre ed umano, e
la leggenda si trasfigurava in un’autenticità d’esperienza. L’immagine del
Buddha e gli episodi del racconto pseudo storico-mitizzato stanno per
le immagini mentali suscitate dai testi. Il contemplante nel leggere
l’immagine, vede la distesa iconica del racconto. Il creatore di immagini
compie un atto di devozione perché vive il sacro e adora il sacro. Il
congiungimento ideale dell’antico e del presente nel fervore della
preghiera e della devozione, nella recitazione delle litanie, si esaltava in
un atemporale anelito di beatitudine. Come ricorda il pellegrino cinese
Xuan Tsang, che visitò il paese nel VII d.C., Bamyan, notevole centro di
traffici commerciali e di vita religiosa, fu importante centro di
penetrazione buddhista dal Gandhara pakistano.4 Rappresentò il punto
d’arresto della diffusione del Manicheismo e del Cristianesimo
Nestoriano provenienti dall’Iran. Infatti, la città afghana situata sulla via

Letteratura e filosofia
47
della Seta, a 200 Km da Kabul e molto a Nord Ovest, si trova
all’incrocio di due importanti vie di passaggio. La filosofia buddhista
prosperò grazie alle ricche donazioni di notabili locali che finanziarono
l’edificazione del grande complesso monumentale e convisse con la
fioritura in secondo piano della dottrina di Zarathustra. Nelle pareti di
roccia i soffitti a cupola dominati dal Buddha sono mandala dai colori
vivaci. È viva nelle raffigurazioni l’espressione della cultura mahayana5
per cui Buddha Cosmocrator è personificazione dell’Universo di cui tutti
gli innumerevoli Buddha di tutti i tempi sono manifestazione. Diverse
cappelle presentano il soffitto a lanterne, espressione materiale del
concetto filosofico della volta celeste: quadrati concentrici via via più
piccoli procedendo verso l’alto con gli angoli allineati con le diagonali,
sostituiscono la cupola. Lo schema architettonico riflette un simbolismo
cosmologico complicato: un’immagine dell’universo come i buddhisti la
concepivano, che era poi un’allusione al cammino dal molteplice all’Uno
che il fedele doveva compiere. Il sito fu abitato dal II al IX secolo d.C.
da monaci eremiti sotto le indicazioni dei quali il popolo Kushana
edificò le statue colossali. Le iconografie qui presenti
antropomorfizzano il concetto astratto del divino sotto l’influsso
filosofico greco e influiscono sulle produzioni cinesi di Yunkang (Vd.C)
e di Longmen (VII d.C). Numerose statue riproducenti i Buddha di
Bamyan hanno viaggiato come souvenir di pellegrini lungo le vie dell’Asia
orientale diffondendo la filosofia mahajana. Un Buddha di grandi
dimensioni, coricato, analogo a quello descritto nella cronaca, esiste in
Cina nel tempio di Bingling nella provincia del Gansu. Bamyan è la più
importante espressione monumentale del Buddhismo Occidentale,
centro di speculazione filosofica, meta di pellegrinaggio. É straordinario
pensare che la grande produzione d’immagini buddhiste con i caratteri
antropomorfi della regalità iranica, che influenzarono la prima pittura
tibetana, iniziò per diffondere un nuovo pensiero filosofico religioso in
una popolazione abituata ad antropomorfizzare la divinità. In un primo
tempo la rappresentazione antropomorfa di Buddha era stata
considerata inadeguata ad esprimere la realtà assoluta, ma ora a causa di
mutamenti nel pensiero religioso, quali l’introduzione della bhakti
(devozione) è elaborata un’iconografia che attraverso i segni alludeva
non solo al Buddha storico, ma ai valori assoluti legati alla predicazione
del dharma6 (dottrina spirituale). Il luogo fu da sempre culturalmente e
geograficamente aperto alle nuove idee penetranti nell’Asia centrale
dall’India, dalla Cina, dalla Parthia e da Roma. Non ci sono stati
tramandati i nomi dei filosofi, dei monaci che qui vissero. Sappiamo che
il pensiero fiorì per effetto dei Re e le popolazioni, abituate alle
coesistenze di diversi sistemi religiosi dettero il loro contributo. Dal

Quaderni della Ginestra
48
culto di Anahita7, di Mitra, dal pantheon zoroastrico e greco sono attinti
elementi per la creazione del pensiero buddhista occidentale, gli effetti
di quest’incontro sono ancora oggetto di discussione da parte degli
studiosi. Folle laiche aderirono alla dottrina del risveglio secondo una
vocazione all’inclusività che risponde al carattere universale del pensiero.
Il monaco mendicante (bhikshu) è chiamato a una scelta di vita radicale,
a una serie di rinunce riguardanti il sistema sociale. L’opportunità di
definire un sentiero laico, uno stile esistenziale a cui uniformarsi senza
dover necessariamente rinunciare alle necessità del contingente
incontrava il favore della classe di mercanti locali.
La presenza di corsi d’acqua, la bellezza paesaggistica del luogo, la
forza e l’armonia, sprigionante dalla visione delle montagne e delle
pianure verde smeraldo, sono stati elementi che hanno influito sulla
scelta del sito come centro filosofico che infonde pace e forza interiore
nella contemplazione. In una nicchia profonda nella Valle di Kakrak a 3
km. da Bamyan rimane ancora un Buddha stante di 7, 7 m che indicava
la via al pellegrino e rappresentava la parola vincente di Buddha che,
come il grido del leone, fa tacere le altre voci della foresta. Le
iconografie seguivano probabilmente dei modelli di riferimento che
traducevano sulla pietra concetti filosofici. È spesso raffigurato negli
affreschi Buddha in Nirvana circondato da personaggi esprimenti
dolore che, con braccia levate al cielo, si feriscono con i coltelli (atti di
autolesionismo per esprimere il dolore della perdita); tra questi
Mahamaya8 e Mahakasyapa9 mai raffigurati altrove nei rilievi gandharici. Il
Mahayana elegge quale parametro di santità il bodhisattva (eroe del
risveglio) che, motivato dall’ideale altruistico del bodhicitta (pensiero del
risveglio) continua a reincarnarsi finché tutti gli uomini non sono stati
salvati. Tutta questa folla di personaggi, vasta galleria di tipi etnici, è
stata inghiottita nel vuoto, la cremazione e la dispersione delle ceneri
hanno consacrato nel rito funebre la perdita irreparabile. Nella comunità
buddhista tutto si consuma nell’aria o sotto il sole: senza ombre o
penombre sotterranee. Buddha nell’interpretazione filosofica qui
diffusa è l’estinto, l’estinzione della vera legge che risorgerà nel Paradiso
dei Tusita10 dove Maytreia11, il soccorritore celeste, il Mitra zoroastriano,
aspetta che si esalti la vera legge nel futuro. Bodhisattva Maitreya, essere
vivente destinato alla bodhi, all’illuminazione, in genere è assiso ed è la
divinità principale tra i soggetti parietali. Maitreya ha un nome personale
Ajita, l’invitto, che rimanda a Sol Invictus e porta come attributo il piccolo
vaso kalasa amrta, che contiene l’elisir della vita ossia la non morte,
l’amrta, l’ambrosia, la bevanda dell’immortalità. L’arte non è solo
narrativa, ma metafisica, Maitreya sancisce la promessa di vittoria sulla
morte e, in un fondo di pensiero, accomuna l’invincibilità e la carità

Letteratura e filosofia
49
magica per tutti gli esseri viventi. Egli è circondato spesso da migliaia di
Buddha di dimensioni minori, seduti in dhyana mudra, in meditazione, o
stanti con aureola a più cerchi. La morte non è un muro che separa due
misteri; è un punto d’incontro di luce e di tenebra. Il Buddha è un
principio assoluto, si tende a rappresentare l’essenza della sua
Illuminazione, cioè la legge che condiziona il superamento del dolore,
della vecchiaia e della morte. Questa legge è la conoscenza, la gnosis, la
matrice del Buddha attraverso la quale è possibile pervenire a una realtà
diversa, assoluta, eterna, immutabile dalla quale non è possibile
decadere. I centri buddistici non sorsero sul vuoto, avevano occupato il
posto di più antichi insediamenti, i luoghi di cui una religione prende
possesso non sono quasi mai vergini; la sacralità si tramanda nei secoli
dai primordi.
Qui la roccia è stata scalpellata già in tempi remoti producendo
petroglifi, si tratta di un luogo sacro forse praticato per millenni di cui il
Buddhismo trionfante si è appropriato, magari scolpendo, al di sopra di
segni antichissimi, un Buddha meditante. Il Buddha perpetua l’istante
fugace in cui la bellezza dell’uomo ha qualcosa di divino, il dio dagli
occhi socchiusi abbassa le palpebre per celare il mistero e il miracolo, la
comunione con l’assoluto. Il suo corpo è il reliquiario della sua
intelligenza. Più lo contempliamo più sembra sfuggirci. Questa assenza
e questo svanire costituiscono il divino dell’Asia. Il Buddhismo ha
sempre lasciato intatti i segni di una sacralità più remota, consapevole
che nei luoghi dove genti per secoli hanno pregato, quella sacralità mai
scompare. L’importanza commerciale di Bamyan subì il declino quando
a metà del VI secolo d.C. le carovane iniziarono ad abbandonare il
percorso attraverso il Karakorum e l’Hindukush per l’altro più a ovest
verso il Tokharestan via Kapisi. La diffusione del pensiero filosofico
buddhista nell’area fu annientata definitivamente dalle incursioni
mongole del 1221 e così sulle vie verso l’India, dove il Buddhismo si
corruppe, degenerò, scomparve, il posto di un monastero o di uno
stupa (il monumento funerario che accoglie le reliquie dell’Illuminato
con valori cosmologici e cosmogonici) fu occupato dalle tombe di santi
musulmani. Era avvenuto un sincretismo nell’espressione artistica per
far accettare un nuovo concetto filosofico religioso, sulla pietra di
Bamyan sono ritratti fedeli orgogliosamente vicini al Buddha.
L’elaborazione è stata molto efficace e feconda, ma non ha resistito al
monoteismo islamico: le pietre scolpite sono diventate bunt (idoli) e il
pensiero buddhista ha lasciato per sempre quelle terre. L’espressione
simbolica del Buddha e della legge investe il Sacro nella sua espressione
più alta. Il che è molto lontano da una dialettica imperniata sul desiderio
e sulla rinuncia, sulla conquista di un’atarassia, di un’indifferenza assoluta

Quaderni della Ginestra
50
che auspica lo spegnersi dell’esistenza in qualcosa d’indefinito e
d’indecifrabile. In questo aspetto nihilista appare alle menti occidentali
il buddhismo di maniera frutto della ricerca nel pensiero europeo del
XVIII secolo. Se il pensiero nato dall’Illuminazione si fosse imperniato
su valori di questo tipo, non ci sarebbe stata alcuna possibilità di
un’evoluzione religiosa di vasto respiro. Il Buddha ha dimostrato
l’esistenza di un piano superiore e diverso, estraneo alle contingenze
della vita e dell’esistenza fenomenica, da raggiungersi tramite un
comportamento che annulli gli effetti della legge delle ricompense e
delle pene, ridimensionando, in senso negativo, i valori che dominano
questa esistenza. Naturalmente essendo il piano nirvanico
assolutamente ineffabile, il Buddha non lo descrive e non lo definisce.
Sarà la speculazione più tarda a immaginare, sulla falsariga
dell’escatologia iranica, una sopravvivenza individuale in un mondo
diverso, luminoso, invariabile, proiettato al di là della volta celeste. Ed è
per questo che il pavimento delle Terre Pure è immaginato in
lapislazzuli, vale a dire una pietra dura che, per il colore e per le
pagliuzze d’oro che la punteggiano, ricorda il cielo stellato. La
speculazione sul Buddha lo mostrerà sia come sovrano dell’Universo (e
proprio perciò la sua immagine risentirà della regalità terrena, sentita
come il più esplicito termine di paragone), sia come asse dell’Universo.
Gli artisti hanno così condensato in un’immagine antropomorfa una
complicatissima serie di valori religiosi con aderenza stretta ai testi per
sbalordire il fedele persuadendolo della sovraumanità del Maestro.
ELISA ZIMARRI
1 M.Guerini(2006) “Afghanistan. Profilo storico di una cultura” Jouvence, Roma. 2 Nel codice gestuale buddhista posizioni delle mani che esprimono lo stato d’animo dell’immagine. L’uso delle mudra è derivato dai gesti della danza. 3 Dea personificante la trasformazione perenne dell’energia cosmica. 4 D.Sechel (1963) “Il Buddhismo”, Milano, Il Saggiatore. 5 Grande veicolo, forma di Buddhismo caratterizzata dall’importanza attribuita al ruolo dei Buddha e dei Bodhisattva. 6 La legge buddhista che regola l’ordine cosmico e i doveri individuali. 7 In persiano antico “la pura” dea protettrice delle acque. 8 La madre di Buddha. 9 Uno dei dieci discepoli principali di Buddha. 10 Paradiso nel regno del desiderio, i suoi abitanti sono i raffinati e calmi Bodhisattva in attesa di rinascita. 11“Bontà amorevole” è simbolo del primato dell’illuminazione sul mondo delle apparenze.

Letteratura e filosofia
51
Ein Bau hat schon sein Recht verwirkt
Will er hinauf bis zu den Sternen.
Ogni impresa che mira a scalare il cielo
È opera destinata a perire.
H. Ibsen, Brand
el primo scorcio del Novecento, a Bellevue, che ben presto
divenne uno dei principali sanatori d’Europa, Ludwig
Binswanger riuscì a fondare un vero e proprio centro di scambio di idee.
Husserl, Scheler, Heidegger, Buber, Freud, Jaspers, Nijinskij,
Grundgens, Warburg e molti altri ancora furono solo alcuni dei suoi più
importanti interlocutori.
In particolare, irresistibile fu il fascino che la fenomenologia esercitò
sullo psichiatra, tanto da indurlo a definire il suo metodo di ricerca
Daseinsanalyse. Una denominazione che mostra in maniera inequivocabile
l’influenza che l’analitica esistenziale heideggeriana ebbe sul suo
pensiero. La fenomenologia, da parte sua, coinvolse uno dei maggiori
fautori delle scienze dell’uomo, dimostrando di meritare, in senso più lato, il
sostantivo di “galassia” attribuitole più recentemente da Vincenzo
Costa, Elio Franzini, Paolo Spinicci1. La straordinaria contaminazione
di saperi a cui si assistette al suo interno fu testimoniata dalla figura del
medico-filosofo, testimoniata non solo da Ludwig Binswanger, ma
anche da Victor-Emil von Gebsattel, Eugéne Minkowski, Erwin Straus.
Un universo in espansione, dunque, che vide al proprio centro
innanzitutto l’interrogativo sul come, sul metodo più opportuno con il
quale approcciare la conoscenza in senso gnoseologico e, con la
psichiatria fenomenologica2, la crisi di senso.
L’attenzione fenomenologica per i rapporti di fondazione tra le parti
e l’intero, per ciò che fa dell’uomo un essere unitario, non ridotto al suo
mero corpo né alla pura idealità, avvinse la sensibilità dello psichiatra,
insoddisfatto delle rigide opposizioni tra mente e corpo presenti ancora
nella psicoanalisi freudiana. Folgorato dalla lettura di Sein und Zeit,
Binswanger si convinse della proficuità della concezione esistenzialistica
dell’uomo per la psichiatria. Le esperienze psicotiche dei suoi pazienti
non potevano essere semplicemente liquidate come buone o cattive,
sensate o insensate, normali o patologiche, ma dovevano essere
considerate modi di esistenza dotati di una coerenza interna.
Al momento dell’epoché, ovvero della messa in sospensione di
N
CRISI E DIREZIONI DI SENSO NELL’ESISTENZA. L’ANTROPOANALISI DI UN DRAMMA

Quaderni della Ginestra
52
qualsivoglia giudizio su fenomeni spesso confinati3 nella sfera della
forsennatezza, seguì e si fece sempre più urgente la ricerca di un metodo
consono a tali modi di “stare-al-mondo”. Binswanger rilesse
criticamente l’opera di Heidegger, focalizzandosi, allora, sul carattere
antropologico più che ontologico del suo capolavoro, per elaborare, in
una della sue opere filosofiche più ambiziose (Grundformen und Erkenntnis
menschlichen Daseins, 1942), una fenomenologia delle forme interpersonali
d’esistenza. Lo scopo che perseguì fu, in altri termini, quello di
comprendere antropologicamente le strutture della psicosi, cogliendone la
generale significatività.
Ma, al di là del più noto riferimento ai temi dell’esistenzialismo e
della fenomenologia tedeschi, imprescindibile fu, in questa fase, anche il
suo rapporto con il mondo dell’arte. In Henrik Ibsen und das Problem der
Selbstrealisation in der Kunst4 (1949) vediamo infatti delineati, in maniera
chiara e originale, alcuni degli assi portanti della sua Daseinsanalyse.
Al principio del suo scritto su Ibsen, l’autore rileva che
«Le opere teatrali di Ibsen, i suoi drammi, sono di fatto solo configurazioni e riproduzioni artistiche del dramma della vita umana in
generale»5,
quasi a voler motivare la scelta monografica.
Lo psichiatra vede mostrarsi, sia nei momenti salienti della vita del
drammaturgo norvegese che nella struttura delle sue tragedie6, l’essenza
tragica dell’esistenza, il suo muoversi sul filo tensivo di molteplici direzioni
possibili e spesso opposte. In effetti, fu per avvicinarsi alla sua
realizzazione, per restituirsi a sé, che Ibsen decise di allontanarsi dalla
famiglia, dalla società, dalla patria originari. La situazione domestica e
quella politica erano così anguste per il tragediografo che spesso egli
stesso dichiarò esplicitamente ai suoi amici di non poter persistere
ancora “«nello stato di una mezza comprensione»” 7. Mezze comprensioni
furono, precisamente, ciò che egli ottenne dal mondo in cui era nato. Un
mondo che riuscì a comprendere pienamente solo nella misura in cui si
diede, distaccandosene, la possibilità di comprendere anche se stesso. In
una lettera a Georg Brandes scrisse: “«Non ho mai osservato la mia
patria e la vita vivente della patria in modo così forte, chiaro, e così da
vicino come proprio dalla lontananza e nell’assenza»”8.
La messa tra parentesi di un mondo, o meglio, di ciò che di esso si
conosce o anche di chi si è in rapporto a esso, appartiene non solo a
Ibsen, ma sembra essere, agli occhi di Binswanger, una necessità
antropologica. “Via-dagli-altri e dalla propria «disposizione»”9 scrive infatti
quest’ultimo, quasi a rimarcare il senso di una epoché psicologica resa nota
dall’artista stesso nella sue lettere giovanili.

Letteratura e filosofia
53
D’altra parte, la sospensione di sé-in-rapporto-a-quel mondo, a un
certo modo di stare-al-mondo, non segna sempre l’inizio della ricerca di un
senso?
Per Binswanger non ci sono dubbi: il conflitto esistenziale che Ibsen
visse con il suo passato fu “potenza anticipatrice” della via che
intraprese, quella della realizzazione di sé nell’arte. La direzione che egli
seguì fu, precisamente, quella dell’altezza poetico-drammatica. Una
direzione, quella dell’altezza, che nella lettura antropoanalitica dei
drammi privati e artistici ibseniani riveste un ruolo chiave.
È proprio l’andare avanti, il salir su, che permette all’Esserci di
rendersi accessibile l’ente, di farlo uscire dal velo oscuro della mezza
comprensibilità.
L’altezza è dunque, per entrambi, per il medico-filosofo e per il
tragediografo, la sola direzione antropologica che possa portare a piena
visione l’essenza vera della vita. Non a caso, Sulle alture (1860) è il titolo
di un poema drammatico, in cui Ibsen dichiara necessaria la sua “ascesa”
artistica, usando queste parole:
“«[…] solo qui il mio spirito si è rafforzato,
sulle alture soltanto cresce la mia natura.
Ho gettato al vento l’ultima mia gioia per una superiore vista sulle cose.
Ora di tutta la mia serietà mi beffo, è tempo di vagare sulle alture.
Abdicato ha il mio piede al tran tran del bassopiano […]»10.
Oltre a ciò, la salita sulle alture del poeta non avrà il proprio scopo
nella pura contemplazione della verità conquistata-lontano-dagli uomini,
ma piuttosto nella: “«restituzione simbolica della vita»”11 al pubblico, agli
altri. Per Ibsen, infatti:
“«Nessun poeta vive qualcosa isolatamente. Ciò ch’egli vive, lo
vivono insieme a lui […] i suoi contemporanei. Se per lui così non fosse, chi mai traccerebbe allora i ponti della comprensione tra colui che
produce e colui che riceve?»”12
Diventa ora indispensabile chiarire il significato del salire sulla cima
della montagna, dell’elevarsi al di sopra del mondo, della vita stessa, per
restituirne simbolicamente, agli uomini dei “bassopiani”, l’essenza.
Di certo sono racchiusi nella salita almeno due sensi: quello del
faticoso distacco dalla terra e quello dell’essere-tesi verso l’alto per
vedere le cose stesse13. Ibsen è mosso dalla volontà di comprendere
pienamente sé in relazione alla sua patria, alla sua famiglia, alla società
del suo tempo e trova nell’arte drammatica il modo di mostrare
l’essenza di tali legami tipicamente umani. La simbolica restituzione ci fa
capire però qualcosa di fondamentale sulla cifra della consegna poetica

Quaderni della Ginestra
54
al mondo “sottostante”. Come ben avverte Ludwig Binswanger:
«Poiché questo vedere, mostrare e domandare riguarda un ente già in
sé e per sé drammatico, nella forma drammatica dev’essere insita […] la
più alta tensione che possiamo pretendere dall’opera d’arte, quella – cioè – che abbraccia l’intero dramma della vita umana, e lo abbraccia in modo
tale, vale a dire in una così “forte e vigorosa forma”, che esso se ne sta lì non più come “vita”, bensì come “restituzione simbolica della vita”, e
come tale si comunica a colui che lo coglie»14.
Perché il dramma comunichi il senso tragico, tensivo, della vita, è neces-
sario plasmare i vissuti “privati” nella forma artistica, ovvero mediare la
durezza del passato, le mezze comprensioni, con una superiore visione delle
cose. Solo così, mantenendo la tensione tra il passato e il futuro, si potrà
renderne visibile l’eterna tragica lotta.
È proprio nell’opera Il costruttore Solness (1892) che vediamo in modo
chiaro, per Binswanger, come le forme umane, universali, dell’estensione
e del movimento si sviluppino pienamente nella direzione della verticali-
tà, la cui importanza è già emersa nel poema Sulle alture. La scalata ri-
chiede il coinvolgimento di più sensi: il tastare delle mani, la coordina-
zione di piedi e braccia, in altri termini, il saper mantenere l’equilibrio, la
proporzione, tra altezza e base. Il protagonista del dramma ibseniano
mostra, invece, propriamente il turbamento della «proporzione antropologi-
ca»15 binswangeriana, esprimendo la tragica possibilità della caduta, del
crollo che minaccia chi tenti di raggiungere senza avvedutezza vette ver-
tiginose.
Il senso dell’innalzarsi inautentico che è caratteristico del protagonista,
non a caso un “costruttore”, è sottolineato da subito, nel primo atto
dell’opera, da Knut Brovik16che gli dice: «Neanche lei aveva imparato un
gran che del mestiere quando lavorava alle mie dipendenze. Ma è riusci-
to lo stesso a cominciare. E ad affermarsi. Togliendo il lavoro a me e a
molti altri …»17. Binswanger ci avvisa che l’uso dei due verbi: “comin-
ciare” e “togliere agli altri” è fondamentale per cogliere la natura del
“successo” di Solness come costruttore, una fortuna raggiunta “«sca-
vando letteralmente - la terra sotto i piedi»”18 di Knut Brovik. D’altra
parte, il protagonista, ormai vecchio, si sente minacciato dal giovane fi-
glio di Brovik a cui nega la nuova commissione, con la motivazione di
volere costruire solo qualcosa di solido e duraturo. C’è, in altri termini,
un evidente contrasto tra la sua astuta ascesa passata e la volontà di edi-
ficare salde sovrastrutture. Si annuncia così lo stato dubbioso che lo af-
fligge e che lo accompagnerà per tutto il dramma, in un sentimento co-
stante di minaccia rispetto all’avvenire (gioventù di Ragnar), alla colpa
passata (la rapida e astuta ascesa) e all’autoesautorazione presente19.
L’aria di pericolo e minaccia che si respira nell’opera culminerà con il
crollo definitivo del protagonista. Uno smarrimento ineluttabile, restitui-

Letteratura e filosofia
55
to simbolicamente a noi da Ibsen con la caduta fisica del costruttore da
un edificio vertiginosamente alto, su cui Solness cercherà di arrampicarsi
spinto dalla fragile passione per la giovane Hilde.
Ancora più complessa e fitta è la trama del dramma ibseniano, ma
basterà qui ravvisare la fecondità antropologica dell’interesse di
Binswanger per l’arte di Ibsen. Attraverso l’incontro tra il mondo
“psichiatrico” e quello “drammaturgico” è possibile infatti cogliere
l’essenza dello smarrimento che può affliggere l’essere umano, qualora
questo si spinga troppo oltre i suoi limiti. Entrambi illuminano così, in
maniera filosoficamente inedita, il senso antropologico-esistenziale
dell’essere trascendente, cercando di mostrarne l’essenziale tragicità, tesa
tra le stelle e l’abisso.
GIUSEPPINA MAZZEI
1Cfr. Costa, Vincenzo, Franzini, Elio, Spinicci Paolo, La fenomenologia, Torino, Piccola
Biblioteca Einaudi, 2002. 2La cosiddetta Wengener Kreis, scuola fenomenologico-psichiatrica di cui Straus, Binswanger, von Gebsattel, Minkowski erano considerati esponenti di spicco. 3«Esiste, nella nostra società, un altro principio di esclusione: non più un interdetto, ma una partizione (partage) e un rigetto. Penso all’opposizione tra ragione e follia. Dal profondo del Medioevo il folle è colui il cui discorso non può circolare come quello degli altri», disse Michel Foucault, uno dei maggiori storici della follia, in una lezione inaugurale al Collège de France (L’ordre du discours, Éditions Gallimard, Paris, 1971; trad. it. di Fontana, Betani, Zini, L’ordine del discorso, 2004, Einaudi, Torino, p. 5).
4Henrik Ibsen, La realizzazione di sé nell’arte, trad. it. a cura di Michele Gardini, Quodlibet, Macerata, 2008. 5Binswanger, Ludwig, Henrik Ibsen. La realizzazione di sé nell’arte, trad. it., p. 4. 6Binwanger dedica un intero capitolo a Il costruttore Solness, (infra). 7Binswanger, Ludwig, Henrik Ibsen. La realizzazione di sé nell’arte, trad. it., p. 5 8Ivi, p. 9. 9Ivi, p. 11. 10Ivi, pp. 22-23. 11Ivi, p. 32. 12Ivi, p. 33. 13«Altitudo è sempre insieme altezza, poter essere scalato, e profondità, abissalità», ivi, p. 50. 14Ivi, p. 32. 15Ivi, p. 60. 16
Il vecchio Brovik, una volta suo principale, ora suo dipendente, vuole che Solness
assegni una commissione a suo figlio, il giovane Ragnar Brovik, disegnatore di talento, ma il costruttore non vuole “cedergli il passo”, rimbrottandogli di essere poco esperto. 17Ibsen, Henrik, Bygmester Solness (1892); trad. it. di Coletti Grunbaum e Castagnoli Manghi, Il costruttore Solness, Unione tipografica, Torino, 1982, p. 319. 18Binswanger, Henrik Ibsen. La realizzazione di sé nell’arte, p. 63.
19Solness fingerà di amare la promessa sposa di Ragnar, sua segretaria, solo per trattenere il giovane disegnatore ancora nel suo studio, per sfruttare a suo favore il lavoro del giovane.


Libri in discussione
57
orrado Ocone propone un percorso inconsueto nella storia del
pensiero liberale, dove alcuni autori considerati spesso fondamen-
tali (ad esempio Locke o Rawls) non compaiono, mentre altri, spesso
esclusi (come Humboldt, o gli italiani Einaudi, Croce e Gobetti), assu-
mono una posizione centrale. Questa scelta offre una prospettiva volta a
privilegiare lo spirito liberale, piuttosto che la teoria. Quest’ultima, anzi, se
intesa come sinonimo di aspirazione ad una formulazione di verità uni-
versali, è rifiutata in quanto sopprimente quello spirito autenticamente
liberale che Ocone definisce «critico, anticonformistico, antidogmatico».
Il liberalismo «non è, ma si fa: è metodo e non sistema», perciò a suo
fondamento non potranno che essere lo storicismo e il pluralismo, in
quanto il suo farsi si dà solo sul campo della realtà storica cangiante e
mediante il conflitto tra le opinioni e gli interessi. Ogni tentativo di fis-
sare in una statica teoria gli elementi della politica, che può essere sol-
tanto prassi, non può avere altro risultato che l’ideologia, la quale è
sempre dogmatica e chiusa alla dialettica delle opinioni.
Il primo autore ad aver fornito alla riflessione politica queste basi è
stato Montesquieu, il quale ha mostrato come un governo non sia libe-
rale quando assume una specifica forma, descrivibile dettagliatamente
dal teorico, ma quando lascia spazio alla libertà ed è quindi «moderato».
Egli infatti non ha disegnato una dottrina definita, ma ha piuttosto insi-
stito sulla distinzione qualitativa delle forme di potere, secondo la quale
il «come» è più importante del «chi» lo esercita.
Ocone propone poi una lettura di Kant – suggerita da Carlo Antoni
– secondo la quale l’autentico spirito liberale del filosofo di Königsberg
andrebbe rintracciato non tanto nelle opere di teoria politica, quanto
nella Critica del giudizio, dove è presente la chiave per «superare, in senso
liberale e compiutamente umano, la deleteria antitesi di universalità e
particolarità», cioè, politicamente, andare oltre la dicotomia «di universa-
lismo e particolarismo culturale, di occidentalismo e multiculturalismo».
In quest’ottica, il rifiuto sia dell’universalità astratta che del sentimento
particolare diventa un invito, anzi un compito, a «ricercare, insieme e at-
traverso il dialogo, l’unica e storica (cioè discutibile e reversibile) razio-
nalità e universalità che ci è concessa: quella che parte dal particolare e
impone a esso una regola».
Se questa interpretazione del pensiero kantiano, pur svincolandosi
dal dovuto confronto con opere come la Metafisica dei costumi, non dà
pienamente ragione del fatto di trovare Kant fra gli autori «senza teoria»,
ancora più ingiustificata appare la presenza, fra questi, di Humboldt, cui
Ocone dedica un intero capitolo. L’autore si trova costretto
C
IL LIBERALISMO ALLA RESA DEI CONTI

Quaderni della Ginestra
58
all’«ossimoro» fra «elemento teorico» e «liberalismo senza teoria», il qua-
le però appare al lettore più come flagrante contraddizione argomentati-
va che come figura retorica. L’idea di individuo proposta da Humboldt
è infatti tutt’altro che scevra di elementi filosofici ‘forti’. Innanzitutto
presuppone una concezione dello Stato minimo, la quale, pur essendo
espressa in termini prevalentemente negativi (a partire, cioè, dal punto
di vista dell’individualità che non deve essere ostacolata), è pur sempre
una «teoria», nel senso che Ocone stesso dà a questo termine.
Inoltre il filosofo tedesco è autore di una dottrina positiva
dell’individuo, secondo la quale la persona si realizza pienamente soltan-
to quando «le sue forze intellettuali e morali hanno raggiunto una forma
armonica ed equilibrata», mediante l’interazione fra l’individuo e
l’ambiente sociale e culturale che lo circonda. Humboldt si oppone per-
ciò all’individualismo atomista, ma non è chiaro perché quest’ultimo
dovrebbe essere «teoria» più di quanto non lo sia l’«individualismo oli-
stico» (l’espressione è di Charles Taylor). Forse Ocone intende dire che
quest’ultimo si oppone alle teorie forti del «soggetto-sostanza» e del
«concetto classico e moderno dell’individuo»; esso sarebbe perciò ade-
guato alla nostra epoca «postmoderna», in cui una concezione forte del
soggetto non è più adeguata. Ma la teoria atomistica non è che una delle
teorie della soggettività emerse nella modernità, e l’olismo humboldtia-
no – che è di derivazione herderiana – non ha alcuna caratteristica po-
stmoderna.
La contraddizione in cui incorre Ocone mostra come il liberalismo
non possa, in realtà, fare a meno di una teoria. Dobbiamo perciò do-
mandarci: perché dovrebbe farne a meno? Perché la storia del pensiero libe-
rale ha visto fiorire un gran numero di teorie tra loro incompatibili, sen-
za che fosse possibile stabilire, in base ad un criterio superiore, quale
fosse più adeguata a indicare che cosa è bene per la società nel suo
complesso e per gli individui che la abitano. Ocone vede perciò con
correttezza il fallimento di ogni teoria liberale, ma senza valutare che ciò
ha per conseguenza il fatto che i pensatori che ancora si richiamano al
liberalismo (in una delle sue molteplici forme) non hanno alcuno stru-
mento filosofico per opporsi a quella deriva che è il neoliberalismo o
«l’ideologia liberista». Ocone, quindi, gioca d’astuzia: per evitare il pro-
blema, propone di prescindere da qualsiasi teoria e così nega lo statuto
di «liberali» ai «neoliberali», proprio perché questi ultimi sono fautori di
una precisa teoria, basata su «false certezze». Ma i capitoli successivi a
quello dedicato a Humboldt mostrano che cosa resti, in questa prospet-
tiva, del liberalismo: una serie di autentiche banalità – per riconoscere le
quali non è certo necessario essere liberali – sul valore del dissenso («è
doloroso costringere un’opinione al silenzio, perché questa opinione po-

Libri in discussione
59
trebbe essere vera» [Einaudi]), del confronto con l’opinione avversa («il
liberale non può dialogare solo con i suoi simili, con coloro che lo con-
fermano nelle sue tesi») e del conflitto («lo Stato non deve cercare
un’armonia più o meno imposta perché sono la difformità, la disarmo-
nia, l’imperfezione il milieu più proprio della politica liberale»).
Non resta altro che «un’esigenza morale», che impone «spirito criti-
co» e «dubbio metodico». Abbiamo perciò, da una parte, una riduzione
del liberalismo ad etica negativa e, dall’altra, un’identificazione di questo
misero residuo con la filosofia. Perché per Ocone il liberalismo «è […]
propriamente la filosofia». Adeguarsi alle esigenze della contemporanei-
tà, come chiede di fare il nostro autore, significa davvero rinunciare a
tutto e ridurre la filosofia a così ben poca cosa?
GIANLUCA CAVALLO
Corrado Ocone, Liberalismo senza teoria, Rubbettino, Soveria Mannelli 2013, pp. 122, € 10
E NULLA SARÀ TUO TRANNE UN ANDARE VERSO DOVE NON C’È DOVE

Quaderni della Ginestra
60
rom the outset, Guido Seddone’s new book, Collective Intentionality,
Norms and Institutions, aims to understand human cooperation.
This is no easy task and the theme has been at the forefront of social
ontological discussion. Though Seddone draws material from the
classics of the field, he aims to present a novel theory of the
foundational meaning of cooperation for the human life-form and how
that enables us to understand and evaluate better the institutional world.
The accounts of cooperation that are based only on we-
intentionality (Tuomela, Searle) are rejected as groups amount to more
than the intentions of individuals’. Similarly, Seddone also rejects
Gilbert’s idea of a plural subject as groups are better understood as
historical networks of individuals. His intention is «to describe social
practices and institutions neither as being entirely dependent on
individual commitments nor as being externally independent of the
members who hold deontic states». While the former accounts of ‘we’
are interested in explaining the accomplishment of shared goals,
Seddone’s analysis is aimed at understanding enduring groups and
institutions that are interested in the conservation of their identities and
practices.
In the first chapter, Seddone introduces the key concept of
belongingness. That is, human embeddedness in certain social practices,
linked with an understanding of social groups like «organisms with a
final structure of self-preservation». Belongingness is continuity
between group and persons in a manner where individuals are
integrated in a group and engaged in preserving the social collaborative
activities and the social organization of that group. Belonging to a
group also requires practical competences, many of which are learned in
early childhood.
With the concept of belongingness Seddone tries to avoid the
problems of mistrust that plague the contract-based theories of groups.
Belongingness is seen as something more basic than just a contract that
can be always broken. While the concept does highlight the
interdependence of individuals and group, it might also be that it tackles
a different problem than the contract-based theories. The danger in
here is that even if Seddone claims to provide a larger and more
contextual view, his theory might not able to elaborate the internal
motivations for setting up a particular corporation or purpose-group
and their internal reasoning. One may worry that belongingness is in
danger of becoming a claim of individuals’ social constitution and not a
claim about the nature of groups as such.
F
FROM COOPERATION TO LIBERAL
INSTITUTIONS

Libri in discussione
61
After explicating the interdependence of individuals and groups in
the first part of the book, Seddone turns to the analysis of norms and
institutions. One of the key claims is that being institutionalized is the
only way a group can be recognized. That is, to become «a social entity
whose social commitments, roles and behavior can be controlled and
possibly legally prosecuted». This claim seems to be too strong because,
as Tuomela has shown, institutions come in varied forms and the broad
norm-governed systems like language might not have the commitments,
roles and behavior in the sense that corporations with more rigid
systems of personal tasks and rights might have.
Seddone is, however, aware that it is not wise to map all kinds of
institutions under the same concept. His own central distinction is that
of between autonomous and internal institutions. Internal institutions
are set within a wider cooperative framework and the duties and
interaction within them are contract-centered. Autonomous institutions,
in turn, are characterized by self-determination and their members have
a deeper and more fundamental relationship between each other and
the group. The difference can be described as that of between
«citizenship as belongingness to a lineage-based-organization» and
«membership as belongingness to a contract and competencies-based-
group».
Nations and states are prime examples of autonomous institutions as
lineage, belongingness and preservation – the central ideas of the whole
book – are combined within them. Seddone makes an interesting claim
that without sovereignty nations only have their identity and the identity
is at a risk of disappearing due to lack of organization. Firstly, this
implies that a state is an organized form of a nation. This, perhaps
inadvertently, associates states with nation states, which is clearly
problematic in the era when real states are more and more multicultural
or multinational. We might also have various other – economy, personal
safety, etc. – interests to join a state than just the preservation of an
institution into which we have been born. Secondly, though some
institutional identities are surely dependent on the level of organization,
this might not be the case with broader and looser cultural or national
identities. Sovereignty on a region is a thing that was definitely not
needed for the preservation of nomadic tribal identities.
With the introduction of institutions and organizations, we run into
the problem of collective and individual responsibility and this is what
Seddone tackles in the next section of his book. He sees hierarchies as a
necessary part of institutions, resulting from «unequal repartition of
tasks». However, he is against rigid hierarchies and argues for openness
and «self-aware cooperative mode» of action where the cooperative

Quaderni della Ginestra
62
context is understood and evaluated. This in turn fosters self-
determination and moral responsibility within these institutions. Thus,
hierarchies and institutional power are necessary but they need not to be
coercive. Instead, in a free society they rely on reflective acceptance by
members.
Seddone finishes his book with an exploration of the idea of
intersubjective freedom – «the possibility of enjoying autonomy within
an institutionalized and cooperative enterprise». He agrees with the
Hobbes’s idea that individuals need to be shielded from arbitrary
coercion but at the same time he wants to combine this with the Hegel’s
insight that individuals need the intersubjective context to be free. Here
the reflective acceptance of law and lawfulness is the key. Law protects
us from coercion by others but at the same time it needs to be accepted
itself as there is potential for the institutions themselves to become
coercive. Ultimately, the ideals of social freedom ought to be embodied
by various institutions like the market economy or education. This leads
Seddone to argue for liberalism that is concerned with the individual
satisfaction of needs and in which solidarity is a social obligation
towards those who participate in the cooperative system.
Seddone’s book is difficult but rewarding. It is difficult in the sense
that the themes that are analyzed are complicated and there are places in
which the reader is left with a desire for more detailed explanations.
there are places where the book is repetitive and could have benefited
from more pedantic editing. For example, the page numbers for
references were occasionally marked as ‘??’. Despite this, the book was
also enlightening. It manages to combine the Hegelian tradition with the
analytical social ontology in an interesting fashion and presents a theory
that progresses from the analysis of social cooperation as human
condition into a defense of liberal theory. Even if I do not personally
endorse all the specific claims made in the book, I agree with the overall
approach of the research. Namely, the use of philosophical
anthropology – a line of research prevalent in the Hegelian tradition –
to back up the claims one makes about the institutional world. I can
warmly recommend Seddone’s book for all who are interested in the
social nature of human beings and the interplay of institutions and
individuals.
ONNI HIRVONEN
Guido Seddone, Collective Intentionality, Norms and Institutions. A Philosophical Investigation about Human Cooperation, Peter Lang, Frankfurt
2014, pp. 186

Libri in discussione
63
entornata realtà raccoglie dieci saggi che testimoniano la ricchezza
del dibattito interdisciplinare che negli ultimi due anni, soprattutto
in Italia, si è sviluppato attorno al tema del nuovo realismo,
mostrandone differenze terminologiche e contestuali.
Nell’introduzione Mario De Caro e Maurizio Ferraris individuano i
quattro tratti fondamentali del nuovo realismo, accomunati dal tentativo
di conservare le istanze emancipative dell’antirealismo «evitandone gli
effetti indesiderati – e in particolare la curva entropica che ha portato il
postmoderno a dire addio alla verità e a dichiarare guerra alla realtà
applicando in modo indiscriminato il principio secondo cui “non ci
sono fatti, solo interpretazioni”». Il primo tratto è il recupero di concetti
come verità e realtà, concetti centrali per un pensiero critico e
decostruttivo, rilanciato in questo nuovo contesto «sotto altre forme,
adatte al mutato momento storico e non ridotte a pura scolastica». Il
secondo è il sottolineare il forte legame tra interpretazione, verità e
realtà rifiutando «l’ossessione postmoderna secondo cui non c’è verità,
ma solo conflitto, interesse, prevalenza del più forte, e che
“interpretare” significhi essenzialmente scendere in guerra, o
quantomeno in campo». Il terzo è il riconoscimento di un nesso
costitutivo tra filosofia e scienza, e l’apertura della filosofia ai risultati
scientifici, pur mantenendo una propria autonomia metodologica. Il
quarto è il proporre una filosofia globalizzata in cui convergono
competenza scientifica, filologica e storica, e pertinenza pubblica: «fa
intrinsecamente, e non accidentalemente, parte della filosofia la capacità
di rivolgersi a uno spazio pubblico, consegnando a quello spazio risultati
elaborati tecnicamente, però in forma linguisticamente accessibile».
L’eterogeneità del nuovo realismo è ben rappresentata dai dieci saggi
che compongono questo libro, suddivisi in tre sezioni dedicate
rispettivamente ai fatti della scienza e ai valori dell’etica, ai limiti
dell’interpretazione e a un confronto sulla realtà psichica. Nella prima
sezione Hilary Putnam (Realismo e senso comune) sostiene un realismo del
senso comune secondo il quale possono esserci molte descrizioni
corrette della realtà e ciò che esiste è indipendente dalla sua
conoscibilità; Mario De Caro (La duplicità del realismo) discute realismo
del senso comune e realismo scientifico; Akeel Bilgrami (Pragmatismo e
realismo) difende un realismo che fa coinvergere l’idea kantiana
dell’idealismo trascendentale con un pragmatismo di derivazione
peirciana; Carol Rovane (La separazione del relativismo dall’antirealismo) si
sofferma, infine, su realismo e relativismo, definendole come due
dottrine non in contrasto e considerando le possibilità di un relativismo
B
DAL NUOVO REALISMO AL RITORNO ALLA REALTÀ

Quaderni della Ginestra
64
che non parta da premessa antirealiste. Nella seconda i saggi di
Umberto Eco (Di un realismo negativo), Diego Marconi (Realismo minimale)
e Maurizio Ferraris (Esistere e resistere) affrontano tre accezioni diverse di
realismo, rispettivamente negativo, minimale e dell’inemendabile,
anticipando il saggio di John Searle (Prospettive per un nuovo realismo)
difensore dell’idea che esista una realtà indipendente
dall’interpretazione, e contrapponendola a varie forme di idealismo.
Nella terza, infine, Massimo Recalcati (Il sonno della realtà e il trauma del
reale) e Michele Di Francesco (Realismo mentale, naturalismo e scienza
cognitiva) si confrontano sul tema della realtà della soggettività e della
sfera psichica, difendendo, il primo, una visione antirealistica di matrice
lacaniana e discutendo, il secondo, le prospettive del realismo mentale di
stampo cognitivista.
TIMOTHY TAMBASSI
Mario De Caro, Maurizio Ferraris, a cura di, Bentornata realtà. Il nuovo
realismo in discussione, Einaudi, Torino 2012, pp. 230
MA LA MIA NOTTE NESSUN SOLE LA UCCIDE