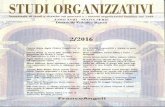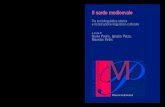Virdis Per Un'e(Ste)Tica Del Poetico Parte 1
-
Upload
brent-krocknam -
Category
Documents
-
view
4 -
download
1
description
Transcript of Virdis Per Un'e(Ste)Tica Del Poetico Parte 1
-
MAURIZIO VIRDIS
PERCEVAL:PER UN'E(STE)TICA DELPOETICOFra immaginario, strutturelinguistiche e azioni
S'ALVURE
Stampato sotto gli auspici della Regione Autonoma della Sardegna
Finito di stampare nel mese di Settembre 1988 presso la
Multi Color Offset Editrice S'Alvure S.n.c. - Vico Aquila, 3 Oristano
__________________________________________________________________
Copyright by: Editrice S'Alvure Oristano
-
Alla memoria del mio maestro Alberto Limentani
1) Tra madrelingua e lingua del padre.Ricerca del padre e ricerca della parola pu dirsi l'oggetto della qute di Perceval, come acquisizione di un luogodimensionato in un "giusto" rapporto con la realt: che significa eminentemente, pi che un pervenire ad una qualsiasioggettivit, immettersi nel gioco calibrato della domanda e della risposta con l'alterit. E la giusta distanziazione chel'eroe, per il tramite del simbolo, deve acquisire per la prima volta; e in questo percorso egli si pone, nella fictionnarrativa, come paradigma di ogni crescita umana, anche, se, come vedremo, attraversando un percorso straniato,alla ricerca di un "senso", che non proiettato su nessuna dimensione escatologica o mistica, ma, come osserva J.Frappier(l), un senso del tutto ovvio: quello verso cui tutti procedono nella parabola di una vita che sembra gipredeterminata dagli altri, dall'esterno, nel suo processo e nei suoi valori. Ed un percorso che trova come neces-sari punti di svolta il gesto e l'atto mancato, l'esperienza dello scacco e del nulla, nello specchio della castrazione edell'impotenza non riconosciuta: un nulla che sostanzialmente consiste nel non saperlo vedere, in una situazione incui il sapere e il linguaggio fino a quel punto acquisiti non servono e non giovano, fino a che esso non trascendala sua dimensione di codice, per arrivare a quella di tramite. Il peccato di Perceval infatti un peccato di silenzio,una domanda non posta; ma proprio nel vuoto della domanda, nel suo detto, che il dire acquista i suoi significati eassume il suo valore.
1) Cfr. J. Frappier, Chrtien de Troyes et le Mythe du Craal, Paris, S.E.D.E.S., 1972, p. 156: "11 n'y a rien de bien nouveau dan ces
[dell'Eremita] conseils: en dehors du respect d au prtre, l'eremite rpte ce qu'avaient dj dit la mre de Perceval et Gornemant de
Goort. C'est l'indice que Chrtien n'envisageait pas pour son hros une fin asctique et mystique: la rgle morale et religeuse qui est
recommande Perceval est simplement celle d'une chevalerie trs pieuse vivant dans le sicle".
2) Cfr. C. Levi-Strauss, Antropolgie structurale deux, Paris, Seuil, 1974.
3) Il trascendersi dei connotati di classe in una idealit la tesi di interpretazione proposta da E. Kohler, Ideal und Wirlichkeit in der hofischer
Epik, Tubimgen, Niemeyer, 1970.
In ogni caso, nella situazione e nella condizione particolare dell'esistenza di Perceval che il suo percorso va vistonella sua istanza significativa, nel ruolo sociale e morale che egli chiamato ad assumere. Anche se la figura del
-
nostro eroe , o pu essere considerata, paradigmatica, si tratta per, paradossalmente, di una paradigmaticit chepotremmo dire angolata; con C. Lvi-Strauss'2' potremmo definirlo infatti un Edipo a rovescio alla ricerca del padre,o della sua istanza, anzich alla ricerca della sua eliminazione. E ci in quanto a lui manca una sovrade-terminazioneche lo significhi, un codice che lo renda soggetto d'azione. Ma l'essere paradigmatico del protagonista viene adassumere tutto il suo significato, qualora si voglia vedere nella parabola narrativa di Perceval un intento propositivomediato dall'Autore attraverso la messa a fuoco (appunto angolata) di una parabola di vita e delle sue peculiaricondizioni di esistenza e di sviluppo. Il romanzo raffigura in un tempo che relativamente breve dal punto di vistareferenziale, ma che lungo dal punto di vista del discorso narrativo, le condizioni esemplari in cui possibile che sisviluppino al massimo grado le potenzialit, eticamente e socialmente positive di ogni essere che, sia pure in potenzae non ancora in atto, sia destinato, per indole propria e per l'eredit di un patrimonio morale e sociale di classe, adoccupare un ruolo di primo piano nel contesto socio-culturale che gli proprio, ma che per altro aspira a trascendere,ponendosi appunto proprio quale esempio ideale'3'.In ci Perceval si distingue dagli altri protagonisti chrestie-niani in quanto in lui descritta una intera parabola di vita,dalle scaturigini infantili alla conquista della maturit, attraverso le tappe necessarie e imprescindibili che lo portanoal punto d'arrivo (se mai ce ne sia uno in questo romanzo). Laddove i protagonisti degli altri romanzi assumono laloro dimensione esemplare in una aventure circoscritta nel tempo (la cui esemplarit pur tuttavia si proietta al di fuorie al di l del tempo), in Perceval invece Vaventure coincide con tutta la sua parabola vitale; e mentre ancora gli altriprotagonisti agiscono per un atto di volont imperscrutabile che li rende soggetti, ma di cui noi vediamo solo glieffetti, mentre ce ne sfugge la dinamica generatrice che dobbiamo ricostruire pi nella mente dell'Autore che nellaloro, in Perceval assistiamo invece proprio al generarsi progressivo di una volont, al precipitare di una serie di eventiin una soggettualit, attraverso tutte le sue tappe e le sue contraddizioni, attraverso percorsi che sono certamente nonlineari, ma anzi tortuosi.La paradigmaticit consiste insomma, come meglio si vedr fra breve, nella narrazione di una parabola le cuitappe sono obbligate e necessaristicamente collegate l'una all'altra, e nella proposizione di questa parabola (che danarrazione diventa storia) come esemplare; proposizione che si invera sia nel retorico contrapporsi di storie e diprotagonisti (Perceval e Gauvain) all'interno del testo, sia nel gioco dell'intestualit che il discorso narrativo instaura;paradigmaticit dunque nei due sensi che ogni dizionario attribuisce alla parola: quello grammaticale e quello, chepur da quest'ultimo deriva, etico-pragmatico.La necessariet e l'esemplarit risultano, come si diceva, angolate, fin dalle prime battute della nostra storia, anzi,si pu dire che proprio in queste consiste lo straniamento, l'angolazione, di racconto e di storia, su cui si imperniail discorso narrativo. La parabola di vita del nostro eroe comincia infatti alle soglie dell'et adulta dopo un'infanzia"innaturalmente'''' dilatata e prolungata nel tempo, vissuta sotto l'esclusivo segno del materno e nell'assenza delpadre; cosicch nel primo approccio con la cavalleria (nell'incontro con i cavalieri e nell'insegnamento di Gornemantde Goort) egli vede non il codice, n la legge del Super-io che lo determinerebbe nel luogo significante che eglidovrebbe assumere su di s occupandolo: egli vede soltanto un'immagine, riflesso-di-s, che lo cattura col poteredi fascinazione, specchio nel quale egli cerca di afferrarsi; come metaforicamente ma anche realisticamente espresso nell'episodio del bacio rubato alla Damigella della tenda e nell'episodio del Cavaliere Vermiglio: messa inpratica alla lettera dei consigli e degli insegnamenti ricevuti i quali agiscono
4) Ci riferiamo alla fase evolutiva del Soggetto descritta in S. Freud, Metapsicologia, Torino, Boringhieri, 1976,p. 47 e segg., fase in cui il Soggetto, nel passare dallo stadio dell'Io-realt a quello dell'Io-piacere, introiettal'oggetto esterno che gli si offre in quanto fonte di piacere; in questa fase, ancora narcisista, Freud ravvisaun "incorporare in s o divorare una specie di amore compatibile con l'abolizione dell'esistenza separatadell'oggetto, che pu essere designato come ambivalente" (p. 51)
-
su di lui nella dimensione immaginaria e non ancora in quella simbolica; egli scambia con la realt le immagini chelo riflettono, senza saper vedere lo schermo specchiante su di cui esse sono proiettate: Perceval fa ancora tutt'uno conl'oggetto della sua cattura; ma, cos come per il Guigemar di Marie de France, le armi scagliate in avanti contro lapreda si ritorcono contro di lui, rimbalzando sulla superficie dello specchio che scherma la realt. Gli insegnamentiche via via acquisisce, il sapere che via via assume su di s vengono recepiti non come codice e legge, ma nellapresunta trasparenza che immetterebbe direttamente nella realt, obliterando lo specchio. Egli vede se stesso neglioggetti che fungono da immagine di lui(4); e anche se le sue esperienze sono man mano sempre pi raffinate eimpegnative, esse vengono sostanzialmente vissute sempre nello stesso modo: il codice resta trasparente in quantomanca in lui la legge del Super-io, la legge paterna che legifera tramite il codice.Ma in questa deficienza risiede proprio tutta la virtualit che Perceval chiamato ad assumersi sulle spalle: egli chiamato infatti non solo ad assumere la legge del codice e il codice come legge, ma anche ad avere coscienza delfondarsi della legge sul codice che, pur nel nulla dell'arbitrariet su di cui esso si fonda, pur sempre necessario,qualora se ne assuma anche la coscienza dell'arbitrariet, a costituire il soggetto in quanto tale, che , a sua voltaelemento fondamentale della societ e del suo mantenimento.E affinch tale processo si compia, Perceval deve necessariamente passare attraverso l'esperienza della mancanza edello scacco, del mancato riconoscimento della mancanza: dell'impotenza. L'atteggiamento che egli tiene difronte alGraal il nodo di tutta l'esperienza esistenziale di Perceval e di tutte le sue contraddizioni, a met fra passato e futuro;l'oscillare tra il desiderio di porre la domanda e l'imperativo di tacere una via di mezzo fra un codice assunto manon interiorizzato (il codice impostogli da Gornemant de Goort che lo ha messo in guardia dal troppo parlare'5', chegli ha imposto in pratica di non credere di potersi affermare e oggettivare direttamente nel linguaggio) e l'impulsoad afferrare e a mordere la realt duplicato della madre cos come tutte le altre prede. La vittoria del codice suldesiderio segna lo scacco di quest'ultimo nello stesso momento in cui esso stato chiamato in causa e messo inmoto; ma lo scacco questa volta non significa obliterazione: perch lo stesso codice che lo ha messo in iscacco neperpetua l'esistenza, anzi ne la condizione. che il desiderio e il codice rimangono ancora due termini separati esenza mediazione, non trapassano l'uno nell'altro, anche se gi stanno in rapporto di presupposizione (il codice hareso desiderio un impulso aggressivo). Se dunque il co-
5) s Si vedano i versi 1648-1656:
Ne ne parlez trop volentiers: Nus ne ne puet estre trop parliers Qui sovent tei chose ne
die Qui torn li est affolie, Car li sages dit et retrait: 'Qui trop parole, il se mesfail'. Por
che, biax amis, vos chastoi De trop parler.
Queste parole suonano a Perceval non solo come imposizione generalizzata, ma scalzano in lui, come si sa e ancora si vedr, il codice
immaginario trasmessogli direttamente dalla madre, senza per altro riuscirvi. Quesinsostituzione espressa chiaramente dallo stesso
Gornemant, in forma di consiglio a Perceval:
"Or ne dites jamais, biax frere, fail li preudom, que vostre mere vos ait apris rien, se
je non.
(vv. 1675-1677)
perch altrimenti "a folie le tenroit l'eri". E l'operazione di sostituzione, che si attua in questo episodio, sottolineata dall'abbandono, da
parte di Perceval, degli abiti materni primitivi con i pi raffinati panni offertigli da Gornemant, operazione che non avviene, per Perceval,
a cuor leggero.
6) Cfr. J. Lacan, Ecrits, Paris, Seuil, 1966; tr. it. Scrtti, Torino, Einaudi, 1974.
-
7) Infatti nell'uomo "la riflessione nello specchio manifesta una possibilit noetriva originale e introduce un secondo narcisismo. Il suo
pattern fondamentale immediatamente la relazione con l'altro" il quale ha per l'uomo una funzione cattivante e anticipatrice, nella quale
questi compie "l'identificazione con l'altro, che, nel caso normale permette all'uomo di localizare con precisione il rapporto immaginario
e libidico col mondo in generale". Cfr. J. Lacan, Le seminaire de Jacque Lacan. Livre I. Les crits techniques de Freud (1953-1954), Paris,
Seuil, 1975; trad. it. Il seminario. Libro I . Gli Scritti tecnici di Freud (1953-1954), Torino, Einaudi, 1978 l primo corsivo nostro]
8) Ci riferiamo qui a quel materiale perinatale che la madre trasmette direttamente al figlio prima di ogni contatto col mondo oggettivo, nella
vita intrauterina e che costituisce una riserva di immagini che andranno a interferire successivamente con il linguaggio. Si veda in proposito
E. Facchinelli, Claustrofilia, Milano, Adelphi, 1983.
dice ha fondato il desiderio, esso non per ancora capace di esprimerlo, di dirlo; la mancata domanda unrespingere ci che non a tutto tondo, ancora un rifiutarsi difronte a ci che non sia reale e oggettivo; un negarsidifronte alla malattia e all'impotenza del Re Pescatore: Re malato nella sua virilit e nella sua regalit, ci che rendemalata e impotente anche la societ su cui egli regna, e che avrebbe bisogno di essere riconosciuto nella sua miseriada un altro soggetto non malato perch possa essere istituito come soggetto. Perceval insomma non riesce a vederela propria immagine riflessa in quella, misera e impotente, del Re Pescatore, in lui non riesce a vedere il proprioduplicato, l'altra faccia di s; la faccia dialetticamente negativa che darebbe senso positivo alla sua azione. Cifacendo egli renderebbe senso anche alla societ arturiana (qualora si voglia vedere nella gaste terre la facciadialetticamente e complementarmente negativa del mondo arturiano). questo mancato riconoscimento che gliimpedisce di porre la domanda sul Graal: egli da un lato abbagliato dall'aspetto esteriore di ci che gli sta di frontee continua a catturarlo e a stimolare in lui lo slancio di cattura appropriati-va, dall'altro vi il codice che il lui vissuto solo come tale e non ancora fortunatamente, si direbbe assurto a legge interiore, cosicch se ancheblocca l'istinto di "curiosit" accapar-ratrice, tuttavia non lo cancella, e se pone l'interdetto a un comportamentodeterminato dall'immaginario materno, non ne reprime la forza che lo porta alla coscienza. Come poc'anzi abbiamodetto, siamo qui in presenza della nascita del desiderio nell'eroe; ma ci che manca l'espressione di esso, il farsisoggetto attraverso il desiderio, se vero che "il desiderio dell'uomo trova il suo senso nel desiderio dell'altro, nontanto perch l'altro detenga le chiavi dell'oggetto desiderato, quanto perch il suo primo oggetto di esserericonosciuto dall'altro "(6); il mancato scambio dialogico sul Graal (1'"oggetto") con il Re Pescatore, ha significato ilmancato riconoscimento di quest'ultimo da parte di Perceval, il quale d'altra parte non ha compreso di essere statoriconosciuto dal suo altro : il codice non s' fatto linguaggio, scambio dialogico dell'oggetto simbolico, assunzionedel s positivo attraverso il s negativo, il soggetto rimane pertanto ipostatico(7).
Come sappiamo, Perceval ha taciuto in quanto porta la colpa di aver fatto morire la madre e per avere applicato ilcodice, paterno, di Gornemant de Goort; possiamo in ci leggere che Perceval si e precluso, con l'abbandono dellamadre, la via d'accesso al linguaggio di quei significati pre-logici e pre-linguistici che sono appannaggio del rapportomadre-figlio, che sono veicolati dalla madre al figlio per via diretta, senza la mediazione del codice'8'; ma il codice,proprio in quanto non interiorizzato come legge, proprio in quanto concepito nella sua applicazione letterale, seanche non sa, ovviamente, esprimere quei significati, non ha per altro la capacit di ricacciarli indietro nella co-scienza di Perceval: essi permangono con tutta la loro forza attiva a determinare l'azione futura. E c' se mai dachiedersi se il nostro protagonista avrebbe mai avuto accesso a questi significati in maniera attivamente significativasenza il distacco dalla madre. I suoi pre-sentimenti acquisteranno valore solo nel mondo che al di l del materno,
-
essi dovranno essere proiettati su di un mondo oggettivo logico e linguistico, quello dell'istanza paterna, affinchacquistino valore simbolico.Ma il simbolo dato solo nell'assenza: ecco perch la madre, in origine presente, "deve" essere costantemente rigettata
9) Intendiamo qui lacanianamente il Fallo come controparte, nell'immaginario, di ci che, nel simbolico, ilNome-del-Padre, l'Altro da cui dipende la condizione del Soggetto. Cfr. J. Lacan, Una questione preliminare adogni trattamento possibile della psicosi, in Scritti, cit. pp. 529-579.
nell'assenza, cos come il suo linguaggio a-linguistico, mentre il padre, originariamente assente, deve essereprefigurato nella presenza senza essere mai raggiunto, rappresentando questi l'istanza linguistica che permetterebbela proiezione, la via d'accesso al linguaggio ai significati pre-sentiti, di cui peraltro non determina mai il senso.Madre onnipresente ma da subito e costantemente rigettata e negata, padre sempre assente, ma continuamente cercato:ecco la dialettica, il pendolo che costituisce l'aventure di Perceval, il pendolo dell'assenza-presenza (il suo fort-da);si tratta ora per lui di imparare a padroneggiare questo pendolo, di saper vedere la presenza nell'assenza, di saperpresentificare l'assente attraverso il linguaggio e solo attraverso esso. Ed in ci che, almeno primariamente, il nostroeroe fallisce, mentre il riuscirvi costituisce l'oggetto della sua qute-aventure.La madre respinta dal codice linguistico, ritorna a-linguisticamente, il padre assente come codice-legge e si pre-sentifica soltanto come codice-lettera al di qua del simbolico.Il Castello del Graal il luogo (forse il non-luogo) dove si scontrano queste istanze e modalit contradditorie, il luogodove l'eroe potrebbe giungere (senza che per altro vi riesca) a dar la parola al pre-sentire materno e a rendere presenteil padre; tutto ci attraverso la domanda che il pre-sentire gli porge; con essa egli risanerebbe il Re Pescatore, suodoppio negativo, ma anche immagine ipostatica del padre mancante (mancante sia in quanto assente, sia in quantomanca di qualcosa: della sua virilit, del Fallo'9')- Nel riconoscimento della sua assenza egli verrebbe chiamato adessere, verrebbe cio finalmente postulato nella sua essenza simbolica e vera: e nella co-incidenza con il Re Pescatoreche suo cugino-fratello (sia referenzialmente sia in quanto suo doppio negativo) ma che anche suo padre, in quantoistanza ipostatica del Fallo, Perceval si istituirebbe come soggetto.Il passaggio del pre-sentito, del pre-linguistico nel linguaggio, o, ci che lo stesso, la presentificazione dell'assentecostituisce, come si diceva, l'oggetto della qute di Perceval. Ci avviene, cos ce lo presenta la narrazione, per tappe:attraverso la cognizione della colpa (e la congiunzione delle due colpe: uccisione della madre che causa del nonporre la domanda sul Graal), attraverso l'imputazione, e attraverso la confessione e il conseguente perdono. Nei treepisodi dell'incontro con la cugina, della dama orrenda e dell'eremita, che corrispondono alle tre tappe suddette,sembrerebbe che Chrtien moduli sempre uno stesso tema, ma in questa modulazione si cela uno svolgimento, si hauna progressione che si manifesta attraverso una ripetizione sfasata. che l'atteggiamento delle parti in causa , divolta in volta, diverso: nel primo dei tre episodi Perceval apprende della morte della madre, che stata da lui causata,apprende che la mancata domanda sul Graal una colpa che ha delle conseguenze gravissime e apprende infine chele due colpe sono connesse, in rapporto di causa-effetto, l'una con l'altra, ma Perceval, pur prendendo coscienza,tende a rimuovere il peso dell'accusa; nel secondo episodio, Perceval pubblicamente accusato delle conseguenzeche la mancata domanda ha provocato, ma non data nessuna connessione fra questa colpa e la provocata morte dellamadre; questa volta Perceval non potr pi rimuovere l'accusa in quanto l'imputazione, a causa della pubblicit incui fatta, ferisce il suo narcisismo proprio nel momento in cui egli si pienamente integrato nella societ arturiana;nel terzo episodio nuovamente messa in correlazione la causa della morte della madre con quella della mancatadomanda, ma gli effetti di questa doppia colpa si riflettono, secondo l'eremita, non sul Re Pescatore e sul suo regno,come gi avevano detto la cugina di Perceval e la Dama Orrenda, ma su Perceval stesso:
Por le pechi que tu en as T'avient que rien n'en demandas De lance ne del graal, Si t'ensont avenu maint mal
-
(vv. 6399 - 6402)Perceval conosce finalmente la risposta alle mancate domande, e, in seguito alla confessione della colpa umilmentericonosciuta, ottiene il perdono cristiano per il tramite dell'eremita; laddove invece, dopo l'imputazione pubblicada parte della Dama Orrenda che feriva il suo narcisismo, il suo ideale-dell'-io, il nostro eroe aveva reagito con lapresunzione cavalleresca, impedendo alla sua baldanza e alla sua fierezza di risolvere gli enigmi: operazione nellaquale egli, come si sa, fallisce, perdendosi in un seguito di avventure senza senso.Come si vede, un medesimo contenuto ci viene presentato in maniera a volte anche sottilmente diversa. Possiamo,come meglio vedremo in seguito, leggere in questa diversit il costituirsi progressivo dell'azionefenomenologicamente intensa come dato globale di motivazione, intenzionalit, responsabilit, desideriolinguisticamente espresso; azione, o, qui, meglio agentivit, che la narrazione ci presenta nella sua genesi, nel suovenire ad essere strutturale attraverso uno svolgimento temporale e una diversificazione posizionale. Ma la storia,nel suo differenziare, lascia in sospeso parecchio, lascia al discorso narrativo, al dialogo autore-lettore forse, laricostruzione del corpo articolato in una totalit organica: se arriva a svelare a Perceval, e a noi, le risposte allemancate domande, non arriva a chiarirci il contenuto semantico, il "senso" della connessione causale delle due colpedel protagonista, n il senso della connessione fra queste due colpe e la rovina del Re Pescatore e della sua terra.Sar solo attraverso una riconsiderazione del rapporto storia-discorso, testo-autore, attraverso una scomposizione delcontenuto e della sua tematica con i mezzi pi diversi, e che non potranno essere esclusivamente quelli dell'analisitestuale, sar dunque attraverso ci, che potremo proporci di rispondere ai nostri interrogativi: ma sar una rispostache non sar semplicemente in termini di "contenuto" o di "messaggio", ma sar anche in termini testuali, di creazionee di modalit di rappresentazione, quali dati interpretativi e da interpretare, in un movimento pendolare fra testo efuori-testo. ancora da questo punto di vista che la nostra narrazione pu dirsi, in entrambi i sensi gi visti, paradigmatica; anchenel senso che solo a lettura ultimata che questo suo valore si scopre, e non solo nel senso narrativo-strutturale, maanche come dato di interpretazione.
2) A mo' di paradigma
Ma della paradigmaticit in senso strettamente testuale che sar necessario primariamente occuparsi.Da un punto di vista strettamente narratologico sembrerebbe che il romanzo ponga come fine della qute di Percevalun oggetto costantemente spostato, decentrato e quindi sempre impreciso, si starebbe per dire significato da uncontinuo rimescolamento degli attori nei ruoli attanziali: ci che genera, di volta in volta, schemi diversi, nessuno deiquali sostituisce o abroga gli altri, ma si pone accanto agli altri senza destituirli.La madre di Perceval , di volta in volta, Antisoggetto (o Oppositore), Oggetto, Aiutante forse anche Destinatore: ellainfatti colei che depriva il figlio della propria libert e che pone ostacoli al realizzarsi del di lui destino di cavaliereche la sua eredit gli impone; ma anche, come si sa, l'oggetto costante della ricerca di Perceval, fin dai suoi primibarlumi di coscienza; inoltre aiutante come le parole dell'eremita dimostrano:
Ne n'eusses pas tant dur, S'ele ne t'est comande A Demedieu, ce sachestu. Mais sa parole ot tel vertu Que Diex por li t'a regard
(vv. 6403-6408)ed forse anche, almeno parzialmente, Destinatore, in quanto sono anche certe istanze materne che dovrannodeterminare l'etica cavalleresca.Gornemant de Goort Aiutante e Oppositore: egli infatti d a Perceval i pi che necessari insegnamenti affinch eglipossa "normalmente" inserirsi nel mondo cavalleresco ed ivi sapersi comportare, ma la rimozione del pre-linguisticomaterno, da lui operata nel codice linguistico dell'eroe, porta questi allo scacco che sappiamo. La cavalleria inveceOggetto di Perceval, come del tutto ovvio; ma anche il Destinatore e il Destinatario dell'azione di lui; ed inoltre
-
Aiutante in quanto costituisce la liberazione del protagonista dalla soggezione del materno, ma anche Oppositore,data l'insufficienza dei suoi codici etico-linguistici.
10) Perch il fatto che il padre sia il "rappresentante originale" della Legge, del codice "esige che si specifichiquale sia il modo privilegiato di presenza con cui si regge al di l di quel soggetto che portato ad occupare inmodo reale il posto dell'Altro, e cio della Madre", J. Lacan, Scritti, cit., p.816.
11) Infatti se "il desiderio si abbozza nel margine in cui la domanda si strappa dal bisogno" (J. Lacan ibidem)" in se stessa la sdomanda verte su altro che non sulla soddisfazione che chiede. Essa domanda di una presenzao di un'assenza. Ci manifestato della relazione primordiale con la madre in quanto gravida di quell'Altro cheva situato al di qua dei bisogni che pu colmare. Essa costituisce gi [corsivo nostro] anche il "privilrgio" disoddisfare i bisogni, cioi il potere di privarli della sola cosa da cui sono soddisfatti. [corsivo nostro]. Questoprivilegio dell'Altro disegna cos la forma radicale del dono di ci che non ha, cio quel che si chiama il suoamore". (J. Lacan, Scritti, cit. p. 688).
Rimangono nella loro fissit il Graal come Oggetto e Perceval come Soggetto, anche se questo ruolo andr megliochiarito in seguito. Quanto al Re Pescatore, si pu dire che egli, in quanto figura riflessa di Perceval, suo doppionegativo e ipostatico, pu accogliere in s tutti i ruoli attanziali canonici: Oggetto potenziale del riconoscimentodi Perceval, Soggetto che riconosce Perceval, e che aspetta il riconoscimento di questi per essere anche soggettod'azione, Destinatore e Destinatario, tramite il graal-abbondanza, dell'immagine piena che andrebbe riconosciuta nelmomento in cui riconosce, immagine che genererebbe il positivo nel momento in cui riconosciuta come negativa,mancante, castrata; inciampo sulla strada di Perceval, ma rilancio verso la strada pi vera: Aiutante ed Oppositorequindi.Ci troviamo cos dentro il kristeviano schema non disgiuntivo proprio del romanzo, caratterizzato dall'ambiguitstrutturale degli attori che coprono simultaneamente pi ruoli attanziali anche opposti, significanti di un sensoipostatico, da ricercare dentro la sostanziale ambiguit del mondo. Ci che per peculiare del nostro romanzo che la somma dei ruoli attanziali non si manifesta in maniera immediata e continua; il testo produce, di epidosioin episodio, degli schemi diversi, ciascuno dei quali ha una ben definita, e non ambigua distribuzione degli attorinei ruoli attanziali; ma gli schemi che via via si susseguono non spostano i singoli attori dai ruoli attanziali cheprecedentemente, e fino a quel momento avevano occupato; gli attori assommano invece, nel loro progredire, talediversit e ambiguit di ruoli: la loro contraddittoriet; che, per esempio, la madre dell'eroe si scopra essere Aiutante,non cancella il fatto che ella, non solo sia stata, ma continui tuttavia ad essere anche Oppositore. qua che si scopre veramente l'essenza paradigmatica della testualit del nostro romanzo. Infatti ogni configurazioneschematico-attanziale si d come possibilit di rapporti attua-lizzabili, ma ogni successiva configurazione, nonoblitera la precedente, ma assommandovisi, vi si agglutina e si concrezio-na con essa, dando luogo ad unastratificazione, cosicch si pu dire che il senso della nostra storia non altro che il suo percorso temporale chestratifica i suoi vari stadi in una visione atemporale; ma questa sorta di visione propria forse pi dell'autore-lettoreche, leggendo la struttura narrativa la proietta in un discorso, fluente lungo la dimensione del tempo (referenziale e dilettura), e la riversa sul protagonista.Quel che occorre ancora una volta sottolineare la gi detta necessariet con cui ogni tappa, ogni configurazionedistributiva dei ruoli attanziali, procede dalla precedente assommandola: cosa che d l'immagine tipica e pi voltemessa in rilievo dalla critica, di un Perceval quale personaggio in evoluzione (e quindi non solo in mutamento e inmovimento) continua. Vediamo dunque partitamente questa connessione necessaristica, ricapitolando e ampliandoquanto gi detto sopra.
-
La separazione dalla madre-tiranno-0/?/?(M7to/-e rigenera questa come Oggetto nel momento in cui Perceval apprendeun codice che la istituisce come assente e quindi come desiderio; il codice, liberando l'eroe dal bisogno immediato dilei e ponendo l'assunzione degli obiettivi in maniera non pi immediata, ma mediata00' da una norma simbolica e dicomportamento, scalza la madre cos come ogni preda duplicato-di-lei,in quanto oggetto reale, in quanto bisogno, inquanto introiezione del piacere che da lei deriva e che la respinge nell'odio in quanto oggetto-oggettivo0"; il codice laistituisce come rapporto interiorizzato, come memoria e come immagine di una comunione, di una immediatezza e diun'innocenza perdute. Ma Perceval
12) G. Chands. Recherche surs l'imaginaire des eaux dans l'oeuvre de Chrtie de Troyes, in "Cahiers deCivilisation mdivale", XIX ,76 (1976), pp. 151-164, fa notare che "La problematique de l'eau apparait lie celle de la femme, la prsence hydrique segnale presque toujours une intervention fminine".
come realt che ancora la ricerca, mentre dovrebbe trovarla come simbolo; il codice, ponendola appunto comedesiderio e come assenza, la tiene lontana e inattingibile: un fossato si scavato fra Perceval e la madre, rappresentato,nel testo, da quel fiume inattraversabile, un ve rade et par/onde, al di l del quale, l'eroe ne sicuro, troverebbe lamadre"2', ma che, rimanendone al di qua, gli presenta il Re Pescatore, il suo duplicato immaginario, il nodo del s:
"ha! Sire toz puissans,Se ceste ve passer pooie, Dela ma mere troveroie, Mien esctent, se eie est vive".
(vv. 2990-2993)cosi si esprime Perceval, ma il Re Pescatore, che sta in mezzo all'acqua, a met fra l'al-di-qua e Pal-di-l del fiume, amet fra la presenza e l'assenza della madre, poco dopo pronto a levare a Perceval ogni speranza di passare il fiume:
Cil qui ne set que faire puisse Ne en quel liu passage truisse, Les salue et demandelor: "Ensaigniez moi, fait il seignor, S'en ceste ve a neTs un pont." Et cil qui pesche lirespont: "Nenil, frere, en la moie foi, N'il n'i a nef, si com je croi, Plus grant de chestiou nos somes, Qui ne porteroit pas cine homes. Vint liues amont et aval N'i puet onpasser a cheval, Qu'il n'i a bac ne pont ne gu".
(vv. 3011-3023)La madre dunque, d'ora in avanti pu essere attinta solo come immagine, come ricordo, come simbolo, come(com)presenza interiorizzata: come realt ella ormai morta! dato che Perceval apprender dalla cugina nelsuccessivo episodio. Ma lo stesso codice che l'ha generata come desiderio ha rimosso da s il linguaggio di lei, il suopre-linguaggio i valori di cui ella portatrice; pertanto il desiderio inespresso, non detto, porta alla sua irrealizzazione,al suo fluttuare nella sfera dell'immaginario, senza che per altro, poich il codice , si diceva, letterale e non legale,sia impedito a tale potenza immaginativa l'accesso alla coscienza.Tutto ci porta necessariamente Perceval a reprimere sulla lingua stessa quella domanda che cosi prepotentementesta per sgorgargli sulle labbra. Ma porta anche necessariamente al disconoscimento del Re Pescatore e del suo essereimpotente nel fisico, nella sua capacit procreativa, nella sua interiorit e nella sua regalit al disconoscimentodella sua castrazione. Il codice, assunto come lettera e non come legge, usato dal nostro eroe alla stessa stregua deisuoi giavellotti, come strumento per la cattura delle sue prede (dove la preda, al momento presente della progressionenarrativa l'adeguamento ad un comportamento sociale cui "immediatamente" Perceval vorrebbe sottomettersi):nell'afferrare le prede, Perceval crede di afferrarsi e di costituirsi: ci che naturalmente non lo porta a vederenell'altro il proprio simile, la propria immagine, a scoprirsi manchevole, a scoprire nella manchevolezza la radice dellasoggettualit. Certo un codice-legge, su Super-io forte non sarebbe forse stato pi utile all'occorrenza, avrebbe anzi,probabilmente, peggiorato le cose, avrebbe forse rafforzato l'immaginario, ma ne avrebbe certo anche rafforzato lacensura dando luogo a quel tipo di cavalleria, orgogliosa, accaparra-trice e assassina, che Chrtien ha sempre rifiutato.
-
Ben si vede dunque come il codice e Gornemant, che di esso il mediatore, sia allo stesso tempo Aiutante, in quantoapre in ogni caso la via d'accesso alla vita sociale cavalleresca e pone la madre come oggetto del desiderio, ma anche Oppositore, in quanto impedisce l'attingimento di quest'oggetto e quindi il senso "vero" della cavalleria.Per quanto riguarda la societ cavalleresca, si potrebbe dire che essa e Perceval sono contemporaneamente in rapportore-ciproco di Soggetto e Oggetto : perch se questi la ricerca come luogo sodale-ideale in cui inserirsi, quella a suavolta ricerca lui come elemento di cui ha saputo intuire e capire le sue potenzialit; ma la limitatezza con cui essaattua i suoi valori (limitatezza che significa, in un'ultima analisi mancanza di quella coscienza piena che Percevalsapr acquisire dopo la sua particolare aventure, ma che sar negata ali'aventure di Gauvain, rappresentante "tipo"della societ arturiana), tale limitatezza dunque costituisce una sorta di contrapposizione all'azione cui Perceval do-vrebbe essere destinato, e di cui nulla sappiamo, data la non finitezza del romanzo, ma che possiamo vedre in manieraindiretta attraverso il confronto con la qute-aventure di Gauvain. La societ cortese-arturiana assume dunque ancheil ruolo di Oppositore (o i Antisoggetto), senza peraltro cessare di essere Destinatore e Destinatario dell'azione diPerceval; questi infatti fino all'episodio dell'imputazione, agisce in nome dei valori cortesi che lo ispirano (almenoa partire dal momento in cui egli addobbato cavaliere da Gornemant de Goort, dal momento in cui cio assume ilcodice), e combatte per la salvezza di essa contro ci che la insidia e la mina. Ma si pu presumere che dopo l'im-putazione, il nostro eroe combatter per la societ cortese contro essa stessa, per attuarne pienamente quei valori chei suoi membri non sono capaci di incarnare. Non vi nulla, nel nostro romanzo, che si ponga in aperta opposizionecontro la societ cortese-arturiana e i suoi valori, ma si deve soltanto vedere un discorso critico sulla sua limitatezza,la sua insufficienza, la prassi quotidiana con cui cerca di inverarsi: niente di nuovo, da questo punto di vista, rispettoa tutti gli altri romanzi di Chrtien: anche in essi infatti, come ha dimostrato lo studio di E. Khler(13), la societarturiana minata fin nel suo stesso interno ed attende l'avvento di un cavaliere eletto che possa risolvere, tramitel'aventure, le sue contraddizioni; la novit del nostro romanzo consiste semmai nella particolarit dell'aventure delprotagonista: ci di cui andiamo parlando e di cui meglio vedremo in seguito quando confronteremo questa aventurecon quella di messa in parallelo che costituisce un supporto narrativo primario per il discorso di Chrtien.Dopo questa digressione che dobbiamo comunque portare lungo il filo del nostro discorso, torniamo alla progressionene-cessaristica degli episodi narrativi, e pi precisamente a quell'episodio nodale che quello di Perceval al castellodel Re Pescatore e del Graal. Si gi ormai pi volte detto del mancalo riconoscimento della di lui mancanza da partedel nostro eroe, e si anche cercato di spiegarne le cause. Ci che ci si deve chiedere ora con particolare urgenza perch questo riconoscimento debba essere effettuato attraverso le domande sul Graal e sulla lancia che sanguina;perch il dialogo che sempre genera i soggetti in quanto scambio dell'uno e dell'altro, riflesso dell'uno nell'altro,desiderio dell'uno per l'altro debba vertere sul Graal e sulla lancia che sanguina: forse perch nel Graal veicolatoun contenuto femminile e materno e nella lancia da vedere l'arma che ha "colpito" il Re Pescatore? perch entrambigli oggetti hanno quindi un contenuto erotico (ed nell'eros che il soggetto si attua pienamente, che la castrazioneimmaginaria e latente di ciascuno si elide sotto lo sguardo vivificante e desiderante dell'o//ro (-a/))? il mancatopassaggio del femminile nel linguaggio (bloccato dal codice-lettera che non sa farsi, fortunatamente, codice-legge,legge del Super-io), che manca di istituire Perceval come soggetto? il disconoscimento dell'impotenza che ancorainfantilmente si appaga di introiettare le prede (duplicato della madre a-linguistica) con qualunque arma di cattura(fosse pure il codice e la lettera): questa la colpa di Perceval? quella insomma di negare la madre perch ancora, incerta misura schiavo di lei, della sua realt, mentre dovrebbe far passare la sua immagine (desiderio) nel simbolico?sta la colpa nel non sapersi porre come "oggetto a del desiderio, come ci che egli stato per l'Altro nella sua erezionedi vivente, come il wanted o l'unwanted della sua venuta al mondo" per cui egli sarebbe "chiamato a rinascere persapere se vuole quello che desidera"04'; nel non sapersi porre come
-
13) Cfr. Kohler, Ideal und wirklichkeit in der hohofischer Epik, cit.,14) Cfr. J. Lacan, Scritti, p. 679.
Fallo per la madre? Accontentiamoci, per il momento, di dare una risposta provvisoriamente affermativa a questiinterrogativi, ma non dimentichiamo che Perceval appena reduce dalla dimora e dalla aventure con Blanchefleur allaquale ha opposto non gi un rifiuto che anzi stato proprio lui a richiedere la sua druerie, ma una insufficienza, unadilazione che difesa a tale insufficienza, per la quale se egli entrato nella dialettica dello sguardo e del desiderio,non ancora in grado di padroneggiarla in quanto mancante del significante simbolico, di cui ancora depositaria lamadre: Perceval hason corage aillors, a lui d'autre ore plus lisovient (vv. 2916-17): il desiderio ancora (?!) sotto ilsegno del materno, ed egli risponde con l'assenza (da Blanchefleur) all'assenza (della madre).
Una questione si potrebbe porre a questo punto: perch vedere nel Re Pescatore il doppio di Perceval, quandoun'attenta messa in parallelo di tre passi del testo potrebbe meglio indurci a vedere in lui il doppio del padre diPerceval? Si confrontino i seguenti tre passi, il primo dei quali tratto dal discorso che la madre di Perceval tiene alfiglio, al momento della sua partenza, intorno al padre di lui, il secondo tratto dal discorso accusatore della DamaOrrenda riguardo alle conseguenze che il peccato di Perceval produrr sul Re Pescatore e sulla sua terra; il terzo tratto dal discorso della cugina di Perceval che informa quest'ultimo sul Re Pescatore:
Vostre pres, si nel savezFu parmi la jambe navrezSi que il mehaigna ciel cors.Sa grant terre, ses grans trsors,Que 1 avoit corne preudom,Ala tt a perdition,Si cha en grant povert.Apovri et deshiretEt escilli furent a tortLi gentil home aprs la mortUterpandragon qui rois fu
Et pres le bon rois Art.
Les terres furent escillies
Et les povres gens avillies,
Si s'en fut qui fur pot. (vv. 435-449)
A mal eut tu te teusses,Que se tu demand l'eusses,Li riches rois, qui or s'esmaie,Fust ja toz garis de sa plaieEt si lenist sa terre en pais,Dont il ne tendra point jamais.Et ses tu qu'il en avendraDel roi qui terre ne tendraNe n'iert de ses plaies garis?Dames en perdront lor maris,Terres en seront escillies
Rois est il, bien le vos puis dire;Mais il fu en une batailleNavrez et mehaigniez sanz faille,Si que puis aidier ne se pot,Qu'il fu frus d'un gavelotParmi les quisses ambesdeus,S'en est encor si angoisseusQu'il ne puet sor cheval monter, (vv. 3508-3515)
-
La ferita castratrice del padre di Perceval la stessa del Re Pescatore, la condizione cui sar ridotta la terra diquest'ultimo in seguito al peccato di Perceval, la stessa in cui fu ridotta la terra del padre di lui in seguito allaferita; perch dunque vedere nel Re Pescatore il doppio di Perceval e non quello di suo padre? che il doppio dicui parliamo, un doppio ipostatico e non effettivo: in questa immagine che il nostro eroe dovrebbe specchiarsi,assumendola, per recuperare in positivo l'eredit di suo padre, addossando su di s la colpa di questi115'; dalla co-gnizione di ci che (gli) manca per essere ci che gli altri (la madre) lo vogliono (ci che pone la legge del desideriocome desiderio dell'Altro) che potr riempire tale mancanza, dopo averla assunta come propria: cosi che potr"volere ci che desidera".
Dopo l'episodio che si svolto al castello del Re Pescatore, 1 legame necessario che tiene la narrazionesembrerebbe interrompersi, ma una lettura pi stringente del testo pu forse dimostrarne il contrario.
L'episodio successivo quello dell'incontro di Perceval con la cugina dalla quale egli riceve la cognizione della suacolpa: o meglio delle sue colpe, della loro connessione e dei loro effetti; ella si trova infatti su quelle che egli crede letracce dei valletti del Re Pescatore dai quali vorrebbe sapere le risposte su quella lancia che sanguina e su quel Graalriguardo ai quali si astenuto di porre la domanda:
Et il vers la forest s'aquelt,Si entre en un sentier et troveQu'il i ot trache tote nueveDe chevax qui ale estoient."Ichi, fait il, quit que il soientAl cil que je querant vois".Lors s'eslaisse parmi le boisTant com cele trache li dure,Tant que il voit par aventureUne pucele soz un chaisne,Qui pleure et crie et se desraisneCome chaitive dolerouse.
(vv. 3422-3433)
15) sulla necessit di assumere su di s, da parte del soggetto, la castrazione come via per attingere il desiderio,si veda J. Lacan, Sovversione del soggetto e dialettica del desiderio nell'inconscio freudiano, in Scritti, cit., pp.765-831.
Per quanto l'incontro capiti par aventure, esso pur sempre al termine di un percorso che seguita tant com celetrache l dure: non forse questo il senso pi vero della "avventura cavalleresca", in linea con tutta l'etica, il
-
cronotopo, chrestienia-no? l'avventura non capita a chi la cerca, a chi si mette sulle sue "tracce"? a chi, cavaliered'elezione, alla ricerca del senso del suo esistere?E la cugina di Perceval sorella del Re Pescatore, ed colei che svela, non solo all'eroe, ma anche a noi, l'ubicazionenel non-luogo in cui situato il castello del Graal: "... l'enporroit, se Diex me gart, / Chevalchier, ce tesmoigne l'en /Quarante liues en cest sen / Tot droit, einsi com vos venez, / C'uns ho-steus n'i seroit trovez / Qui Just bons ne leausne sains... (vv. 3468-3473), afferma ella dapprima, ma al ribattere di Perceval che egli stato riccamente ospitato nelmigliore degli hostel, non di l lontano, ella "comprende" che egli stato ospitato "Chiez le riche Roi Pescheor".Se l'episodio del Graal nodale perch in esso convergono, e da esso sono irraggiati tutti i punti della circonferenzanarrativa della nostra storia, l'episodio dell'incontro con la cugina segna un punto di svolta per questa storia: infatti illegame che da qui in poi tiene la sua articolazione diverso da quello che fin qui abbiamo visto. Permane certamentela struttura per accrescimento e stratificazione degli stadi; ma dell'azione, dell'azione fondata che da qui in poi sitratter: riguardo a questa, tutto ci che precede stato solo una premessa e la genesi; se l'azione, come meglio diremopi in l, significa in prima istanza far passare il desiderio nel linguaggio, ci che dalla narrazione stato fin qui messoa fuoco (e nella maniera "angolata" che abbiamo visto) la genesi del desiderio e la necessit per cui esso debbatrovare espressione: d'ora in poi si tratter della effettiva "espressione" di esso, affinch si possa passare all'azionevalutata e finalizzata, pur proiettata sullo schermo della sua genesi.Non siamo infatti del tutto convinti di quanto afferma J. Frappier, sia pure con un'affermazione attenuata e sfumata,che l'evoluzione di Perceval, nel momento in cui egli raccoglie la sfida di Clamadeu, "correspond un affermissementde sa volont propre et de sa libert"; e che qui il nostro eroe"n'obit qu' l'instinct de sa prouesse ou dj, peut-tre, ia conscience d'un devoir strictement chevaleresque etpersonnel"0; crediamo invece che Perceval sia ancora vittima dei suoi automatismi che Chrtien non manca disottolineare, mentre forse proprio Blanchefleur che evolve in questa espe-rienza; costei infatti, con abile e fineastuzia femminile, aveva suscitato in Perceval quella volont che pure ella biasima, pun-lando sul suo orgogliomaschile ancora niche esot:
... vostre cors ne vostre eagesN'iest teus, ce sachiez asseiir,Que vos a chevalier si durNe a si fors ne a si grantCome est cil qui la hors atant,Vos pessiez contretenirN'estor ne bataille soffrir
(vv. 2118-2124)e subito dopo Chrtien commenta, con una certa misoginia malcelata sotto la maschera del pronome impersonale:
Tel plait li a cele bastiQu 'eie le blasme et si le veli;Mais sovent avient que l'en seltEscondire sa volente,Quant on voit home entalentDe faire trestot son talentPor che que mix l'en entaient.Einsi fait eie come sage,Qu'ele li a mis en corageCe qu'ele li blasme molt fort.
(vv. 2128-2137)
-
Perceval cade dunque nella trappola del linguaggio, attraverso la presunta trasparenza del codice, ed egli crede, ancorauna volta, di potersi affermare attraverso la cattura di una preda; duplice questa volta: il nemico vinto e la dreriedella damigella.
16) Cfr. .1. Frappier, Chrtien de Troyes et le Mythe du Graal, cil. p. 104.
Ma quando ella, questa volta con pi sincero amore, vorr distoglierlo da un pericolo e da un ardire ormai superfluo,il nostro eroe la difender suo malgrado, perch vittima della lo-senge di lei; per quanto ella lo preghi dolante etcorrechie che egli n 7 alast mie7A la bataille
... tot che ne valoit noient, Et s'est oit or merveille est range, Car il avoit en sa losengeGrant douor qu'ele li faisoit, Car a chascun mot le basoit Si doucement et si sof Queeie li metoit la clef D'amors en la serre del cuer.
(vv. 2630-2637)A chi si applica la parola losenge! A Blanchefleur? no, perch ora lei, dolante et correchie, sincera; a Perceval,allora? neppure, perch egli colui che la subisce: la parola dell'impersonalit commentatrice del narratore cherimarca come Perceval sia due volte vittima della "parola", senza aver, in nessuno dei due casi, capito le intenzioniche vi si celano dietro; e se, come il successivo episodio del Graal porter in maniera del tutto necessaria, sulla"parola" che l'amore si fonda, questa dovr essere scevra di losenge. Se siamo d'accordo col Frappier che il nostroeroe segue, in questa circostanza, "l'instinct de sa prouesse" non siamo d'accordo sul fatto che egli agisca in manieralibera rispetto ai legami della drurie; se siamo d'accordo che "l'gocentrisme de Perceval reparat [...] ici", non siamod'accordo sul fatto che egli sia "anim d'une gnrosit qui empche de le confondre avec son gosme puril denagure"07': Perceval ancora fanciullo egocentrico! schiavo degli automatismi di un linguaggio che agisce sulla suasemplicit. Ed egli ancora non vuole ci che desidera, la sua prova di coraggio stata rivolta solo a s stesso e nonalla sua amie; che egli infatti abbandona, almeno momentaneamente, per raggiungere la radice del suo desiderio, percolmare l'assenza e la mancanza: per raggiungere la madre!L'episodio segna comunque una tappa importante per Perceval e per il paradigma angolato della sua storia: egliha fatto l'esperienza del gioco dell'innamoramento (ma non ancora dell'amore), basato sul gioco della parola: fattoessenziale; ma egli deve imparare a padroneggiare questo gioco. E pertanto egli dovr caricare su di s quell'immaginein cui si riflette e che lo cattura, immagine che dovr esser non gi quella piena, ma quella mancante: quella che giust'appunto pronta a presen-larglisi al castello del Re Pescatore; lo scacco che ivi subisce pu essere interpretatocome la necessaria conseguenza, il doppio dello scacco che, contro ogni apparenza ha subito a Biaure-paire, dove gli stato mise en corage, ci che altri // blasme, dove ha voluto ci che non desiderava: egli dovr allora far proprio ilproprio riflesso, ma proprio quel riflesso negativo che, in quanto tale, non potr catturarlo, quel riflesso che, negativonell'immaginario, ipostatizza il positivo nel simbolico. Perch "il passaggio dal (-r} (phi minuscola) dell'immaginefallica dall'uno all'altro lato dell'equazione fra immaginario e simbolico, lo positivizza comunque, anche se va ariempire una mancanza. In qualsiasi modo faccia da supporto al (-1), vi diviene sempre ? (phi maiuscola), fallosimbolico che impossibile negativizzare, significante del godimento"'181; perch il desiderio che istituisce laLegge e non il contrario, la Legge che deve arginare il capriccio dell'Altro onnipotente: la Madre, oggetto deldesiderio d'amore "in cui il soggetto si installa"; perch il "desiderio si abbozza nel margine in cui la domanda sistrappa dal bisogno"; perch "la vera funzione del Padre [...] fondamentalmente quella di unire (e non di opporre) undesiderio con la Legge"; perch questa congiunzione impone il sacrificio della castrazione09': per tutto questo la veraelezione di Perceval, la esemplarit di lui che partito da un desiderio che si "strappa" - e quanto prepotentemente -dal bisogno, sta appunto nel fondare la Legge sul desiderio (e non viceversa, come gli altri cavalieri, come Gauvain,suo termine contradditorio);
-
17) ibidem18. J. Lacan, Scrini, cil., pp. 826-82719. J. Lacan, Scrini, cil., p. 828
sta nel partire da un'assenza di Legge, di padre (di Padre) e nel trovarlo, negativizzato, sotto le spoglie del RePescatore che anche il suo doppio. Egli ritrova il padre nella sua "vera" funzione e non nella sua idealit, nell'ipostasidi esso, non come Legislatore, ma come Legge del desiderio che esige la castrazione: ecco perch il Re Pescatore colui che pu essere considerato il doppio del padre, ma anche di Perceval.Come non leggere allora il paradigma della nostra storia sulla falsariga del paradigma lacaniano? come non vedere inPerceval un soggetto che si attua a partire dal suo sovvertimento? che parte sovvertito, che parte - ed questa Vango/azione del nostro paradigma - da una legge di gi sovvertita?Ma Chrtien apporta forse una "novit" {?!), una differenza non piccola: lo "strappo dal bisogno" deve essere sentitocome una colpa affinch il desiderio si fondi come assoluto (distaccato: Assoluto) dalla Madre e affinch la Legge diquesto poggi sul perdono cristiano.Ora siamo in grado forse di vedere come la nostra storia ci si ponga sotto l'aspetto di un paradigma, anche, esso,nella sua valenza grammaticale: valenza complessa perch questa paradigmatiche si fa sintagmatica. Ogni tappa, che,come abbiamo visto contiene in s una performanza attanziale, una particolare distribuzione degli attori nei ruoliattanziali della grammatica narrativa; ogni tappa, che possiamo vedere, insieme con J. Frappier1, come una tappatipica di ogni esistenza umana: ogni tappa , dunque, come il concretarsi di una delle relazioni grammaticali possibiliche, in absentia, richiama tutte le altre, le necessita e ne necessita (cosi come un caso grammaticale presuppone tuttala declinazione); ogni tappa (e tra queste poniamo anche l'intera aventure di Gauvain) l'affermarsi di una possibilesituazione d'esistenza (il succube della madre, l'infante ingenuo e crudele, il niche-sot che crede di afferrarsi affer-rando, l'uomo che maldestramente ha appreso un codice di comportamento, l'innocente e prematuro innamorato,l'uomo difronte all'interrogativo che svuota l'esistenza, ecc., ecc.). Ma proprio perch ogni tappa presuppone le altre,qui, in un testo, queste ci vengono dette: narrate; cosicch noi possiamo leggere nel testo il manifestarsi di unparadigma, il suo farsi: il suo esserci raccontato. Ed cos che il paradigmatico si sposta nel sintagmatico: e in talmodo, come sopra si accennava, ogni tappa si assomma alle precedenti e d luogo a una concrezione stratificata ele linearit della narrazione si trascende in un circolo: dalla Madre si parte, e alla Madre si ritorna; ma questa vogliadi ritorno, costantemente frustrata da un inciampo, da una aventure che si frappone lungo la via, sposta il sensodell'oggetto e ne altera la valenza, e la linearit del procedere -sia in avanti che all'indietro - si trasforma in unacircolarit.Ma come ogni grammatica dei casi che non voglia esaurirsi in una semplice formalizzazione strutturale deve cercarefuori di s la cifra che tiene in piedi la declinazione, e, cos facendo, sconfina nella pragmatica e nella fenomenologiadell'essere parlante*2, cos, allo stesso modo, si dovr cercare la cifra che tiene il paradigma della nostra storianell'azione e nel suo costituirsi: nella legge del desiderio che, passando nel linguaggio, determina l'agire dell'uomocoma soggetto. E come ogni grammatica dei casi presuppone una concezione dell'umana prassi sullo schermo fluentedello spazio-tempo, presupposizione che trasforma il continuum dello stare al mondo in una sintagmatica del fare edell'agire, allo stesso modo la considerazione paradigmatica sotto cui abbiamo posto la nostra storia si fa sintagmaticase vi presupponiamo una
20) Cfr. J Frappier, Chrtien de Troyes et le Mythe du Graal, cit. p. 159: "des tableaux successifs, relis par unlger fil narratif, dcoupent dans la vie du hros les tapes capitales, les tournant dcisifs de son ascension,de sort que chacun des pisodes, vrai d'une vrit particulire Perceval, se colore aussi d'une vrit plus
-
gnrale, didactique et symbolique, car il peut reprsenter une image des diffrentes phases de l'existencehumaine"
21) "l'objet syntaxique est bimodal par ce qu'il existe deux genres bien dfinis de relations syntaxiques, Ily a d'une part les relations purement syntaxiques que sont les relations grammaticales et d'autre part lesrelations souvent dites "smantiques" que sont les telations actantielles (ou casuelles) prenant en charge lesrles smantiques [...] Les relations grammaticales s'inscrivent dans l'horizon des automatismes du langage. [...]Les relations actantielles supportant les rles smantiques s'inscrivent en revanche dans l'horizon des rapportsentre langue et pense". (J. Petitot-Cocorda, Morphogense du Sens I, Paris, Presses Universitaires de France,1985, p. 122-123).
concezione (una problematica?) dell'agire e del suo farsi: cosicch il significato del paradigma trascenda la suavalenza di grammaticalit per assumere quella di una eticit, o, meglio, quella del suo fondarsi, per diventareesemplare: exemplum al di l del modello logocentrico, e della "differenza" su cui si fonda.
3) Intermezzo mitico-tematicoUn problema che intriga e, recentemente, sempre di pi l'analisi del testo quello del tema, dei temi edella struttura tematica e del rapporto di questi con la struttura "forte", gramma-narratologica del rcit. SecondoGreimas3, l'insieme delle configurazioni semiche del discorso sono sottoposte ad una selezione da parte degli elementipropri della struttura narrativa, dai ruoli attanziali; selezione che avviene ai fini della co-genza testuale e dellamanifestazione del senso di esso. Ci provoca una tensione fra il narrativo e il discorsivo (fra i ruoli attanziali cheselezionano dei semi pertinenti da una parte, e dall'altra la ridondanza dei semi del discorso). Ma "un discours abstraitest 'thematis', c'est--dire qu' il traite de notions, d'origine cognitive (la libert, la joie, etc.). Il se figurati-vise si [...]il a recours [...] des lexmes qui voquent des choses, des personnes, des dcors du monde sensible. [...] La figurativisation peut se convertir en 'iconisation', tape ultime du parcours gnratif visant produire l'effet de sens 'ressem-blance avec la vie'."'23.In questa prospettiva gerarchizzante, "si l'on accorde une dimension lexmatique aux configurations discursives,on appellera alors thmes l'quivalent des smmes"*24; ma in prospettiva di analisi del testo letterario, questagerarchizzazione fa problema, costituisce una difficolt. Difficolt che gi stata sollevata da J. Petitot-Cocorda:"tant donn que les thmes discursifs actualisent des smes figuratifs exclus par dfinition de la smantiquefondamentale, ils ne peuvent, comme nous l'avons plusieurs fois not, prendre en charge les valeurs produites parcelle-ci que par le biais de leurs classmes 'lis'. Mais alors on ne voit plus comment la narrativit peut faire monteren surface les racines pulsionnelles de l'imaginaire, comment elle peut tre ce jeu incessant et infini de simulacressmiotiques permettant de reprsenter par leurs parcours des tenants-lieu de ces 'indicibles' irrepr-sentables que sontle 'sens' de la vie et de la mort, de la nature et de la culture, de la diffrence sexuelle, etc."(25).Il Petitot-Cocorda risolve la questione proponendo una classificazione gerarchica all'interno dei temi medesimi,distinguendo fra prgnances thymiques (o classemi liberi) e temi discorsivi (o classemi legati, quelli che stabilisconol'isotopia del discorso), per cui la semantica fondamentale della narrativit deve essere "repense sous la formed'une articulation de prgnances thymiques (et pas simplement de substance du conte-nu)"(26) infatti "un des grandsintrts de la thorie des structures smio-narratives est de faire de la narrativit l'lment privilgi o se manifestentles structures profondes de l'imaginaire. C'est dire qu'elle postule (plus ou moins explicitement) qu'il existe labase du 'sens de la vie' un dfaut constitutif de reprsentation (un 'trou noir') et que ce dfaut se voit suppl,mdiatis, par des oprations narratives trouvant dans cette fonction leur sens anthropologique. Lorsqu'elle posealors que les structures narratives sont contrles et finalises dans leur dimension syntagmatique par des classmesdlocaliss slectionnants et 'libres', axiologiss et thymiquement investis, elle postule en fait (toujours plus ou moins
-
explicitement) que ceux-ci sont 'profonds' (vie/mort, homme/femme, nature/culture, etc.) et bien que lexicalisablespar plongement de la mtalangue dans la langue objet, d'une tout autre nature que les smantmes et classmes desfigures lexicales. [...] C'est pourquoi ils sont peu nombreux et pratiquement universels, et
22) Cfr. A.J. Greimas, La struttura degli ottanti del racconto in Del Senso Milano Bompiani, 1970.23)Cfr. Anne Hnault, Narratologie, Smiotique gnrale. Les enjeux de la s-miotique: 2, Paris, PressesUniversitaires de France, 1983, pp. 136-137.Cfr. J. Petitot-Cocorda, Mophogense du Sens /, cit.; p. 255.24) Cfr. J. Petitot-Cocorda, Morphogense du Sens I, cit., pp. 259-6025) ivi, pp. 259-26026) ibidem
bien que lmentairement articuls peuvent rgir nanmoins de vastes squences syntagmatiques"(27).Ma, ci domandiamo ancora, sufficiente una gerarchizza-zione, anche cosi rifondata dal Petitot-Cocorda, a darciconto di un discorso e di un discorso letterario? veramente riducibile un testo letterario, nella sua essenzialit, aquesteprgnances tymiquesl Possiamo essere d'accordo che il senso "forte" di un tale testo possa essere ricondottoa tali pregnanze, ma il senso "forte" anche il senso "vero"? Il senso di un discorso non anche quello della suainterrelazione fra pertinente e ridondante, non anche quello della messa in discorso e della messa in questione dellepregnanze, del loro essere portate da una prassi quotidiana quanto mai sfumata e variegata? D'altronde se vero ciche dice lo stesso Petito-Cocorda, e cio che "une grande partie de la mtapsychologie freudienne (conue comme unethologie anthropologique) peut s'interprter dans ce cadre comme une thorie de la faon dont le symbolique relayela prgnance et, ainsi charg, 'd'inconscient', interfre avec le cognitif" e che "l'apprentissage du langage est solidaired'une 'catastrophe gnralise' de la prgnance biologique et que les sources de prgnance sont 'inconscientes' enquelque sorte des 'trous noirs' de la reprsentation, des pulsions"
-
prodezza, l'ingenuit, la saggezza, l'accusa, il perdono, lo stato di natura, la civilt, e quanti altri mai! La stessaanalisi che siamo venuti qui sopra conducendo presuppone un reperimento di temi basato su interessi, anche nostriparticolari, che si pongono su una linea di interpretazione. Il tema andrebbe concepito come un semema: comel'applicazione a un nucleo semantico-grammaticale (attante, predicato, ecc.) di una serie di classemi (talvolta legati,talvolta liberi, o liberi e legati insieme), la selezione dei quali operata da una cooperazione fra stimoli del testo e"interessi" del fruitore.Posto quindi, sia pure con tutte le limitazioni suddette, il criterio dell'interrelazione di temi forti o pregnanti e ditemi pi propriamente discorsivi (e data una, sia pur approssimativa, definizione di tema), proveremo a vedere,concretamente nel nostro testo, anche se in via necessariamente ipotetica e comunque provvisoria, l'inverarsi dellainterrelazione suddetta.Partiremo dall'ipotesi "forte" e pregnante del mito di Parsifal proposta da C. Lvi-Strauss. Secondo quest'ipotesi, ilmito che sta alla base del nostro romanzo pu essere considerato come il rovescio del mito di Edipo: a un eroe cherisolve gli enigmi rispondendo alle domande contrapposto infatti un eroe che deve porre dei quesiti; a un eroe chepratica un abuso di sessualit (incesto) contrapposto un eroe ancora inesperto di essa; ma entrambi i miti che purdivergono in quello che gre-masianamente si chiamerebbe il contenuto invertito, collimano nel contenuto posto chesarebbe l'istituzione della fertilit vitale contro la sterilit, fatto che si pone in relazione al giusto ed equilibrato usodella parola e della sessualit: non dovendo essere, n l'una n l'altra, n in eccesso (Edipo), n in difetto (Parsifal).Ben si pu vedere, anche in base a ci che stato detto sopra, come i temi qui sopra esposti siano centrali, pre-gnanti, per l'interpretazione del nostro romanzo; ma quanto di esso, del suo "senso" non resta fuori se ci si limita adessi soltanto e alla loro semplice articolazione dicotomica? Si potrebbe anche pensare che il testo, adattandosi allacultura in cui immerso e da cui creato (la cultura cortese della nobilt feudale del medioevo francese), propongao riproponga un nuovo mito adattato alla contingenza storica. Ma siamo dell'idea che, se anche ci troviamo difronte auna riproposizione mitica, questa non sia n pacifica, n totale.Abbiamo infatti visto, nei paragrafi precedenti, per quale tortuosa via narrativa Perceval giunga ad istituire la Culturacontro la Natura; e come vada inteso che la Natura non debba essere eliminata in opposizione categoricamentedicotomica col suo termine correlativo. Abbiamo anzi visto come la storia faccia un circolare ritorno indietro eraggiunga, alla fine, il punto di partenza: la Madre-Natura, luogo a cui, d'altronde si arriver non gi realmente masimbolicamente per la mediazione del desiderio.Ci si pu allora domandare se questo percorso tortuosamente circolare non sia necessitato, piuttosto che dal fattodi dover-voler fondare o riproporre il mito della cavalleria proiettandolo sulle pregnanze timiche di un mito arcaicoe inconscio, non sia necessitato invece dall'esigenza di rifondare la cavalleria! non si tratterebbe quindi di opporrela Cultura-Cavalleria alla Stato selvaggio-Natura: la cavalleria gi infatti un dato di fatto, ma la sua "cultura" insufficiente proprio per la sua drastica opposizione alla "natura".Si potrebbe allora dire che la posizione del mito-poeta, diChrtien, sta sopra un'opposizione paradigmatica gi costituita e da l parassitariamente agisce la sua conversionee la sua sovversione. Ed da questa specola che parte la fluttuazione tematica, la quale, solo dopo che il circolosar concluso, potr trovare stabilit strutturale e renderci conto di certe ambiguit tematiche (come la sterilit delgastepas, della madre di Perceval e del Re Pescatore, dove per il nostro eroe pi che ben nutrito) o di temiapparentemente estranei come quello della colpa e del perdono.E che questo mito di rifondazione non porr pi una categorica opposizione dicotomica, ma riassorbirquest'opposizione per la via del simbolico; e semmai la nuova opposizione sar: opposizione/eliminazione (oriassorbimento) dell'opposizione; pi che la proposizione o la rifondazione di un mito, Chrtien sembra proporci ilsuperamento della logica mitica: infatti nessuna nuova sostanza di contenuto ci viene data (si tenga conto del fattoche gli insegnamenti che Perceval, alla fine della vicenda, riceve dall'eremita sono sostanzialmente quelli che avevaavuto dalla madre: nessuna inversione di contenutola).
-
Il 'senso' del romanzo sarebbe allora quello della necessit di un rifondarsi universalizzato: ed cos che il testopu proporre, e noi d'altro canto comprendere, dei temi come quello dell'orgoglio - tanto quello prepotentedell'Orgueilleus de la Lande o dell'Orgueilleuse de Nogres, suo riflesso speculare, tanto quello pi "raffinato" diGauvain; oppure tenui come quello del selvaggio e dell'ingenuo, che solo apparentemente sono un unico tema:Perceval spesso visto come un selvaggio allo stato di natura, ma v' chi vi sa scorgere tutte le sue potenzialit el'umana simpatia che da lui promana proprio grazie al suo essere allo stato di natura, che allora non sar pi uno statoselvaggio, ma sar invece ingenuit: proprio quella virt che lo fa grande.
29) Cfr. la noia (1)
Tutti i cavalieri devono allora rifondarsi, e innanzitutto come singoli, riassumendo lo stato di natura materna persuperarlo senza obliterarlo, per avere coscienza che ogni cultura tale proprio in quanto si oppone alla natura cheresta pertanto
ineliminabile e il cui oblio causa la catastrofe, sia come dato di fatto, sia come dato etico.E al di l della contingente problematica della cavalleria, Chrtien ci ricorda che se la Cultura, cosi come ognilinguaggio e ogni codice, si basa sull'opposizione di dati diversi, sulla "differenza", questa "differenza" non andrcerto abolita, pena il non funzionamento della Cultura, ma andr considerata come tale: nell'insieme dei suoi terminiopposti riassorbiti nella totalit che li pone.Un meta-mito, allora, quello di Perceval-Chrtien? forse, visto che propone una dicotomia che ha come uno dei suoitermini, il superamento della dicotomia. Ma preferiamo vederci la proposizione del poetico, specie se prendiamo inconsiderazione dei temi come quello del codice, della sua necessit, della sua limitatezza, della necessit di superarlosenza cancellarlo; il tema della necessit di reintroiettare l'oggetto dopo averlo appunto "oggettivato", di superareinsomma la pur necessaria "differenza" del logocentrismo.Ma i temi della colpa, dell'imputazione e del perdono (insieme con l'interrogativo, che il lettore si pone, sul loroperch e sulla loro connessione narrativa; i temi dello stato selvaggio e della ingenuit - temi questi ultimi che assaispesso hanno costituito problemi interpretativi nodali e centrali della critica chre-stieniana) non possono, questi teminon agganciarsi al problema della responsabilit dell'azione, dei suoi motivi e della sua intenzione: a quei termini cioche costituiscono quella che P. Ricoeur chiama "la rete concettuale dell'azione"'30'.
30) Nel senso detto da P. Ricoeur.
4) L'azione di Perceval.Cos stando le cose, il testo allora non pu non essere visto dalla parte del ricevente, dal punto di vista di una "esteticadella ricezione"; nel senso, anche, che la genesi del testo in quanto tale parte da un insieme di dati che il fruitorepercepisce in maniera complessa, forse caotica, ma che tendono a disporsi in ordine. Se vero che un certo percorsodi lettura (pi profondo, ma, proprio per questo, pi ingenuo) tende a selezionare quegli elementi di senso che possanopi facilmente inserirsi dentro lo schema logico-semantico greimasiano, attraverso l'investimento semantico degliattori-attanti e della topologia entro cui l'azione si svolge, pur tuttavia una certa parte di materiale che necessariaalla mimesi si mostra "eccedente", "ridondante", rispetto all'investimento di tale logica del senso. La percezione deveallora compiere il lavoro dipertinentizzare ci che "necessario', ma proprio questo lavoro che assume significatoestetico, ed in questo lavoro che il racconto si pone come testo. Ci che "resta" viene valorizzato dal lavoro dipercezione come lo scotto da pagare per il raggiungimento di un senso.Perch in questo resto scottante, in questa "histoire que nous entendons tre dans un rapport de priorit et decausalit au rcit"'30 che il racconto, il rcit si pone come un ordine, come il senso "forte" di cui sopra si parlava
-
(e che, per il nostro romanzo consisterebbe nell'affermazione della Cultura sulla Natura: nella disalienazine dalla"tirannia" materna; e inoltre nella fondazione di una "nuova" cavalleria). Ma se il senso forte non pu fare a meno dichiamare in causa Vhistoire, nella quale esso deve fare ordine, il "vero" di questo senso sta anche in questa chiamatain causa, nella rivisitazione di quel materiale di storia in cui va posto ordine: il senso forte viene allora alterato -nello stesso tempo in cui viene determinato - dal percorrimento medesimo di questo materiale, dalla sua presa inconsiderazione.Ci che per proprio del nostro romanzo che a questo ripercorrimento chiamato il protagonista prima ancorache il lettore. al protagonista che deve essere chiaro non solo il senso, ma anche la genesi di quell'azione che loporta a essere un "nuovo" eroe mitico, e l'instauratore di un senso forte: proprio del suo essere primariamente, agented'azione. Tuttavia il discorso narrativo dell'Autore lascer che questa genesi sia ricostruita e posta dal lettore il qualedeve ricostruire, per comprendere il testo, ci che Perceval medesimo deve sapere; e il