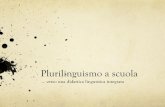Valutare l italiano a scuola · 21 e 22 maggio 2015 sul tema "L'Italiano e le altre al tempo del...
Transcript of Valutare l italiano a scuola · 21 e 22 maggio 2015 sul tema "L'Italiano e le altre al tempo del...
Valutare l’italiano a scuola
Guido Benvenuto
Dip. Psicologia Processi Sviluppo e SocializzazioneMetodologia Ricerca Pedagogica
Napoli, 16.02.2018
Temi per la rifessione
n Dimensioni e livelli della valutazione, a scuolan Gli “oggetti” della valutazione nella
did.italianon Competenze del docente, per la valutazione
dei processi di apprendimenton Piste per una valutazione partecipata e
collegiale: costruire prove comuni, correzione collegiale
La valutazione
3
profitto
comportamento
partecipazione
Progressi rispetto livelli partenza
impegno
serietà
responsabilità
Tutto il processo di apprendimento
Incidenza valutazione
4
aspetti psicologici ed emotivi
aspetti psicologici ed emotivi
costruzione immagine di sé
costruzione immagine di sé
senso di autoefficacia
senso di autoefficacia
motivazione studio
motivazione studio
apprendimentoautostima motivazione
Funzione regolativa/formativa
Diagnostica. Per rilevare la situazione di ingresso e impostare un’azione didatticaPredittiva e prognostica. Per determinare la prosecuzione degli studi o prevedere gli esitiSelettiva e/o Sommativa. Per discriminare i livelli di passaggio tra determinati segmenti del percorso formativo(ri-)Orientativa. Per pianificare un graduale passaggio e prosecuzione nei percorsi formativi
Dimensioni conoscitive(rilevazione e misurazione)Descrizione. Elencazione degli attributi Comparazione. Confronto di un risultato con altri (classe/scuola/nazione)Certificazione. Confronto dei risultati rispetto a livelli standard o su scale comuni
Funzioni e dimensioni conoscitive nella valutazione
valutazione iniziale
valutazione intermedia
individualizzazione centrata su attività
compensative
individualizzazione dei materiali
di apprendimento (Diva)
valutazione finale
valutazione dei prerequisiti
valutazione formativa
valutazione sommativa
valutazione predittiva
- esami - giudizi
di orientamento
valutazione prognostica
valutazione diagnostica
valutazione analogica
Le f
unzi
oni d
idat
tich
e de
lla v
alut
azio
ne
1) quello della valutazione decimale, praticato pressoché da sempre nella nostra scuola (eccezione: giudizi);
2) quello per punteggi negli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione.
3) quello della certificazione delle competenze (fine ciclo primario, second.primo grado; biennio; esame, esame di stato)
Quale modelli/modalità? Sistemi valutativi vigenti
Dimensioni nella valutazione
Soggettiva
Valutazione
Intersoggettiva
Oggettiva
Piani/livelli
Individuale/classeCollegiale/classeDisciplinare/DipartimentaleCurricolare/ciclo/ambitiInterdisciplinare/certificazioneIstituzionale/RAV
Scelta delle forme di verifica
Per l'italiano preferisco verifiche orali individuali e scritte con domande aperte, di analisi di un testo, di riflessione o collegamento fra diversi argomenti. Le prove strutturate e a scelta multipla le affiancano per ottenere una immediata informazione delle conoscenze, ma non permette la riflessione critica personale (la "misurabilità annienta la "personalità").
Ritengo le verifiche orali in gruppo siano preferibili a quelle individuali per abbassare il livello di tensione e per favorire integrazione e scambio di idee. In esse, inoltre, il docente (a differenza dei compiti a casa e della discussione di un progetto) può "sondare" meglio una più ampia serie di competenze e abilità da parte degli alunni e capire meglio lacune e difficoltà. Le materie umanistiche, inoltre, non si prestano, per loro natura, a verifiche a risposta multipla.
Scelta delle forme di verifica
In generale preferisco prove di verifica individuali perché sono le uniche da cui si può ricavare l'idea più vicina alla reale preparazione dello studente. In quelle di gruppo si può sempre nascondere l'insidia del " furbo "che si appoggia agli altri.
Scelta delle forme di verifica
Il test a risposta multipla mi risulta utile soprattutto per la storia, in quanto ritengo necessario che i ragazzi abbiano delle coordinate precise sulle quali orientarsi. Per quanto riguarda l'italiano scritto preferisco che i ragazzi abbiano dei supporti (testi, articoli) sui quali lavorare anche perché spesso il classico tema si riduce ad una mera copiatura. Un discorso simile vale per l'orale: la letteratura deve a mio giudizio partire da un testo e quindi perché no un interrogazione?!
Scelta delle forme di verifica
Stimolo/strumentoInterferenze connesse alla rilevazione o alle procedure
valutative
Docente/valutatoreDisparità di chi valuta legate a tratti
comportamentali e aspettative
SituazioneInterpretazioni parziali o
forzate connesse al contesto
1) Contiguità (prossimità) domande
2) Successione/ contrasto
3) Contiguità prove
4)Tempi e modalità di correzione
5) Indulgenza/ severità6) Pigmalione
(aspettative)7) Pregiudizio8) Stereotipia9) Alone10) Distribuzione forzata
dei risultati
11) Contraccolpo12) Maturazione13) Competenza14) Interferenza
del contesto15) Contagio
Alcune distorsioni
Livelli del sistema: valutazione interna/esterna
Esterna (Invalsi)n Di sistema, riferita alla
produttività scolastica (efficacia ed efficienza, qualità e standard dei servizi) e degli apprendimenti medi
Interna (Scuola)n Autovalutazione istituto
(progettazione didattica, qualità degli insegnamenti, soddisfazione studenti e famiglie)
n Valutazione alunni (diagnostica, formativa e sommativa) dei docenti
GISCEL Gruppo di Intervento e Studio nel Campo dell’Educazione Linguistica costituito nell’ambito della Società di Linguistica Italiana
Sull’impiego delle Prove INVALSI
d) Per valutare l’operato di una scuola non sarebbero certo sufficienti test di italiano e matematica, ma si dovrebbero estendere le prove a tutte le materie insegnate (o almeno alla maggior parte di esse).
e) Anche le prove attuali di italiano e matematica sarebbero insufficienti. Per l’italiano, ad esempio, si misurano oggi competenze relative alla riflessione sulla lingua e alle competenze di lettura e comprensione; sarebbe indispensabile allargare il campo almeno alle competenze di scrittura, di ascolto e di parlato, settori per i quali – per vari motivi - non si dispone al momento di strumenti utili per testing a largo raggio.
10. Ancora più delicato è il ruolo che possono assumere le prove di grammatica, un campo in cui regna tuttora l’incertezza su contenuti, obiettivi, progressione, e i programmi o le indicazioni curricolari sono di conseguenza vaghi. In questa situazione alle prove di grammatica si può richiedere:
- di proporre il riconoscimento di categorie in contesto;- di porre, per quanto possibile, reali problemi da risolvere col ragionamento e non domande a cui si possa rispondere mnemonicamente o meccanicamente; - di limitare la verifica a un repertorio di categorie, termini e concetti che sia il minimo indispensabile a ogni livello scolare; su questo minimo si dovrebbe aprire un ampio dibattito tra insegnanti ed esperti;- di porre molta attenzione alla terminologia, che dovrebbe essere essenziale e condivisa; ove necessario, si potrebbe fare ricorso a parafrasi esplicative; - di contenere per quanto possibile questo repertorio minimo su un terreno di acquisizioni condivise, senza rispecchiare ipotesi teoriche di specifiche scuole di pensiero, in modo da non bloccare lo sviluppo delle ipotesi e delle esperienze;- di evitare di trattare in termini di verità/falsità questioni che sono suscettibili di controversia; la grammatica non deve essere vista come un catalogo di verità dogmatiche ma come un campo aperto alla discussione e alla ricerca. Anche in questo punto si tocca un aspetto essenziale di un’educazione scientifica e democratica.
Per un documento GISCEL sulla valutazione di sistema
Quale italiano?
http://www.compita.it/chi-siamo/il-progetto/
http://www.indicazioninazionali.it/J/
Reading LiteracyOCSE PISA: «la capacità di comprendere e utilizzare testi scritti, di riflettere su di essi e di engaging with testi scritti, al fine di raggiungere i propri obiettivi, sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità e svolgere un ruolo attivo nella società».
documenti ministeriali relativi ai diversi indirizzi della scuola secondaria di II grado 1. Indicazioni nazionali per i Licei2. Linee guida per gli Istituti tecnici3. Linee guida per gli Istituti
professionali
Il 4° Seminario nazionale a Rovereto -21 e 22 maggio 2015 sul tema "L'Italiano e le altre al tempo del plurilinguismo”:
Il Seminario è strutturato in alcune relazioni di approfondimento e otto laboratori centrati sui seguenti temi:1.L’italiano neostandard tra oralità e scrittura (italiano neostandard e italiano scolastico; le regole dell’oralità, il parlato scritto, le regole della scrittura)2.Le opportunità offerte dalle tecnologie digitali nello sviluppo delle competenze linguistiche(i programmi per comprendere, correggere e scrivere testi; la scrittura collaborativa in rete; la lingua multimediale: cinema, fiction, parole in musica per apprendere la lingua; gli ipertesti)3.Studiare le discipline in italiano: leggere, comprendere, scrivere testi espositivi e argomentativi (le caratteristiche dei testi scolastici delle varie discipline; l’uso didattico dei testi di studio; la didattica specifica per la comprensione e la produzione di testi espositivi e argomentativi)4.La lingua per l’esercizio della cittadinanza (lo spazio a scuola per imparare a leggere indicazioni, istruzioni, documenti, leggi; i testi rigidi - vincolanti come luogo di potenziamento della competenza di comprensione dei testi; l’uso responsabile della lingua in ambienti digitali)5.Il plurilinguismo: le lingue minoritarie (obiettivi, metodologie, pratiche efficaci per l’insegnamento/apprendimento delle lingue minoritarie)6.Il plurilinguismo: l’italiano come lingua 2 (la lingua d’uso e la lingua scolastica; la grammatica per i madrelingua italiani e per i non madrelingua; quale letteratura per gli studenti stranieri?)7.Verticalità e trasversalità nello sviluppo delle competenze linguistiche (il curricolo integrato di italiano e lingue straniere; la gradualità degli apprendimenti linguistici dall’infanzia alla fine del 1° ciclo; oralità e scrittura tra italiano e lingue straniere)8.Valutare e certificare le competenze linguistiche in lingua 1 e lingua 2 (modelli e strumenti per verificare, valutare e certificare le competenze linguistiche; oggetti specifici e oggetti comuni nella valutazione delle competenze linguistiche tra lingua italiana e lingue straniere; osservare e valutare processi e risultati nello sviluppo delle competenze linguistiche).
“Comunicazione nella lingua madre”: una competenza chiave
Il testo della Raccomandazione Europea: la comunicazione nella madrelingua indica la capacitàdi esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia oraleche scritta, e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico inun’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vitadomestica e tempo libero.
Le conoscenze, le abilità e le attitudini essenziali legate a tale competenza sono:n La competenza comunicativa risulta dall'acquisizione della madrelingua, che è
intrinsecamente connessa con lo sviluppo della capacità cognitiva dell’individuo diinterpretare il mondo e relazionarsi con gli altri.
n La comunicazione nella madrelingua presuppone che una persona sia a conoscenza delvocabolario, della grammatica funzionale e delle funzioni del linguaggio. Ciò comporta unaconoscenza dei principali tipi d’interazione verbale, di una serie di testi letterari e nonletterari, delle principali caratteristiche dei diversi stili e registri del linguaggio nonché dellavariabilità del linguaggio e della comunicazione in contesti diversi.
n Le persone dovrebbero possedere le abilità per comunicare sia oralmente sia per iscritto intutta una serie di situazioni comunicative e per sorvegliare e adattare la propriacomunicazione a seconda di come lo richieda la situazione. Questa competenza comprendeanche l’abilità di distinguere e di utilizzare diversi tipi di testi, di cercare, raccogliere edelaborare informazioni, di usare sussidi e di formulare ed esprimere le argomentazioni inmodo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto.
n Un atteggiamento positivo nei confronti della comunicazione nella madrelingua comporta ladisponibilità ad un dialogo critico e costruttivo, la consapevolezza delle qualità estetiche e lavolontà di perseguirle nonché un interesse ad interagire con gli altri. Ciò comporta laconsapevolezza dell'impatto della lingua sugli altri e la necessità di capire e usare la linguain modo positivo e socialmente responsabile.
Reading Literacyè definita da OCSE PISA come «la capacità di comprendere e utilizzare testi scritti,di riflettere su di essi e di engaging with testi scritti, al fine di raggiungere i propriobiettivi, sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità e svolgere un ruolo attivonella società».
http://www.invalsi.it/invalsi/ri/pisa2009.php?page=pisa2009_it_01b.
10 competenze base per il docente
n predisposizione di piani valutativi di classe: dalla raccolta delle informazioni necessarie alla valutazione individuale all’impiego di procedure standardizzate (dal portfolio al test);
n utilizzazione flessibile di strumenti di verifica secondo le diverse funzioni della valutazione (regola aurea della docimologia: la verifica giusta per ogni finalità valutativa);
n conoscenza e applicazione delle principali tecniche di costruzione di test strutturati;
10 competenze base per il docente
n costruzione e sperimentazione di strumenti alternativi al testing (istruzioni, procedure semi-strutturate, setting valutativi)
n riferimento a standard nazionali/ internazionali e utilizzazione dei principali descrittori statistici per l’analisi dei risultati (analisi statistica con indicatori di confronto);
n analisi della validità degli strumenti di verifica costruiti/utilizzati (analisi dei contenuti e dei formati) e della loro affidabilità (item analysis e accordo nei giudizi valutativi);
10 competenze base per il docente
n partecipazione nell’allestimento di banche dati per le procedure valutative (quesiti strutturati, casi significativi, descrizione di procedure, esemplificazioni di analisi, ecc)
n misurazione di tratti attraverso l’attribuzione di punteggi (voti), formulazione di giudizi (valutazioni analitiche e sintetiche)
n restituzione e comunicazione dei risultati in forme individualizzate e pubbliche (valutazione e comunicazione)
n riflessione sulla problematicità della valutazione (mettere i voti o esprimere giudizi a scuola), in termini di “equità” (valutazione e dispersione scolastica).
Competenze per la valutazione
partecipazione all’allestimento di banche dati
valutazione e dispersione scolastica
allestimento di setting valutativi e procedure semi-strutturate
valutazione e comunicazione
item analysis e accordo nei giudizi valutativi
costruzione di test uso flessibile e funzionale della strumentazione valutativa
statistiche con indicatori di confronto
valutazioni analitiche e sintetiche
predisposizione di piani valutativi di classe
Analisi risultatiCostruzione/ utilizzazione di
strumentazioni e procedure
Ideazione/ progettazione
Piste per una valutazione partecipata e collegiale
- Costruire prove comuni- Correggere con criteri concordati
Pro.V.A.Progetto ValutazioneProgetto Valutazione
GUIDAGUIDA RAPIDARAPIDA
a) progettare prove di Verifica del/per l’Apprendimento; b) approfondire metodologie e tecniche attraverso la condivisione di indicazioni e materiali sulla valutazione scolastica; c) dialogare su tematiche valutative nell’ottica di una maggiore condivisione con i colleghi ma anche con gli studenti; d) collaborare nella costruzione di item di valutazione, valorizzando i contributi dei gruppo; e) produrre le prove comuni via web.
www.progettovalutazione.org
PRO.V.A.
Esperienza &
Collaborazione
L EL E F I N A L I T A ’F I N A L I T A ’ D E LD E L P R O G E T T OP R O G E T T O
1
2
PRO.V.A. È una piattaforma per la progettazione di prove di verifica degli apprendimenti di matrice costruttivista e learning 2.0Propone ai docenti un ambiente di apprendimento e sperimentazione pratica basato su:• Pluralità di formati e supporto metodologico• Modalità collaborative
L’applicativo PRO.V.A. (PROgettare PROve di Verifica del/per l’Apprendimento) è stato ideato all’interno di un portale interamente dedicato alla fruizione di risorse per la Valutazione Scolastica(www.progettovalutazione.org)
Accesso alla piattaforma PRO.V.A.Per entrare a far parte del progetto valutazione è sufficiente registrarsi.
Digitate www.progettovalutazione.org e quindi seguite la procedura di registrazione facendo clic su Registrati.
Saranno sufficienti poche informazioni di base, in particolare un indirizzo di email che servirà come conferma dell’avvenuta registrazione.
Una volta registrati occorre tornare nuovamente alla pagina principale, digitare email e password negli appositi campi e fare clic su entra.
NB: SE SI POSSIEDE UN CODICE DI ACCESSO, OCCORRE INSERIRLO IN FASE DI REGISTRAZIONE. IL CODICE CONSENTE DI FAR PARTE DI UN GRUPPO CHIUSO.
La Home Page
Ciascun Utente accede alla sua pagina personale dove può:•Creare una nuova prova di verifica dell’apprendimento•Sviluppare una prova già impostata•Collaborare alla realizzazione di una Prova avviata da un altro utente•E ancora•Stampare una prova realizzata per somministrarla in classe•Generare un file excel per la correzione della prova.
Queste funzioni sono accessibili facendo clic sui pulsanti.
Impostare una nuova Prova
Facendo Clic su Crea Prova appare la maschera di impostazione della Prova di valutazione.
È necessario compilare i vari campi, scorrendo fino in fondo alla pagina quindi fare clic sul pulsante (1):
“Salva le impostazioni della Prova”
Dopo aver fatto clic il sistema invia un messaggio di conferma e invita l’utente a compilare il primo Item (2).
1
2
La tipologia di formati valutativi presenti in PRO.V.A. si articola in:1. Quesiti a selezione della risposta e a correzione “oggettiva”1.1, Completamento semplice o multiplo (testuale/cloze)1.2, Corrispondenza o Abbinamento 1.3, Ordinamento o Graduatoria1.4, Risposta singola (univoca)1.5, Risposta multipla1.6, Scelta Multipla1.7, Vero/falso (biunivoca)2. Quesiti a costruzione della risposta e a correzione “criteriale” 2.1, Scala valutativa (per risposte aperte e prove di scrittura)2.2, Rubrica valutativa (per valutazione di competenze o per livelli di padronanza)
L’utente può ora creare il primo Item.
Il primo passo consiste nella selezione del tipo di Item da creare.
Facendo Clic su quello scelto (3) si apre la maschera di compilazione.
Scrivere il primo Item
17/03/2018 42
Valutare la produzione scritta
IEA-IPS 1980-1985
Un’esperienza di condivisione di criteri per la correzione
Processi cognitivi
Riprodurre Organizzare-Riorganizzare Inventare-Produrre
Contenuti
Funzione comunicativa prevalente
Destinatario Fatti-Idee Eventi Cose, fatti, idee, stati d’animo Idee, stati d’animo, nuove realtà
Apprendere Se stesso Copiare, scrivere sotto dettatura
Riscrivere una storia letta o ascoltataProva 3: ristesura di una storia
Prendere appunti, riassumere, fare un sommario, parafrasareProva 2: riassunto
Commentare a margine un testo, metafore, analogie
Esprimere Se stesso, altri Descrivere stati d’animoProva 4a:
Scrivere una storia personale, tenere un diario, scrivere una lettera personaleProva 5: Composizione narrativa
Scritti riflessivi, saggi a carattere personaleProva 7: Comp. riflessivaProva 8: Comp. libera
Informare Altri Citare, compilare un modulo, scrivere un avvisoProva 1a: lettera con descrizione di una biciclettaProva 1b: lettera con descrizione di se stesso
Resoconti, notizie, istruzioni, telegrammi, avvisi circolari, messaggi, riassuntiProva 1c: biglietto ai familiariProva 1d: biglietto di giustificazioneProva 2: riassunto
Direttive, descrizioni tecniche, biografie, rapporti scientifici, resoconti di esperimentiProva 4b: Descrizione di un procedimento
Scritti espositivi, definizioni, saggi e articoli, presentazione di libri, commenti
Convincere Altri Citare da autorità o esperti
Scrivere lettere commercialiProva 1e: domanda di impiego
Annunci pubblicitari, volantini, testimonianze di opinioni e di punti di vista personaliProva 9: lettera di consigli
Scritti persuas., editoriali, saggi e articoliProva 6: Comp. persuasiva
Intrattenere Altri Citare poesie o prose Scrivere storie partendo dal finale, scrivere finali di storie, rielaborare storieProva 5:
Definire una parola Scritti poetici, parodie, versi, testi teatrali
Modello dell’area dello scrivere scolastico
Griglia di valutazione utilizzata nell’Indagine IEA-IPS
n VG – Valutazione Globale
ÿ VA – Aspetti della valutazione analiticaÿ A. Qualità del contenutoÿ B. Organizzazione e presentazione del contenuto
ÿ C. Stile e adeguatezza del registroÿ D. Grammaticaÿ E. Lessicoÿ F. Ortografiaÿ G. Impaginazioneÿ H. Calligrafiaÿ I. Reazioni del valutatore
Divergenze nella valutazione della stesso elaborato40 insegnanti/correttori
1
7
17
11
4
7
17
13
21
uno due tre quattro cinquescala di valutazione
0
5
10
15
20
% c
orre
ttori
Valutazione globaleOrtografia
Divergenze nella valutazione
Accordo, consenso e scarto nelle valutazioni di più correttori
Forme di divergenze nella valutazioneconfronto tra indagini
accordo53,5%
consenso29,8%
scarto16,7%
accordo54,5%
consenso39,7%
scarto5,8%
Accordo= stesso valoreConsenso= scarto su due valori (una direzione)Scarto= scarto su più valori (più direzioni)
Indagine IEA-IPS Indagine CARSFI-FNISM
Prove “Descrizione di procedimento”: istruzioni, criteri per la valutazione e
elaborati modello
n Istruzioni per lo studenten Hai un amico straniero ospite a casa tua. Domani
mattina devi uscire presto. Lasciagli un biglietto nel quale spieghi come fare un buon caffè. Non occorre che fai disegni perché hai lasciato la macchinetta moka smontata sul tavolo di cucina, con vicino la scatola del caffè.
n La tua prova verrà valutata in base alla chiarezza e alla precisione con cui descrivi il procedimento.
n Se vuoi correggere qualcosa puoi farlo, ma non devi ricopiare tutta la prova e non puoi usare il correttore (bianchetto).
n Hai 20 minuti di tempo per completare la prova.
Descrizione di un procedimentoIstruzioni per la valutazione
Valutazione globale
n Le istruzioni richiedono allo studente di scrivere:a) un biglietto;b) ad un amico straniero (inesperto);c) per spiegare;d) come fare un buon caffè con la macchina moka.
Si tratta quindi di un messaggio informale ad un destinatario conosciuto per descrivere un procedimento.
n L’amico dovrebbe essere in grado di fare un buon caffè dopo la lettura del biglietto, per cui ci si può porre nei suoi panni e valutare la descrizione anche in base al risultato ottenibile.
n Per le istruzioni generali vedi manuale IEA-IPS.
Valutazione analitica: Qualità del contenutoVerificare se sono state identificate le diverse fasi del procedimento indicate nello schema seguente
Fasi Informazioni accessorie1 Mettere l’acqua nella base della
macchinetta fino ad un determinato punto (valvola, filtro, etc.).
Acqua fredda o calda.
2 Mettere il filtro nella base.3 Mettere il caffè nel filtro. Caffè premuto o no;
quantità di caffè.4 Avvitare/fissare la parte superiore sulla
base.5 Mettere sul fuoco la macchinetta. Fiamma alta o bassa;
coperchio chiuso o aperto (con paraspruzzi).
6 Spegnere il fuoco/togliere la macchinetta dal fuoco quando è uscito tutto il caffè.
Guardare o aspettare il gorgoglio.
Non sono penalizzabili ulteriori indicazioni, purché non in contrasto con le istruzioni di base. La totalemancanza di una o più fasi impedisce di superare il punteggio di 2. In presenza di tutte le indicazioni, ilpunteggio va assegnato anche in relazione alla qualità del prodotto finale (un buon caffè).
Altri criteri
n Organizzazione e presentazione del contenutoVerificate se nella descrizione lo studente ha presentato le diverse fasi
ordinandole tra loro in modo conseguente utilizzando indicatori si sequenza (vedi schema precedente, ricordando che le fasi 2 e 3 sono invertibili fra loro).
n Stile e adeguatezza del registroSi può spiegare come seguire il procedimento in vari modi, sia nella forma di
messaggio informativo, sia nella forma di elenco di istruzioni (testo regolativo).
Verificate se è stato scelto e mantenuto un registro adeguato al tipo di testo scelto. Verificate inoltre l’adeguatezza delle scelte lessicali in relazione al contesto (persona inesperta, presenza visibile dei pezzi necessari).
Controllate inoltre la coerenza delle strutture sintattiche ( è da penalizzare l’alternanza di diversi modi verbali nella sequenza delle istruzioni).
Le prove migliori dovrebbero presentare anche dei riferimenti personali in relazione al destinatario (intestazioni, saluti/auguri finali, battute, etc.).