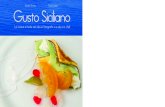Ubaldini Siciliano
-
Upload
cristina-ubaldini -
Category
Documents
-
view
12 -
download
1
description
Transcript of Ubaldini Siciliano

SINCRONIE
Rivista semestrale di letterature, teatro e sistemi di pensiero
Anno X, fascicolo 19, gennaio-giugno 2006
VECCHIARELLI EDITORE

SINCRONIE Rivista semestrale di letterature, teatro e sistemi di pensiero pubblicata con il contributo dell’Università di Roma “Tor Vergata”
Direttore: Andrea Gareffi Comitato scientifico: Michael Caesar (Birmingham), Giorgio Cerboni Baiardi (Urbino), Arnaldo Bruni (Firenze), Paolo Cherchi (Chicago), Eugenio Coseriu † (Tübingen), José Lambert (Leuven), Paul Larivaille (Parigi), Michel Lassithiotakis (Parigi), Marco Lucchesi (Rio de Janeiro), Nicholas Mann (Londra), Jean-Jacques Marchand (Losanna), Ulla Musarra-Schroeder (Nijmegen), Giuseppe Mazzotta (Yale), Nikolaos M. Panajotakis † (Venezia), Walter Puchner (Atene), Francisco Rico (Barcellona), Ulrich Schulz-Buschhaus (Graz), Gianni Venturi (Firenze), Alfred Vincent (Sidney), Diego Zancani (Oxford), Gerasimos G. Zoras (Atene). Redattori: Nello Avella, Edo Bellingeri, Patrizio Barbaro †, Claudia Chierichini, Giuseppe Frangi, Loretta Frattale, Heather Gardner, Cristiana Lardo, Annamaria Laserra, Tommaso Livoli, Raffaele Manica, Roberto Mosena, R. Nicola Papa Caminiti, Fabio Pierangeli, Maria Caterina Poznanski, Lucia Rodler, Roberta Rossini, Emiliano Sbaraglia, Varo Augusto Vecchiarelli. Segreteria di redazione: Cristina Ubaldini (responsabile), Simona Casciano, Simona De Luca, Francesca Magni, Ilaria Merlini, Tiziana Migliaccio, Fabrizio Patriarca.
Redazione: Laboratorio di Scrittura e Lettura della Facoltà di Lettere e Filosofia Università di Roma “Tor Vergata”, via Columbia, 1 - 00133 Roma E-mail: [email protected] Amministrazione: Vecchiarelli Editore, Piazza dell’Olmo, 27 - 00066 Manziana 06/99.67.42.20 (tel.) 06/99.67.45.91 (fax) E-Mail: [email protected] www.vecchiarellieditore.com Copyright © 2002 Vecchiarelli Editore
Condizioni di abbonamento (due numeri annui): Italia C 31 Estero C 42. Numeri singoli e arretrati C 20,65
Pagamento: tramite c.c. postale 17025008; c.c bancario 60619 CARIVIT Agenzia di Manziana ABI 6065 CAB 39170

INDICE INEDITI LETTERE DI GOVONI, ZAVATTINI, SPAGNOLETTI, MANZINI, SICILIANO A GIUSEPPE MAROTTA a cura di Cristiana Lardo Milano (e Napoli), da lontano p. 13 Lettere p. 17 IL VERO E IL VERISIMILE. VITA E ROMANZO NEL NOVECENTO a cura di Cristiana Lardo Introduzione p. 27 Maria e Giovanni Pascoli fra storia e poesia di Francesca Florimbii p. 33 L’inabilità alla vita di una donna del Seicento. Artemisia Gentileschi di Francesca Magni p. 41 Alberto Savinio, Narrate, uomini, la vostra storia di Susanna Bisi p. 49 Alberto Savinio: la biografia come una conversazione di Antonella Usai p. 63 Vita di Goethe di I. A. Chiusano di Emiliano Sbaraglia p. 75 Pasolini e le altre “vite” di Enzo Siciliano di Cristina Ubaldini p. 81 «Memoria non è peccato finché giova». Vita di Giovanni Comisso di Nico Naldini di Fabio Grossi p. 91

Il romanzo di una vita. Il maestro di Regalpetra di Matteo Collura di Gianni Zambito p. 99 La chiaroveggenza del già vissuto. Melania G. Mazzucco, Lei così amata di Tiziana Migliaccio p. 111 Tra giallo, noir, epica e dramma: l’unicità di Romanzo criminale di Alice Di Stefano p. 121 TESTIMONIANZE Conversazione con Vincenzo Consolo a cura di Domenico Calcaterra p. 141 STUDI Una zuppa dantesca: lettura di Purg. XXXIII, 34-36 di Simone Cacurri p. 173 La tecnica dell’allusione nelle poesie di Andrew Marvell di Eleonora Persichetti p. 181 Napoleon as celebrated in the words of poets di Jacques Misan-Montefiore p. 189 Scipio Slataper: percorsi di un intellettuale di frontiera di Paola Cosentino p. 199 A Caporetto: taccuini italiani di Raffaele Manica p. 219 Attraversare lo schermo tra pagina e film di Eusebio Ciccotti p. 239 RUBRICHE Nota filologica: Per una probabile ricostruzione estetica: le unghie di Laura di Ilaria Merlini p. 263

Nota antiquaria: Le utopie negative di Joseph Hall e di Eustache Le Noble di Marco Catucci p. 271 Nota bibliografica: Prospettive pavesiane di Adriano Bussone p. 279 Nota a margine: «Teatro del mito, teatro della parola, teatro della poesia»: la sfida di Giuseppe Conte di Irene Baccarini p. 283 Toasts & Ramblers: Viaggiando con Leopardi: Lucio Felici di Fabio Pierangeli p. 289 Il rosario nelle mani di Vanni Soave di Cristina Ubaldini p. 292 RECENSIONI Francesco Biamonti: le parole, il silenzio, Atti del Convegno di San Biagio della Cima-Bordighera, 16-18 ottobre 2003, Genova, Il Melangolo, 2005 (Marco Debenedetti) p. 299 Luigi Fontanella, Azul, Milano, Archinto, 2006 (Fabio Pierangeli) p. 300 Georg Lakoff, Non pensare all’elefante, Roma, Fusi Orari, 2006 (Maria Squarcione) p. 301 Daniele Maria Pegorari (a cura di), Non disertando la lotta. Versi e prose civili di Mario Luzi, Palomar, Bari 2006 (Francesco Medici) p. 302 Aurelio Picca, Via Volta della morte, Milano, Rizzoli, 2006 (Melania Tarquini) p. 304

Cristina Ubaldini PASOLINI E LE ALTRE “VITE” DI ENZO SICILIANO
Avevo un amico poeta. Amava scrivere versi di-sponendoli in forma di rosa. Fu ucciso di notte in una vigna. Enzo Siciliano, La principessa e l’antiquario
Si scrive una biografia apparentemente per molte ragioni: certo per arricchire le
conoscenze intorno ad un autore o per offrire un quadro “storico” alle sue opere, ma probabilmente l’unico vero desiderio che muove ad un tale lavoro è quello di entrare in contatto in qualche modo con tutto ciò che sta dietro l’opera e non rie-sce a raggiungerci, maggiormente, forse, con la vita dell’uomo o della donna che l’hanno creata.
La tentazione più pericolosa nella quale può indurre la composizione di una biografia è proprio quella della appropriazione; chi narra la storia di un uomo sente subito il brivido del potere, la vertigine del dominio sul quel destino. Molto gioca in tutto ciò l’immedesimazione. Quell’io narrante che non può creare nulla, che deve “limitarsi” a dar conto di fatti già decisi e svolti e conclusi, si proietta nella materia narrata, se ne nutre a tal punto che i confini rischiano di sciogliersi e le i-dentità del biografo e del biografato di confondersi. La narrazione in questo caso porta con sé il rischio terribile di farsi deformazione, di sconfinare nella mistifica-zione. Non è infrequente che la vita raccontata venga usata come pretesto per una autobiografia o come manifesto di una ideologia. Così, è nella narrazione stessa che si devono trovare i rimedi, le difese, contro tali derive.
Ma forse è il caso di chiarire un po’ meglio i termini del problema biografia e della biografia letteraria più nello specifico. Le parole di Stefano Jacomuzzi mi sembrano le più adatte ad illustrarne l’ambiguità e la complessità, senza risolversi in un reciso giudizio:
Bisogna sapersi rassegnare: la biografia è una raccolta più o meno giudiziosa di frammenti collocati nell’illusione di una unità che la stessa loro quantità, lo stesso loro allineamento nel tempo sembra del tutto autorizzare, garanten-doci la validità dell’interpretazione. Sembra volersi porre a mezz’aria: tra l’arbitrarietà dell’invenzione e l’oggettività della documentazione e contami-na (si contamina) l’una e l’altra, perché l’una è percorsa dalla sua ansia di

Cristina Ubaldini
82
umane realtà e l’altra se ne giova per trovare chiavi e molle ed evitare le sec-che di un inaccettabile ma inevitabile determinismo.1
I due opposti modelli possono essere considerati la cosiddetta biografia “scien-
tifica” (banalizzando, potremmo dire “alla Strachey”2), in cui si offrono solo alcuni selezionati omogenei dati della vita di un uomo, e la biografia “romanzata” (“alla Maurois”3), che insegue un’essenza, che cerca di coagularsi in una immagine: niente di più lontano e incomparabile. Insomma, la biografia letteraria non è un genere letterario; è comunemente riconosciuto una forma spuria4. È una delle tante ibrida-zioni possibili che oscillano continuamente tra il vero e il verisimile: biografie “sto-riche”, biografie romanzate, biografie immaginarie, romanzi in forma di biogra-fie… certo è che questo suo essere sempre qualcosa che rimanda ad altro rischia di farla diventare una maschera o un’illusione. Solo quando riesce a eludere tutte le trappole del “genere” la biografia letteraria si realizza pienamente come tale. In quanto genere proteiforme, la sua forma non può che essere la sua sostanza; le biografie standardizzate, quelle che pretendono di dar conto sempre delle stesse cose, secondo un modello generale (nascita, età della vita, rapporti interpersonali, opere, contesto storico, etc.) sono un’aberrazione; non esiste, non può esistere uno schema da applicare meccanicamente e secondo il quale condurre la ricostruzione di una vita (quello cronologico, ad esempio, che apparirebbe intuitivamente “natu-rale”, si rivela a volte una trappola deterministica). In assenza di una forma preor-dinata non si ha altro che il vuoto e non si può fare altro che sperare di evocare una qualche verità da questo vuoto. In ogni caso fondamentale mi sembra la con-siderazione di Massimo Grillandi nel suo intervento pubblicato su «Sigma»5,
un buon biografo deve avere la serietà di ricerca e la preparazione dello sto-rico, la potenza espressiva del narratore, le finezze dello scrittore e del lette-rato, l’acume e la prontezza del giornalista, la sensibilità e l’emotività del poe-ta.
Sembrano parole scritte espressamente per Enzo Siciliano. Siciliano si è cimen-
tato in tutte le diverse dimensioni che la biografia contempla: il saggio biografico (Puccini), la biografia romanzata (Il risveglio della bionda sirena. Raphaël e Mafai. Storia di un amore coniugale, dedicato alla coppia di artisti Mario Mafai e Antoinette Raphaël),
1 S. Jacomuzzi, La Storia e le storie: elogio dell’aneddoto, in Vendere le vite. La biografia letteraria, numero monografico di «Sigma», XVII, 1984, p. 87. 2 Il suo capolavoro sono considerate la quattro biografie del cardinale H. E. Manning, di F. Nightingale, di Th. Arnold e del generale Ch. Gordon raccolte in Eminent Victorians (1918), cui è seguita Queen Victoria nel 1921. 3 André Maurois è considerato il creatore del genere biografia romanzata, in cui si mescola-no erudizione e fantasticheria; prima fra tutte, pubblicata nel 1921, quella dedicata a Shel-ley, Ariel ou la vie de Shelley. 4 Si leggano i numerosi interventi raccolti nell’appena citato Vendere le vite. La biografia lettera-ria. 5 M. Grillandi, In difesa del romanzo biografico, in Vendere le vite. La biografia letteraria, cit., p. 6.

Pasolini e le altre “vite” di Siciliano
83
la messa in scena a metà tra il fantasioso e il documentario di un fatto storico (Mor-te di Galeazzo Ciano), l’evocazione-finzione di una “vita d’artista”, quella di Mozart, in chiave sentimentale (I bei momenti), e poi la coppia di scritti dedicati a Pasolini (Vita di Pasolini e il suo rovescio, Campo de’ Fiori). Vero e verisimile si sposano in queste opere in tutte le possibili variazioni di grado: possiamo considerarle come elementi di un unico quadro, ciascuno dei quali declinante a modo proprio il titolo di questa sezione.
Con Puccini6 Siciliano realizza, come lo definisce l’autore stesso, un «saggio bio-grafico». La fonte privilegiata sono ovviamente i carteggi e la struttura è quella “tradizionale” in cui si delinea la vita del musicista attraverso periodizzazioni nelle quali si situa la composizione delle opere. Ma il tono non è mai scontato, la parte-cipazione dell’autore è sempre viva e vivace; la voce narrante è quella di un appas-sionato intenditore che non si limita a ricostruire freddamente i fatti, anzi, entra nelle discussioni critiche con entusiasmo, tratteggia con accenti lirici i personaggi delle opere e tenta di evocare il loro presentarsi all’anima del musicista.
Morte di Galeazzo Ciano7 è invece un tentativo coraggioso e ben riuscito di scan-daglio dell’impossibile. In una pièce teatrale in cui sono ricostruiti con gli occhi dell’immaginazione gli ultimi giorni e le ultime ore di Galeazzo Ciano, quelli priva-tissimi, di cui la Storia ufficiale non potrà mai dar conto, si cerca di rievocare i pen-sieri, i gesti, le parole che nessuno ha potuto ascoltare, ciò di cui nessuno ha potuto essere testimone, se non i protagonisti che non ci sono più. Nell’Introduzione Sici-liano manifesta la «necessità di situare nel cerchio di una memoria espressiva per-sone ed eventi di una tragedia il cui significato è ancora da ricondurre a ragione». Ecco: una «memoria espressiva», forse il bandolo della matassa risiede in questo sintagma: bisogna raccontare superando i limiti della cronaca e salvare dal grigio del passato quel colore che ci parli ancora, in modo verisimile perché veridico. In fondo, nell’arte il verisimile non è se non verità che rimanda alla realtà. Il testo tea-trale è il punto estremo di quella che potremmo definire proprio la “messa in sce-na” della biografia romanzata; in questo caso oltre ai fatti vanno portati in luce le parole pronunciate, i sospiri, i gesti, le espressioni; l’immaginazione dell’autore è tutto, perché il “biografo” deve far vedere e sentire tutto. Qui come nella Vita di Pasolini, e lo vedremo, è la morte il punto di osservazione della vita; può sembrare banale e inevitabile (Alberto Savinio ci ha mostrato come questo sia efficacissimo8), ma non è sempre così; talvolta è la vita stessa ad avere da dire tutto quel che c’è da dire.
Come nel Risveglio della bionda sirena. Raphaël e Mafai. Storia di un amore coniugale9. Di Mafai e Raphaël è raccontata la vita appassionata, l’eccesso di vitalità e de-
terminazione di lei e l’eccesso di eros che dominava lui. Siciliano racconta la loro
6 Collana diretta da Indro Montanelli, Milano, Rizzoli, 1976. 7 Torino, Einaudi, 1998. 8 Cfr. Albero Savinio, Narrate, uomini, la vostra storia, Milano, Adelphi, 1984 e i saggi di S. Bi-si, Albero Savinio, Narrate, uomini, la vostra storia, supra, pp. 49-61 e A. Usai, Alberto Savinio: la biografia come una conversazione, infra, pp. 63-69. 9 Milano, Mondadori, 2004.

Cristina Ubaldini
84
storia d’amore e arte, di passioni e delusioni, di continua costante ricerca (vorrei dire “della felicità”) sulla scia dei carteggi, dei diari e dei racconti delle figlie. In questo caso egli sceglie un ruolo solo apparentemente facile, quello del narratore in qualche modo assente, del quasi redattore di fatti ascoltati. Nel secondo capitolo, a poche pagine dall’inizio, intitolato Parentesi secca - volendo da saltare a piedi pari, Sicilia-no spiega:
Quello che sto scrivendo è un romanzo vero - assai più dal vero di quanto non siano di solito i romanzi, che però, se non fossero dal vero, avrebbero poco del romanzo. Il vero nel romanzo è cosa così aleatoria che naufraga nella fantasia, a cominciare, come diceva Didimo Chierico, dal “cangiamento dei nomi”. Devo dire che non ho cangiato niente. Qui sta il nocciolo della questione. (p. 33).
Qui, per questo «romanzo vero», vale ciò che scrive ancora Siciliano del tratta-
mento delle fonti nella finzione totale del romanzo La principessa e l’antiquario10: «ac-cadeva che le interpunzioni incerte, le virgole mal situate, le maiuscole casuali, mi commuovessero di più che non la sicurezza dello stile», (p. 11).
Come accada è difficile dire, ma succede, talvolta, così:
diedero immediatamente vita, le tre sorelle [Mafai], nella casa di Miriam, a un intreccio di racconti che stanavano la memoria da sotto la cenere spenta. D’improvviso parlavano fra loro, come io non ci fossi - il romanzo comin-ciava a disegnarsi nelle loro parole, in certe risate che trasudavano ricordi. La distanza temporale si faceva immagine. (pp. 36-37).
Il resto è poesia. Nei Bei momenti, romanzo in forma di biografia dedicato a W. A. Mozart, sono
le passioni dell’anima e dei sensi a dominare: pagine di diario, lettere, conversazioni scandagliate come fossero vere, fin nel più profondo della memoria viva, intima; fin nel cuore dei cuori dei protagonisti. Un artista viene descritto e evocato attra-verso i segni indelebili che ha lasciato nelle anime di chi lo ha accompagnato e gli è stato accanto. Eppure in quei ricordi, nel loro riaffiorare alla memoria, si registra una sorta di frattura, la sensazione che questa “biografia a più voci” debba registra-re, come tutte le biografie, l’impossibilità di impossessarsi del suo “oggetto”. Ogni “testimone” racconta la propria versione, incrociandola con le altre, senza poter mai giungere al centro di quell’essenza quasi mistica che è la vita del protaginista.
Un caso a parte costituisce il volume Aberto Moravia. Vita, parole e idee di un ro-manziere11. Si tratta di una biografia in vita, di un ritratto dunque. Scrive Siciliano nella Introduzione
Una prima e incompiuta stesura di questo libro è stata pubblicata nel 1971. Mi aveva sollecitato a scrivere Nico Naldini: doveva risultare un ritratto di
10 Milano, Mondadori, 1998. 11 Milano, Bompiani, 1982.

Pasolini e le altre “vite” di Siciliano
85
Moravia al magnetofono, una biografia ricostruita attraverso una serie di conversazioni che avessero andamento casuale e sfiorassero particolari di vi-ta non troppo conosciuti.
Si tratta dunque di trascrizioni di conversazioni, non un disegno preciso, solo il tentativo di farsi, ancora una volta, testimone, di una vita; nulla di organico, se per organico intendiamo “letterario”, “costruito”, architettato con l’affascinante inten-zione demiurgica del biografo.
Se condividiamo quello che scrive Lionello Sozzi12:
Il biografo è mosso, lo voglia o no, dall’ambizione di far luce sulle oscure vi-cende in cui affonda la radice dei versi, di far vedere come la bellezza delle forme scaturisca dalle sorgenti del quotidiano. Ma la sua è un’impresa dispe-rata, continuamente ritentata, ad ogni pagina, e continuamente frustrata. È come, ad ogni istante, voler far uso di una certa chiave per aprire una serra-tura che non è la sua,
non ci apparirà strano che il biografo si trovi ad essere ora un demiurgo, ora un al-chimista. Forse, come “alchimista delle vite”, Siciliano costituisce in parte una ec-cezione. Ben consapevole di questo senso di frustrazione, egli però, come biografo e non come romanziere, non sembra essere andato in cerca intenzionalmente della propria materia. Il caso, il destino lo hanno voluto spesso testimone diretto e co-protagonista dei fatti raccontati, oppure testimone chiamato, come chiamati furono gli apostoli. Pasolini lo volle fortemente nel suo Vangelo secondo Matteo, lo disse: «devi essere Simone». Era un segno, la vita lo avrebbe chiamato ancora e ancora a questo lavoro di testimonianza.
Nella Vita di Pasolini il lavoro di biografo ha molto a che vedere col concetto di vero. Alfieri è la guida. «Sapegno aveva tenuto un corso su Alfieri. Avevo sostenu-to l’esame su Alfieri, ed ero tutto per Alfieri»13,
A vent’anni mi innamorai di Vittorio Alfieri. […] Di sicuro, Alfieri visse nel-lo scrivere la propria Vita altra pietà che non è quella dell’offerta rituale a ciò che è stato. La sua pietà andava ad altro: andava a se stesso, se mai fosse riu-scito a cogliere nell’ordine del proprio vissuto un merito, un sistema di con-tinuità, il concretarsi di un carattere, la scintilla appunto del destino - che poi doveva essere quella del suo stile di poeta, sigillato nel cuore dei propri ver-si.14
Possiamo agilmente rovesciare questa frase ed attribuirla a Enzo Siciliano, che è
stato nella Vita di Pasolini mosso dalla pietà per l’amico, mosso dall’amore per la verità. E nel caso di Pasolini tutto rema contro le migliori intenzioni del meglio in-tenzionato biografo. La sua è stata una vita che si è fusa con l’opera, una esistenza 12 L. Sozzi, Vite di poeti: amore e morte, in Vendere le vite. La biografia letteraria, cit., p. 13 Campo de’ Fiori , Milano, Rizzoli, 1993, p. 66 14 Dalla Lectio Magistralis per la Laurea Honoris Causa ricevuta dall’Università di Roma “Tor Vergata” il 2 marzo 2006, trascrizione pubblicata su «La Repubblica», 3 marzo 2006, p. 55.

Cristina Ubaldini
86
che ha voluto essere mito, un destino macchiato e oltraggiato da una morte brutta e “finta” come un insulto supremo. Scrivere la vita di Pasolini significava restituire a quel destino la sua parte di verità.
Come poteva riuscirci Siciliano? si rimedia all’oltraggio solo con l’eleganza. E qui l’oltraggio è ancor più subdolo di quanto si possa credere; esso si fonda e si au-tolegittima criminosamente con quell’opposto “oltraggio” che Pasolini stesso muoveva al cuore nero del mondo e della Storia. Un oltraggio, quello della sua uc-cisione, che si nasconde, infido, nella mistificazione. Pasolini era stato trasformato in uno stereotipo e doveva essere risarcito di una storia, di una immagine, di una misura che lui per primo, forse, aveva istigato a travalicare. Così, paradossalmente, si dovevano ristabilire le misure, volutamente oltrepassate da tutti, solo col loro ri-spetto. Per raccontare un uomo tanto complesso, una figura così estrema, una voce che ha voluto sempre essere alta (nel volume, nell’intonazione, nel messaggio che portava) ci vuole una voce dimessa, a volte evanescente; la voce del testimone, di colui che conosce e sa, e non ha bisogno né voglia di denunce o di eccessi di liri-smo, ma sente la necessità di narrare senza mai indulgere nel presuntuoso uso dell’io.
Nella Vita di Pasolini il rapporto tra narratore e materia si fa difficile, fragilissi-mo, rischioso quanto mai: per quanto si debba in qualche maniera mettere insieme la “materia”, sempre prima di tutto, bisogna ricostruire il più fedelmente possibile. In questo caso, di romanzato non c’è nulla, neanche quando le informazioni non sono dirette e sono più incerte, vale a dire per i primi anni della vita di Pasolini. Per il resto è stato, piuttosto, necessario ripulire, restituire (restaurare, nel senso più proprio e rispettoso del termine) con la massima cura: tanto, troppo, era già stato detto. Anche questo è “letterario”; il “letterario” (nella unica accezione in cui si possa intendere, e cioè alta e nobile) si contrappone qui al “romanzato” (nell’accezione peggiore possibile di “edulcorato”) come forma di giustizia contro l’ingiuria della distorsione e della mistificazione compiute a più livelli e per le più disparate finalità.
Chi ha ucciso Pasolini e perché? la versione di Pelosi è convincente, è provata e accettabile? proprio di recente la riapertura del processo ha dichiarato che non lo è; troppi particolari non tornano, troppi indizi sono dubbi, troppi aspetti della vicen-da parlano un linguaggio sforzato. Siciliano lo aveva detto subito che quella morte sapeva troppo di finto; l’omicidio di Pasolini era stato messo in scena, “romanza-to” secondo un modello e un personaggio che la stessa vittima aveva ormai offerto di sé; il modo migliore per rendere credibile qualcosa, si sa, è mascherarlo a verisi-mile; ma la verità è altrove. La maschera inflitta a Pasolini è stata utilizzata come strumento di morte: la tesi fondamentale, il pensiero portante di quest’opera è pro-prio quello di far luce su una morte che ha infangato una intera vita e una intera opera. E Siciliano ricostruisce quel fattaccio, quell’omicidio, con la finezza dell’indagatore, la lucidità dell’interprete, la raffinatezza del letterato. Quella morte è stata costruita perché fosse perfettamente coerente con l’immagine stereotipata che il mondo si era creato di Pasolini; era, come nei classici del giallo, troppo per-fettamente pasoliniana per essere credibile. Tanto che anche le parole di una donna

Pasolini e le altre “vite” di Siciliano
87
che ricorda a un anno di distanza di aver sentito Pasolini gridare quella terribile notte Siciliano le commenta così:
Che fosse menzogna, o verità, quella sua testimonianza, non si poteva discu-tere. Erano le parole già trascritte su un copione preparato nel giro di vari mesi, dettato dall’aspirazione ingenua a sentirsi in qualche modo partecipe d’un evento tagliato in grande dalla vita.15
era troppo più grande di quella maschera, troppo più grande era il suo nemico, di quell’ennesimo “riccetto” col quale avrebbe trascorso l’ultima nottata.
Come scrive Massimo Grillandi,
biografare vuol dire scrivere sino in fondo una vita, comprenderla ed amarla, non privilegiarla; ma darla con tutta l’arte e l’umanità di cui siamo capaci […]. Del resto, ogni uomo ha necessità di comprensione e non di compas-sione, di verità vera e non di verità parziale o artefatta. Il resto, che è molto abbondante, lasciamolo, in biografia come nel romanzo, nella penna.16
In questa ricostruzione non ci sono “aneddoti”, ci sono solo documenti e te-
stimonianze. La “vita” di Pasolini viene ripercorsa minuziosamente - le circostanze della morte in primis, poi, più tradizionalmente, dalla nascita alla morte - con estre-ma attenzione; nessuna tentazione “artistica”, nessun autocompiacimento; il lin-guaggio è semplice, lineare; ogni capitolo è una ricostruzione ampia non solo di una esistenza, ma (non potrebbe essere altrimenti) della storia di una società e di una cultura. Il narratore fa un piccolo passo indietro e lascia che i fatti abbiano tut-to lo spazio per manifestarsi nella loro complessità. Tutto quanto può offrire nu-trimento a questi quadri viene impiegato: testi letterari, opere critiche, lettere, inter-viste. Mai pedante, mai freddo o noioso, mai schematico: i fatti sembrano scorrere sotto la sua penna con estrema fluidità; e mai lirico o melodrammatico: una pagina autobiografica di Pasolini17 viene posta all’avvio di questa lunga opera e subito su-perata
Lasciamo adesso la ricreazione fantastica e affettuosa della mitologia familia-re. La sua musica resti come melodia in eco oltre quel che sto per racconta-re.18
La figura di Pasolini viene restitutita della sua umanità e normalità - non è il
profeta, non è la figura Christi, forse non è nemmeno quello che lui stesso sentiva o pativa di essere. Ci vuole coraggio a scrivere in questo modo.
Se il “romanzato” è l’aberrazione che è stata inflitta alla figura di un uomo, la Vita di Pasolini si fa così, per necessità, negazione di un romanzo, sua confutazione.
15 E. Siciliano, Vita di Pasolini, Milano, Mondadori, 2005, p. 8. 16 M. Grillandi, Op. cit., p. 10 17 Tratta da I parlanti, poi inserita in Ragazzi di vita. 18 E. Siciliano, Vita di Pasolini, cit., p. 32.

Cristina Ubaldini
88
Ma il narratore di questa vita non è certo assente; è per buona parte testimone ocu-lare, parte in causa, comparsa e comprimario; un comprimario misurato, attento, discreto, onesto.
Solo per un istante in Appendice, egli si mostra pienamente in luce come diretto interlocutore dello scrittore friulano,
quando lo conobbi era il 1956 […] lo incontrai nella sua casa romana di via Donna Olimpia: mi chiese cosa leggessi, e gli parlai di Ezra Pound. Avevo letto e riletto i Pisan Cantos. […] Ebbe una reazione furiosa: Pound razzista, fascista eccetera. Quel primo incontro fra noi due andò male […],19
ma è solo un modo per introdurre un altro “incontro”, quello che sarebbe avvenu-to tra Pasolini e Pound:
Nelle rughe, nelle sclere del vecchio Pound c’era lo sconvolgimento di un Occidente che si vedeva travolto dalle proprie stesse ragioni di vita, nella propria sapienza conoscitiva. E Pasolini gli stava di fronte: le sue domande specchiavano una medesima disperazione, la stessa apocalisse, lontani en-trambi da qualsiasi connotazione di ideologia e politica, entrambi vivi come esorbitanti poeti fuori norma disobbedienti a qualunque galateo di sanità let-teraria, fiduciosi che la Storia comunque andasse per i propri strani sentieri avanti […],20
e la sua figura torna nell’ombra.
Lo sa che è necessario raggiungere un equilibrio tra i fatti e le opere, tra gli uo-mini e gli scritti e sa anche che non si può mai fare del primo dei due aspetti la cau-sa dell’altro; vita e opera e poi vita che vuole essere opera.
In questo caso non ci si può accontentare di leggere l’opera per quello che è in sé, dato che, evidentemente essa è manifestazione, realizzazione, prefigurazione, specchio, doppio, di una vita21. Perché c’è un ulteriore rischio: che la restituzione si faccia apologia. Un rischio evitato agilmente anche nei momenti più delicati; quelli delle denunce e dei procedimenti penali. Se una vita è un’opera (e come potrebbe non esserlo in questo caso!) su cui si è accanita un’ermeneutica deviante e a cui so-no stati imposti modelli grotteschi, essa si presta, proprio in qualità di opera, ad una interpretazione che le renda giustizia. E qui, forse, potremmo concedere a Sozzi qualcosa, un po’ di più: di frustrazione (tutta relativa all’esito della ricostru-zione biografica, e non al suo autore) ne rimane sempre; perché, poi, togliere e di-struggere la maschera sarebbe la soluzione? rendere giustizia fino in fondo, è ov-vio, non è mai possibile: perché la verità assoluta non concede di essere raggiunta. Pensiamola così, allora: questo libro ha potuto fare molto, ha fatto tutto il possibi-le: si offre al mondo, non solo come tentativo di rendere una certa giusta verità, ma - molto di più! - come pegno di pace.
19 Pasolini: la vita, la poesia, in Ivi, p. 469. 20 Ivi, p. 470. 21 Petrolio è il simbolo di quella vita; e la vita e la morte di Pasolini si legano a quel libro.

Pasolini e le altre “vite” di Siciliano
89
Non resta ora che concludere la nostra piccola rassegna delle “vite” di Siciliano con Campo de’ Fiori, l’altra faccia, il controcanto della Vita di Pasolini, il lato privato; che inizia così: «Nel ricordo, mi sembra stesse facendosi notte». È il pomeriggio del 5 novembre 1975, i funerali di Pasolini.
In questo libro c’è tutta l’umanità di un rapporto di amicizia; le descrizioni sono più partecipate e colorite, lo stile è meno trattenuto. È la storia di un gruppo di a-mici e sodali, la storia di una generazione, di un “tempo”. L’autore, è stato tanto attento a non comparire nella Vita, quanto è presente e partecipe in queste pagine (una vera e propria memoria romanzata). Si gioca su due piani: il viaggio verso Ca-sarsa per un incontro dedicato a Petrolio è occasione di ricordare e rivivere fatti e momenti ormai passati, la geografia di oggi aiuta a ripercorrere le altre geografie di ieri. Qui può finalmente dire “io”:
Era il 1955. Su «Nuovi Argomenti» fu stampato Le ceneri di Gramsci. Lo lessi e me ne innamorai. […] Lo leggevo non sul lato dell’ideologia, ma sul lato del-la passione. La lente di Pasolini mi sembrava tutta rivolta al soggettivo, e tale l’ho sempre considerata. (p. 61)
e mettersi tra i personaggi, tra gli interlocutori del protagonista:
leggerai Petrolio […] La sua volontà aveva il lampo freddo dell’acciaio. Ma, nel suo dire quelle parole, era stato investito dal dolcissimo bagliore d’estasi che gli si accendeva negli occhi quando poteva dirsi soddisfatto senza riserve da qualcosa di suo
e parlare del suo «Pier Paolo»: «Ma Pier Paolo ci insegnava comunque che bisogna-va giocare d’attacco» (p. 38); «“Fare la rivista” con Pier Paolo significava cercare fra le buste di ignoti che arrivavano in redazione (la sede romana della Garzanti) un po’ d’oro perduto o nascosto» (p. 115),
Ma era Pier Paolo il mago - riduceva le persone alla sostanza del loro essere, piegandole con una forza di cui si avvertiva il soffio quando taceva, o se in-vestiva del proprio talento pedagogico quanto veniva dicendo. A quel punto lo si assecondava. (p. 146).
raccontandone la grandezza tutta umana con le parole dell’amico caro.