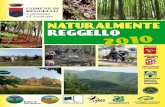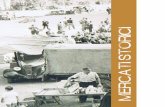toponimi della valdarda - quadernivaltolla.files.wordpress.com · (Purtroppo non mi è stato ancora...
Transcript of toponimi della valdarda - quadernivaltolla.files.wordpress.com · (Purtroppo non mi è stato ancora...

1
Pubblicato dalla rivista “quaderni della valtolla” edita in Vernasca (Piacenza –Italy), anno 2002. Nel caso di riproduzione totale o parziale citare la rivista e l’autore.
TOPONIMI ALTOMEDIOEVALI DELLA VAL D’ARDA1 I “Fines Castro (Firmo) Arquatenses, i “Fines Castellana” e la “Valle” del monastero tollense. Giacomo Coperchini Il professor Vito Fumagalli, nella sua pubblicazione “Un territorio piacentino nel secolo IX: I <<Fines Castellana>>, apparsa nel 19682, ha tentato di identificare i toponimi ivi compresi e di determinare l’estensione di questo territorio giudiziario minore del territorio storicamente piacentino, sulla scorta dei Placiti del Regnum Italiae di Cesare Manaresi, delle Carte più antiche di Sant’Antonino di Piacenza di Ettore Falconi e del Codice Diplomatico Longobardo di Luigi Schiapparelli, oltre che delle edizioni diplomatiche di Umberto Benassi, di Carlo Cipolla, di Pier Maria Campi, di Giovanni Drei e di Girolamo Tiraboschi. Un riesame delle precedenti opere e gli studi compiuti da Giulia Petracco Sicardi sul Castello di Lacore3 e sulle carte private della Cattedrale di Piacenza, edite da Paola Galetti, mi hanno permesso di ottenere una più precisa identificazione e localizzazione di diversi toponimi e di definire meglio l’estensione geografica dei Fines4.
1 Finalmente uno storico della Val d’Arda si è accorto del lavoro, che avevo edito nel 1988, tendente a chiarire con la maggior esattezza possibile, al di là delle assonanze e delle approssimazioni, la toponomastica altomedioevale che fa capo a Castell’Arquato, Lugagnano, Vernasca, Morfasso, Alseno e Fiorenzuola. Sono pertanto debitore al professor Massimo Pallastrelli se posso presentare queste note agli abitanti della Valle dove sono nato. 2 VITO FUMAGALLI: Un territorio piacentino nel secolo IX: I <<Fines Castellana>>, in “Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken”, 48 (1968) pp. 1-35. 3 GIULIA PETRACCO SICARDI: Il castellum ubi Lacore dicitur, in “Archivio Storico per le Province Parmensi”, s. IV, XXII, 1970, pp. 130-136. 4 Paola Galetti, nel suo studio sul territorio piacentino, identifica senza riserve, i Fines Arquatenses e Fines Castellana e riprende, pur senza specificare, alcune mie identificazioni (cfr. PAOLA GATETTI: Una campagna e la sua città – Piacenza e territorio nei secoli VIII-X, ed. Clueb, Bologna, 1994, pp. 93-94). CRISTINA LAMIO e BARBARA SPOTTI, nella loro tesi di laurea di storia medioevale (relatore VITO FUMAGALLI), discusse nell’anno scolastico 1990-91, trattando dei Fines Castellana aggiungono nuovi documenti e nuovi toponimi.. (Purtroppo non mi è stato ancora possibile reperire il testo di tali tesi, nel quale verificare se il

2
Infatti in un precedente intervento, “Quadro ecologico e interpretazione storica del territorio piacentino bobiense”, edito dal Bollettino Storico Piacentino (II, 1988)5, che ha tenuto conto anche delle identificazioni toponomastiche dei beni dell’Abbazia di Tolla, operate da Pierfrancesco Gandolfi6, ho corretto, sia nel testo, sia nelle note, sia nelle cartine allegate, taluni errori basati su assonanze ed omonimie, integrando contemporaneamente le identificazioni di alcuni toponimi “castellani” e “tollensi”, che non avevano trovato riscontro in V. Fumagalli e P. F. Gandolfi. Innanzitutto ho evidenziato che il territorio amministrativo detto, dall’813, Fines Castellana7, si chiamava, in periodo longobardo e nel primo periodo franco, fino all’810, Fines Arquatenses o, in modo più completo, Fines Castro Firmis Arquatenset8 (sic), permanendo nelle carte nonantolane la denominazione di Fines (Piacentina seu) Castro Arquensis9 ancora nell’833, quando nei documenti piacentini era già in uso la nuova locuzione10. A proposito di Castro Firmis si deve rilevare che una carta di donazione alla chiesa di Varzi (Parma, ma diocesi di Piacenza) del 774, è rogata a Castro Fermo11, mentre un’altra dell’801, scritta a Romigliana di Carpaneto Piacentino (Vigo Rimilani quod est Sezade), tratta di un’altra donazione di beni, posti ad Antoniano di Lugagnano, a favore della chiesa di “Sant’Antonino” sido Castro Fermo12. Le professoresse P. Galetti e G. Petracco Sicardi, nel 1978, mostrano qualche dubbio sulla completa identità tra Castro Firmo e Castro Arquatense13, ma ogni incertezza può essere fugata (vedi sotto).
mio precedente lavoro era stato giudicato, dall’Università di Bologna, coerente e di qualche utilità). 5 GIACOMO COPERCHINI: Quadro ecologico e interpretazione storica del territorio piacentino-bobiense, in “Bollettino Storico Piacentino”, Piacenza, 1988. 6 PIERFRANCESCO GANDOLFI: Origine, fortuna e decadenza dell’antica abbazia piacentina di Tolla, Piacenza, 1975. 7 Non so se la “STRADA CASTELLANA”, che da Fiorenzuola si dirige a Castell’Arquato, possa aver dato tale denominazione ai Fines o sia stata così chiamata in tempo successivo. Carmen Artocchini nel suo studio sulla viabilità nel Piacentino, richiamando gli statuti di Castell’Arquato, parla di “una strada verso la croce di San Lorenzo” e di una “strada che da Morignano si dirige a Fiorenzuola”, senza che risulti se era o meno chiamata Castellana. (CARMEN ARTOCCHINI: L’uomo cammina. Sulle vie del piacentino dalla preistoria ad oggi, Piacenza, 1973, p. 38). 8 Locuzione, con imprecisioni ortografiche, che va letta, a mio avviso: Fines Castro Firmo Arquatenses. 9 Certamente la distanza da Nonantola e l’approssimata conoscenza dei toponimi, hanno trasformato Castro Arquatensis in Castro Arquensis, mentre nell’826 i documenti nonantolani parlano di Castro Arcotense (vedi sotto). Nel 990 la località è già indicata Castro Arcuatho. 10 Si veda, GIACOMO COPERCHINI: Quadro ecologico, ..cit. p. 265, nota 37 11 LUIGI SCHIAPPARELLI: Codice Diplomatico Longobardo, doc. 291, pp. 426-427. 12 PAOLA GALETTI e GIULIA PETRACCO SICARDI: Le carte private della Cattedrale di Piacenza, I, (784-848), Parma, 1978, doc. n. 8, pp. 39-41. 13 PAOLA GALETTI e GIULIA PETRACCO SICARDI: Le carte private della Cattedrale, cit. pp. 43, 48, 171.

3
L’essere stato Castro (Fermo o Firmo) Arquatense il denominatore di un vasto territorio, come si rileva dalla desinenza –ense14, indica la notevole importanza che la località aveva già raggiunto in periodo longobardo (certamente anche in precedenza) e permette di stigmatizzare l’inutile perdita di tempo e di credibilità nel ricercare “nobilitazioni” di Castell’Arquato ricorrendo ad uno pseudo-leggendario cavalier Torquato, ad un fantomatico Magno, o a qualche Castro Quadrato (se non anche Alquadro), con tanto di cardo e decumano perpendicolari tra loro e con le altre strade ad angolo retto… su un terreno che tutti possono costatare come notevolmente accidentato. Per quanto attiene a Monastero di Morfasso, una puntuale e critica rilettura dei documenti, mi ha permesso di identificare o almeno localizzare i toponimi15 Cadinario, Adilio, San Cassiano, Catinello, Cucullo, Casale Barbati, Rivarioli, Saliano, Pulplano, Clavenucia, San Donato, Santo Stefano, Solarolo, Persegario, Regiano, Ulmetha, Mocionassi, Corte Regia vicino a Castelnuovo, oltre a confermare quanto già identificato da P. F. Gandolfi. Recentemente, in uno studio, apparso su “Archivum Bobiense”, n. 23, 2001, relativo alle Abbazie di Bobbio e di Mezzano Scotti di Bobbio, dal titolo Le terre di San Colombano: La “Valle in qua situm est Monasterium” ed il Monastero “Sancti Pauli de Mediana”, a p. 237, nota 24, ho collegato, spero in modo coerente, l’origine del Monastero di Tolla con la diaspora di monaci colombaniani avvenuta al tempo di Attala, secondo abate di Bobbio (615-624), del re longobardo Adaloaldo 16 (615-626) e di sua madre Teodolinda (589-626). I TOPONIMI TOLLENSI Come per i Monasteri di Bobbio e Mezzano, nella fondazione di quello di Tolla, le autorità longobarde devono aver ceduto un vasto territorio demaniale17 per costituire la Valle in quo situm est Monasterium. Pertanto tutti i toponimi, riportati nelle donazioni regie o nelle riconferme papali e imperiali, devono essere considerati esterni a tale Valle18. La “primitiva” Valle deve essere stata costituita dalla attuale parrocchia di Monastero con la lunga propaggine verso la Val Chero, civilmente inserita nella parrocchia di Veleia di 14 Si consideri Parm-ense, Lunigian-ense, Laud-ense, Mediolan-ense, Pipi-ense Cremon-ense e il contiguo territorio Aucense. (Non esistevano, come territorio paragonabile ai Fines Arquatense, i Fines Medianense o <Judicari>a medianense, per quanto gli storici ne trattino come di realtà giudiziaria effettivamente esistente poiché la desinenza – ense viene utilizzata per indicare un’estesa proprietà del monastero di Sancti Pauli de Mediana = Mezzano Scotti, contesa dal Monastero Ebobiense proprietà localizzabile in Alta Val Nure). 15 GIACOMO COPERCHINI: Quadro ecologico, .cit., tav. II. 16 Anche Cristoforo Poggiali, pur senza alcuna prova di “monumenti” (documenti) superstiti, pone l’origine di Tolla al tempo di Adaloaldo (CRISTOFORO POGGIALI: Memorie storiche di Piacenza, Tomo II, p. 192). 17 Si tenga presente che già al tempo dei Romani, come risulta dalla Tabula Alimentaria Traianea, nell’area presso Veleia erano presenti beni del demanio imperiale (Imperator noster), come ha evidenziato GIULIA PETRACCO SICARDI. 18 Quando si è formata civilmente, la Valle di Tolla, questa arrivava fino a Groppo di Gora.

4
Lugagnano19. (Propaggine ancora più evidente quando San Michele non faceva ancora parte del comune di Morfasso). Nell’808 il Monastero risulta, in tale zona, confinante della estesissima corte regia di Gusano, donata, da Carlo Magno, al Vescovo di Piacenza Giuliano. Doveva essere compresa nella “Valle” anche una parte di Settesorelle di Vernasca, nel territorio della pieve di Sant’Antonino di Castro Firmo (vedi sotto), ma non nella sua diretta dipendenza, poiché nell’823 risulta, che i porcari della corte vescovile di Carpaneto devono cedere al Monastero un settimo dello scatico20 dei boschi di Septemsorores. Lo stesso discorso vale per Castelletto e Vezzolacca di Vernasca, poste al di là dell’Arda (rispetto a Monastero). È noto dai “Quaderni della Val Tolla”21 la non completa e totale soggezione canonica delle due località alla pieve di Castell’Arquato. A conferma di tale ipotetica situazione, si rileva che le “Valli” dei Monastero di Bobbio e di Mezzano comprendevano territori oltre il Trebbia. Se per i due monasteri, i documenti imperiali e regi richiamano la “Valle in quo situm est monasterium”22, per Tolla ciò non avviene in modo esplicito. Circa i primi toponimi tollensi, si ha il ricordo di 21 iugeri e 46 tavole di possessi (donati a Tolla da un defunto Elmerico) costituiti dalla chiesa (e sue dipendenze) di Santa Maria in Tertuliano (o Tortiliano) (Chiesa di Santa Maria della Rotonda sul poggio Ericino, presso Vignola)23, nel fine Castroferonense (Frignano) e dalla foresta prope ripa fluivi Scultenna (Panaro) in loco Viniole (Vignola di Modena), e che, nell’826, l’abate Elmerico, vescovo (commendatario)24, cede al monastero di Nonantola di Modena, in cambio di beni, donati a Nonantola dal defunto Garibaldo, localizzati in loco et fundo Castro Arcotense, loco qui dicitur Riocivo o (Riocavo) con salae muratae, turcular, caneva, terrae seminatae, un castaneto e altra silva, terra aratoria e pascuo dell’estensione di 27 iugeri. 19 Il Capitano Boccia [cfr. ANTONIO BOCCIA: Viaggio ai monti di Piacenza (1805), (a cura di CARMEN ARTOCHINI), Piacenza, 1977, p. 58], riferisce che Carignone (e Lago) dipendeva dai “comuni” di Olza e Monastero). Si fa presente che nel 1805 non erano ancora stati istituiti i comuni, con le varie frazioni, come li intendiamo attualmente. 20 Lo scatico doveva essere un compenso per l’uso del bosco altrui nell’allevamento dei porci. 21 ANGELO CARZANIGA: Sant’Andrea del Castelletto, Divagazioni sulla prima chiesa, Vernasca, 1999, pp. 49-71. 22 Per Bobbio si definiscono dettagliatamente i confini. 23 Le notizie e la grafia dei toponimi relativi a Vignola sono tratti da “L’Emilia-Romagna paese per paese”, Bonechi, Firenze, 1986, alla voce “Vignola” di MILENA RICCI ZACCHI. 24 Si ha la stessa situazione del Monastero di Bobbio, che nell’843-49 e nell’860-65 risulta soggetto ad Amalrico, vescovo di Como. Il vescovo Elmerico può essere collegato col documento dell’anno 820, relativo al monastero di Gravago, in cui risulta che tale monastero era stato in precedenza sottratto alla Chiesa Piacentina, in contrasto con quanto stabilito da Ilprando (744) e Rachis (746).

5
Successivamente la documentazione diplomatica ricorda diverse donazioni e/o conferme a partire dall’ultimo periodo carolingio. Nell’880 Carlo III il Grosso riconosce a Tolla:
1) Cadinario: La località doveva essere localizzata presso Borla. Nell’890, a Lugagnano, in una controversia tra Pietro di Niviano e Gaidoldo di Macomero, sono presenti testimoni provenienti da Lugagnano, da Prato, da Ottesola, da Mignano, da Lacereto, da Antognano, da Aquabona (accertata località presso Villora di Varsi) e da Cadinario. Nell’887, a Borla, Ornucco da Borla dà in livello a Pietro da Niviano beni posti a Niviano, a Lugagnano, Macomero e Mignano, alla presenza di testimoni che provengono da Borla, da Mignano, da Favale, Vernasca e Tadinerii=Cadinerii. L’identificazione delle due forme del toponimo fa propendere per una sua localizzazione presso Borla. 2) Legiolo: non identificato. (In un documento di Federico Barbarossa, Renato Vignodelli Rubrichi e Felice Da Mareto danno Segrolo). 3) Adilio: l’aferisi della vocale iniziale (ed anche della dentale), cosa accertata anche per Aminiano, ha trasformato il toponimo in Ilio, sicura grafia della pieve di Iggio di Pellegrino Parmense (Parma, ma diocesi di Piacenza). 4) Casanova: certamente la pieve di Casanova di Bardi (Parma, ma diocesi di Piacenza)25. 5) Vidriano: non identificato.
Nel 902, Berengario dona il castello di:
6) Speluncha: Sperongia (costruito per contrastare pagani e predoni, (saraceni e ungheri). (La pieve di Macinesso-Veleia ne rivendicherà la soggezione canonica)26.
Nel 963 vengono restituite al monastero le cappelle di:
7) San Cassiano: San Cassiano di Castell’Arquato, tra l’Arda e la strada della Sforzesca. 8) Sant’Angelo (con la corte di Mistriano): Sant’Angelo non era il titolare della chiesa di Mistriano, dedicata alla Madonna. 9) Mistriano: certamente la località presso Castell’Arquato, detta anche Mestriano.
25 Iggio e Casanova potrebbero essere state pievi, inizialmente, di diretta dipendendenza dal Monastero di Tolla come lo erano San Paolo in Campoplano (Pieve di Campi) e San Giovanni di Sezegna (Pievetta di Santo Stefano d’Aveto) soggette direttamente a e San Paolo in Sarturiano (Zavattarello), Sancti Antonini (Perducco di Zavattarello), San Paolo di Valdinizza e Sant’Albano in Condubrio in Val Nizza e Staffora per Bobbio. 26 Macinesso, che per diverso tempo ha dato il nome alla pieve e in seguito alla parrocchia di Veleia, è un casale presso il Chero lontano dalla chiesa a cui ha dato il nome.

6
Nel 1014 Enrico II riconferma la “cella” di Mistriano, beni in San Cassiano e le località:
10) Lavernasco: certamente Vernasca, per quanto riguarda il castello e la chiesa di San Colombano, rettorato dotato di autonomia relativa, come evidenziato da Massimo Pallastrelli, nel territorio della pieve di Castell’Arquato, ma non della pieve arquatese. (La cella di Vernasca, ipotizzata come dipendente originariamente dal Monastero di Bobbio, non trova, che io sappia, alcun riscontro documentario, come si può vedere nelle carte edite da Carlo Cipolla, (Se i monaci tollensi hanno dedicato una “loro” chiesa a San Colombano e hanno aggiunto alla dedicazione del loro monastero anche il nome di San Gallo, compagno di Colombano, può significare una loro probabile origine “colombaniana” al tempo di Attala)27. 11) Lucaniano: certamente Lugagnano. Il territorio di Lugagnano, anche se rimane dipendente ecclesiasticamente dalla pieve di Castell’Arquato, civilmente rientrerà nella giurisdizione della “Valle di Tolla”. 12) Catinello: (il Campi dà Cativello) Località da porre presso la pieve, allora pavese, di Fontana Fredda di Cadeo. Nel 1264 l’abate Giovanni del monastero di Tolla, facendo delle permute con Ubertino Landi, concede un fitto nelle località bosco deffonderato e Catinello dipendenti, da Fontana Fredda. (Felice da Mareto fa coincidere il toponimo con Castelletto, ma si tratta, a mio avviso, di semplice assonanza). 13) Cucullo: Potrebbe trattarsi di Cucullo presso la pieve di San Nazzaro (vedi sotto), perché il Monastero possedeva beni presso la pieve di San Pietro in Cerro e presso la pieve di Polignano, vicine a San Nazzaro. 14) Casale Barbati: Casal Barbato di Fontanellato (Parma). 15) Rivarioli (il Campi dà Ravanioli): Forse il nome è rimasto allo Stirone Rivarolo, tra Borla e Besozzola di Pellegrino Parmense (Parma ma in diocesi di Piacenza). (La forma Ravanioli è stata collegata da Pier Francesco Gandolfi con Ravazzoli di Sperongia, ma la stessa Sperongia risulta sicuramente già tollense al tempo di Berengario I). 16) Saliano (il Campi dà Soliano): Due documenti dell’825 e 827 parlano di un Saliano (Salliano) presso Suzzano, Larzano e Niviano di Rivergaro, ma non sembra che quello tollense vi corrisponda. Il toponimo tollense potrebbe essere collegato a Sariano di Gropparello per la frequente rotizzazione della labiale (la “elle” facilmente
27 Si veda sopra.

7
diventa “erre”). Non escluderei una localizzazione presso Borla, date le seguenti indicazioni. 17) Burla: certamente Borla di Vernasca 18) Pulplano: Perpiano di Vigoleno di Vernasca.
Nel 1040, Ariberto d’Intimiano, in fuga dalla prigionia di Corrado II, per merito dell’abate di Tolla Albizzone, dalla località San Cassiano (certamente quella presso Castell’Arquato), dona all’abbazia stessa, nelle pievi di San Martino (San Martino in Olza di Cortemaggiore) e di San Donato (pieve di Polignano di San Pietro in Cerro), le “corticelle” di:
19) Clavenucia: Chiavenna Landi di Cortemaggiore. 20) Santo Stefano (con Solarolo e Persegario): Santo Stefano non identificato. 21) Solarolo: La località, con tracce evidenti di una chiesa, trasformata in abitazione, dedicata alla Madonna, si trova presso Paullo di Fiorenzuola, nella recente parrocchia di Barabasca (con chiesa a Riomezzano). 22) Persegario: Il toponimo, se non identificabile con Felegara presso Paullo, può essere collegato con Persegario, documentato nel Registrum Magnum, presso Cortemaggiore. I fitonimi (nomi legati ai vegetali) hanno la desinenza eto o ario (Saliceto, Carpaneto, Sambuceto…, Pomario…, Linario…).
Nel 1148 Eugenio III riconfermando a Tolla: beni e la chiesa in
Mistriano, la chiesa (ovviamente di San Colombano) di Vernasca
e la chiesa di Sperongia, ricorda, per la prima volta, beni in:
23) Castro Arquato: Certamente Castell’Arquato, [tra cui ritengo vadano annoverati i beni ceduti dal monastero di Nonantola nell’826 (non riconfermati espressamente nei documenti precedenti) e San Cassiano].
Ricorda inoltre castelli, pertinenze e chiese in 24) Corte regia apud Castellonovo: Castellonovo è stato identificato con Castelnuovo Fogliani di Alseno. Ci sono però, nel Registrum Magum, alcuni documenti che devono essere presi in considerazione per una sicura identificazione. Nel doc. n. 54, a. 1141 la località detta successivamente Castelnuovo si chiamava ancora Belmonte, anche se, a tale data, il Comune di Piacenza, che ne era diventato proprietario, si preparava a farne un castello (ad fossatos faciendum). Solo dopo il 1184 (doc. nn. 5 e 30, a. 1184, doc. n. 202, a. 1195, doc. n. 66, a. 1196, doc. n. 201, a. 1198) si parla già di Castello Novo. Nell’assegnazione di terre intorno al castello non viene ricordato come confinante il Monastero di Tolla. Pertanto la corte regia mi fa propendere per una identificazione con

8
Cortina di Alseno, vicina a Castelnuovo Fogliani. La chiesa di Cortina Vecchia (o vegia) è dedicata a San Salvatore come il monastero di Tolla28. (Tuttavia anche la chiesa di San Biagio di Castelnuovo Fogliani, pur dovendo dipendere dalla pieve di Campo Cervario, negli estimi ecclesiastici, risulta con reddito proprio come tutte le chiese che dipendevano da Monasteri). 25) Molfassio: certamente Morfasso. (La pieve di Macinesso ne rivendicherà la soggezione canonica). 26) Riogarrulo: certamente Rugarlo di Bardi (Parma, ma diocesi di Piacenza). 27) Regiano: (Felice da Mareto tralascia questo toponimo) Quasi certamente Rezzano di Carpaneto29. 28) Sancto Dalmatio di Piacenza: certamente la chiesa di San Dalmazio di Piacenza.
Nel 1167 l’imperatore Federico Barbarossa, riconferma ciò che aveva modo di leggere sui documenti dei suoi predecessori: (a) Carlo (il Grosso) per Cadinario, Legiolo, Adilio, Casanova, Vidriano, (b) Ugo e Lotario, per il riconoscimento di prerogative (nel documento non si hanno toponimi), (c) Berengario per il castello di Speluncha, (e) Enrico II per il castello di Lavernasco, la cella di Santa Maria nella Villa di Mistriano, masserizie nella villa di San Cassiano, Luganiano, Catinello (Cattinelo), [manca Cucullo] Casale Barbati, Rivariolo, Saliano, Burla, Pulplano. Riprende il contenuto del documento emesso dal papa Eugenio III, per quanto attiene a castel Molfassi, villa Riogarruli, possessi entro e fuori Castel Regiano, terminando con la corte “Regia” presso Castelnuovo e la chiesa di San Dalmazio. Dopo Pulplano vengono ricordati per la prima volta:
29) Masarioli (metà della corte): non identificato. 30) Rechapenna: (Rochapenna?) non identificata, ma potrebbe corrispondere a Rocca di Casali, poiché Penna indicava sicuramente una zona legata a Rocha30
Dopo Regiano vengono aggiunti possessi in: 31) Ulmetha (villa): Potrebbe essere Olmeto, in Val Chero (con castello ed oratorio), in parrocchia di Montezago di Lugagnano, non lontano da Rezzano. 32) Marengo: non identificato. Si può forse ipotizzare Marenghi di Antognano di Lugagnano, vicino ad Olmeto. Si deve tuttavia tener presente che il toponimo può aver tratto il nome dalla famiglia omonima. (Non credo si tratti di Marengo in provincia di Alessandria).
28 Secondo il Wolf dalla pieve di San Pietro in Campo Cervario dipendevano Cortina Vecchia (San Salvatore), Cortina Nuova (Santa Maria) e Custodono o Costaduno (Santa Maria). Non si fa menzione di San Biagio di Castelnuovo. 29 Il Monastero di Tolla, come riporta il Kher, ha un contrasto con la pieve di Travazzano da cui dipendeva Rezzano, ma non viene specificato se il motivo della contesa interessava tale località. 30 SANTINO CAVACIUTI: Il “Comune” di Pédina alla metà del ‘500, p. 162.

9
33) Mocionassi: (F. Da Mareto riporta Macinesso) Si possono fare due ipotesi sulla sua identificazione, collegando il toponimo a Mucinasso di Piacenza o a Macinesso di Veleia di Lugagnano che ha dato successivamente il nome alla pieve posta sulle rovine di Veleia, detta nell’835 Sant’Antonino de Augusta o Austa o Agudo (come legge il Campi in un documento dell’XI secolo31). Nell’823, per lo scantico di Settesorelle, interviene come testimone Giovanni de Mazionassi, che compare nell’825 come de Mationassi che può corrispondere a Macinesso. (Nell’832 si parla di una corte vescovile posta a Mugiagianasi o Muginassi o Mugianassi), che ha molta probabilità di essere Mucinasso, ma una nota del sec. XII, che intende la località come Magenassi, riporta a Macinesso. Nel 1191 la pieve di Macinesso e il vescovo di Piacenza Tedaldo, contestano al Monastero la soggezione canonica in loco et curte Molfaxi, in curte Speluncie et in aliis locis que sunt in confinio ipsi monasteri de Tolla (entro il territorio del monastero di Tolla). Il che indicherebbe la non dipendenza e soggezione di Macinesso da Tolla ad opera di Federico Barbarossa. 34) Campo Venanzio (possessi): non identificato.
Il documento termina con la generica indicazione di possessi nel Piacentino, nel Parmense e nel Cremonese. (Può darsi che qualcuno dei toponimi, non ancora identificati, sia da ricercare nel Cremonese). Nel 1186 Urbano III conferma integralmente la bolla di Eugenio III del 1148, anche se nello stesso anno affida al parroco di Caviago l’incarico di definire una causa tra l’abbazia e l’arciprete della pieve di Travazzano. La sentenza è confermata da Adriano IV nel 1158. (Purtroppo i regesti delle bolle papali non parlano di toponimi oggetto del contendere). I TOPONIMI ARQUATENSI - CASTELLANI Poiché la cartina, allegata al lavoro di Vito Fumagalli, viene ripresa dagli storici, che si occupano della Val d’Arda ed in generale del territorio diocesano piacentino, riporto integralmente l’elenco dei toponimi presi in considerazione dallo storico, aggiungendo più adeguate identificazioni, specificando la parrocchia ed il comune, in cui sono localizzati i toponimi stessi, per eliminare possibili omonimie ed assonanze. Ogni toponimo viene inserito nei Fines di appartenenza, vale a dire i Fines Piacentina (intesi come sottodistretto a cui facevano capo le valli del Nure, del Trebbia e del Tidone), i Fines Castellana, i Fines
31 Il Campi collega il toponimo Agudo ad un’ipotetica pieve di Sant’Antonino che sarebbe esistita a Godi di San Giorgio, ma si tratta ovviamente di uno svarione toponomastico.

10
Aucenses, i Fines Laudenses, e i Fines Parmenses. Il richiamo, nel testo di V. Fumagalli, ai documenti di Falconi, Manaresi, Schiapparelli ecc, mi permette di aggiungere diversi toponimi, non presi in considerazione dallo studioso, ma presenti nei documenti stessi ed in altri da lui citati. (Le nuove identificazioni sono inserite di seguito ai toponimi che li accompagnano).
1) Albarola di Vigolzone (Albariola), Falconi, n. 20, a. 843. Nei Fines Placentina. 2) Altoè ? di Podenzano (Octavum), Manaresi, n. 59, a. 854. Non si tratta di Altoè, ma di Ottavello di Rivergaro, come si ricava dal documento n.3, a. 816 di Falconi, dove Octabo risulta coerente a Larzano di Rivergaro. Nei Fines Placentina. 3) Antognano di Lugagnano (Antonianum), Falconi, n. 45, a. 881. Nei Fines Castellana. 4) Bagnolo di Bicchignano di Vigolzone (Bagnolum, fundus), Falconi, n. 20, a.84332. Nei Fines Placentina. 5) Bardi (Parma, ma diocesi di Piacenza) (Bardi casale), Tiraboschi, n. XXXI , a. 833. Nell’833 Gausperto di Bardi mentre si definisce dei Fines et iudicaria piacentina, chiede in usufrutto al monastero di Nonantola quanto è stato donato al monastero stesso a Bardi et Odolo seu pro aliis singulis casalibus in Finibus Placentina seu Castro Arquensis, chiede inoltre la chiesa di San Gervasio e Protasio, e possessi in Cirione. L’atto è steso nella cella del Monastero di Nonantola localizzata a Ponte Marmoriolo. (Si veda alla voce Ongina). Nei Fines Castellana (perché indicato nei Fines Castro Arqu(at)ensis). 6) Barzano ? di Gropparello (Barreanum), Manaresi, n. 59, a. 854. La località in comune di Gropparello prende il nome, a mio avviso, dalla famiglia Bersani. Il toponimo va quindi ricercato altrove, ma certamente nei Fines Castellana. 7) Baselica Duce di Fiorenzuola (Basilica Duci), Manaresi, n. 59, a.854. Baselica Duce risulterà sede del conte dell Aucia, che ereditava dal padre il comitato piacentino. Anacronistica e del tutto priva di validità risulta l’ipotesi di alcuni “storici”, secondo la quale, l’apposizione Duce sarebbe derivata dal ricordo di Oberto, duca di Toscana, capostipite dei Pallavicini, che è vissuto nel secolo X !. Nei Fines Aucenses. 8) Borgo Val di Taro (Parma, ma diocesi di Piacenza), (Turris), Cipolla-Buzzi, n. XXXVI, a. 833-835. Rifondata dai Piacentini col nome di Turrisiana. Non faceva certamente parte del comitato Toresiano, come ipotizza il Formentoni, perché il comitato Torresano era
32 Nel documento n. 41, a. 847 di Galetti risulta l’altro Bagnolo dipendente da Fiorenzuola d’Arda. Nei Fines Aucenses.

11
nell’Astigiano. (Risulta pertanto errata la mia identificazione del coronimo lungo il torrente Staffora, che si rifà all’ipotesi formulata da Vito Fumagalli). In Montana et Marittima. 9) Borla di Vernasca (Burla), Falconi, n. 58, a.88733. Nei Fines Castellana. 10) Calendasco (Kalendasco), Falconi, n. 67, a. 892. Nei Fines Placentina. 11) Cangelasio di Salsomaggiore (Parma, ma diocesi di Piacenza, di cui era un’antica pieve) (Cangelasium locus), Campi, n. XXXIX, a. 899. Come territorio storicamente piacentino doveva rientrare, come Salsomaggiore (Salsemaiore), località, originariamente, dipendente da tale pieve, nei Fines Castellana. 12) Caorso (Caput Ursi, fundus), Falconi, n. 4, a. 818. Nei Fines Placentina e/o Aucenses. 13) Carrozza di Vianino di Verano Melegari (Parma, ma diocesi di Piacenza) (Carrocia, Carutia), Schiapparelli, I, n. 109, a. 753, Manaresi, n. 59, 854. Nei Fines Castellana 34. 14) Casanova di Bardi (Parma, ma diocesi di Piacenza, di cui era un’antica pieve) (Casanova), Manaresi, n. 87, a. 879. A Casanova sono collegati diversi toponimi registrati in documenti editi da Giulia Petracco Sicardi e ralativi al Castellum (Castrum o anche Casale) ubi Lacore dicitur, che è detto espressamente ancora nel secolo X in finibus Castellana. I toponimi non più indicati sulle carte geografiche attuali sono: Prade prope Cene, detto esplicitamente in Casale Casanova, Aquabona che in vecchie carte risulta presso Villora di Varsi (Parma, ma diocesi di Piacenza), Castro, Castello, Casale Lacore da identificarsi con Rocca Varsi (Vecchia e Nuova) (Parma, ma diocesi di Piacenza), Costa de Casale presso Lacore, Agnanina che certamente corrisponde al castello dell’Agnellina (scomparso) presso Pessola di Varsi (Parma, ma diocesi di Piacenza), Murriano (o anche nella forma Morriano) in finibus Castro Firmis Arquatenset (sic) doveva essere pure presso Pessola. Nei Fines Castellana. 15) Castell’Arquato (Castrum Arquatense), Schiapparelli, II, n. 142, (Castrum Arquensis), Tiraboschi, n. XXXI, 833. Castell’Arquato era indicato anche come Castro Fermo, sede di una chiesa (battesimale) dedicata a Sant’Antonino prima di
33 In un documento dell’877, edito da G. Petracco Sicardi, si parla di Pietro de Borlasco, come originario del “territorio” di Borla. 34 In un documento dell’884, edito da G. Petracco Sicardi, Carucia è legato a Pociolo che potrebbe corrispondere a Pozzolo di Bore (Parma, ma in diocesi di Piacenza).

12
assumere, come ora, la dedicazione all’Assunta. (vedi sotto). Nei Fines Castellana. 16) Castel Nuovo Bocca d’Adda (Lodi) (Castellonovum, locus et fundus), Drei, II, n. XXXV, a. 1026. La località, indicata presso il fiume Lambro, che correva in territorio di Somaglia e Guardamiglio di Lodi, corrisponde a Castelnuovo di Somaglia, dove si tenevano le Diete imperiali. Castel Nuovo Bocca d’Adda anticamente si chiamava Roncariolo o Roncariola ed era nel comitato Laudense. Roncarolo di Caorso non ha quindi niente a che vedere con il “Roncarolo nel lodigiano”, come invece ritengono tutti gli storici, appunto perché era Castelnuovo Bocca d’Adda. 17) Castel Nuovo Fogliani di Alseno (Campum Cervarium), Manaresi, n. 59, a. 854. Più precisamente San Pietro, presso Casalbino di Castel Nuovo. Nei Fines Castellana al confine coll’Aucenses. 18) Cazzarini ? di Antognano di Lugagnano (Camorini). Falconi, n. 21, a. 844. La località che certamente rientrava nei Fines Castellana, non corrisponde a Cazzarini, ma a Camorlino di Chiavenna Rocchetta di Lugagnano. Paola Galetti nella sua opera “Una campagna e la sua città – Piacenza e territorio nei secoli VIII – X” (1994) (dopo il mio studio del 1988), identifica la località con Camorlino, anche se considera insicura, e non errata, l’ipotesi di Vito Fumagalli35. 19) Chiavenna Rocchetta di Lugagnano (Clavenna), Manaresi n. 87, a. 879. Nei Fines Castellana. Clavenucia dei documenti tollensi e nonantolani corrisponde a Chiavenna Landi di Cortemaggiore. Fines Aucenses. 20) Ciriano? di Carpaneto (Cerellianum), Manaresi, n. 59, a. 854. Il dubbio di Vito Fumagalli va certamente eliminato. Si tratta della località in comune di Carpaneto. Il documento n. 32, a. 841, edito da Paola Galletti e relativo ad una cella del Monastero di Gravago e alla chiesa di San Giorgio, poste sicuramente presso Batelaccio di Vigolo Marchese di Castell’Arquato, conferma tale identificazione. Nei Fines Placentina 21) Contile (Contili) di Varsi (Parma, ma diocesi di Piacenza), Manaresi, n. 59, a 854. Nei Fines Castellana. 22) Corno Vecchio di Lodi (Cornum), Drei, II, n. XXXV, a. 1026. Nei Fines Laudenses. 23) Favale di Monastero di Morfasso (Fabale), Falconi, n. 40, a. 880. Nei Fines Castellana. 24) Fidenza (Parma) (S. Domninum), Manaresi, n. 40, a. 830. Nei Fines Parmenses. 25) Fiorenzuola d’Arda (Florenciola), Manaresi, n. 40, a. 830. Ritengo che, a sud, il confine dei Fines
35 PP. 93-94, nota. 53

13
Aucenses fosse rappresentato dalla Via Emilia o Romea o almeno dai confini della giurisdizione plebana di Castell’Arquato, vale a dire il territorio delle parrocchie di Lusurasco di Alseno e di Vigolo Marchese di Castell’Arquato. Nei Fines Aucenses. 26) Fontanabroccola, San Nicomede di Fidenza (Parma) (Fontana Broccoli, locus), Schiapparelli, G. e L., n. II a. 890. Sul confine tra i Fines Castellana – Piacentina e i Fines Parmenses. (Nelle Raziones decimarum risulta che metà di Fontanabroccola era del Vescovo di Piacenza). 27) Fornovo (Parma) (Fornovum), Manaresi, n. 59, a 854. Nei Fines Parmenses. 28) Godi di San Giorgio Piacentino (Gudi, fundus et locus), Falconi, n. 51, a. 884. Fines Piacentina. Il Campi identifica la pieve di Sant’Antonino di Agudo con Godi, che non ha mai goduto di tale prerogativa. Si tratta certamente della pieve di Macinesso detta Augusta, Austa, Aguda. (vedi prima) Nei Fines Piacentina. 29) Golaso di Varzi (Parma, ma diocesi di Piacenza) (Acolasium, Agolate, Agolace), Schiapparelli, I, n. 59, a. 736, Idem, II, n. 249, a. 770, Manaresi, n. 87, a. 879. Nei Fines Castellana 30) Gropparello (Gaianum, Gagianum), Manaresi, n. 59, a. 854, Falconi n. 69 a. 893 (in prato domni regi in Gagiano finibus Castellana). Non è sicuro che Cagnano = Gropparello si debba identificare con Gagiano anche se è notevole l’assonanza. Gagiano era comunque nei Fines Castellana. Si deve comunque considerare che presso Gropparello esiste il paese di “Castellana” che sembra aver tratto tale denominazione dalla sua posizione a ridosso dei Fines Castellana. Non mi pare che tale località possa aver dato il nome ai Fines. 31) Lacereto di Rustigazzo di Lugagnano (Ladericium, Latricia, Ladericia), Manaresi, n. 59, a. 854, Falconi, n. 40, a. 880, Idem n. 49, a. 883. Nei Fines Castellana. 32) Larzano di Rivergaro (Lartianum, Larcianum, fundus casale, locus), Falconi, n. 3 a. 816, Idem n. 10, a. 827. Nei Fines Piacentina. 33) Lorenzoni di Antognano di Lugagnano (Runcioni prope Arda), Falconi, n. 53, a. 884. L’identificazione coi Lorenzoni, vicino al Chiavenna, si basa su semplice assonanza. La località è certamente Ronzone di Lugagnano vicino all’Arda. Nei Fines Castellana. Anche Paola Galetti conviene con l’identificazione di Ronzone anche se si mostra dubbiosa, essendo i Lorenzoni “vicino a Lugagnano ed al fiume Arda” (sic). Ma Lorenzoni è prope Clavenna.

14
34) Lugagnano (Lucanianum, locus ), Falconi, n. 53, a. 884. Idem, n. 55, a. 886, Idem n. 58, a. 887, Idem n. 62, a. 890, Idem n. 63, a. 890 (in villa nucupante Lucaniano ad eclesia Sancti Zenoni). Nei Fines Castellana. 35) Lusurasco di Alseno (Leoterascum), Falconi, n. 69, a. 893. L’identificazione con Lusurasco (Lisiraschi) dipende da semplice assonanza. La località, non ancora identificata, era certamente nei Fines Castellana. Toponimi con la desinenza – asco sono particolarmente diffusi. (Occorre una certa “prudenza” nel considerare tale desinenza come di origine “sicuramente” ligure). Anche il Laurasco delle carte bobiensi non corrisponde alla frazione alsenese, pur essendo dedicata a San Colombano. 36) Marano di Carmiano di Vigolzone, Falconi, n. 20, a. 843, (in Mariano). Idem, n. 51, a. 884. (Marianum, locus et fundus). Monteclo indicato nel documento n. 20 è certamente Montiglio di Bicchignano di Vigolzone e non, come ipotizza V. Fumagalli, a pag. 9, Montechiaro di Rivergaro. Il Mariano del doc. 51 non sembra avere alcun legame con il primo, dato che dovrebbe essere localizzato presso Godi di San Giorgio P. Nei Fines Piacentina. 37) Mariano di Castell’Arquato, presso Lugagnano (Marriano, Finibus Castellana), Falconi, n. 11, a. 832. Nei Fines Castellana. È indicato, nell’810, anche un Murriano o Morriano in finibus Castro Firmis Arquatenset, che certamente non corrisponde a Marriano, pur rientrando ugualmente nei Fines Castellana. (Vedi prima). 38) Mignano di Vezzolacca di Vernasca, pur essendo a sinistra dell’Arda (Amenianum, Aminianum), Schiapparelli, II, n. 142, a. 760, Falconi, n. 40, a. 880. Nei Fines Castellana. 39) Mistriano (anche Mestriano) di Castell’Arquato (Mistrianum), Falconi, n. 53, a. 884. Nei Fines Castellana. 40) Mocomero di Castelletto di Vernasca (Mocomeria, casale), Falconi, n. 29, a. 870, (Bocomeria) Il luogo di stipulazione dell’atto (Pontenure) ed i testimoni di Pontenure, Piacenza e Corneliano, fanno ritenere che Bocomeria possa non coincidere con Mocomeria. Idem 54, a. 886. Idem, n.58, a. 887. Nei Fines Castellana 41) Montagnano di Vigolo Marchese di Castell’Arquato (Montanianum), Falconi, n. 63, a. 890. Nei Fines Castellana.

15
42) Morignano di San Lorenzo di Castell’Arquato (Moranianum, Mormianum, locus, villa), Manaresi, n. 59, a. 854, Idem, n. 87, a. 879. Nei Fines Castellana. 43) Mormorala? di Valmozzola (Parma, ma diocesi di Piacenza) (Marmoriola), Manaresi, n. 59, a. 854. Potrebbe trattarsi di Marmarola di Lugagnano. Nei Fines Castellana 44) Moronasco di Fiorenzuola e di Chiaravalle di Alseno (Marinascum), Manaresi, n. 59, a. 854. Nei Fines Castellana al confine con gli Aucenses. 45) Muradello di Pontenure (Muridelle), Manaresi, n. 59, a. 854. Fines Piacentina o Fines Aucenses. 46) Niviano di Lugagnano (Nivianum, Nevianum, Nebianum, Nebianum, casale, vicus, locus, locus et fundus), Falconi, n. 21, a. 844, Idem n. 53, a. 884, Idem, n. 57, a. 887, Idem, n. 62, a. 890, Nei Fines Castellana. Niviano di Rivergaro era detto Novelianum e rientrava nei Fines Piacentina. 47) Obolo di Gropparello (Odolum, casale), Tiraboschi, n. XXXI, a. 833. Non si tratta di Obolo, che è solo assonante, ma della località scomparsa di Odolo, dove era localizzata la primitiva chiesa di Bardi, dedicata ai Santi Gervasio e Protasio, (Parma, ma diocesi di Piacenza). Nei Fines Castellana, poiché indicato in Finibus Placentina seu Castro Arquensis, insieme a Bardi. Anche P. Galetti conviene con tale identificazione. 48) Ongina di Vidalenzo di Polesine Parmense (Parma, anticamente in diocesi di Piacenza, come dipendenza dalla pieve di San Martino in Olza) (Onglena, Unglina, villa), Manaresi, n. 59, 854, Schiapparelli, G. e L., I, 895. La località Ongina doveva essere localizzata presso il torrente omonimo, in territorio di Castelnuovo Fogliani di Alseno o in territorio di Vernasca. Si rileva anche che Santa Maria del Casasco localizzata, insieme a San Colombano, a Vernasca, era detta anche “d’Ongina”. Nei Fines Castellana. Il rigo Unglena, di cui parlano i documenti longobardi, su cui è indicato il Ponte Marmoriolo, che segnava (e segna) il confine tra il territorio piacentino e quello parmense è il “Rio” detto attualmente “Piacentino”. È, o era chiamato fino all’Ottocento, Ponte Marmirolo, il ponte su tale rio, che interseca la via Emilia nel punto di passaggio dalla provincia di Piacenza a quella di Parma. Si tratta quindi di un corso dell’Ongina diverso dall’attuale, che risulta deviato nel rio Grattarolo. Anche la Longina che viene indicata nel documento di Berengario (915-924), contenuto nel Registrum Magnum, non corrisponde all’attuale Ongina, ma al corso d’acqua detto Onginella, completamente sul

16
Parmense. Tale canale doveva essere collegato originariamente con l’Unglena del ponte Marmirolo. 49) Oriano di Solignano (Parma, in diocesi di Parma, ma presso il confine con la diocesi di Piacenza) (Oriolum, Vicus Orri…), Manaresi, n. 59, a. 854, Idem, n. 87, a. 879. Segnalo come plausibile alternativa di Oriano il toponimo Oriolo era una località presso Fiorenzuola d’Arda dove esisteva una chiesa dedicata alla Madonna, che segnava il confine tra la Pieve di Castell’Arquato e quella di Fiorenzuola. Nei Fines Castellana e/o Aucenses. 50) Ostia di Belforte di Berceto, (Parma, diocesi di Parma, ma sul confine con le diocesi di Luni e di Piacenza, Baselica di Bercelo era lunense, Ceppin-Pontolo di Borgotaro era in diocesi piacentina) (Lustia), Manaresi, n. 59, a. 854. Fines Parmenses, perché oltre Taro, anche se, nel Registrum Magnum, alcuni “piacentini valtaresi” sono originari di Ostia. 51) Pessola di Varsi (Parma, ma diocesi di Piacenza) (Pissia), Manaresi, n. 59, a 854. Nei Fines Castellana. 52) Piane presso Fidenza (Planitiae), Campi, n. XXXIX, a. 899. Nei Fines Parmenses. 53) Pietramogolana di Berceto (Parma, sul confine della diocesi di Piacenza) (Petramugulana), Manaresi n. 59, a. 854. Fines Parmenses. (Nella definizione dei confini tra il gastaldato piacentino e quello parmense potrebbe apparire anche piacentina, ma la sua localizzazione oltre il Taro lo escluderebbe). 54) Pomaro di Piazzano (Pomarium, villa), Manaresi, n. 105, a. 897. Fines Piacentina. 55) Ponte dell’Olio (ubi a Ponte dicitur), Manaresi, n. 59. a. 854. Completamente errata l’identificazione. La località doveva essere presso Lugagnano. Nei Fines Castellana. 56) Pozzolo di Bargone di Salsomaggiore (Parma) (Potiolum), Manaresi, n. 59, a. 854. Come ancora Salsomaggiore, anticamente Pozzolo deve essere stato, per qualche tempo, in diocesi di Piacenza, come risulta dalle dichiarazioni degli “uomini” della località, fatta al “Comune” di Piacenza. Sul confine tra i Fines Parmenses e i Fines Castellana. Il confine tra il gastaldato piacentino e quello parmense, riportato in un documento di Arioldo (626-636) che ne richiama uno di Adaloaldo (615-626) ed in uno di Pertarito (673 o 674) compreso tra il Ponte di Marmirolo, sul rio Piacentino (tra la parrocchia di Castelnuovo Fogliani di Alseno e le parrocchie fidentine di Rimale e Formio di Fidenza) e Salsomaggiore (Parma, ma diocesi di Piacenza) corrisponde all’attuale confine diocesano. Il rigo inter

17
Potiolo et Salsemaiore non è il rio Pozzolo, in parrocchia di Bargone di Salsomaggiore, ma il rio Ghiaia, che scorre tra Salsomaggiore e Bargone. 57) Pozzo Pagano di San Giorgio P. (Puteum Pagani lege Paganum), Manaresi, n. 59, a. 854. Fines Piacentina. 58) Prato presso il Ceno nell’area di Varsi (Parma, ma diocesi di Piacenza) (Prata, Prade), Schiapparelli, I, n. 59, a. 736. Falconi, n. 43, a. 88136. Mentre il documento di Schiapparelli si riferisce alla Val Ceno, quello di Falconi si riferisce alla zona di Lugagnano e precisamente al gruppo di case che ha formato, con Ottesola, Prato Ottesola di Lugagnano. Ambedue le località erano nei Fines Castellana. 59) Prato Ottesola di Lugagnano (Autesiola), Manaresi, n. 59, a. 854. Nei Fines Castellana. 60) Rezzano di Carpaneto (Verutianum), Manaresi, n. 59, a. 854. Non vi sono elementi per ritenere sicura l’identificazione con Rezzano. Anzi la località in comune di Carpaneto è già chiamato Regiano in documenti tollensi. Mentre Verutianum poteva essere nei Fines Castellana, la località, sulla sinistra del Chero, era nei Fines Piacentina a cui appartenevano sicuramente Carpaneto Piacentino, Godi e Centovera di San Giorgio. 61) Roveleto di Cadeo (Roberetum), Manaresi, n. 91, a. 880-81. La località doveva essere presso Rustigazzo come si ricava dal doc. n. 29, a. 835 edito da P. Galetti. Nei Fines Castellana. 62) Salde di Oriano di Solignano Parma (Saldum), Campi, n. XXXIX, a. 899. Nei Fines Castellana, perché il Campi lo indica come appartenente a Piacenza. Ma se Saldum corrispondesse a Salde di Oriano, occorrerebbe ritenere che la parrocchia parmense, sia dal punto civile che religioso, fosse anticamente in diocesi di Piacenza, come le località vicine, a meno che questo Saldum, che viene nominato insieme a Cangelasio di Salsomaggiore (Parma, ma diocesi di Piacenza), non corrisponda all’identificazione di V. Fumagalli. (Potrebbe tra l’altro essere una cattiva lettura di Salsum, come viene anche chiamato più semplicemente Salsomaggiore). 63) Salsomaggiore (Parma, ma diocesi di Piacenza) (Salsemaiore, Salsemagiore), Manaresi, n. 59, a. 854, Falconi, n. 69, a. 893. Nei Fines Castellana 64) Sariano di Gropparello (Vicus Savori, Salerianum), Manaresi, n. 59, a. 854, Idem, n. 91, a. 880-81. Se Salerianum può essere collegato alla località in comune di Gropparello, altrettanto non si può dire di
36 Un documento dell’875, edito da G. Petracco Sicardi, conferma la localizzazione precisa in Casale Casanova in loco qui dicitur ad Prade prope fluvio Cene.

18
Vicus Savori o Vicus Saponi che potrebbero essere forme errate di Vico Sahiloni. Sariano poteva essere nei Fines Castellana. Vico Sahiloni, perché corrispondente a San Giorgio Piacentino, era nei Fines Piacentina. 65) Solignano, Parma (Solonianum, Salinianum, vicus) Schiapparelli, II n. 159, a. 762, Manaresi, n. 59, a. 854. Solignano, già dipendenza dal Monastero di Bobbio, non faceva parte, come le località vicine, della diocesi di Piacenza. Rientrava nei Fines Parmenses. 66) San Lorenzo di Castell’Arquato (Eccl Scti Laurenti, Sanctus Laurentius) Manaresi, n. 59, a. 854, Drei, III, n. 570, a. 1183. Nei Fines Castellana. 67) San Nazzaro di Monticelli d’Ongina (Cucullum, Cogullum, locus et fundus), Manaresi, n. 77, a. 874, Falconi, n. 35, a. 874, Idem, n. 51, a. 884, Idem, n. 65, a. 891. Come ho rilevato nello studio del 1988, la località Cocullo del doc. n. 51, non coincide con la pieve di San Nazzaro, anche se ne faceva parte. Era nei Fines Aucenses e/o Piacentina. Il Cogullo o Cucullo inter Pado et Lambro dei docc. 35 e 65 era localizzato dove ora sorge Guardamiglio di Lodi, un tempo nell’Oltrepò piacentino anche dal punto di vista religioso. Una località chiamata Cucullo rientrava tra i possessi del Monastero di Tolla. 68) Specchio di Solignano (Parma, ma diocesi di Piacenza) (Speglum), Manaresi, n. 59, a.854. Nei Fines Castellana. 69) Tabiano di Salsomaggiore, Parma (A differenza del capoluogo comunale, Tabiano non faceva parte della diocesi di Piacenza), (Tarabianum), Benassi, n. II, a. 835. Fines Parmenses. 70) Torrano di Ponte dell’Olio (Tarelianum, locus), Manaresi, n. 59, a. 854. Fines Placentina. Non si tratta certamente di Torrano, documentato, nel 839, come Toriano (Galetti doc. n. 30). La località Tarelianum doveva essere nei Fines Castellana. 71) Travazzano di Carpaneto (Travatianum), Manaresi, n. 59, a. 854. Nei Fines Placentina anche se non lontano dai Fines Castellana. 72) Valli di Lugagnano (Valli, ubi dicitur), Falconi, n. 54, a. 886. Nei Fines Castellana. 73) Variano di Morfasso (Varianola, Varianolum vicus ), Manaresi, n. 87, a. 879, Falconi, n. 45, a. 881, Nei Fines Castellana. 74) Varsi (Parma, ma diocesi di Piacenza) (Varissium, Varsium, Versium, casale), Schiapparelli, I, n. 52, a. 735, Idem, n. 54, a. 735?, Idem, 59, a. 736, Idem, 64, a. 737, Idem, II, n. 201, a. 774, Manaresi, n. 59, a. 854. Nei Fines Castellana.

19
75) Vianino di Varano Melegari (Parma, ma diocesi di Piacenza) (Vianinum ad basilica …), Schiapparelli, I, doc. n. 52, a. 735, (Idem, n. 54, a. 735 o 737), Idem, n. 60, a. 737. Vianino, a differenza dell’attuale dedicazione a San Giacomo, nel doc. n. 64, a. 737 di Schiapparelli, risulta soggetto a Sant’Antonino (Vianino ad basilica Sancti Antonini). Nei Fines Castellana. Il documento 54, senza data (o 535 o 537) e senza precisa data topica che dal contesto superstite sembra essere la basilica di Varsi, in analogia coi docc. 52, 60 e 64, potrebbe riferirsi alla basilica di Vianino. La località casale Cavallionano, con terra qui est frascario, non presa in considerazione da V. Fumagalli, può essere localizzata in base alle coerenze, che sono il rivo Lappaniacco et Ropina, intesi come rio della Pignolacca e al rio delle Rovine della parrocchia di Metti di Bore (Parma, ma diocesi di Piacenza), anche se una coerenza con casale Vianino crea qualche difficoltà interpretativa. Nei Fines Castellana. 76) Vignola di Fiorenzuola d’Arda (Viniola), Manaresi, n. 87, a. 879. La località doveva essere nei Fines Castellana ed identificarsi con Vignola di Borla di Vernasca. 77) Vigoleno di Vernasca (Vicus Leonis), Manaresi, n. 87, 879. Anche Falconi nel doc. 22, a. 849 parla di due abitanti di Vico Leoni, presenti a Niviano di Lugagnano. Nei Fines Castellana. Completamente errata l’identificazione di Vigoleno con Sancto Georgio de Viculo, fatta dal Campi, seguito nelle opere divulgative, poiché si tratta di Vigolo Marchese di Castell’Arquato la cui chiesa, dedicata a San Giorgio, era cappella della pieve arquatense. La dedicazione della chiesa monastica di Vigolo a San Giovanni è recenziore. Ci sono ottime probabilità che quello che viene considerato un “battistero” sia proprio la chiesa di San Giorgio. Lo dimostra il doc. n. 32, a. 841, edito da P. Galetti, dove si parla di Betolasco corrispondente a Batelasco di Vigolo Marchese, essendo richiamato il fiume Clavenna (Chiavenna) e Sacto Georgio. Per la presenza in loco di una “cella” del Monastero di Gravago si veda sotto). 78) Vigolo Marchese di Castell’Arquato (Viculum), Manaresi, n. 59, a 854 Nei Fines Castellana 79) Villora di Varsi (Parma, ma diocesi di Piacenza) (Villola), Manaresi, n. 87, a. 870. Nei Fines Castellana

20
LE CHIESE DI SANT’ANTONINO DI CASTRO FIRMO (ARQUATENSE) [E LA CHIESA DI SAN FERMO E RUSTICO DI PONTIANO (CARPANETO)]. Mons. Domenico Ponzini ha messo in evidenza che, nel 901, nel 924 e nel 1056, la pieve di Castell’Arquato aveva come patrono Sant’Antonino, a differenza di quanto è avvenuto in “seguito” con la dedicazione a Santa Maria Assunta37. Esiste, a conferma di questa documentazione storica inequivocabile, una carta dell’801, edita da Paola Galetti e Giulia Petracco Sicardi né “Le carte private della Cattedrale di Piacenza” in cui risulta che la chiesa (pievana) di Castro Firmo (Arquatense )38 era già dedicata a Sant’Antonino e non a Santa Maria Assunta. Nonostante l’identificazione (seppur in forma dubitativa) da parte delle due autrici, di Sant’Antonino di Castro Firmo con la chiesa (pievana) di Castell’Arquato e nonostante i documenti riportati da Ponzini, gli storici ritengono “ancora” come cosa “vera” che, al tempo dei Longobardi e precisamente durante il regno di Desiderio, la chiesa pievana del borgo medioevale fosse “già” dedicata alla Madonna. Questo perché “lo dice” il Campi, che si basa su una pseudo-donazione che un certo Magno, nel 758, avrebbe fatto al vescovo di Piacenza, della chiesa di Santa Maria e del luogo di Castel Quadrato o Alquadro che “appellasi oggi Castell’Arquato”39. In uno studio del 198840, che riprende l’ipotesi formulata da P. Galetti e G. Petracco Sicardi, sulla corrispondenza tra Castro Firmo e Castell’Arquato, ho messo in dubbio la veridicità della figura di Magno, anche se non avevo ancora l’assoluta prova della “inesistenza” di Santa Maria, come pieve di Castell’Arquato41. L’ipotesi, da me formulata, non è stata presa in considerazione nemmeno da qualche autore che possedeva “certamente” il mio estratto del Bollettino Storico Piacentino42. Gli studiosi, che si rifanno al Campi, hanno speso fiumi di parole sulla figura di Magno e su i suoi rapporti con Castel Quadrato o 37 Si veda Nuovo Giornale 7/11/1992, Libertà 9/11/1992 e 1995. 38 PAOLA GALETTI e GIULIA PETRACCO SICARDI: Le carte private della Cattedrale di Piacenza, I, (784-848), Parma, 1978, doc. n. 8, pp. 41-43, doc. n.11, pp. 46-48. 39 PIETRO MARIA CAMPI: Dell’historia ecclesiastica di Piacenza, vol. I, 1651, p. 299. Dove il Campi abbia trovato che il nome della località era anche Castel Quadrato o Alquadro resta un astruso mistero? (se non si tratta di qualche grossolano errore di scrittura). 40 GIACOMO COPERCHINI: Quadro ecologico e interpretazione storica del territorio piacentino-bobiense, in “Bollettino Storico Piacentino”, Piacenza, 1988, p. 265, nota 37. 41 Alla nota 37 affermo: <<…Nell’801 …vengono donati beni in …Antognano…alla chiesa di Sant’Antonino sido Castro Firmo (che le autrici identificano, seppur con qualche dubbio, con Castell’Arquato)>>. <<…poiché la chiesa non è dedicata a S. Maria, si prospettano due ipotesi: o è falsa la cosiddetta Donazione di Magno ….oppure la località (Castro Firmo) non corrisponde all’attuale Castell’Arquato>>. 42 Mi riferisco in particolare a Castell’Arquato. Arte e vita quotidiana dalle origini al tardo rinascimento di MARC LE CANNU, con un saggio di CARLO FRANCOU, pp. 46-49.

21
Alquadro, senza controllare la veridicità o meno della fonte di informazione a cui attinge il Campi43, ripreso alla lettera dal canonico Giuseppe Curati, cui si ispira F. C. Carreri44. La donazione di Magno è un “palese falso”, perché indica, Santa Maria, come dedicazione della chiesa di Castell’Arquato in periodo longobardo, e perché l’unità di misura del mosto, che doveva essere fornito, dal vescovo di Piacenza, alla stessa chiesa, è indicata in “veggiole”, ignote all’Italia Longobarda, che usava “anfore” e “congi”. (Per salvare la storicità di tale documento bisogna ammettere che il Campi abbia avuto tra le mani un apocrifo, rimanipolato e corretto secondo la situazione religiosa esistente al tempo della riscrittura dell’atto, …se esisteva un originale!). (Ritengo che al Campi sia stato passato del materiale “inventato”, ma “preso per buono” dallo storico, di cui Giorgio Fiori, nei recenti studi in suo onore, ha evidenziato la dabbenaggine45). Pertanto tutti gli studi sulla figura di Magno (da me messa in dubbio nel 1988) sembrano “pestar acqua in un mortaio”46. Bene ha fatto Massimo Pallastrelli a sbarazzarsene in quattro righe. La falsità o almeno la non genuinità del documento deve essere stata rilevata sia da Luigi Schiapparelli, sia Carl Richard Bruhl, che pur conoscendo il Campi, non riportano, nel loro Codice Diplomatico Longobardo, la “donazione” di Magno. Il falso e/o l’apocrifo rimaneggiato, non ha impedito al Vescovo di Piacenza di essere stato veramente il dominus di Castell’Arquato e non ha impedito alle clausole, contenute nella pseudo-donazione, di essere rispettate. Nell’801 Allerisso, ff. Valderisso, abitante a Vigo Rimilani quod est Sezade (Cascina Romiliana di Carpaneto Piacentino)47 dona a Giovanni “diacono” della chiesa Sancti Antonini marteris Christi sito Castro Fermo quanto possiede in casale Antoniano (Antognano di Lugagnano). Castro Fermo è certamente Castell’Arquato poiché nell’810 si parla di un territorio corrispondente ai finibus Castro Firmis Arquatense[t], indicando sicura identità tra Castro Firmo e Castro Arquatense.
43 GIGLIOLA SOLDI RONDANINI: Castell’Arquato dalla Pieve al Comune, in “Rivista Storica Italiana”, 1974. M. C. CIULLI: La pieve di Ccastell’Arquato nel sec. XIII, in “Piacenza economica” genn. 1975, p. 54 PIETRO CASTIGNOLI: I rapporti tra Castell’Arquato e Piacenza dall’alto medioevo alla metà del XIV secolo, in “Atti della seduta generale ordinaria del 18, 9, 1988 di Castell’Arquato della Deputazione di Storia Patria per le Province Parmensi. –sez. di Piacenza, s.d. (1989). 44 Per la citazione di G. Curati, si veda MASSIMO PALLASTRELLI: Castell’Arquato. Il Comune e la Pieve nei secoli XIII-XIV, Piacenza, 1991, p. 10. 45 GIORGIO FIORI: La credibilità di Pier Maria Campi, in PIERRE RACINE (a cura) “Studi in onore di Pier Maria Campi”, Fondazione Piacenza Vigevano, Piacenza, 200, pp. 54-67. 46 In occasione di un ipotizzato corteo celebrativo, ho inviato alla stampa locale ed al Sindaco di Castell’Arquato le mie perplessità sulla valenza storica di Magno. Il lavoro è stato cestinato. 47 Libertà 6/8/1977

22
Tale identità è stata intuita da Paola Galetti e da Giulia Petracco Sicari, anche se le due autrici non l’hanno ulteriormente evidenziata per smentire l’affermazione del Campi e dei suoi epigoni. Nello stesso documento, Allerisso dona, a Teodero,diacono della chiesa Sancti Fermi et Rustici fundata in loco ubi dicitur Pontiano, quanto possiede in casale Castruciano (Casturzano di San Giorgio Piacentino). Da tale indicazione risulta che la pieve di Carpaneto, dedicata a San Fermo e Rustico, era localizzata a Ponziano (località attualmente scomparsa). UNA CELLA DEL MONASTERO DI GRAVAGO PRESSO “SAN GIORGIO” DI VIGOLO MARCHESE Michele Tosi, nel 1993 e nel convegno tenuto a Bobbio e Bardi nel settembre 1994, ha messo in evidenza la funzione delle “celle” monastiche, sia per quanto si riferisce all’evangelizzazione del mondo rurale in seguito anche alla crisi “tricapitolina”, dopo lo sfascio dell’organizzazione sociale del mondo romano, la guerra greco-gotica e l’invasione longobarda, sia per quanto si riferisce alla rinascita economica delle terre toccate dall’“esperienza” colombaniana. La stessa opera, in periodo longobardo, anche se con modalità diverse (a meno che vi sia stato un influsso diretto del monachesimo bobiense), deve essere stata portata avanti anche dai monasteri rurali “benedettini” quali Fiorenzuola, Tolla e Gravago, a cui si deve aggiungere quello di Mezzano in Val Trebbia. La difficoltà maggiore che si presenta nel definire correttamente l’incidenza monastica sulla popolazione e sul territorio, dipende da un’errata o carente identificazione dei toponimi, come ha messo in evidenza lo stesso Tosi48, sia per l’abbazia di Bobbio, sia per Fiorenzuola, Tolla, Gravago e Mezzano. Si ritiene pertanto opportuno, quando si hanno elementi probanti o almeno plausibili, proporre (o riproporre) alcune identificazioni toponomastiche, fuori dalle “solite cose” che si ripetono, con stucchevole monotonia, sulle “radici” dei paesi. Un lavoro di risistemazione toponomastica è stato auspicato anche dalla professoressa Giulia Petracco Sicardi fin dal 1978, quando, insieme alla professoressa Paola Galetti, ha dato alle stampe: “Le carte private della Cattedrale di Piacenza, I, (784-848)”. Il doc. n. 32 dell’anno 841 di tali carte è molto interessante. Esso permette di individuare una “cella”, con le sue terre, che il monastero di Gravago (Bardi – Parma – in diocesi di Piacenza) possedeva in Val Chiavenna e di chiarire l’origine, il significato e la dedicazione del cosiddetto “battistero” di Vigolo Marchese (Castell’Arquato), spezzando una lancia a favore dell’ipotesi di
48 Purtroppo lo stesso Tosi ha talvolta, in studi spesso richiamati dagli storici, preso grossi abbagli di natura toponomastica.

23
Massimo Pallastrelli, che, a ragione, identifica Sancto Georgio de Viculo con la frazione di Castell’Arquato e non con Vigoleno, come fa Pier Maria Campi, seguito da suoi epigoni. La presenza di una “cella”, piccola comunità cenobiale, se da un lato indica l’opera pastorale del monastero fondatore, dall’altro ne individua un centro di organizzazione agricola ed un punto di appoggio nei trasferimenti dei monaci da e per la casa madre. Sotto quest’ultimo punto di vista, la “cella” denotando l’esistenza in loco di una strada, (via publica) permette di ricostruire la viabilità nell’Alto Medioevo, senza ricorrere ad alcuna invenzione per poter attingere ai finanziamenti per la Francigena. Il documento è scritto in curte Carpeneto ed indica, come testimoni e racionatores, una persona (forse Bonello) che viene da Ciriliano, due altre, Perimundo e Gariberto, padre e figlio (che hanno certamente proprietà nelle località citate nel documento) che sono originari di Vico Sachiloni49 e Albino di cui non si conosce la provenienza. In esso Arnone, di stirpe franca, che opera a nome del Monastero di Gravago (ad parte ipsius Monasterii Gravaco) permuta delle terre col Vescovo di Piacenza Seufredo, che opera a nome della chiesa piacentina (la Cattedrale), mediante prete Gisulfo e l’avvocato Adroaldo. Il Vescovo cede tre pezze di terra arativa, in casale Betolasco, di 5 pertiche e una pezza di vigna con pratello, [in casale Betolasco] (come si evince dalla presenza di Perimundo che è confinante sia della terra arativa sia della vigna, e dalla presenza del pratello sui confini della terra arativa), di 2 pertiche e 6 tavole. La vigna col pratello hanno come confinanti lo stesso Arnone e Perimundo. Le tre pezze di terra arativa hanno come confinanti anche Erioaldo, una via e particolarmente il fluvio Clavenna. La descrizione termina (dopo una lacuna del testo) con la locuzione de cella monasterii Gravaco. Arnone, ad parte ipsius Monasterii Gravaco, cede tre pezze di terra [aratoria] [in Linaria]50 e in [casale] Betolasco e una quarta in Costa, per un totale di 2 iugeri51 e [2 ?] pertiche. Cede inoltre tre vigne in [Linari]a ed una quarta presso una cella del
49 Nell’846, doc. 40, Gariberto, detto Uberto, figlio del fu [Perim]undi, qui fuit abitator in Vico Sahiloni vende i suoi beni in Vico Sahiloni e Casaleclo. Nell’833, doc. 28, un Gariberto risulta libellario in fundo et loco Sancto Georgico ubi vico sahiloni dicitur, in casale Paredasco e in Fillerassi. 50 Ho integrato con [Linaria] la parte illeggibile del documento, in base a quanto è espressamente indicato successivamente. Meno sicura la mia ipotesi che una parte di terre cedute da Arnone siano localizzabili a Betolasco, perché nel testo potrebbe esserci un espressione del tipo <<in cambio delle terre in Betolasco>>. 51 Iugero: unità di misura di superficie di origine romana equivalente ad un rettangolo di 240 x 120 piedi (ossia circa 2500 m/q). Pertica: come unità di misura di lunghezza corrispondeva a dieci piedi, vale a dire a m. 2,96. Come unità di misura di superficie nel mondo romano corrispondeva a 600 m/q. (La pertica piacentina come unità di superficie corrisponde a circa m/q. 762). Piede: unità di misura di lunghezza ancora in uso attualmente nel mondo anglosassone pari a m. 0,3048. Tavola: unità di misura di superficie che sembra avere relazione col piede.

24
Monastero di Gravago (prope cella ipsius monasterii), per un totale di 2 pertiche e 6 tavole. Arnone aggiunge 14 tavole di terra arativa e 9 tavole di vigne per adeguare le dimensioni delle proprietà cedute dal Vescovo. I confini della prima pezza di terra [arativa], in Linaria, sono da un lato Sancti Georgi, dall’altro Aliberto, da un capo Arnone, dall’altro il torrente Clavenna; i confini della seconda (quella che corrisponde alla quarta), in Costa, da due parti una proprietà del monastero di Gravago, dalla terza gli eredi di Andrea, dalla quarta la via pubblica; i confini della terza (corrispondente alla seconda), in <Betolasco> o in Linaria, sono da un capo Arnone, da un lato e da un capo ?, dall’altro lato una proprietà del monastero di Gravago; i confini della quarta (corrispondente alla terza), in <Betolasco> o in Linaria, sono da un capo e un lato Erioaldo (certamente confinante in Betolasco), dall’altro lato una proprietà del monastero di Gravago, dall’altro capo ?. I confini della prima vigna in [Lin]aria sono da un lato Stadelberto, dall’altro e da un capo Staurace, dall’altro capo Arnone; quelli della seconda da un lato ed un capo una via, dall’altro lato la “sorte” di Sindolone, dall’altro capo Garifuso; quelli della terza da un lato una via, da un capo un rio, ….I confini della vigna presso la cella del Monastero di Gravago, sono da un lato e da un [capo] un possesso ([sor]te) dello stesso Monastero di Gravago, dall’altro lato una via dall’altro capo Orsone. Gli elementi, di cui si dispone, per individuare la localizzazione della cella del Monastero di Gravago, sono dunque, oltre al torrente Chiavenna (fluvio Clavenna), Costa, Sancti Georgi, Betolasco, Linaria, una Via Publica e, considerando i luoghi di stesura dell’atto e di provenienza dei testimoni, Carpeneto, Ciriliano e [Vico Sachiloni]. Non vi sono dubbi, a parte le possibili omonimie, che Carpeneto52 (in altri documenti corte del Vescovo di Piacenza) e Ciriliano corrispondano a Carpaneto Piacentino e a Ciriano di Carpaneto. L’abbondanza della coltivazione delle viti ed il toponimo Costa, anche se generico e diffuso in Val Chiavenna, fanno escludere la parte pianeggiante e indirizzare l’attenzione alla parte collinare di tale Valle: da Vigolo Marchese a Rustigazzo di Lugagnano. Proprio a Vigolo Marchese (oltre alla vicinanza con Ciriano) si trovano un agionimo ed un toponimo che indicano in quale luogo il Monastero di Gravago possedeva la sua cella. Essi sono Sancti Georgi e Betolasco. Prima che fosse fondata la chiesa di San Giovanni (1008), autonoma, come il monastero stesso, dalla pieve di Castell’Arquato, esisteva, ed è continuata ad esistere la chiesa di
52 Sono convinto, per gli elementi che si ricavano dal testo del doc. 15 a. 815 , che la silva qui dicitur Carpenetus, inter Mosa et Paperia, non sia da identificare con Carpaneto Piacentino, ma con una foresta nella zona delle Mose di Piacenza.

25
Sancto Georgio de Viculo, soggetta alla stessa pieve, come risulta nella notissima bolla di Bonifacio VIII del 1296. La chiesa di San Giorgio, documentata nell’841 e nel 1296, esiste ancora (a meno che se ne accerti la localizzazione in altra parte del territorio) anche se non ne porta più il titolo. È il cosiddetto “Battistero”. La pianta centrale, lo stile architettonico “barbarico” e non “romanico” del Battistero, lo fanno precedente alla chiesa monastica di San Giovanni e lo fanno coincidere con il San Giorgio documentato nell’841. Se l’attuale costruzione a pianta centrale è un rifacimento (più o meno ampio), lo è di un modello preromanico, o tardo-antico, o bizantineggiante che sia, ma non ha origine né significato, né funzione battesimale. Diversamente da quanto riferiscono alcuni studiosi, Vigolo Marchese, non è mai stato Chiesa battesimale o Pieve e tale da avere un eventuale battistero. Infatti il documento del Vescovo Sigifredo del 1031, che viene portato a prova della dignità plebana di Vigolo Marchese, perché vi si parla della pieve de Viculo, dedicata a San Salvatore, si riferisce ad un altro Viculo, e precisamente a Vigolo Val Nure di Bettola o, come si diceva una volta, Vicolo di Roncovero (di Bettola). La sua posizione culminante e centrale rispetto ad una porzione del territorio bettolese non lascia dubbi sulla sua primitiva funzione plebana (forse in sostituzione di un tempio pagano d’altura). La sua chiesa, soppiantata nella dignità plebana da Padri di Bettola (Plebs Paldarii), è ancora dedicata a San Salvatore. A dire il vero, in Val Chiavenna, c’è un’altra chiesa dedicata a San Giorgio: quella di Antognano di Lugagnano. Il toponimo Betolasco fuga ogni dubbio. A Vigolo Marchese, sulla sinistra del torrente Chiavenna, di fronte a Vigostano, c’è la località Batelaccio (detta anche Batelasso o Batelazzo) che certamente corrisponde a Betolasco. Le differenze col toponimo attuale “italianizzato” sono solo apparenti: il fonema dialettale corrisponde perfettamente. La dedicazione a San Giorgio, come ha evidenziato nei suoi scritti Domenico Ponzini, lega lo pseudobattistero al mondo bizantino o, tramite re Cuniberto (688-700), al mondo longobardo. Se nella fondazione del Monastero di San Giovanni di Vigolo Marchese, non si parla mai della chiesa (battistero) di San Giorgio, è perché questa dipendeva dalla pieve di Castell’Arquato, e quindi non aveva niente a che vedere col Monastero, anche se “a due passi”. Più importante sembra il fatto che il Monastero è stato fondato là dove già esisteva una “cella”, forse la più importante cella del Monastero di Gravago. Da un semplice toponimo come Betolasco, si possono ricavare “importanti” tracce artistiche, religiose, economiche e sociali.

26
Spero che queste note possano chiarire l’identità di alcuni toponimi con quelli riportati nelle carte altomedioevali e stimolino un dibattito sulla loro più o meno coerenza coi documenti storici la cui edizione è, purtroppo, a distanza di anni, ancora molto lacunosa.








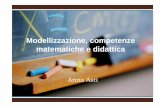






![DOVE REPERIRE LE VERSIONI DEGLI ... - Zucchetti Software · Zucchetti Elaborazoni [ZUCCHETTI SOFTWARE s.r.l.] Stampe Utilità Finestra ? O INFORMAZIONI PRODOTTO INFOVISION MLILTIESITD](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/5c69466909d3f2e4258ca052/dove-reperire-le-versioni-degli-zucchetti-software-zucchetti-elaborazoni.jpg)