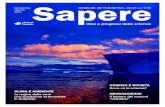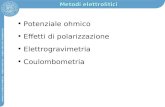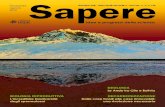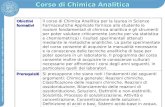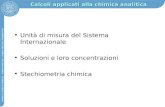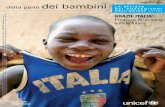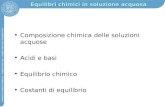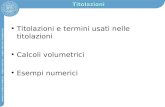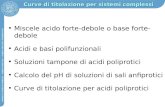Sviluppo storico ed aspetti attuali della chimica...
Transcript of Sviluppo storico ed aspetti attuali della chimica...

'( l
RASSEGNE
Sviluppo storico ed aspetti attuali della chimica tossicologica
STEFANO CHIAVARELLI E FEDERICO TOFFLER ( 0)
Laboratori di Chimica Terapeutica, Istituto Superiore di Sanità Istituto Chimico della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Cattolica S. C. ·Roma.
I. CENNI STORICI
La storia dei veleni ha la stessa età dell'umanità e l'inizio degli studi in questo campo può farsi risalire alle poesie didascaliche di Nikander sui veleni ed avveleni che, nel 20 secolo a. C., descrivevano i sintomi delle malattie conseguenti ad ingestione di oppio, bianco di piombo, ecc. Non troviamo però nessuna traccia nella storia di quell'epoca e dei secoli successivi sui mezzi di riconoscimento degli stessi veleni. Per lungo tempo un avvelenamento poteva essere riconosciuto solo in base ai sintomi direttamente osservati.
Sebbene nel 7° secolo lo studioso greco Stephanos di Alessandria osservasse già che l'anidride arseniosa, arroventata in fuoco di carbone, colora in bianco le superfici di monete di rame lucido, nei tempi dell'alchimia si vedeva in questo fenomeno soltanto un'apparente nobilizzazione d el rame in argento, ma non una reazione di riconoscimento dell'arsenico. Solo occasionalmente venivano utilizzate constatazioni fortuite per il riconoscimento di sostanze velenose. Nel 120 secolo per esempio, Al-Nabarawi, scrittore arabo, riferiva che nelle farmacie egiziane si usava abusivamente l' acetato di piombo per depurare sciroppi zuccherini di qualità scadente. Questo trattamento nocivo alla salute veniva rivelato con un metodo assai primitivo, ma, d'altra parte, ingegnoso : lo sciroppo sotto sospetto veniva diluito con acqua e sottoposto alle esalazioni di sostanze fecali mettendolo sopra l'apertura di una latrina . Se si colorava in nero - e ciò per la costante presenza di idrogeno solforato che precipitava il piombo come solfuro di piombo - si aveva la prova della presenza di piombo ed il commerciante veniva punito dalla legge. Potremmo considerare questa dimostrazione di sofisticazione sia come la
(0
) Centro di Chimica del Farmaco e delle Sostanze Biologicamente Attive del C.N.R., Sezione II presso ·l'Istituto di Chimica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica S. C. Recapito : Istituto Superiore di Sanità.
Ann. Ist. Super. Sanità (1968) 4, H5·4 58.

446 RASSEGNE
prima reazione chimico-tossicologica, che come la prima applicazione analitica dell'idrogeno solforato.
Ad un livello certamente più evoluto si t rovava l 'analisi chimico-tossicologica d el 17° secolo, quando già si conoscevano altre reazioni di identificazione per il riconoscimento degli elementi velenosi (As, Sb, Pb) ; tuttavia queste non avevano ancora il significato di vere reazioni chimico-tossicologiche per l'identificazione di veleni eventualmente presenti negli alimenti, nel corpo umano o animale. In quest 'epoca venivano introdotti, da Robert Boylc (1627-1691), i concetti di analisi, reazione e reagente aprendo così la possibilità alla chimica analitica di elevarsi a livello di scienza ed aprendo contemporaneamente anche la strada per la nascita e lo sviluppo d ell 'analisi chimico-tossicologica nel senso moderno.
Una sofisticazione abbastanza frequente in quei t empi contribuì ancora allo sviluppo dell'analisi chimico-tossicologica. Per il « miglioramento >> dei vini agri si utilizzava un antichissimo metodo, probabihz~ente di origine romana, cioè la d eacidificazione del vino con ossido di piombo. Già i romani rendevano più gustoso il vino agro concentrando il mosto ad un t erzo in recipienti di piombo ed aggiungendolo poi al vino. Poichè gli acidi organici possono attaccare fortemente il piombo, durante questo trattamento si precipitava non solo una parte degli acidi organici del vino, come sali di piombo poco solubili, ma i '' plumbea vina >> inoltre contenevano piombo in quantità maggiore o minore, sotto forma di sali dolciastri solubili. Al posto del piombo metallico - che agisce lentamente - i vignaioli più progrediti usavano anche l'ossido di piombo. Naturalmente, questo nocivo diffusissimo '' miglioramento n causò numerosi avvelenamenti da piombo e la cosiddetta 11 malattia da vino >> richiamò ben presto l'attenzione degli scienziati per trovare un mezzo utile all'identificazione del piombo nel vino. Si conoscono molti tentativi in merito, e nel 1707 il problema divenne addirittura oggetto di una t esi di laurea - probabilmente fu la prima dissertazione su tema chimico-tossicologico - ; si formarono anche gruppi di ricer catori, come per esempio, la famosa scuola di Wiirttemb erg. Eberhard Gockel, fisico di Ulm, operava ricerche con acido solforico; Johann Vicarius di Friburgo con carbonato d'ammonio e potassio; il medico Mogling utilizzava un r eagente preparato con solfuro di arsenico (auripigmento) e calce viva, che originariamente era stato preparato per ottenere un inchiostro simpatico dal farmacista francese Brossan di Montpellier nel 1650. Aggiungendo questo reagente ad un vino contenente piombo, si formava una torbidità nera oppure un precipitato di solfuro di piombo. Questa era la famosa prova wiirttemberghesca del vino, che nel 180 secolo fu anche ufficialmente introdotta in numerosi Paesi. Nel1787 Hahnemann migliorò questo metodo sostituendo il velenoso solfuro di arsenico con solfuro di calcio ed operando inoltre in ambiente acido perchè, nel caso di vini contenenti ferro, si evitava così la precipita-
.&nn. 1st. Buper. Banilt~ (1968) 4, H6·,68.
- -
l '

-. CIIIAVARELLI E TOFFLER 447
zione del solfuro di ferro e quindi un eventuale mascheramento dél piombo. Il chim.reo francese Fourcroy invece propose . come reagente la soluzione acquo11a di idrogeno · solforato, che mezzo secolo più tardi . era destinata a diventare veramente la base della classic.a sistema~ione analitica di Fresenius.
Importanza anc'ora .maggiore del piombo costituiva il riconoscimento dell'arsenico, veleno fondamentale e molto usato in tutti i
1tempi. Per la sua
identificazione si usava prima· di tutto, la cositidetta colorazione. bianca .del rame mediante arsenico, a cui precedentemente abbiamo accennato. Un'altra prova consisteva nel buttare su carbone incandescente il materiale so&petto dello stomaco - anti addirittura tutto il cadavere - allo scopo di con.statare_ l'eventuale comparsa di un odore agliaceo. L ' identificazione più cc scientifica» di quei tempi è dovuta al tossicologo Hahnemann che effettuava-l'estrazione dell'arsenico dallo s tomaco con acqua e lo precipitava in ambiente acido sotto forma di solfuro di arsenico con una soluzione acquosa di idrogeno solforato. Ridotto poi con carbone, l'arsenico era riconosciuto dall'odore agliaceo carat· teristico. Insieme ad altre reazioni di riconoscimento per l'arsenico, Hah- • nemann descriveva, nella sua monografia pubblicata nel 1786, le reazioni di altri elementi tossici, come Hg, Cu, Sb, Pb, con soluzione acquosa di idrogeno Sf?lforato. Possiamo considerare queste reazioni come uno stadio · preliminare dell'utilizzazione dell'idrogeno solforato nel procedimento sistema· tico analitico di separazione di Remigius Fresenius.
Ai progressi della chimica analitica nella seconda metà del 180 secolo· hanno contribuito molto i lavori di Torbern Bergman (1735-1784) che si può considerare come il fondatore dell'analisi per via umida. In generale, si può dire che una scienza sta diventando disciplina indipendente solo quando la suà materia scientifica viene riassunta in un libro di testo scolastico. Per l'analisi chimico-tossicologica questo si è verificato nell803, quando Wilhelm Remers pubblicò il suo famoso libro : u Lehrbuch der polizeilich-gerichtlichen Chemie >>, -in cui riassumeva, in modo molto chiaro, i metodi chimicoanalitici tossicologici noti a quell'epoca. Così per il riconoscimento del piombo riconfermava la prova di Hahnemann, ma in modo ancora più inequivocabile, ricorrendo all'incenerimento finale del residuo secco ed alla riduzione fino ad ottenere un globuletto metallico, mentre, per !?identificazione dell'arsenico, raccomandava la riduzione mediante carbone con formazione di unò specchio arsenicale in un matraccio. Inoltre, discuteva sia del riconoscimento 1
di altri elementi, .. come Au, Ag, Hg, Cu, Zn, Sb, che dell'identificazione di acidi, di 'alcali caustici, dell'allume, della barite e ,dei veleni ad azione meccanica (gesso, vetro), ecc. Circa i veleni animali e vegetali accennava solo che la loro identificazione è molto difficile se non addirittura impossibile. Ampia parte dedicava al riconoscimento delle adulterazioni degli alimenti e ad un insieme di ricerche chimico-tossicologiche che sono ancora citate nei moderni libri di laboratorio.
.dnn. Ist. Super. Sanità (1968) 4, t46·458.

448 RASSEGNE
Il problema più importante dell'analisi tossicologica di quei t empi cioè l 'identificazione dell'arsenico - è stato risollo definitivamente solo dal chimico inglese James Marsh (1790-1846) . Egli ebbe l 'idea geniale di separare l'arsenico dal materiale in esame sotto forma di idrogeno arsenicale volatile . L'apparecchio che costruì a questo scopo era l'imitazione dell 'acciarino di Doberein e quindi non somigliava ancora all'apparecchio di Marsh da noi attualmente conosciuto. In un tubo a forma di cc U ll, munito di un rubinetto, venivano sviluppati dall'estratto acquoso dello stomaco, acidificato con acido solforico e da una lamina di zinco, idrogeno ed idrogeno arsenicale insieme. La miscela di gas che effluiva dal rubinetto, incendiata, formava su di una lastra di vetro sovrapposto uno specchio arsenicale grigio o n ero. Liebig successivamente consigliò di condurre la miscela dei gas attraverso un tubo di vetro riscaldato, p er la separazione quantitativa dell'arsenico. In questa veste definitiva è entrata poi n ell 'analisi chimico-tossicologica la prova di Marsh, che si dovrebbe quindi chiamare più propriamente prova di MarshLiebig.
Più semplici, ma non così specifici, sono il metodo di Gutzcit, nel quale l'idrogeno arsenicale viene identificato con nitrato d'argento, e quello di Mayencon e B ergcret, che al posto di sali d 'argento utilizzavano sali di mercurio.
Si è riconosciuto pres to che la sensibilità e precisione della prova di MARSH -LIEBJG aumentano ancora, se il materiale organico contenente l'arsenico viene mineralizzato prima dell'esame. Una delle possibilità è la disgregazione conosciuta oggi come m etodo di Fresenius-Babo-Ogier, mediante trattamento con clorato di potassio ed acido cloridrico gassoso a temperatura non molto elevat a . Attualmente questo metodo è soppiantato spesso da altri in cui si usano acido solforico concentrato ed acido nitrico, acido perclorico oppure peridrol e n ei quali si impedisce con l 'uso di apparecchi particolari la perdita degli elementi volatili. Naturalmente, i metodi di distruzione originalmente creati per scopi chimico-tossicologici possono essere utilizzati indifferentemente anche per l 'analisi chimica d egli alimenti, ad esempio, p er la determinazione di impurezze metallich e nelle conserve, di residui di anticrittogamici, di insetticidi e di mezzi di conservazione negli alimenti di origine vegetale, ecc. Già nel' 1844 R cmigius Fresenius proponeva di creare una serie di metodi standard analitico-tossicologici e pen sava che tali m etodi potevano essere messi a punto senza alcuna difficoltà per quanto riguardava i veleni inorganici . Tuttavia, questa proposta non venne poi mai realizzata.
Alcuni anni dopo fu descritta da Fresenius e Babo un'altra prova per l'identificazione chi~ico-tossicologica dell'arsenico, secondo cui l' arsenico veniva precipitato come solfuro e poi successivamente ridotto con cianuro di potassio e carbonato di sodio in corrente di anidride carbonica : in queste condizioni solo l ' arsenico e non l'antimonio si separa sotto forma di specchio
.o'lnn. /al. Super. Sanità (1968) 4 , 44 6-458 .

CIIIAVARELLJ E TOFFLER 449
metallico .. Ciò rappresenta un vantaggio notevole rispetto al metodo di MarshLiebig - specialmente se sono presenti l'arsenico e l'antimonio insieme -nel quale lo specchio arsenicale doveva essere ancora identificato con ulte
riori prove. In quell'epoca veniva infine descritto un altro metodo di riconoscimento
d ell'arsenico, ancora oggi in uso, cioè la prova di R einsch. Questa ha il vantaggio di esser e eseguibile anche in presenza di sostanze organiche e quindi, ad esempio, direttamente sul contenuto dello stomaco. Una lamina di rame viene scaldata nella soluzione in esam e, acidificata con acido cloridrico ; in presenza di sostanze arsenicali precipita sul rame un rivestimento grigio di pentaarseniuro di rame che, riscaldato in presenza di aria, si trasforma facilmente in anidride arseniosa riconoscibile microscopicamente dalla sua forma cristalJjna caratteristica.
Quindi, mentre per i veleni minerali (As, Hg, Pb, ecc.) già si conoscevano i me todi adatti agli esami chimico-tossicologici tra la fine del 180 secolo e l'inizio del 19o, per i veleni vegetali tali metodi non esist evano ancora e, nel caso di avvelenamento con i veleni vegetali, si cercava di identificare morfologicamente qualche parte della pianta velenosa. Ben presto iniziava tuttavia una nuova fase di sviluppo, in quanto l'interesse legale si spostava dai veleni inorganici a quelli di natura organica e prima di tutto agli alcaloidi. i più importanti dei quali erano stati scoperti proprio nella prima mf'tà del 19o secolo.
Il primo problema da risolvere riguardava l 'isolamento in forma pura dei veleni vegetali provenienti da un organo, rendendoli così idonei all'analisi ehimico-tossieologiea. Come già accadde nella s toria della chimica tossicologica, Io stimolo a sviluppare nuovi metodi fu fornito anche questa volta da un fatto criminale ; nel 1850 infatti, il conte Bocarmé avvelenò suo cognato con la nicotina isolata da lui s tesso dal tabacco. Le analisi chimiche riguardanti questo caso furono affidate al professore di chimica di Bruxelles, J . S. Stas, che elaborò un metodo per isolare la nicotina da materiali provenienti da un organo. Il metodo si basava sull'osservazione che i sali acidi d egli alcaloidi sono solubili sia in acqua che in alcool e che le basi liberate con a lcali delle soluzioni acquose possono essere estratte con etere etilico. Il m etodo è stato poi modificato da J . Otto, il quale ha introdotto un'ulteriore, estrazione con etere di petrolio, per a llontanare impurezze solubili in etere etilico. Questo m etodo, originariamente creato solo per l'isolamento di un determinato gruppo di veleni veget ali, in seguito è diventato di grande impor~ tanza per la storia della chimica tossicologica ed è ancora oggi conosciuta a tutti i tossicologi come metodo di Stas-Otto-Ogier.
Nella seconda metà del 19o secolo si pongono finalmente le basi di quei metodi che oggi permettono aJia chimica tossicologica di assolvere i suoi vas tissimi compiti. Si debbono brevemente ricordare ad esempio la « capillar-
.dnn. / st. Supa. Sanità (1968) 4 , 446-458.

450 RASSEGNE
analisi n di Schonbein e Goppelsroder e le reazioni alla tocca su carta da filtro, che si possono considerare i precursori della cromatografia su carta ; ed infine, l'analisi spettrale introdotta da Kirchhoff e Bunsen n el 1859. Nel 1865 Hoppe-Seyler descrisse l' identificazione dell'ossido di carbonio nel sangue, mediante lo spettro di assorbimento. Nel 1881 Hartley utilizzò per la prima volta lo spettro di assorbimento ultravioletto per l'identificazione tossicologica dell'aconitina. In questo modo, l' analisi chimico-tossicologica vedeva crescere parallelamente sia i compiti, sempre nuovi e più complessi ad essa affidati, che i mezzi a sua disposizione per risolverli.
II. COMPITI E METODI DELLA CHIMICA TOSSICOLOGICA CONTEMPORANEA
« La chimica tossicologica deve aspirare a determinare la minima quantità di sostanza tossica nel modo più sicuro possibile )),
In questa unica frase vediamo concentrate tutte le difficoltà che deve affrontare oggigiorno il chimico tossicologo per poter risolvere in modo soddisfacente i vari problemi a lui affidati. Oggi spesso egli ha a che fa.re non solo con alcuni veleni minerali od alcuni alcaloidi, ma anche con un numero continuamente crescente di medicinali sintetici come pure di pesticidi, di erbicidi, di esfoglianti, di sostanze nocive alla salute usate industrialmente : solventi, ecc. Inoltre, anche nell'ambito dei singoli gruppi si deve ricercare un numero sempre maggiore di sostanze. P er poter meglio sottolineare l'evoluzione svoltasi in questo senso negli ultimi 125 anni, basta osservare che, mentre in base ad un'osservazione di Liebig - forse non del tutto attendibile - nel 1842, per il 99 % dei casi di avvelenamento veniva preso in considerazione l'acido arsenioso, viceversa, secondo dati statistici, nel 1962 in Inghilterra l'arsenico entra in causa solo in due su 1450 casi di avvelenamento a scopo suicida ed in nessuno dei casi di intossicazione accidentale. Diventano invece predominanti come mezzi di avvelenamento gli analgesici ed i narcotici, e, primi fra tutti, i derivati dell' acido barbiturico. Nella Germania Occidentale ad una statistica di questo genere si aggiungono anche i pesticidi a base di paration. Da 15 anni, infatti, queste sostanze sono diventate di dominio pubblico a causa di un processo sensazionale e da allora, per una specie di psicosi indotta, vengono utilizzati spesso a scopi criminali ed in casi di suicidio.
Anche gli avvelenamenti da ossido di carbonio sono in aumento, d ata la sua presenza non solo nel gas illuminante, ma anche nei gas industriali, nei gas dei fumaioli e nei gas di scarico dei motori a scoppio e degli impianti di riscaldamento mal funzionanti. Altrettanta importanza hanno gli avvelenamenti industriali ed avvelenamenti accidentali in casa ; questi ultimi hanno una notevole tendenza a crescere : nel1965 se ne r egis trano 25 milioni di cui 28.500 mortali .
.d nn. IBI. Super. Santi~ (1968) 4, H 5·•58.

CBIAVARELLI E TOFFLER 451
Brevemente abbiai!lo accennato quindi ai vari problemi attuali che l'analisi chimico-tossicologica deve risolvere. Naturalmente l'accrescersi ed il complicarsi dei problemi connessi con l'identificazione ed il dosaggio delle sostanze tossiche impone un continuo processo di adeguamento dei metodi in uso in questo campo. Questo significa anche che il chimico tossicologo deve avere una preparazione maggiore di una volta, deve conoscere in modo sicuro ed esatto le diverse tecniche applicate per le ricerche, la loro specificità e sensibilità.
Esaminando le possibilità analitiche a disposizione del chimico tossicologo moderno, appare caratteristica la combinazione dei classici metodi di disgregazione e di preparazione - usati per isolare le sostanze tossiche e per separarle in gruppi analitici principali - con metodi moderni e l'identificazione dei veleni eseguita cqn metodi chimico-fisici. Cosicchè ancora oggi molti analisti per la determinazione dei veleni organici preferiscono il metodo tradizionale di Stas-Otto-Ogier (l), per la sua applicabilità universale ai più svariati materiali. Una delle ·molte varianti di questo metodo assai usato, è nota come metodo di Daubney e Nickolls (1), e consiste nel precipitare con solfato d'ammonio i prodotti che possono interferire, in modo da permettere poi .una efficace e rapida estrazione.
Per l'analisi del paration, contenuto in materiali provenienti da organi, e specialmente per la ricerca contemporanea di questo veleno e dei suoi prodotti di decomposizione, si è affermato il metodo rapido di separazione, elaborato da Feldstein e Klendshoj (1). Mediante distillazione in corrente di vapore si separano dapprima i veleni volatili, il residuo della distillazione si filtra per eliminare le proteine coagulate col calore e così pure - dopo aver raffreddato sufficientemente - i grassi. Successivamente si procede all'estrazione cloroformica.
Per l'identificazione dei barbiturici si preferiscono generalmente metodi più veloci, come la deproteinizzazione con wolframato di sodio oppure metodi speciali, come quello di Dressler ('), basato sulla concentrazione sotto vuoto degli estratti grezzi e successiva estrazione frazionata. Da questi estratti, i sonniferi vengono poi ottenuti in forma pura e riconosciuti con il punto di fusione. ../
I metodi moderni di estrazione , diretta (6), che sembra debbano avere un migliore avvenire, si adattano inoltre e principalmente a determinazioni quailtitative. Il tessuto finemente omogeneizzato - dopo la stabilizzazioD;e del pH a valori definiti - viene estratto con solventi organici non miscibili con acqua.
Anche la separazione dei veleni isolati secondo gruppi analitici, e cioè in singole frazioni, procede secondo il metodo classico di Stas-Otto-Ogier ; allo scopo di comprendere il maggior numero di sostanze possibili esso viene suddiviso in più vie, rispetto alla sua forma originale nella quale si conside-
Ann. !st. Super. Sani/4 (1968) 4, 445·458 .

452 RASSEGNE
rava soltanto l'isolamento di alcaloidi. Una delle variazioni più moderne e complete di un 'analisi chimico-tossicologica totale è stata elaborata dal chimico tossicologo inglese Curry (•), che separa i veleni organici in diver se frazioni, tramite estrazioni successive con solventi diversi ad un determinato pH.
P er i residui delle singole frazioni, in generale valgono i vari metodi di riconoscimento delle sostanze isolate e pure, cioè microdetcrminazioni colorimetriche o di precipitazione, determinazione del punto di fusione, metodi cromatografici e sp ettrofotometrici, ccc.
Una descrizione precisa di tutti i metodi esistenti esula dai fini che questa rassegna si propone, ma è indispensabile ricordare brevemente almeno i più importanti ed i più recenti di questi.
Metodi cromatografici (').
Le t ecnjche cromatografiche sono della massima importanza per l'analisi chimico-tossicologica contemporanea. Esse debbono la loro diffus ione alla quasi universale applicabilità, all'alto grado di separazione delle miscele di sostanze organiche ed al fatto che richiedono piccolissime quantità di materiale. La separazione cromatografica in generale si basa su fenomeni fisici, cioè sulla suddivisione di una o più sostanze tra due fasi - di cui una è generalmente ferma (fase stazionaria) e l'altra invece è mobile - . Detta separazione è legata alle differenti proprietà fisiche d elle sostanze ed all'int erazione tra le forze superficiali della fase st azionaria c delle sostanze chimiche st esse. Il cammino percorso da una sostanza nel cromatogramma, è funzione del meccanismo fisico operativo che si sfrutta n ella separazione cromatografica e determinato da un equilibrio esistente tra fase stazionaria c fase mobile . Si distinguono tre principali tipi di meccanismi fisici operativi e, quindi, tre sistemi cromatografici : adsorbimento, ripartizione e scambio ionico. In pratica tutti e tre i tipi di meccanismi operativi si svolgono più o m eno simultaneamente, ma con predominio di uno sugli altri.
La cromatografia su carta , su strato sottile, su colonna, di scambio ionico e la gascromatografia costituiscono le diverse modalità di applicazione di questo metodo di separazione.
Cromatografia su carta. - La cromatografia su carta è una forma speciale della cromatografia di ripartizione, che per la sua semplicità e facilità di esecuzione rappresenta uno dei metodi più brillanti per la separazione ed il riconoscimento di miscele di composti organici . In questo caso particolare le fibre cellulosiche della carta da filtro fungono da supporto e la fase stazionaria è rappresentata dall'acqua fissata sulla carta, mentre il solvente applicato per sviluppare il .cromatogramma funge da fase mobile . Una goccia di soluzione, contenente alcuni microgrammi della sostanza o della miscela di sostanze da analizzare viene posta sulla carta a pochi centimetri di distanza
.dnn. ! st. Super. Sanità (1968) 4, 44 5·4.58 .

CillAVAIIELLI E TOFFLER 453
dal bordo dal quale la fase mobile entrerà nella carta. Dopo evaporazione all'aria del solvente in cui era sciolta la. sostanza in esame, il cromatogramma viene sviluppato irrigando la carta con solventi organici saturi d'acqua. Secondo il modo di scorrimento della fase mobile, si . hanno procedimenti diversi : ascendente, discendente, radiale e bidimensionale. Dopo lo sviluppo la carta viene essiccata in corrente d'aria e le sostanze in esame separate vengono rese visibili con opportuni reattivi. Il rapporto tra distanza del punto di partenza e posizione della macchia e tra punto di partenza e fronte della fase mobile (Rf), in determinate condizioni, è costante e caratteristico per ogni sostanza ; quindi, può servire per l'identificazione della sostanza stessa:-
Il metod~ si presta anche a determinazioni quantitative, eluep,d.Q dalla carta, con opportuni solventi, i componenti della miscela separati.
Sul piano analitico-tossicologico il metodo cromatografico su carta -in origine applicato alla separazione degli amminoacidi - è oggi indispensa· bile per l'identificazione di alcaloidi, barbiturici, sonniferi non barbiturici, ecc. Esso può essere combinato con altri metodi analitici, ad esempio con quelli spettroscopici di assorbimento, ecc. Il vantaggio del metodo cromato· grafico su carta n9n sta solo nel fatto di permettere la separazione di picco· ]issime quantità di sostanze in miscele complesse - ciò che è· offerto anche dai metodi cromatografici su colonna e dalla gascromatografia - ma anche nella alta specificità di identificazione, in quanto .questa può àvvenire mediante la cromatografia simultanea .con sostanze di confronto.
Cromatografia su strato sottile. - Sempre crescente è l'importanza della cromatografia su strato sottile (8) che è stata portata da Stahl (') ad una forma adatta anche alle analisi di r9utine. La tecnica generale di questo me· todo 'assomiglia molto a quella su carta. La fase stazionaria è qui rappresentata da uno strato sottile di un adsorbente (gel di silice, cellulosa, ecc.) unito ad un legante (amido, gesso), distribuito in forma omogenea su l~stre di vetro ; per fase mobile, si usano solventi o miscele di solventi organici.
Rispetto alla cromatografia su carta, questo metodo ha i vantaggi di una maggiore selettività - si formano macchie rotonde, nettamente circo· scritte- di una più alta sensibilità, riproducibilità e di tempi di cammino molto brevi e, quindi, di una maggiore rapidità. Ulteriori vantaggi sono rap· presentati dal fatto che si possono - analizzare contemporaneamente piccolissime quantità di almeno 17 diverse sostanze (su lastra di 20 X 20 cm), e si possono usare anche rivelatori aggressivi - non adatti invece per la carta - . L'uso di rivelatori chimici diventa addirittura superfluo quando si impieghi il gel di silice fluorescente: in questo caso le macchie si rivelàno con l'ispezione a luce ultravioletta. A questi vantaggi si aggiungono la semplicità del metodo ed il suo basso costo. Si deve inoltre notare che anche questo metodo è adatto non solo all'analisi qualitativa delle sostanze, ma, come è
.dnn. lsJ. Supu. Sanità. (1968) 4, 445·458.

454 RASSEGNE
stato dimostrato pure da noi {1°), m ediante una tecnica particolare, a separare miscele complesse - non separabili nemmeno con cromatografi a su carta - e, dopo l ' individuazione dei singoli componenti, a determinarne la loro quantità. Concludendo, anche questo metodo è diventato indispensabile per il chimico tossicologo.
Cromatografia su colonna. - A differenza dei precedenti, i metodi cromatografici su colonna sono meno usati p er scopi chimico-tossicologici analitici, in quanto richiedono un tempo maggiore per le preparazioni e non perm ettono inoltre di cromatografare contemporaneamente le sostanze da analizzare e quelle di confronto. Tuttavia, la cromatografia su colonna è il metodo più opportuno per separazioni quantitative di miscele. La soluzione della miscela da separare viene fatta passar e attraverso l 'adsorbente o supporto posto in un tubo di vetro munito di un rubinetto (colonna cromatografica). Le sostanze presenti n ella miscela si fissano sull'adsorbente. Per lavaggio della colonna con solvente o miscele di solventi, si sviluppa il cromatogramma, cioè le sostanze costituenti la miscela prendono posto a diversi livelli a seconda della loro affinità con l'adsorbente ; continuando l'eluizione possono essere raccolte in diverse frazioni di eluato, corrispondenti alle diverse zone formatesi nella colonna. Se le sostanze sono colorate, e quindi le varie frazioni sono visibili, la separazione può anche a v venire tagliando la colonna secondo le zone e procedendo successivamente alla eluizione. I più comuni adsorbenti in u so sono : gel di silice, acido silicico, allumina , amido, cellulose, ecc.
Gascromatografia. - Il metodo cromatografico da cui l ' analisi tossicologica può aspettarsi la soluzione di molti suoi problemi attuali, è la gascromatografia che s i basa sull'impiego di un gas come fase mobile (elio, argon, azoto, idrogeno, ecc.). Si ha una cromatografia gas-solid~, se la fase stazionaria è solida (allumina, gel di silice, carbone, cellite, cromosorb, ecc.) ed una cromatografia gas-liquido, se la fase stazionaria è liquida (poliesteri di glicoli con acidi adipico e succinico, silicone, ecc.). La fase liquida in generale viene realizzata sotto forma di film che riveste particelle solide di un supporto inerte o la superficie interna di colonne capillari. Senza entrare nei dettagli che caratterizzano questi due tipi di cromatografia si può dire che, in questo m etodo, il materiale da esaminare (gas, liquido volatile o soluzione di una sostanza solida) viene introdotto nella corrente di gas eluente, che lo trasporta attraverso una colonna cromatografica. Ciascun componente del campione si distribuisce allora in maniera caratteristica fra la fase gassosa e la.fase stazionaria. La frazione nella fase gassosa si sposta con la corrente di gas di trasporto, per cui i composti man mano si separano ed escono dalla colonna con la corrente effiuente in tempi diversi. Uno strumento di rivelazione, basato sulla misura della conducibilità termica, o sulla ionizzazione di fiamma oppure di raggi p, p ermette di registrare in un diagramma il passaggio dei
.Ann. lsl. Sv.per. Sanità (1968) 4, 44 5-(58.

•'
,.
CBlA V AJIELLI E TOPl'LER 455
singoli componenti. Un sistema registratore trasfo~a la risposta amplificata del rivelatore sotto forma di picchi. Le sostB:DZe. vengono identi.fìcate qualitativamente in base al tempo necessario ad effluire dalla colonna (tempo di ritenzione), e quantitativ amente dall'area del picco.
La possibilità di determinare una o più sostanze sottoponendo ad una unica operazione quantità piccolissime del materiale in esame co~ce uno dei grandi vantaggi di questo metodo che garantisce anche un'ottima separazione delle sostanze ed un'alta riproducibilità anche dal punto di vista quantitativo. Tuttavia, il metodo può essere utilizzato solo per le sos~~er termostabili ; inoltre, la non specificità dei detectors impone .- nella maggior parte dei casi - di integrare questo metodo con altre tecniche analitiche, come per esempio, la spettrografia infrarossa, ecc. In effetti, un gascromatogramma non è altro che un seguito di picchi più o meno spiccati, che naturalmente debbono essere identificati. Questo metodo si adatta principalmente alla soluzione di problemi speciali, quali ad esempio quelli della chimica tossicologica industriale, dove si debbono prendere in considerazione soltanto alcune sostanze ben definite (solventi o miscele di gas industriali) . Sempre maggiore applicazione trova la gascromatografia anche nelle ricerche chimico-analitiche tossicologiche, specialmente in alcuni campi di particolare interesse, come per esempio nella determinazione degli alcoli in soluzioni acquose, nella determinazione dei sedativi ipnotici (i cosiddetti « farmaci neutri » tipo carbromal, bromural, meprobamato, doriden, ecc.), in materiali di origine biologica, nell'identificazione di vari farmaci, come amfetamina, scopolamina, acido salicilico, morfina, librium, caffeina, steroli, ecc. Incoraggianti risultati sono stati ottenuti anche da noi nella determinazione quantitativa dell'atropina in composizioni farmaceutiche.
Cromatografia di scambio ionico. - Una trattazione dettagliata di questa tecnica particolare esula dai limiti di questa esposizione ; è tuttavia necessario accennare brevemente solo ad una sua applicazione specifiC?a e cioè al metodo analitico di attivazione neutronica con una tecnica di separazione rapida a scambio ionico dell'ar se.nico in materiali biologi9i. Questo metodo consiste nell'irradiazione del materiale in esame e nel successivo trattamento con una miscela di acidi (solforico - nitrico - perclorico) ed evapO'l'azione a secco. Il residuo, sciolto in acido solforico diluito (0,0005 M), si fa passare su una colonna di una r esina scambio cationico.
L'ar senico eventualmente presente nel materiale biologico viene trasformato in ione arseniato e può essere separato dagli altri elementi interferenti - come sodio e rame - che rimangono in forma cationica facendo passare la soluzione acida su colonna a scambio cationico. L'arsenico (76) viene determinato nell'eluato mediante il conteggio delle scintillazioni (11)·
2 ..4.nn. 114. Suz-. San11à (1968) 4, H6·458 .

456 RASSEGNE
M etodo elettroforetico P).
E lettroforesi su carta . - È questo un metodo di migrazione differenzia lr b asato sulla diversa mobilità in un campo elettrico delle molecole carich e presenti in una soluzione elettrolit ica (genera lmente una soluzione t ampone), post a su un suppor to costituito da car ta da filtro. Qu esto metodo analit ico ha un elevato p otere risolutivo e consente la separazion e di miscele complesse, in p articolare d i molecole organiche capaci di assu mere carica elettrica, t' di molecole capaci di dare complessi ionizzahili (amminoacidi , m acromolecoi C' proteiche, carboidrati, ecc.) . Lo spostamento, a p arità di intensità di campo elettrico e di dura ta dell'elettroforesi, è funzione d ella carica elettrica della sost anza , per cui è possibile, variando il pH del camp ion e, realizzar e la sep arazione dei componenti la miscela.
In generale, quello che è valido per la cromatografi a su carta vale anch e p er l'elettroforesi su carta, che per(, sembra non abbia trovato an cora una applicazione così v ast a, anche se l 'elettroforesi risulta perfino superiore a lla croma tografia su carta nella riproducibilità dci valori Rf r nella rapidità di separazione.
M etodi sp ettro(otometri.ci p er assorbimento (1) .
Potenti e t a lvolta insostituibili mezzi di indagine costituiscono per il chimico t ossicologo i metodi spettrofot ometrici per assorbimento. L'analis i spcttrofotomet r ica per assorbimento è basata sulle proprietà d ella ma ter ia di poter assorbire sclettivamente l'en ergia associata a determinat e r adiazioni elettromagnetiche. A seconda della region e del campo elettromagn etico, in cui av vien e l 'assorbimento, si distinguono : la spcttr ofotometria ultravioletta e del visibile, e la spet trofotornetria infrar ossa.
Spettro(otometria ultravioletta e nell'ambito del visibile. - L a spcttrofotometria ult ravioletta è molto u t ilizzata n ei laboratori chimico-tossicologici per la sua elevatissima sensibilità. Oltre all'identificazion e di veleni organici (alcaloidi, insetticidi, ecc.), essa v iene applicat a anche ai cont rolli ed alla det erminazione quantitativa dei farmaci, e tutto ciò perchè già piccolissime quantità sono sufficienti ad effettuar e gli esami.
L ' applicazione di questo metodo all' ident ificazione di sos tanze ignote richiede p erò una cer ta cautela ; è necessario infatti r icorrere anche ad altre prove analitiche e reazioni chimiche della sostanza, pr ima di giunger e a conclusioni definit ive, in quanto l' analisi sp ettrofotometrica ultravioletta non sostituisce, ma integra solo la ricerca chimica sist ematica. L' assorbimento ultravioletto di una sostan za assume un significato più sp ecifico, quando lo si modifichi con v ariazioni del pH in modo cara tteristico, com e per esempio n el caso dei b a rbiturici, della morfina c codeina, ecc .
.&nn. Jsl. Su]JC'. Sm>ilà (1968) 4, 445·458.

CRlAVARELLI E TOFFLER 457
Un esempio t1p1co eli analisi spettrofotometrica nell'ambito del visibile è la determinazione dell'ossido eli carbonio nel sangue. In questo campo, la maggior parte delle tecniche (11
) si basa sullo stesso principio utilizzato da Hoppe-Seyler per l'identificazione spettroscopica : con appropriati mezzi eli riduzione l'ossiemoglobina viene trasformata in emoglobina libera, mentre la carbossiemoglobina non subisce moelificazioni. Con Inisure eli estinzione ad una o più lunghezze d'onda, prima o dopo la riduzione si determina quanti· tativ!lmente il contenuto di carbossiemoglobina.
Molto elegante è il metodo visivo di Hartridge (11}, che utilizza lo spettroscopio d'inversione. Questo effettua due spettri che sono distanti, uno rispetto all'altro, di 180°. Con una diluizione normale del sangue le bande a. dello spettro dell'ossiemoglobina vengono così coperte. Con il sangue conte· n ente ossido di carbonio compare uno spostamento che è proporzionale al contenuto in carbossiemoglobina del sangue. Il metodo dà risultati sicuri, anche con campioni di sangue conservati a lungo.
Spettrofotometria infrarossa. - Molto più specifiche degli spettri ultra· v ioletti sono le curve di assorbimento infrarosso, nelle quali si mettono in evidenza delle bande di assorbimento provocate dalle oscillazioni degli atoini nella molecola e caratteristiche di determinati groppi funzionali presenti nella molecola stessa. Lo spettro è assolutamente specifico per una sostanza : minime variazioni di struttura si riflettono in sensibili cambiamenti dello spettro infrarosso. Questo fornisce un rigoroso criterio d ' identità tra due sostanze : il confronto diretto tra i rispettivi spettri appare specialmente adatto all'analisi chiinico-tossicologica che richiede una elevatissima specificità d elle identificazioni.
CONCLUSIONI
Nell'evoluzione dell'analisi chimico-tossicologica , qui sinteticamente tracciata, appare evidente come le ricerche in questo campo si siano proposte e continuino a proporsi l'elaborazione di metodi sempre più precisi e più facilmente applicabili agli scopi immediati della tossicologia. Le vaste possibilità che la chimica analitica offre attualmente al tossicologo, spiegano le difficoltà, non sempre facilmente superabili, che egli incontra quando debba stabilire quali siano i metodi più adatti alla soluzione di problemi di carattere tossicologico-legale.
E evidente come, in questo campo, una raccolta dei metodi concorde· mente ritenuti più attendibili potrebbe risolvere molte di queste incertezze. La continua evoluzione delle tecniche e dei problemi analitici rende ovviamente impossibile l'elaborazione di una raccolta di carattere ufficiale e vinco· !ante, ma non impedisce che, anche attraverso una collaborazione nazionale ed internazionale di quanti si interessano a questi problemi, si possa giungere
..4nn. l sl . Su])ff. San!IA (1968) 4, HS·458.

458 RASSEGNE
ad una raccolta di metodi consigliati che potrebbe costituire una prima base riconosciuta all' analisi chimica con scopi tossicologico-legali.
Si deve infine sottolineare che i problemi d ella tossicologia non si riassumono solamente nell' ambito della chimica analitica. È infatti evidente come un avvelenamento possa esser e riconosciuto non solo per mezzo della diretta identificazione del veleno, ma anche in base alla compar sa di metaboliti derivanti dalla sostanza tossica attraverso modifìcazioni biochimiche, di carattere vitale o post-mortale. Appare in t utta eviden za, in questo modo, il carattere multidisciplinare della tossicologia che, attraverso la chimica tossicologica, potrà trarre utili insegnamenti da altre discipline, ma potrà anche contribuire al progresso delle nostre conoscenze nei campi apparent emente lontani della chimica biologica e di quella microbiologica.
4 maggio 1968.
BIBLIOGRAFIA
( 1) STAs, J . S., Bull. Acad. Roy. Med. Belg., 11, 202 e 304 (1851) ; OTTo, F. J ., A nn. Chem., 100, 39 (1856); FABRE, R. & R. TRUHAUT, Précis de Toxicologie, 1961, vol. II, p . 316.
(l) DAUBNEY, C. G. & L. C. NICKOLLS, Analysl, 62, 851 (1937); 63, 560 (1938). (•) FELDSTEIN, M. & N. C. K.LENDSHOJ, Analysl, 78, 43 (1953). (') DRESSLER, A., M. MULLER & H. ScniiNFELD, Arch. Toxikol., 17, 286 (1959). ( 6) BONNICHSEN, R. , A. C. MAEHLY & A. FRANK, J. Forensic Sci., 6, 411 (1961). ( 0) CURRY, A. S. In : Toxicology, Mechanisms and Analytical Melhads. C. P. Stewart &
A. Stolman, E ds., Academic Press, New York and London 1960, vol. l, p. 260. (1) Per i particolari sui singoli metodi, si consigliano testi di Chimica Tossicologica. Tra i mol ti
r accomandiamo : C. P. STEWART & A. STOLMAN, To:xicology, Mechani&ms and Analytica/ Melhods. Academic Press, New York and London 1960, vol. l-II; A. STOLMAN, Progreu in Chemical Toxicology, Academ ic Press, New York oud London 1963, vol. l; 1965, vol. II; 1967, vol. Ili .
(B) RANDERATH, K., Thin-Layer Chromatography, Verlag Chemje GmhH. Weinheim/Bergstr. (Germany) 1966.
( 0) STAHL, E., Chemiker Z1g., 82, 323 (1958). ( 10) CauvARELLI, S., H. F. ToFFLER, L. V. FENNOY, R. LANDI VITTORY & P. MAzzEo,
Farmaco, Ed. Sci., lO, 408 (1965). (11 ) KruSHNAN, S. S. & N. E . EmCKSON, J . Foren&ic Sci., 11, 89 (1966). (12) KURZ, H . & H .-D. WALLER, Arch. Tox ikol., 15, 291 (1954-55) ; FRETWURST, F. & K. H.
ME!NECKE, Arch. Toxikol., 17, 273 (1959). (1•) HARTRIDGE, H., J. Physiol. , ..... l (1912); Kunz, H. & H.-D. WALLER, Arch. Toxikol.,
15, 292 (1954-55).
.Ànn. l sl. Super. SanitlJ. (1968) 4, '46·468 .

![TITOLO: Sunto di un corso di filosofia chimica AUTORE ... fileLettera del professor Stanislao Cannizzaro al professor S. De Luca [321] Io credo che i progressi della scienza, fatti](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/5c6e4c8309d3f29e208b4d72/titolo-sunto-di-un-corso-di-filosofia-chimica-autore-del-professor-stanislao.jpg)