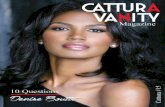LA CATTURA E LO STOCCAGGIO DELLA CO 2 Ingegner Ezio Nicola D’Addario
Su una nuova cattura di Nemichthys scolopaceus Rich. nello Stretto di...
-
Upload
sebastiano -
Category
Documents
-
view
214 -
download
2
Transcript of Su una nuova cattura di Nemichthys scolopaceus Rich. nello Stretto di...
This article was downloaded by: [Stony Brook University]On: 27 October 2014, At: 18:56Publisher: Taylor & FrancisInforma Ltd Registered in England and Wales Registered Number: 1072954Registered office: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London W1T 3JH,UK
Bolletino di zoologiaPublication details, including instructions forauthors and subscription information:http://www.tandfonline.com/loi/tizo19
Su una nuova cattura diNemichthys scolopaceus Rich.nello Stretto di MessinaSebastiano Genovese aa Istituto di Zoologia dell'Università di Messina ,MessinaPublished online: 14 Sep 2009.
To cite this article: Sebastiano Genovese (1954) Su una nuova cattura di Nemichthysscolopaceus Rich. nello Stretto di Messina, Bolletino di zoologia, 21:1, 81-92, DOI:10.1080/11250005409439192
To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/11250005409439192
PLEASE SCROLL DOWN FOR ARTICLE
Taylor & Francis makes every effort to ensure the accuracy of all theinformation (the “Content”) contained in the publications on our platform.However, Taylor & Francis, our agents, and our licensors make norepresentations or warranties whatsoever as to the accuracy, completeness,or suitability for any purpose of the Content. Any opinions and viewsexpressed in this publication are the opinions and views of the authors, andare not the views of or endorsed by Taylor & Francis. The accuracy of theContent should not be relied upon and should be independently verified withprimary sources of information. Taylor and Francis shall not be liable for anylosses, actions, claims, proceedings, demands, costs, expenses, damages,and other liabilities whatsoever or howsoever caused arising directly orindirectly in connection with, in relation to or arising out of the use of theContent.
This article may be used for research, teaching, and private study purposes.Any substantial or systematic reproduction, redistribution, reselling, loan,
sub-licensing, systematic supply, or distribution in any form to anyone isexpressly forbidden. Terms & Conditions of access and use can be found athttp://www.tandfonline.com/page/terms-and-conditions
Dow
nloa
ded
by [
Ston
y B
rook
Uni
vers
ity]
at 1
8:56
27
Oct
ober
201
4
SEBASTIANO GENOVESEAssistente
Istituto di Zoologia deU'Universita di Messina
Direttore: Prof. Filippo DULZETTO
Su una nuova cattura di Nemichthys scolopaceus Rich.
nello Stretlo di Messina.
Ii 19 febhraio del corrente anno venne portato in Istituto unesemplare di Nemichthys, che era stato raecolto da aleuni marinaisulla spiaggia di Faro (Streuo di Messina). Dato che questa forma emolto rara nel Mediterraneo ho creduto opportuno segnalarne conla presente nota il rinvenimento, Mi risulta infatti chc nel MuseoZoologieo di Firenzc sono conservati due esemplari faeenti partedella eollezione Giglioli. Secondo quanto riferisce GRASSI, essi proverrebhero s'icuramente da Messina, e sarebbero stati raecolti dopoil 1880. Avendo questo A. avuto modo di esaminarli nel 1913, diceche erano in cattivo stato di eonservazione; uno. maneava infatti didi tuttoil tratto filiforme caudale, mentrc l'altro, pur essendo intero, prcsentava delle nofevoli aIterazioni, dovute probabilmente alfatto ehe l' esernplare era rimasto per un ccrto periodo sulla spiag....,gia prima di essere raccolto e fissato in alcool, Di quest'ultimo sie limitato a dare la deserizione di quei caratteri ehe era riuscito amettere in evidenza.
II terzo esemplare, di eui si ha notizia, fu deseritto da ARIOLA;esso fu raccoito quasi tramortito, galleggiante alIa superficie delmare a Finalmarina it 10 aprile 1902, e trovasi couservato nel MuseoCivico di Storia Naturale. di Genova. Questo. A., che ne scgnalo lacattura net" 1904, 10 attrihui al genere Nemichthys, nia non ne precise la specie. Egli ricsamiuo 10 stesso individuo nel 1913, proeecedette al compute della vertebre per via radiologica, e crcdette diravvisare delle caratteristiche tali da giustifieare la crcazione di unanuova specie: N. mediterraneus.
II quarto esemplare mediterraneo, it pili lungo fra qnelli sinoradescritti {mm. 1445), fu raccolto ancora vivo alIa superficie del marenei paraggi di Tolone, e fu descritto da HOULE; esso fa parte dellacollczione della Stazione Zoologiea di 'I'amaris,
Dow
nloa
ded
by [
Ston
y B
rook
Uni
vers
ity]
at 1
8:56
27
Oct
ober
201
4
82
Due aItri esernplari sono stati segnalati da CAZIOT e IS:'iAHD efurono raeeoIti nel Golfo di Nizza rispettivamente ncl1909 e nel 1911.
11 settimo rinvcnimento si riferisce ad un csemplare catturatonel tratto di mare antistante Ia Riviera di Levante nel mar Ligure,tra i 500 ed i 600 metri di profonditii, in un periodo di tempo nonesattamente precisato, ma ~ompreso fra gli anni 1936 e 1940, perche proveniente da materiale pescato con reti a strascico durantequel periodo. Tale cattura fu segnalata e I' esemplare descritto daTUOTTI nel 1947. L'individuo pero si presentava mutilato della « parscautlalis », mancante fin dal suo attacco, e presentava inoltre Iamascella infcriore spezzata in vicinanza della sua estrernita.
L' esemplare da me pI'eso in esame fu rinvenuto ancora vivosulla spiaggia di Torre Faro, Iocalita distante una decina di: chilometri da l\Iessina, e sita sulf'estrema punta orientale della Sicilia.In tale Iocalita sono frequenti - come c n.oto ~ i rinvenimenti diforme abissafi, che,. strappate dal Ioro habitat naturale dal gioeodelle correnti, vengono spiaggiate specialmente su questo tratto dicosta, Cia' avviene con maggiore frequenza nei periodi in cui nelloStretto predominano venti sciroccali. Il nostro esemplar~ infatti furaecoIto mentre un forte vento di sciroceo spirava gia da parecchigiorni.
Appcna raccolto I'Individuo fu messo in un recipiente con dell'acqua di mare e portato in Istituto, dove si mantenne in vitaancora per qualchc ora, nonostante prescntasse un taglio nella partemediana del corpo ed un'altra piccola lesione nella regione opercolare. Per il resto I'esemplare era del tutto integro anehe nelle sueparti piil delicate, quali la lunga e filiforme parte caudale e Ie terminazioni bottonciniformi delle mascelle.
GUASSI, in base alle differenze morfologiche che risultavano dalleprecedenti descrizioni, e sopratutto in base all' eslstenza delle duedistinte forme larvali Tilurus hyalinus Facciola [Leptocephalus tilurus D'Ancona) e Leptocephalus trlchiurus Cocco [Tilurus trichiurusKaup, T. Rnfincsquei FaceioIa), che ritenne sicuramcnte attribnibilial genereNcmichthys, aveva creduto opportune distinguere in lineaprovvisoria due specie: Nemicluhys scolopaceus Rich. (nec Roule,nec Brimer, sin. N. meditcrraneus Ariola) e Nemichthys pseudosco-.lopaceus (sin. .N. scolopaceus Roule e Braur, nee, Richardson).
L'appartencnza dei Tiluri al genere Nemichtliys non e stata condivisa pero da ROULE, che ha descnitto per tale genere de~le formelarvali del tutto differenti. Secondo questo A. infatti gli stadi Iar-
Dow
nloa
ded
by [
Ston
y B
rook
Uni
vers
ity]
at 1
8:56
27
Oct
ober
201
4
- 83-
vali di Nemicluhys scolopaceus sarebbero rappresentati dalle Tilurelle, mentre i Tiluri apparterrebbero ad altra famiglia di Murenoidi,come del resto aveva gia fatto intravedere FACCIOLA, che fu tra iprimi a studiare tali forme larvali. Egli Ie attribui in un primotempo all'Oxystomus hyalinus del Hafinesque - forma peraltro duhbiae da molti considerata larvale - e successivamente addirittura aIleMurene,
RouLE e BERTIN nello. sviluppo larvale del Nemicluhys scolopacens distinguono i seguenti stadi: Leptocejalo A (250 miomeri preanali, 3 paia di cromatofori, identificabile con L. canaricus Lea eL. Andreae Schmidt.), Leptocefalo B (320 miomeri preanali, cromatofori larvali scomparsi, identificabile con L. polymerus Lea e conL. curoirostris Stromman), Tilurella A [miomeri prcanali 180, 'inte-'
stino rettilineo, filamento codale, mascelle allungate) c Tilurella B(miomeri preauali 39, intestino piegato ad U). OItrc a queste formeIarvali ROULE considera anche stadi prelarvali di Tiluri, identificaudoli in quattro piccoli esemplari' da lui descritti, di cui due provcnienti dal Mediterraneo. Le ragioni che avrehbero indotto ROUL!;ad assegnare al Nemicluhy« scolopaceus i sudetti stadi larvali sarcbbero principalrnente tre: 1) Ic Iarve del tipo Tilurella, considerateil numcro clevato dei loro miomeri e Ia forma delle Illascelle; Iurrghe, esili, munite di numcrosi c fini denti, appartcngono evidelltemente al cicloontogenetico di un rappresentantc della famiglia deiNemict icidi; 2) il numero dei miomeri, che sorpa,ssa 300, Ie attribuisce sicuramente al genere Nemichtliys; 3) essendo state catturatequeste forme larvali in una rcgione dell'Oceano Atlantico, dove ilNemichthys scolopaceus Rich., unica specie atlantica del gencrc, simostra molto frequentemente, c legittimo rapportarle 211a sudettaspecie.
L'esemplare da me studiato (Fig. 1), che si conserva fissato informaliua in questo Istituto, presenta i seguenti caratteri biomctrici:
Lunghczza totale [estrcmita mascellare superiore- estremitacaudale) •
Lunghezza del capo [estremita mascellare sup.s-opercolo]Lunghezza della testa (narici-opercolo)Lunghezza mascellare superiore (fino alIa commissura
hoccale) •Larghezza massima del corpo •Larghezza massima della testa (all'oceipitc)
mrn, 1015» 69J> 24
'J> 54J> 7» 9
Dow
nloa
ded
by [
Ston
y B
rook
Uni
vers
ity]
at 1
8:56
27
Oct
ober
201
4
- 84-
Altezza massima della testa mm. nAItezza massima- del corpo » 15Altezza del corpo misurata a 10 ern, dall' estremita del I
mascellare superiore . ) 5Altezza del corpo misurata a 20 em, dall' estremita del
mascellare superiore ) 10Altczza del corpo rnisurata ,a 40 ern, dall' estremita del
mascellarc superiore » 15Altezza 'del corpo misurata a 50 ~m. dall' estremita del
mascellare superiore ) 13AItezza del corpo rnisurata a 60 em, dall' es tremita del
mascellare supcriore ) 6Altczza del ccrpo misurata a -65 em. dall' estremita del
mascellare superiorc » 2Diametro occhio » 5
Spazio interorbitale . 'I) 4,5Distauza tra il margine antcriore dcll'occhio e I'estremita
del mascellare snpcriorc ) 47Distauza tra ilmargine posteriore dell'occhio e la dorsale » 15
e la pettorale. ) 21e la anale » 29
Non credo sia necessario dare una completa descrizione delI'esernplare perche e. stata fatta dcttagliatamente dai precedenti AA.Mi Iimitero solo a prendere in considerazione quei caratteri che 10state di perfetta conservazione e di freschezza mi hanno consentitodi mettere bene in evidenza,
L'esemplare si presenta colorato in grigio chiaro cinereo nellaregionc dorsale; in quella ventrale i\ colore grigio tende ad imbrunirsi. La testa e anch'essa grigia scura e si presenta fortementepigmentata in bruno intenso, quasi nero. L' occhio rotondo ha uniride che, mentre nell'individno fissato in. formalina presenta deiriflessi nettamente vcrdastri, conformemente a qnanto era stato osservato precedentemente, nel vivo, pur prescntandosi caratteriaticamente cangiante, tende piu al giallastro, quasi all'amhra.
La pinna dorsale ha inizio a 15 mm, dal bordo posterioredell'occhio; essa e formata nel primo tratto da raggi Hessibili di varialunghezza, uniti da una membrana, Il primo raggio e ·lungo mm, 5,e tale lunghezza eonservano i raggi fino a 10 em, dall'estremitii dellemascelle, A 20 em: lao Iunghezza e quasi doppia, essendosi misurati
Dow
nloa
ded
by [
Ston
y B
rook
Uni
vers
ity]
at 1
8:56
27
Oct
ober
201
4
, 1-
.•.•
._
_•
r'~
,.•.
.... ".
,.
I~
••.
•.•
,.._
.._
.I
Fig.
1..-
Nem
icht
hys
scol
opac
eus
Ric
h.
.Fig
.2.
-T
esta
diN
.sc
olop
aceu
sR
ich.
CQ <.n
Dow
nloa
ded
by [
Ston
y B
rook
Uni
vers
ity]
at 1
8:56
27
Oct
ober
201
4
86 -
raggi . Iunghi mm. 12. La serie dci raggi corti, rigidi cd uncinatiall'indietro, che scgue imml?diatamente quella dei raggi flessibili, hainizio a 47 em, dallestremita mascellare.
La pinna anale, chc si presents pit) omogenea, ha inizio subitodopo I'ano, I suoi raggi sono pit) Iunghi e ph) grossi dei cor~ispon
denti della dorsale, e sono uniti da una membrana scura pigmentata. II primo raggio misura mm, 7. A 20 em, dalf'estremitd rnascef--:lare i raggi .toccano la loro massima lunghezza di mm, 13, a 40 em.sono Iunghi ancora mrn, 12.
La parte caudaic dell'esemplarc, lunga circa 35 ern, (cousideriamo certo un p6 arbitrariamcnte come puntcdi attacco della parscaudalis quello posto a 65 em. dalle estremita delle mascellc), siprcsenta scura, pigmeniata in bruno SCUTO, filiforme, come gid si cdetto, e con elementi vcrtebrali tali da conseutire la massirna motilitll alIa partc stessa. Nci nostro escmplarc infatti si c formatoaddirittura un nodo, a circa 2 em. dalla fine, comc si puo rilevaredalla figura (Fig. 1). Sia Ia pinna dorsale elie la anale si continuanonella parte caudale con raggi molto sottill, pit) scuri quclli dellaanale, menoquelli della dorsale.
Sull'esemplare sono state eseguite delle radiografie per il computo .delle vertebre; t~Ie operazione, specie per' quanto. riguarda Iaparte caudaIe, c resa molto difficilc .sia <lalla scarsa densita calcica,sia .dalln dimensione molto ridotta delle vertebre, Si sono tuttaviacontate 188 v~rtebre, e se ne sono calco late altre 160 circa per Iaparte caudaIe, sicche si arriverebbc ad un rotale' di 350 vertebrecirca, conformcmcnte a quanto gid riscontrato :da Ariola.
In N. scolopaceus Iatesta (Fig. 2) - come c noto - si continua condue inascclle leggermente disuguali e molto alli.mgate a guisa dibecco di uccello, carattere che giustifica appieno il nome specificodi scolopaceus (beccaccia). Ad una certa distanza dalf'estremita essesi prescntallo arcuate in senso contrario, Ncll' escmplare in csameIa mascella superiore, che c a~ehcun po piii Iarga alla base, eIunga (misurata dalla commissura boccale) mm. 54; queHa inferioremm, 52. Ambedue tcrminauo "con una caratteristica espausione abottone di forma ovalc, appiattita esternarnente,. e couvessa in corrispondenza della' supcrficie interna. (Figg. 3 e 4). Lc due masccllesono munite di numerosi denti couici ad estremita appuntita rivoltaallTndietro; (Fig. 5) essi sono distribuiti anchc Iungo i margini laterali, dai quali debordano quasi per tutta la loro lunghczza. Nellarnascella superiore i denti SOllO distribuiti lungo due zone di forma
Dow
nloa
ded
by [
Ston
y B
rook
Uni
vers
ity]
at 1
8:56
27
Oct
ober
201
4
87
ovale che, partendosi dalla commissura hoccale, si assottigliano distalmente e terminano in corrispondenza del quarto anterinre, Essedel imitario uno spazio privo di denti; in cui si spingono quell!impiantati sui resto della mascella, che si presenta notevolmerlteco nvessa. Tali denti nella parte -anteriore sono distribuiti in unasuperficie Ai forma triangolare col vertice rivolto verso la testa eche sispinge fino all'altezza delle narici. In corrispondenza dellaestremila bottonciniforrne essi si vanno facendo sempre pill piccolifino ad assumere una forma mammellonare. Nella mascella inferiorei denti, meutre in tutto il tratto arcuate sono distribuiti uniformemente, a cominciare dal punto in cui viene a contatto con quellasuperiore, tendono a scornparire lungo una Iinea mediana, ehe siallarga semjJre ph) verso 'Ia testa. Sicche in definitiva essi si distri,...huiscono lungo due zone separate da UIlO 'spazio mediauo di formatriangolare; COil la base rivolta verso la testa. E siccomc tale spazioC leggermente concave, in esso, quando Ia bocca c, chiusa, va c situarsi il cuscinetto dentate della mascella superiore, Lc due mascellesono fortemente pigme!?-taie in quasi tutta la loro lunghezza; nell'ultimo tratto pero, e' precisamente a circa 4-5 nrillhnetri dall' inizio
dell'espansione bottonciniforme, esse si presentano di colore grigiochiaro e con scarsa pigmentazione; in modo da apparire quasi tra
sparenti. Ed c appunto in questo tratto che Ie mascelle raggiungonoil loro minimo spessore diventando estrelllalllente, fragill, e cometali soggette a rompersi facilrnente. Si spiegano cosi le mutilazioni'frcquenti dclle estremita delle mascellc, Ie quali, fra l' altro, con
tribuiscono a farlc apparire piu dritte di quanto in effetti non siano,essendo l'arcuazione all'infuori molto : rnarcata nell' ultimo tratto(Fig. 2). Non e da eseludere quindi che Ie prime descrizioni, .fattesu esemplari catturati nello Atlantico e nel Pacifico.dove la speciee ampiamente distribuita' fino alla profondita di 2000 metri eded oltre, Ie quali si Iimitano a presentarci Ic mas celle prolungautcsiin unTungo, sottile becco (GibTER 1870), si riferiscano ad esemplarinon perfeuamente integri.
VULLUi'iT (1888), descrivcndo un individuo catturato ad 888 metridi proforrdlta nel corso delle ·campagnc del Talisman, afferma addirittura che le mascelle sono uguali e dritte in avauti, e cosi ce I~
rappresenta in una figura schematica, Ia cui verosimiglianza c moltodubbia, anche per la evidente imprccisione con cui sono raffiguratela dorsale e la anale.
Aneho GooDEe BEAN (1896) nel dare i caratteri distintivi del
Dow
nloa
ded
by [
Ston
y B
rook
Uni
vers
ity]
at 1
8:56
27
Oct
ober
201
4
- 88-
genere Nemicluhys descrivono Ie mascelle solamente come «greatlyelongate, forming a long, slender bill ». La loro descrizione nonescludequindi la caratteristica divaricazione a"ll'infuori, che anzirfsulta evidente daUa figura che essi stessi danno dell'esemplare, neI'esistenza delle espansioni bottonciniformi,
BRAUER (1906) dice che la mas cella superiore nel suo esemplaresemhra rotta, rna nello schizzo cite accompagna la descrizione apparenetta l'arcuazione mascellare verso l'csterno.
Fig. 3. = Bottone terminale della mascella superiore di' N. scolopaceus Rich.visto di fianco.
Andando adesso agli esemplari Mediterranei, e cominciando daiprimi segnalati, cioe da quelli della collezione GIGLIOLI, vediaino cheGRASSI, 'pur avendo notate che Ie ~ascelle terminavano con un « minimo rigonfiamento, 0 bottoncino che vogliasi dire appiattito » datoche queste parti, per la loro estrema fragilita 0 per effetto del dis-'seccamento potevano mancare, aveva preferito non tenerne contonella diagnosi del genere. Egli si limito infauiad accettare la descrizione del Giil'iTHER, anche perche non voleva giustamente assegn~re a tale' particolare anatomico carattere differenziale Interspecifico,
Anche l'esemplare di Ariola, secondo quanto riferisce 10 stessoGRASSI, presentava origioariamente « un piccolo rigonfiamento a capocchia di spillo» sull'estremita del muso; naturalmente tale rigonfiamento all'epoca del riesame da parte di GRASSI (1913) non ~ra' pinevidente, dato che era rimasto eoai lungo tempo nel liquido fi6sativo,
ROULE nella deserisione della testa si 'attienc a quanto detto da
Dow
nloa
ded
by [
Ston
y B
rook
Uni
vers
ity]
at 1
8:56
27
Oct
ober
201
4
- 89-
GU;,\TIIER; c si rifa addirittura alla descrizione del VAILLAi\T presentandoci « deux fines mandibules pointant droit devant elles ». Lemasccllc sarehhcro-quindi dritto e non prcsenterebbero l'arcuazionecarattcristica all'infuori. Ma in effetti poi nclla tavola a colore diAKGEL, che correda la descrizione dell'csemplare, Ie mascelle sonoraffiguratc arcuate, e specialmente in uno dci tre esernplari talcarcuazionc c ph) accentuata di quanto non sia in realta,
Fig. ·1. Bottone terminale della mascella inferiore di N. scolop aceus Rich.visto di fiauco,
Dalla descrizione dellesemplare segnalato da TROTTI non si haalcun dubhio sul!' esistenza delle espansioni hottonciniformi dcllemascelle. Egli infatti dice chc net suo esemplare « l'apice dclla mascella superiore terrnina con un minuscolo rigonfiamcnto; quellodella mascella Inferiore si prescnta piu corto perohe spezzato invicinanza della sua estremita ».
Non mancano quindi nelle descrizioni. precedenti chiari cennie riferimenti circa l'csistenza di tali espansioui bottonciniformi dellemascelle, che noi scnz'altro riteniamo un costante parricolare morfologico, carattcristico della specie in esame. Tale nostra affermazione 'c avvalorata dalla evidenza del nostro reperto, e suffragataancora dal fatto che Ie precedenti descrizioni sono - come ho avutomodo di rilevarc - incomplete, e si Iirnitano a raffigurarci le mascelIe
come molto allungate ed a guisa di becco di uccello, senza escludere peraltro la esistenza di altri particolari morfologici.
Dow
nloa
ded
by [
Ston
y B
rook
Uni
vers
ity]
at 1
8:56
27
Oct
ober
201
4
- 80-
L _
A B
Fig. 5. - Figura schematica della distrihuzione dei denti nelle due maseelledi N. scolopaceus Rlch.» A) superiore; B) Inferiore,
Dow
nloa
ded
by [
Ston
y B
rook
Uni
vers
ity]
at 1
8:56
27
Oct
ober
201
4
- 91
Non c'e dubbio infine che il nostro esemplare appartcnga allaspecie Nemiclithys scolopaceus Rich., che ritcuiamo altresi essereI'unica appartenente al genere Nemichthys.TllOTTI infatti per dueindividui 'del Mar Ligure, e cioe quello tdi Ariola edil suo, arrivaalla conclusione che .essi presentano delle « notevoli coincidenzemorfologiche» per quanto la eomparazione non possa essere perfctta, mancando in una delle due forme Ia coda. Egli aggiunge cheIe stesse potrehhero esscre riferite entrambe alia specie scolopaceus.Non v'e duhhio ancora ehc 'le forme raccolte nello strettodi Messina, secondo quanto ha potuto stabilire gia da tempo GIlASSI, sianosimili non solo a queUe liguri, ma anche alle forme deseritte dagliAutori americani. Ed a questa couclusione 'era giunto in seguito adun esame comparativo, che aveva potuto effettuare tra i suoi osemplari, quello di ARIOLA cd unaltro, proveniente dall; Atlantico, edinviato al Ih:LLoTTI dal Museo di Washington.
Facciamo rilcvare aItrcsi che Ia forma di RouLE, la quale insiemea quella di BRAlJEi\ apparterrebbc sccondo GRASSI alIa specie provvisoria pseudoscolopaceus differirebhe dalle aItre mediterranee soloper la conformazione delle estremita delle mascelle, essendo perfettamente simile per il resto, E volendo prescindere infiue dalleopposte ipotesi sulle forme larvali, su cui nuovi e phi. ampi rcpertipotrehhero fare lucc definitiva, non esitiamo a considerare anchequesta forma uguale alle rimanenti, po iche riteniamo fra l;aItro pocoprobabile l'esistenza di due distinte specie di . Nemiehihys in untratto di mare cosi ristrctto (Mar Ligure), quando e accertata al contrario l'ampia distrihuzione della certa unica specie esistente.
BIBLIOGRAFIA
AII!OLA V. ~ 1901 = Pesci nuovi 0 rari per il Golfo di Genova. AIIII. Mus. Civ.St. Nat. GellOva, serie 3, vol. XLI.
- - ~ 1913 ~ Nemlcluliys mediterraneus del Golfo di Genova. Acquicolt:Lomb., anno 6, n. 5, ,llilallo.
BELLOC G. - 193B - Liste des poissons pelaglques et bathypelagiques captures aucours de le clnquieme croisiere, avec diagnoses preliminaircs de deuxespeces nouvelles, Rev. des Trav. OJf. Peches Mar., col, II, [asc, 3.
BIlAUEIl A.=1906 ~ Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen 'I'iefsee-Espedirionauf dern Dampfer "Valdivia) IB98-99. Die Tiefsee-Fische, 1 Sistematischer Teil, vol. 15, Fischer, leila.
CAZIOT E., IsxAIlD P. = 1920 = Capture de Nemiclitliys scolopaceus Richardson dansIe Golfc de Nice. Bull. 'Soc. Zool, de France, uol, 45, Paris.
Dow
nloa
ded
by [
Ston
y B
rook
Uni
vers
ity]
at 1
8:56
27
Oct
ober
201
4
- 92-
D'AxCOXA U. ~ 1931 ~ Apodes. Fauna e Flora del Golfo eli Napoli, .lIon. 38.FACCIOI.l L. ~ 1882 ~ Dcscriaioue didue specie di pesci del genere Oxystomus
viventi nelle acque di Messina. Naturulista Siciliauo, allno I, II. 8.- - 1883 ~ Hivista delle specie di Leptocephalidi del Mar di Messina.
Atti R. Acc.Peloritana, aTl1IO IV.GOODE G.B., Bl~AX T. II. 1895 ~ Oceanic Ichthyology. Smith. last. U. S. Nat.
JIlls. Washingto!l.GllASSI B. ~ 1931 - l\Ietamorfosi dei murenoidi. Hicerche siatematiche ed ecolo
gichc. R•. Comito Talass, Ltal., .11011 I, Velle;;;ia.GilXTIIEH A.·. = 1870 ~ Cataloglle of the Fiches in the British JIuseulll. Vol.
8, London,- - 1886 = Handbucli der Icluliyologye, Wi(!11 ..
JOIlDAX D. S., E\'EIDl.-\XX B. W. - 1900 - The Fishes of North and Middle America. Smith. Bull. 11. 47, Washingtoll.
illAzzAIlELU G. ~ 1909 = Gli animali abissali e Ie correnti souomarine nello Stretto.Ii Messina. Riv.•1Iens. Pesca .« Idrob., anno Xl, II. 9-12•
.MutulA\" J., II.IOUT G. = 1912 ~ "The Depths of tlus Ocean, JIflcmillltll, Loudon.HOULE L. - 1910 ~ Notice preliminaire sur la description ct I'identification d'une
Iarve Iep tocephalienne appartenan t au type (Ixystomus Ra], (Ttlurus KolJ.).Bull, Inst, Oceauograpl;ifJue, n, 171.
~ 1910 ~ Description d' uu Nemichthyde -meditcrruneen. .1'111. Inst,Uceunograpliique, col, 1.
= .1919 = Poissous pr veuant des campagues dn Yacht ( Priucesse Alice ~
(l891~1903) ct et du Yacht (IIirondelle II). (1914)· Re,. C:lmp. Scient.,LU, JIouaco.
~ 1934 - Les poissons et Ie monde vivant des eaux, Tome VII. L'Abimedes grands fonds marins. Libraire Delagrave, Paris.
HOUl.E L., AXGEI. F. ~ 1933 = Poissons provenant des campagnes du Prince AlbertIer de Monaco. Res. C·ZlIIp. Scient•• [asc, LXXXVI, JIon!lco.
ROULE L., BEUTJX L. - 192·1 - Noticc preliminaire sur Ia collection des Nemichthydes recuillis par I'expedirion du (Dana) (1921~1922) suivie de considerations sur Ia classification dc cette section des Po issons Apodes,Bull. Mus. Nation. Hist. Nat., t'ol 30, Paris.
'I'onroxasa, E., TUOTTI L. ~ 1919 ~ Cutalogo dei Pesci del :'lIar Ligure, CelltroTalass. Tirreno, Pubb. II. 1.
Tnor'rr L. ~ 1947 ~ Note su alcuni pesci cauurati per sclabicameuto a liveJlo dellazona intermedia nel Golfo Ligure, Atm. Mus. Ci», St, Nat. GCllOl1a,col, LXIII.
Y,\lf.L\XT L. ~ 1888 ~ Expedilions Scientiphiques du "travailleur" et du "Talisman"pendant les annees 1880:83. Poissons, JlIassoll' Paris.
Dow
nloa
ded
by [
Ston
y B
rook
Uni
vers
ity]
at 1
8:56
27
Oct
ober
201
4