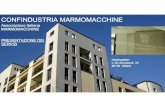Storia ed evoluzione della Confindustria dalla fondazione ... Daniele.pdf · Storia ed evoluzione...
Transcript of Storia ed evoluzione della Confindustria dalla fondazione ... Daniele.pdf · Storia ed evoluzione...
Storia ed evoluzione della Confindustria dalla fondazione ai giorni nostri Daniele Boccetti
INTRODUZIONE
Mentre lo studio delle organizzazioni sindacali è stato ampiamente sviscerato e dibattuto sin dalle origini del movimento operaio, lo studio delle associazioni datoriali è rimasto per anni un argomento tabù o, peggio ancora, un “non argomento”. Lo sviluppo di una serie di studi sulle organizzazioni di rappresentanza imprenditoriale inizia negli anni Settanta, nel periodo di maggior furore ideologico-politico e arriva fino ai giorni nostri conoscendo una lieve battuta d’arresto negli ultimi anni per effetto della grande crisi economica. Gli studi fino ad allora si erano concentrati su sindacati e organizzazione del lavoro e si era, di fatto, creato uno squilibrio delle conoscenze importante. Alcuni osservatori anglosassoni si spingono oltre dicendo che studiare l’impresa è sufficiente e che “è inutile soffermarsi sulle associazioni datoriali, i giuristi sostengono che mentre l’associazionismo dei lavoratori è necessario quello dei datori di lavoro è eventuale. L’impresa è già un soggetto collettivo”1. Pur non arrivando a tanto, anche nel nostro paese, rimane evidente la diversa attenzione e il differente grado di approfondimento negli studi riservati a questi “attori politici”. A questo dato storico si accompagna una proverbiale riservatezza, che in alcuni casi sfocia nella diffidenza dei dirigenti e dei funzionari della associazioni, che si sono spesso dimostrati restii a fornire dati, informazioni e materiali a chi fa ricerca. Un atteggiamento che ha rafforzato l’ipotesi “cospiratoria” e che ha finito per considerare le associazioni di rappresentanza schive, “chiuse, insicure e poco trasparenti”2. Dopo una breve parentesi storica e alcuni flash sulla principale associazione di rappresentanza imprenditoriale presente in Italia, la Confindustria per l’appunto, si analizzeranno sommariamente le declinazioni giornalistiche (Il sole24ore) e quelle universitarie accademiche (Luiss Guido Carli). Nel secondo capitolo si affronterà il caso specifico della nascita della Federmeccanica, considerata ad oggi l’esperienza più significativa all’interno della stessa Confindustria (per i numeri espressi,
1 Tiziano Treu, ordinario di Diritto del lavoro presso l’Univeristà Cattolica del Sacro Cuore, Milano, “Un nuovo associazionismo imprenditoriale?” in Diritto delle Relazioni Industriali, Numero 1/XVI, 2006. 2 Luca Lanzalaco, ordinario di Scienza politica presso Università degli Studi di Macerata, “Le associazioni imprenditoriali tra eredità storica e sfide del futuro” in Diritto delle Relazioni Industriali, Numero 1/XVI, 2006.
1
per il modello culturale imposto e perché rappresenta di fatto il tessuto cognitivo del sistema industriale italiano). Il terzo e ultimo capitolo si confronterà con la più generica questione della rappresentanza, vedendo nel dettaglio, come è cambiata l’associazione, le caratteristiche principali delle organizzazioni imprenditoriali italiane, i loro problemi, il rapporto con la politica, fino ad arrivare alle dinamiche (e le difficoltà) comuni tra organizzazioni dei lavoratori e organizzazioni delle aziende. Per agganciare lo schema teorico ad un minimo di dati si riporteranno le risposte di alcuni imprenditori ad un questionario loro somministrato (da una Confindustria territoriale, quella di Bergamo per l’esattezza) che dimostrerà una certa congruità rispetto all’analisi intrapresa. Nelle conclusioni si cercherà di capire dove sta andando la Confindustria, quale modello di rappresentanza ha in mente, che relazioni industriali vuole stringere e il riposizionamento nella crisi (considerando l’accordo sulla rappresentanza sottoscritto recentemente e il “patto di Genova” sottoscritto qualche settimana fa, ma, se vogliamo, anche lo sforzo comune per fare “da stampella” all’attuale esecutivo Letta, la ricerca di stabilità e le posizioni espresse sull’ultima “finanziaria” varata). L’approccio sarà storico, economico e sociale, l’analisi dei testi è finalizzata a dare alcune chiavi di lettura ai compagni impegnati nel sindacato che volessero in qualche misura sapere come è nata, come si è sviluppata e come opera la rappresentanza Confindustriale.
CAPITOLO 1
1.1) GLI INIZI DELL’ASSOCIAZIONISMO INDUSTRIALE La nascita di Confindustria risale al maggio 1910, in coincidenza con i primi sviluppi dell'industrializzazione nel nostro Paese. Per quasi mezzo secolo dalla data dell'unificazione nazionale, l'Italia (a differenza di altri paesi che già si erano affacciati allo sviluppo industriale) era rimasta in bilico fra arretratezza e sviluppo, a causa della scarsità di materie prime e risorse energetiche, degli elevati livelli di analfabetismo e dell'esistenza di vaste sacche di miseria endemica, non soltanto nel Sud della penisola. Si spiega pertanto, come quella prima base industriale che era andata formandosi tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, fosse stata il frutto di un parto tutt'altro che agevole. C'era voluto un mutamento d’opinione della classe politica dell'epoca, perché venisse abbandonata la tesi che la ricchezza dell'Italia stesse unicamente, o quasi, nell'agricoltura. Ciò aveva portato il Parlamento a varare nel 1887 un regime protezionistico a favore della nascente industria siderurgica e del settore tessile, in concomitanza con un provvedimento analogo a sostegno della
2
produzione cerealicola. In quella circostanza, avevano fatto la loro comparsa alcune leghe imprenditoriali, per sostenere le rivendicazioni di questo o quel comparto industriale, senza tuttavia riuscire a farsi largo in un contesto economico dominato dagli interessi preminenti della grande proprietà fondiaria e dell'alta finanza. Soltanto all'inizio del Novecento, quando anche l’Italia cominciò a partecipare alla congiuntura espansiva a livello internazionale, la causa dell'industrialismo guadagnò terreno. Tra il 1902 e il 1906 nacquero i primi sodalizi a carattere territoriale, da quello di Monza a quello di Torino, accanto alle associazioni di categoria (la prima era stata quella laniera) costituitesi negli anni precedenti in alcuni centri come Biella, Milano, Genova, Schio e Terni, dove era andato crescendo nel corso del tempo il numero delle ciminiere. Delle forme embrionali di associazionismo prendevano campo, ancora erano poco definite e avevano obiettivo sfocati, tuttavia iniziavano a sentire l’esigenza di consorziare gli imprenditori.
1.2) NASCITA DELLA CONFINDUSTRIA
Da questi primi nuclei di associazionismo imprenditoriale sorti in ordine sparso, nacque, quindi, il 5 maggio 1910 la “Confederazione italiana dell'industria”, con il fine di coordinare a livello nazionale le iniziative degli imprenditori sia nei rapporti con il governo e le amministrazioni locali, sia nei riguardi delle organizzazioni sindacali. Primo presidente della Confederazione fu Luigi Bonnefon, un industriale della seta sceso da Lione in Piemonte. Prima sede di Confindustria fu Torino poi, dal 1919, Roma, in piazza Esedra, finché, agli inizi degli anni Venti, gli uffici vennero trasferiti in un palazzo di piazza Venezia di proprietà delle Assicurazioni Generali. Gli uffici sono rimasti li sino al dicembre 1972, data in cui hanno trovato funzionale sistemazione in un moderno palazzo all'Eur (Viale Astonomia dove si trova anche oggi). Quattro anni prima, nel 1906, era stata fondata la “Confederazione generale del lavoro”. La storia della Confindustria coincide con quella della rivoluzione industriale, avviata all'inizio del Novecento dalla diffusione della forza motrice elettrica e dagli sviluppi del settore metalmeccanico, e si intreccia con la rivoluzione tecnologica degli anni 80, nata dagli eccezionali effetti indotti dall’elettronica e dall'informatica. Percorrendo questo lungo cammino l'Italia è uscita, da una condizione di arretratezza economica e di subalternità nella divisione internazionale del lavoro trasformandosi infine in una società industriale avanzata. Non si è trattato di un percorso semplice e rettilineo, ma estremamente complesso, con numerose battute d'arresto. Prima che gli imprenditori italiani riuscissero a far nascere, nel 1910 una propria associazione capace di rappresentare e tutelare gli interessi del mondo industriale è stata necessaria una lunga gestazione, durata per quasi mezzo secolo a partire dalla data dell'unificazione nazionale. Un obiettivo difficile per una imprenditoria che ha dovuto far valere i propri diritti di
3
cittadinanza in un Paese che, per tanto tempo, aveva continuato a reggersi quasi esclusivamente su un'economia agricola e artigianale, all’interno di una società statica e tradizionalista in cui, ai vertici dello Stato, dominavano solo gli esponenti della grande proprietà fondiaria e del capitale finanziario legati a doppio filo con l'alta banca francese e inglese. L'Italia in quel periodo pose le fondamenta del suo processo di sviluppo al culmine dell'età liberale, non solo grazie alle stampelle fornite dallo Stato in nome del "lavoro nazionale" ma anche grazie al dinamismo e alle capacità di un numeroso gruppo di “capitani” d'industria alcuni dei quali destinati a dar vita a forti dinastie imprenditoriali3. Una svolta questa che, nonostante gli squilibri settoriali e territoriali, evitò probabilmente alla penisola la stessa sorte di alcuni paesi del Mediterraneo e dei Balcani, condannati a restare nelle aree di sottosviluppo dell'economia europea. L'Italia, da allora, ha intrapreso il cammino (che è stato più volte sul punto di interrompersi, durante il periodo fascista e all'indomani della seconda guerra mondiale) che l'ha portata, da un quarto di secolo a questa parte, ad affermarsi fra le nazioni più industrializzate del mondo ad inizi 2000.
1.3) I PRIMI ANNI DI VITA: LA CONFINDUSTRIA TRA LE DUE GUERRE MONDIALI
I primi anni di vita della Confederazione sono senza dubbio i più travagliati, infatti dopo solo 5 anni dalla costituzione la Confindustria e gli imprenditori dell’epoca si ritrovarono nella Prima guerra mondiale. Il periodo fu di forte sviluppo per dell’industria siderurgica (che diede sicuramente un contributo importante alla vittoria della guerra), tuttavia si usci da quella fase storica più deboli, più dilaniati e più divisi. Il tempo di riprendersi dal conflitto e arrivò la stagione degli scioperi e delle grandi manifestazioni. Nel settembre 1920, le maestranze dei principali stabilimenti di tutta Italia, procedettero all'occupazione delle fabbriche. Queste occupazioni si prolungarono per un mese e suscitarono l'impressione che si fosse alla vigilia di un moto insurrezionale4. In questo clima, reso ancor più difficile da un'estrema instabilità politica e dalle gravi difficoltà finanziarie della riconversione post-bellica, il movimento fascista giunse alla conquista del potere. Sebbene Mussolini avesse proclamato che il suo governo mirava al potenziamento dell'apparato produttivo e alla massima disciplina nelle fabbriche in nome degli interessi nazionali (e per questo non fu visto 3 Al di là delle presidenze che si sono succedute, nei primi quindici anni della Confindustria si affermano alcuni imprenditori che saranno poi la spina dorsale dei grandi gruppi industriali “moderni”: in particolare: Giovanni Agnelli, Camillo Olivetti, i fratelli Perrone, Guido Donegani, Cesare Pesenti, Giorgio Enrico Falck, Ettore Conti, Giovanni Battista Pirelli, Gaetano Marzotto, Ernesto Breda e Giuseppe Orlando. 4 Sono di quel periodo, e in risposa al clima che si era determinato, le leggi su riduzione dell'orario di lavoro, indennità di licenziamento, assicurazione di invalidità e vecchiaia.
4
neanche di cattivo occhio dai “produttori di allora), le principali confederazioni di categoria deplorarono le violenze dello squadrismo. Dopo l'assassinio di Giacomo Matteotti, il direttivo di Confindustria chiese il ripristino dell'ordine e della legalità costituzionale con un memorandum presentato nel settembre 1924 a Mussolini. Continuò inoltre a opporre (flebile) resistenza sia all'imposizione del monopolio fascista della rappresentanza dei lavoratori, sia ai progetti di corporativismo integrale. Soltanto nell'ottobre 1925, quando ormai i sindacati operai e i partiti antifascisti erano sul punto di essere messi al bando, la Confindustria si rassegnò a riconoscere il sindacato fascista quale suo unico interlocutore5. Negli anni fra le due guerre, duramente segnati dalla "grande crisi" mondiale del 1929, il regime fascista accordò all'industria assistenza e protezione, analogamente a quanto fecero altri governi di fronte a una recessione che minacciava di scardinare l'intero sistema produttivo. L'intervento pubblico, sfociato nel 1933 nella creazione dell'Iri, salvò dal dissesto numerose imprese passate così sotto "mano pubblica". Successivamente la politica autarchica favorì l'avvento di posizioni monopolistiche e di oligopolio, al prezzo di un progressivo isolamento dell'industria italiana dai circuiti del mercato internazionale e a scapito delle innovazioni tecnologiche e della competitività. In questo periodo dopo una breve presidenza di Raimondo Targetti e un lungo mandato, fra il 1923 e il 1934, di Antonio Stefano Benni si alternarono alla testa della Confindustria personaggi di grande spicco come Alberto Pirelli, presidente dell'Associazione fra le società per azioni, e il senatore Giuseppe Volpi che sarebbe rimasto in carica sino al 1943. Ma la Confindustria, per quanto accreditata e influente nelle alte sfere del Regime si trovò alle prese con il ruralismo e l'antiurbanesimo, la formazione di un ordinamento corporativo e gerarchico ("tutto dentro lo Stato, niente fuori dello Stato", secondo le direttive di Mussolini) che finirono per rappresentare la negazione dei principi del capitalismo industriale.
1.4) LA RICOSTRUZIONE E IL MIRACOLO ECONOMICO
All'indomani della seconda guerra mondiale, la Confindustria e le parti sociali assunsero un ruolo di primo piano nell'opera di ricostruzione. Ciò avviene per merito soprattutto di Angelo Costa, presidente dell’Associazione dal 1945 al 1955, dopo i brevi periodi di presidenza transitoria di Giuseppe Mazzini e Fabio Friggeri a seguito della caduta del fascismo e la liberazione di Roma. Egli seppe stabilire rapporti non strumentali, ma nel rispetto delle reciproche sfere d'autonomia, con i governi centristi di De Gasperi e riuscì a ricomporre il tessuto dei rapporti contrattuali con le organizzazioni sindacali. Fin dagli esordi del suo
5 Il patto di Palazzo Vidoni.
5
mandato vennero così siglati alcuni importanti accordi con la Cgil: lo sblocco dei licenziamenti, la perequazione salariale fra Nord e Sud, il ripristino delle Commissioni interne e l’istituzione della scala mobile. Quasi tutte le regole democratiche erano state calpestate nel ventennio e ciascuno per la propria parte doveva fare del suo meglio per ricomporre la democrazia, nel paese e nelle fabbriche. Altre intese a livello nazionale e di categoria vennero poi concluse nel corso degli anni Cinquanta con la Cisl e la Uil, le nuove confederazioni sorte nel 1948 dal distacco dalla Cgil della componente cattolica e di quelle repubblicana e socialdemocratica. Affiancato da un segretario generale come Mario Morelli (che manterrà tale carica sino al 1970) nell'opera di difesa e valorizzazione dei principi dell'iniziativa privata, Costa fu un deciso fautore del ripristino degli automatismi di mercato e della liberalizzazione degli scambi appoggiando le scelte della classe politica, anche a costo di non trovare il consenso di alcuni gruppi industriali restii a rinunciare al protezionismo doganale. Una presidenza senza dubbio importante in un periodo nel quale si rimettevano in discussione tutti gli equilibri. L'adesione nel 1957 dell'Italia al Mercato Comune e il "miracolo economico" vennero percepite dagli industriali come la realizzazioni delle convinzioni liberistiche di Angelo Costa. Trascinata dal forte sviluppo delle grandi imprese del "triangolo industriale" (meta da quel periodo di forti correnti migratorie dal sud della penisola) l'economia nazionale raggiunse tassi di sviluppo fra i più elevati del mondo occidentale. Sono questi gli anni della presidenza di Alighiero De Micheli. L'istituzione del ministero delle Partecipazioni statali e poi la politica di programmazione economica, che determinò nel 1962 la nazionalizzazione dell'energia elettrica, portarono però lo stato maggiore della Confindustria (presieduta da Furio Cicogna) su posizioni fortemente divergenti, sfociate in duri contrasti nei riguardi dei nuovi governi di centro-sinistra.
1.5) LA RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE E LA NASCITA DELLE “ARTICOLAZIONI” CONFINDUSTRIALI.
Per il mondo industriale (alla cui guida tornò nel 1966 Angelo Costa) le difficoltà si accentuarono nel corso degli anni Settanta. All'indomani dell'"autunno caldo" del 1969, le ondate di conflittualità operaia che si susseguirono per un decennio nei principali stabilimenti, scossero le fondamenta del sistema d'impresa, rendendo sempre più difficile la governabilità delle fabbriche. Di fronte al pericolo di isolamento, e nel pieno di una pesante recessione economica dovuta al vertiginoso rincaro del petrolio e alla forte crescita del costo del lavoro, la Confindustria reagì con una correzione di rotta in due direzioni: sul versante interno, con la cosiddetta "riforma Pirelli", si propose di rafforzare le proprie strutture organizzative con una rappresentanza più equilibrata e partecipata delle associazioni territoriali e di categoria e con l'apporto innovativo delle leve
6
più giovani, organizzatesi fin dal 1958 in vari gruppi locali. Su quello esterno, la Confindustria si aprì a un più ampio confronto con le forze politiche e sociali. Il disgelo nei riguardi del sindacato, avviato nel corso della presidenza di Renato Lombardi (affiancato dal 1970 da un manager esperto, Franco Mattei), sfociò nel 1974, durante quella successiva di Giovanni Agnelli, nella proposta di un'azione comune contro rendite e parassitismi, con lo scopo di ridare slancio e vigore alle forze produttive dell'impresa e del lavoro (vedremo poi il dettaglio nel secondo capitolo quando si analizzerà l’intero ”percorso” della Federmeccanica). In questo clima e nell'intento di contribuire a un ritorno della pace in fabbrica, venne siglato con i sindacati nel gennaio 1975 l'accordo sull'indicizzazione dei salari. A reggere la Confindustria nel periodo della "solidarietà nazionale" fra i partiti dell'arco costituzionale, intesa a fronteggiare l'offensiva del terrorismo, venne chiamato per la prima volta un personaggio di grande prestigio, che non proveniva dalle file dell'imprenditoria: l'ex governatore della Banca d'Italia Guido Carli. Durante il suo mandato (dal 1976 al 1980), che vide alla direzione dell'Associazione un autorevole economista come Paolo Savona (a cui si deve l'avvio operativo del Centro Studi), venne formulata da Confindustria la proposta di uno "statuto dell'impresa", in grado di affrancare il sistema imprenditoriale da "lacci e lacciuoli" politici e burocratici.
In questa fase storica e in questo contesto che nascono le “articolazioni” della Confindustria e del mondo confindustriale: il 9 novembre del 1965 venne fondato, “Il Sole 24 ore”, grazie all’accorpamento di due noti giornali di quell’epoca, “Il Sole” (nato nel 1865) ed il “24 Ore“ (che sorse nel periodo della seconda guerra mondiale). Le sue sedi sono ormai sparse in tutto il paese ma i due principali centri di redazione rimangono Milano, sede centrale che è situata in via Monte Rosa, e Roma in cui vi è quella parte di redazione con specifici obiettivi politici. Tutto il gruppo è attualmente sotto la gestione di Confindustria, che lo ha acquistato in tutti i suoi settori. Il Sole24ORE infatti non è soltanto un quotidiano ma rappresenterà un sistema editoriale formato da: IlSole24ORE Radiocor (agenzia di stampa economico - finanziaria), IlSole24ORE.com (il sito del quotidiano con accesso a servizi, banche dati e giornale digitale a pagamento), Radio 24 (emittente radiofonica nazionale "News and talk" nata il 4 ottobre 1999), Ventiquattrore.tv (è stata l'emittente del Gruppo 24ORE su satellite e sul digitale terrestre dal 2001 a fine 2006). Il quotidiano milanese, ha assunto nel tempo rilevanza e autorevolezza anche a livello internazionale, assicurando un’ampia e qualificata informazione economica incentrata sui principi dell'impresa e sulle regole del mercato. In quegli anni la Confindustria diventa anche proprietaria dell'Ateneo romano "LUISS Guido Carli", nato dall'acquisto da parte della stessa associazione degli imprenditori di una precedente istituzione universitaria, l'Università Pro Deo, costituita nel 1966. L'istituzione è stata
7
fondata nel 1974. Nel 1977 l'Università cambia ufficialmente il nome in LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali. Poco dopo, Guido Carli diventerà presidente dell'Università. La Luiss ha costituito per anni un moderno vivaio di formazione (nel campo dell'economia, del diritto e delle scienze politiche) per molti giovani del Centro-Sud. E’ figlia di quei tempi la concezione che l’associazione degli industriali debbano ricoprire ruoli culturali, formativi e filantropici oltre che di normale tutela delle aziende e del mercato (come vedremo bene nel secondo capitolo)
1.6) GLI ANNI DEL CAMBIAMENTO VERSO LA SOCIETA’ POST INDUSTRIALE E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL’ECONOMIA
All'inizio degli anni Ottanta, una fase importante nella vita dell'Associazione coincise con la presidenza di Vittorio Merloni (1980-1984). La sua designazione alla massima responsabilità degli industriali italiani costituì un tangibile riconoscimento del notevole ruolo assunto nel frattempo dalla piccola-media impresa all’interno dell’associazione. Il fabrianese era l’unico Presidente con una fama non legata ai grandi gruppi e alle grandissime aziende, non legato alle grandi dinastie imprenditoriali o alla tradizione industriale delle grandi città (Roma, Napoli, Torino, Genova). Esso rappresentava un aggiustamento di rotta che denotava un cambiamento nella tipologia di industria del paese. L'esigenza di una efficace politica industriale e la revisione della struttura del salario (dopo la disdetta della scala mobile) vennero poste al centro dell'azione della Confindustria, sotto la direzione di Alfredo Solustri le cui competenze professionali erano maturate all'interno dell'Associazione. Successivamente nel corso del mandato di Luigi Lucchini (tra il 1984 e il 1988) si affermò il principio della centralità dell'impresa come fattore propulsivo per la crescita economica e la modernizzazione sociale del Paese. La particolare esperienza nel campo delle relazioni sindacali ed esterne del direttore Paolo Annibaldi (che ricoprì questo incarico sino al 1990) valse a rendere più intensi i rapporti della Confindustria con istituzioni pubbliche e soggetti sociali. Sono questi gli anni di un forte rilancio dell'industria italiana, che conobbe rilevanti innovazioni organizzative e ampliamenti delle sue strutture produttive in nuove aree del paese, un tempo appena sfiorate dal processo di sviluppo (molte delle quali nel meridione).
Successivamente, in vista dell'appuntamento nel 1993 con la formazione del mercato unico europeo, s'impose sempre più la necessità di internazionalizzare l'economia italiana. Per la Confindustria, l'esito della partita nel nuovo scenario europeo sarebbe dipeso dalle ristrutturazioni aziendali, dall'aggiornamento degli impianti e dei processi, dalla competitività complessiva del sistema-paese, da una maggiore dotazione
8
di infrastrutture, dall'efficienza della macchina amministrativa, dall'ammodernamento dei servizi pubblici, da una nuova struttura del costo del lavoro e della contrattazione collettiva. Grazie alla politica di accordi fra governo, Confindustria e sindacati - avviata sotto la presidenza di Sergio Pininfarina tra il 1988 e il 1992 - l'Italia seppe controllare l'inflazione e realizzare una sia pur imperfetta politica dei redditi, evitando i rischi di un'emarginazione dai paesi più industrializzati. Decisivo in tal senso fu l'accordo del 10 dicembre 1991 sulla lotta all'inflazione, a seguito del quale il 1° maggio del 1992 per la prima volta non venne pagato il "punto pesante" di contingenza. Tale linea proseguì sotto la presidenza di Luigi Abete (dal 1992 al 1996) con l'accordo del 7 luglio 1992, che stabilì l'abolizione della scala mobile. Nel corso di quegli anni venne ribadita l'autonomia e l'apartiticità della Confindustria al di fuori di ogni collateralismo politico e furono adottati nuovi criteri partecipativi del sistema associativo. Il processo d'integrazione dell'Italia nella Comunità europea si rivelò, tuttavia, assai più ricco di ostacoli di quanto si pensasse originariamente, a causa di una nuova difficile congiuntura economica. Il Paese si trovò ad affrontare, negli anni di Tangentopoli, una grave crisi politica e istituzionale. Pur trovandosi a operare in acque così agitate, anche a causa di inchieste giudiziarie che coinvolsero alcune grandi imprese, la “Confindustria tentò di mantenere la rotta, all'insegna di una linea di condotta non corporativa e aperta al confronto con la società civile sostenendo lo sforzo delle imprese italiane per aumentare i loro livelli di competitività, impegnandosi, nell'ambito della concertazione con governo e sindacati che portò all'accordo del luglio 1993 sulla politica dei redditi”. Confindustria contribuì ad individuare le misure più appropriate per provvedere al risanamento finanziario e ridare ossigeno al sistema produttivo. Nel corso degli anni Novanta si susseguono importanti innovazioni nel sistema industriale italiano con il passaggio al post-fordismo e la diffusione delle tecnologie elettroniche. Nelle regioni del Centro-Nord si andò ampliando la rete dei distretti industriali, dei comprensori specializzati in particolari segmenti della produzione. Numerose località del Mezzogiorno hanno conosciuto sviluppi significativi, grazie a nuove iniziative messe in cantiere dall'imprenditoria locale e da operazioni di decentramento di parte delle loro attività effettuate da alcuni grandi gruppi nazionali e stranieri. La Confindustria ha rafforzato le sue credenziali di istituzione capace di conciliare la tutela dei propri associati con gli interessi generali del Paese e lo sviluppo di una moderna cultura economica e sociale.
Dal maggio 1996, con la presidenza di Giorgio Fossa, l’associazione si è spesa per altri importanti settori per la crescita dell'economia italiana e la modernizzazione del sistema. Riforma del sistema previdenziale e sanitario, semplificazione legislativa e amministrativa, sviluppo della formazione e della ricerca, riduzione della pressione fiscale sulle imprese,
9
liberalizzazioni e privatizzazioni, flessibilità del mercato del lavoro e dei fattori produttivi, creazione al Sud di condizioni più idonee per l'incremento degli investimenti e dell'occupazione: sono questi i principali temi che Confindustria ha affrontato negli ultimi anni del secolo con proprie indicazioni e proposte. All'interno della Confindustria, in anni recenti, è stata sviluppata ulteriormente la presenza a livello territoriale del Gruppo dei Giovani Imprenditori i quali hanno acquistato maggior consistenza nelle strutture associative. Sono inoltre entrate a far parte del sistema aziende privatizzate o in via di privatizzazione facenti capo all'Eni e all'Iri, a seguito dello scioglimento delle rispettive rappresentanze associative imprenditoriali, Asap e Intersind (come previsto dall'esito del referendum del 18 aprile 1993 sull'abolizione del ministero delle Partecipazioni statali). Tra le principali novità di questo periodo particolare rilievo ha assunto l'impianto di un'organizzazione integrata nelle nuove tecnologie informatiche: in tal modo si è voluto corrispondere efficacemente alle esigenze di una compagine associativa sempre più vasta e differenziata, nell'ambito di una realtà economica e sociale in continuo cambiamento.
In questa prospettiva si colloca la Carta dei Valori Associativi. Approvata dall'Assemblea del 1999, essa sancisce i principi ispiratori su cui si basa il comune sentire delle aziende che riconoscono alla Confindustria un ruolo fondamentale nella rappresentanza e nell'associazionismo imprenditoriale.
1.7) IL NUOVO MILLENNIO E LA GRANDE CRISI
Questi anni si caratterizzano dall’ultima fase dell’entrata in vigore dell’euro in sostituzione della lira e da un altro e più incisivo evento che segnerà profondamente gli anni avvenire: “l’attentato alle torri gemelle” che provoca una rottura, autentica oltre che simbolica, con il passato. L’euro si rivela il mezzo di stabilità comune che avvicina i paesi membri della comunità e senza il quale le singole monete poco avrebbero contenuto l’impatto negativo della crisi. Sono gli anni della presidenza di Antonio D’Amato, che affronta queste battaglie iniziando dal rilancio della competitività e del mezzogiorno. Il Governo da parte sua instaura un modello flessibile del mercato del lavoro6. L’Europa pone rigidi obiettivi di stabilità e giunge alla firma della nuova costituzione europea. Intanto la globalizzazione, l’innovazione tecnologica che hanno contribuito ad abbattere molte barriere, hanno però messo in competizione paesi distanti tra loro per cultura, capacità competitive e tradizioni estremamente diverse. Nella primavera del 2004 gli industriali italiani chiamano Luca Cordero di Montezemolo, già presidente della Fiat e della Ferrari, a rappresentarli.
6 È di questi anni (14 febbraio 2003) e figlia della nuova cultura industriale globale e competitiva (poi sappiamo come andrà a finire) la legge Biagi che rivoluziona le nuove norme in materia di occupazione e mercato del lavoro.
10
Vengono poste al centro dell’azione di Confindustria il rispetto delle regole internazionali, la lotta alla contraffazione, la tutela dei brevetti7. L'obiettivo dichiarato è stato far crescere le imprese promuovendo politiche di semplificazione, innovazione, flessibilizzazione e liberalizzazione. Gli industriali puntano sulla organizzazione della produzione avendo bene in mente che il mercato che si allarga non è solo un mercato di esportazione ma è sempre più anche un mercato di produzione. L’altro “pilastro” dell’attività confederale riguarda gli investimenti in formazione e ricerca, ma anche la salvaguardia del “made in Italy”. Il presupposto è che il mondo è tornato a viaggiare sulle idee, sapendo bene che le idee sono anche il prodotto di una applicazione perseverante e di uno studio profondo e diffuso. Dal canto suo il Governo, cercando di dare fiducia agli investitori, dopo i recenti scandali aziendali internazionali si concentra sulle riforme, quali il sistema pensionistico, la scuola e il federalismo.
Da fine 2008 inizia la grande crisi economica-finanziaria che sconvolge e in qualche misura rimette in discussione tutte le organizzazioni sociali. Essa costituirà uno spartiacque per tutti i soggetti operanti nel mondo produttivo e di fatto indebolirà il tessuto produttivo nazionale, il sistema economico e le “parti sociali” che ne giovano e che dallo stesso traggono sostentamento. Ad un indebolimento del complesso industriale italiano si accompagnerà un indebolimento (e una differenziazione) della rappresentanza e del modo di intenderla, le cui conseguenze sono ad oggi imprevedibili.
CAPITOLO 2 2.1) MODELLI CULTURALI E RAPPRESENTANZA IMPRENDITORIALE: IL CASO FEDERMECCANICA DAGLI ANNI 70 AGLI ANNI 90 Questo particolare capitolo si prefigge di analizzare un periodo temporale particolare e la nascita di un’associazione specifica, quella dei metalmeccanici, all’interno della Confindustria, che, dalla costituzione in avanti, ha dettato un po’ il passo di tutta l’organizzazione e che con la nascita, lo sviluppo e la pratica contrattuale ha segnato il passo delle relazioni sindacali. Un focus per allontanarsi per un attimo da un ragionamento generico e andare a sviscerare, tramite dati, esempi e fatti la rappresentanza imprenditoriale metalmeccanica in un ventennio di storia italiana.
7 Tutti temi “sensibili” per le aziende nel momento in cui si sono affacciati e consolidati sul mercato le cosiddette “tigri asiatiche”.
11
Tramite la lettura di diversi documenti analizzeremo la relazioni industriali dalla nascita della Federmeccanica (15 settembre 1971) al finire degli anni 80, inizio anni 90 che costituiscono senza dubbio il momento più alto di una riflessione che non è più solamente contrattuale ma che diventa istituzionale e politica (aldilà delle attribuzioni partitiche). Attraversando eventi storici rilevantissimi, ma lasciandoli sullo sfondo, come “l’autunno caldo”, la costituzione di di CGIL-CISL-UIL in federazione unitaria (FLM), lo shock petrolifero del 73, la riforma del meccanismo della scala mobile (e il referendum poi), la marcia dei 40000, il rinnovo del contratto dei metalmeccanici etc etc., cercheremo di interpretare il ventennio nel corso del quale si sono sostanzialmente ribaltati (o comunque recuperati) i rapporti di forza (a favore degli imprenditori) e che ci ha di fatto portato nell’epoca moderna (ante-globalizzazione). La storia degli imprenditori metalmeccanici all’interno della Confindustria è una storia di strappi, di differenziazioni, di nascita di una coscienza di classe, di traino etc. Le ricadute di questa “connotazione forte2 si sentono anche oggi, si pensi ai contratti separati e alla contrapposizione forte, ancora in corso, con la Fiom. 2.2) CONTESTO STORICO-ECONOMICO- SOCIALE I livelli occupazionali e la loro distribuzione costituiscono la prima variabile del ragionamento che andremo a sviluppare. Al culmine del boom economico del ’63, oltre 6.253.000 persone erano occupate direttamente nell’industria, esse crescono più o meno ininterrottamente fino agli anni 80 raggiungendo i 6.535.000 (grazie anche al “travaso” dal settore dell’agricoltura). Dagli anni 80 in avanti la discesa dei dipendenti dell’industria è costante. Cosi, mentre nel settore “altre attività” o “terziario” la crescita è costante, l’occupazione industriale scende a livelli tali da considerarsi “epifenomeno della riduzione massiccia del peso sociale, strutturale, della classe operaia italiana all’interno della stratificazione socio-professionale del paese”8. All’erosione del peso socio-professionale della classe operaia si affianca il fiorire della “nuova borghesia industriale” che, per molti studiosi, è il fatto innovativo dell’Italia del dopoguerra. Dall’incrociarsi di questi due andamenti emerge un quadro realistico e in grado di facilitare la comprensione di ciò che è successo nei 20 anni individuati. Già a partire dagli anni ’50, mentre si consolidano i grandi gruppi industriali, si assiste alla crescita costante di una nuova borghesia industriale: accanto ai macro-impulsi hanno operato costantemente un fascio di forze imprenditoriali promananti “dal basso” che non ha eguali in Europa. Un’impresa nuova, non figlia di patrimoni fondiari, non figlia di titoli
8 Giulio Sapelli, ordinario Storia dell’Italia contemporanea, Università di Milano, “Modelli culturali e rappresentanza imprenditoriale – il caso Federmeccanica”, novembre 1990.
12
nobiliari, non figlia di famiglie illustri. Siamo dinnanzi a gruppi sociali formati da figli di piccoli imprenditori, ma soprattutto da mezzadri toscani e marchigiani, da artigiani veneti, da emigrati friulani e da operai specializzati e professionalizzati che attraversano trasversalmente “le Italie” e si fanno “classe”. “Queste è l’essenza della questione: si è trattato di un esteso e imponente processo di mobilitazione sociale, del forse più importante processo di mobilità verticale mai avvento nel nostro paese. E sicuramente del più rilevante per le sue conseguenze sociali e politiche”9. All’interno di questa nuova classe di imprenditori, spicca, perché numericamente più consistente e strategicamente più importante, l’industria metalmeccanica. E quindi in questo scenario va inserito il percorso economico e cultural-politico dell’industria metalmeccanica italiana e della sua rappresentanza. Due le riflessioni da farsi, sebbene di segno opposto, sulla genesi dell’associazione Federmeccanica. Da un lato la caduta dei tassi di profitto, consumatasi in modo verticale dal 69 in avanti, la conflittualità sindacale, la crescita vertiginosa dei salari, l’ammodernamento delle tecnologie e dei modelli organizzativi creano l’humus sociale e politico per un nuovo associazionismo e le precondizioni per “consorziarsi”. Dall’altro, la struttura finanziaria prevalente nell’industria in generale e in quella metalmeccanica in particolare (ossia l’essere fondata su una struttura proprietaria non aperta a terzi sul mercato, il che impone una crescita fondata sui propri mezzi o sull’indebitamento, con importanti riflessi sulla struttura dimensionale delle imprese), la dimensione stessa di impresa (autoveicoli, elettrodomestica, aereonautica e siderurgia prevale la grande impresa, fonderia navalmeccanica e impiantistica la media impresa, macchine utensili, componentistica e macchine in genere la piccola), la dinamicità e le capacità del settore, rendono la nascita della Federmeccanica travagliata. Il singolo imprenditore che è concentrato (socialmente e culturalmente) sulla sua perfomance piuttosto che sugli interessi “di classe” è meno propenso ad associarsi, a condividere la propria esperienza e ad aprirsi agli altri. Tutti gli elementi esposti, messi insieme, mostrano un quadro molto articolato e molto frammentato e che rendono la rappresentanza obiettivamente più difficile. 2.3) NASCITA E FINALITA DELL’ASSOCIAZIONE FEDERMECCANICA Da questi elementi occorre partire per comprendere il processo che darà luogo alla nascita di Federmeccanica il 15 settembre del 1971. I rappresentanti delle Associazioni Industriali territoriali di tutta Italia che originarono la Federmeccanica, aderente alla Confindustria, all’art. 3 dell’Atto Costitutivo si prefiggevano di “tutelare, nel campo dei problemi del
9 Giulio Sapelli, ordinario Storia dell’Italia contemporanea, Università di Milano, “Modelli culturali e rappresentanza imprenditoriale – il caso Federmeccanica”, novembre 1990.
13
lavoro e particolarmente nel campo sindacale, gli interessi dell’industria metalmeccanica e degli aderenti rappresentandoli ed assistendoli nei rapporti con le organizzazioni sindacali e stipulando attraverso i competenti organi i contratti collettivi di lavoro….la Federazione svolgerà altresì opera di ricerca e studio nel campo dei problemi sindacali, sociali e del lavoro nei loro vari aspetti giuridici, tecnici sociologici ed economici, curerà le relazioni con Associazioni ed enti, nazionali ed internazionali ….promuoverà la formazione professionale nel settore metalmeccanico a tutti i livelli, e provvederà, infine, all’informazione ed alla consulenze degli associati relativamente ai problemi generali e speciali dell’imprenditorialità e delle industrie”10. Il conflitto sociale, con quelle variazioni improvvise e tanto rilevanti dei costi dei fattori produttivi, portava alla luce un universo fortemente ramificato di interessi cristallizzati nella “nuova borghesia industriale”. Da questo punto di vista, tra le conseguenze dell’autunno caldo nella storia d’Italia, oltre a quelle generate dall’improvviso l’emergere della cittadinanza sociale della classe operaia, va annoverata quella altrettanto decisiva e importante della nascita dell’identità collettiva della nuova “borghesia industriale metalmeccanica”. Un’identità collettiva di contrapposizione, quasi una reazione: banalizzando, non si sapeva ancora che cosa erano e dove andavano ma avevano chiaro in mente cosa non erano e contro chi si sarebbero battuti. Questo ha fatto si, in qualche maniera, che negli anni cruciali della storia del nostro paese si diffondesse un’immagine, in Italia e all’estero, tutta incentrata sulla “questione operaia”, mentre invece, contestualmente a quella, nasceva in modo prepotente, una “questione imprenditoriale”. “Ciò che portò all’unificazione associativa quel complesso tanto differenziato di forze, ch’era appunto, come si è detto, l’industria metalmeccanica italiana, fu l’emergere improvviso della mobilitazione sociale operaia prima e sindacale poi”11. Il primo presidente, Emilo Mazzoleni sosteneva che le imprese metalmeccaniche non potevano più sopportare lo stato di tensione e violenza che si registrava dal settembre 1969 e evidenziava la necessità di un dialogo con il sindacato formato su regole e processi negoziali che desse certezze all’azione degli imprenditori. La Federmeccanica doveva anzitutto tener conto delle esigenze delle piccole e medie imprese che divergevano in maniera importante rispetto a quelle delle grandi imprese, Fiat in primis. La conseguenza “contrattuale” di questa impostazione era la rottura del tavolo delle trattative per il rinnovo del CCNL (16 gennaio 1973). Il gesto, eclatante per i tempi, fa sorgere l’interrogativo: quale fu il meccanismo di
10 Cfr. Archivio Federmeccanica, Atto costitutivo dell’Associazione “Federazione Sindacale dell’Industria Metalmeccanica Italiana”, redatto presso il notaio Luigi Napoleone, in Roma, il 15 settembre del 1971. 11 Giulio Sapelli, ordinario Storia dell’Italia contemporanea, Università di Milano, “Modelli culturali e rappresentanza imprenditoriale – il caso Federmeccanica”, novembre 1990.
14
identificazione degli interessi, di formazione di sistemi di solidarietà di creazione di un associazione? Gli esponenti della nuova borghesia industriale non avevano ancora una rappresentanza ben definita, ma dall’insorgere della mobilitazione e sull’onda della stessa erano minacciati. I loro interessi non potevano difendersi tramite la troppo generale rappresentanza della Confindustria ma necessitavano di una difesa di “classe” e di “settore”. I portatori della nuova identità, specialmente i piccoli e medi imprenditori metalmeccanici, erano titolari di imprese che solo attraverso l’unificazione associativa potevano creare quelle energie sociali e politiche tramite le quali promuovere il soddisfacimento della loro volontà (le grandi imprese potevano invece disporre di un “potere situazionale di fatto” fondato sul controllo autonomo e diretto di risorse in quote massicce e tali da turbare la “pace sociale” con la minaccia della disoccupazione). Tutti questi fattori consentirono di porre su solide basi la costituzione della Federmeccanica, non enfatizzando più di quanto fosse indispensabile la stessa articolazione e la sottrazione di poteri della Confindustria che così veniva delineandosi. 2.4) EVOLUZIONE E STRATEGIE DELLA FEDERMECCANICA Quindi l’associazione nasceva non con la volontà di infrangere, ma con quella di istituire regole, e la volontà di farlo è comprovata dal programma d’azione dell’associazione subito reso noto. I nodi individuati sin dall’inizio erano: la crescita del costo del lavoro rapida e non programmata, la corrispondente non crescita della produttività, il regime degli orari e il ridotto tasso di utilizzazione degli impianti, l’esasperata conflittualità industriale unitamente all’assenteismo crescente. A detta loro, il combinato disposto di questi elementi aveva messo in crisi i rapporti aziendali e umani dei protagonisti del processo produttivo. Le relazioni industriali, per l’associazione erano da ricostruire: perfino i livelli contrattuali erano in discussione. Il sindacato, almeno alcune frange, premeva molto per il contratto nazionale ma anche per il livello decentrato per far in modo che il conflitto fosse permanente. Federmeccanica sosteneva un sistema di regole più chiaro dove la contrattazione nelle aziende non si sovrapponesse a quella nazionale e non investisse l’azienda più volte. La posizione degli imprenditori metalmeccanici non era contraria in linea di principio ad una contrattazione articolata a livello aziendale che si proponeva come la soluzione aziendale dei problemi che non trovano risposte a livello nazionale, tuttavia non la incoraggiava12. Certezza dunque, e non imprevedibilità; programmazione e non rottura degli equilibri appena consolidati. Contribuire quindi a una ulteriore, regolata e meno squilibrata crescita del paese. Ecco cosa voleva Federmeccanica nella
12 È piuttosto curioso il ribaltamento dei ruoli tra sindacato e FEDERMECCANICA se si pensa alla contrattazione nazionale e territoriale, nel dibattito anche odierno.
15
fase iniziale-costituente. L’azione iniziale della Federmeccanica si sostanziava in questo: partecipazione alla gestione del potere contrattuale e “costituzione di un nucleo associativo insieme fortemente coeso e fortemente propositivo”13 Da qui il dibattito che ci portiamo dietro e che analizzeremo nel prossimo capitolo su quale fisionomia doveva darsi la Confindustria: nel direttivo confindustriale del 1972 si confrontavano le tesi di Umberto Agnelli e Franco Mattei e si dibatteva se l’associazione doveva essere un’organizzazione eminentemente politica, oppure, in primis, rivolta a fornire servizi e a garantire potere contrattuale. Come la si voglia vedere è evidente l’apporto dato al dibattito dalla Federmeccanica e la crescente sintonia della stessa con la Confindustria14. E quindi, già dai primi anni della costituzione si può identificare nell’associazione FEDERMECCANICA qualcosa di più di una semplice rappresentanza di interessi immediati, scaturenti dall’agone del conflitto. Emerge da subito un ruolo nell’indicazione progettuale, di delineazione di prospettive future, una visione d’insieme destinata poi a dipanarsi negli anni successivi. 2.5) VERSO LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI GENERALI, FINE DEL CICLO OPERAIO-SINDACALE AVVENTO DI QUELLO BORGHESE-INDUSTRIALE S’intravvede subito, nella dinamica concreta della vita della Federmeccanica, il suo trasformarsi in associazione che non vuol più soltanto adempiere a pure finalità di resistenza sindacale, vuole incanalare la discussione su temi più generali e di interesse comune. In quel breve lasso di tempo veniva affacciandosi, quali che fossero e che furono le conseguenze non previste, un sistema informale diretto a ricercare quanto meno una reciprocità e una compatibilità tra gli interessi e la progettualità preposte alla rappresentanza del mondo industriale e di quello operaio. Il presidente Mandelli che nel 74 succede a Mazzoleni nella sua relazione parla di superare i corporativismi, parla di superamento della conflittualità, richiede un ruolo attivo al governo e invita la politica a essere più risoluta nel dare le risposte e nel tenere a mente le istanze dei produttori “oggi è forse possibile, operare il salto di qualità, che permette di conciliare le esigenze della società industriale con quelle della società civile, il successo dell’impresa, che pur resta alla base della nostra legittimazione dei nostri imprenditori, non è più sufficiente a garantirci il posto che ci compete nella società, dobbiamo dimostrare la nostra capacità di 13 Giulio Sapelli, ordinario Storia dell’Italia contemporanea, Università di Milano, “Modelli culturali e rappresentanza imprenditoriale – il caso Federmeccanica”, novembre 1990. 14 Nelle elezioni che si svolsero nell’assemblea del 73, il presidente della Federmeccanica, Mazzoleni, risultava il secondo dei primi 10 eletti con 3749 voti (dopo Leopoldo Pirelli con 4103)..
16
partecipare, in prima persona, alla direzione del paese”15. E mentre nel 75 si costituisce la Federtessile, viene alla luce negli industriali metalmeccanici una volontà e capacità partecipativa prima inusitata che si delinea proprio mentre è in corso il processo di profonda ristrutturazione della classe operaia nel paese. L’epopea di Federmeccanica si compone e si nutre anche di alcuni fenomeni simbolici come i 1500industriali riuniti a Roma nel corso delle trattative per il rinnovo del CCNL, manifestazione di certo non consueta, che fanno crescere il consenso e la considerazione dell’associazione. Si assiste quindi ad un cambio culturale dell’associazione e degli imprenditori che la compongono: una cultura non più limitata alla risposta ma fondata sulla convinzione di dover elaborare progetti generali che aspirano a rispondere a problemi universalistici anziché particolaristici. E quindi interpretazione dei problemi sociali del paese in prima persona, diagnosi per la risoluzione degli stessi e dispersione delle tensioni provenienti dalle lotte operaie e sindacali. Addirittura Madelli sostiene che il contratto metalmeccanico del ‘79 oltre ad essere un punto altissimo ed acquisitivo per tutte le aziende, opera affinché la ricchezza torni ad essere considerata un “valore etico” in Italia e che la ricomposizione della società italiana passa anche da questo. Di pari passo, tra la fine degli anni 70 e inizio anni 80, la mobilitazione sindacale e operaia declinava e la conseguenza non fu soltanto “un secco ridimensionamento quantitativo della classe operaia, ma la sua radicale declassazione politica, da classe generale a classe particolare come dimostrò in seguito il referendum sulla scala mobile del 1985”16. Il nuovo ciclo, a suo modo di vedere, era caratterizzato dalla centralità politica della borghesia industriale, che non si confronta in maniera decisiva non con la classe operaia e con il sindacato ma con lo stato e la classe politica. L’evento che segna, nell’immaginario collettivo, il punto di avvio del nuovo ciclo è la sconfitta sindacale nel corso della lotta dei 35giorni alla Fiat, culminata con la marcia dei 40.000. Ciò giungeva a compimento con l’avvento della fase neo-industriale della società italiana che aveva, come ricordato, come connotati caratteristici: la terziarizzazione dell’industria, il progresso tecnologico, la diminuzione numerica della classe operaia, l’accrescersi di processi di differenziazione e segmentazione sociale. Da un punto di vista contrattuale, dopo il 1980 i salari iniziano a discendere e a differenziarsi (prima c’era la parità di trattamento tra impiegati e operai), iniziano a darsi aumenti sulla base del merito, indennità speciali per speciali funzioni e inizia, più in generale, un mutamento verso la dispersione salariale e l’articolazione retributiva.
15 Cfr. AF, Mandelli, Verbale dell’Assemblea generale ordinaria, Roma 11 giugno 1974 16 Giulio Sapelli, ordinario Storia dell’Italia contemporanea, Università di Milano, “Modelli culturali e rappresentanza imprenditoriale – il caso Federmeccanica”, novembre 1990.
17
Dagli anni 80 in avanti il nuovo soggetto politico voleva incidere di più e impose a tutti, governi e sindacati il “fattore Confindustria” di cui si doveva tener conto nella definizione della politica economica e della politica rivendicativa. Nel corso dell’Assemblea genrale di Federmeccanica, il 1 luglio 1982, dopo la relazione del presidente Walter Fontana, il vicepresidente della Confindustria Mandelli, espresse in termini inequivocabili ciò che era la volontà e l’orientamento dell’azione “nel 1968 la borghesia ha abbandonato il potere politico, che è stato occupato prima dai sindacati oggi dai partiti. La disdetta dell’accordo sul punto unico di contingenza è stato un atto dovuto al paese e un fatto politico che ha riconquistato alla borghesia una quota di potere che l’appartiene. Ora l’attività politica del Paese non potrà non tenere conto della presa di posizione degli imprenditori”17. 2.6) L’ANIMA PENSANTE E POLITICA” DALLE RELAZIONI INDUSTRIALI ALLE ISTITUZIONI I primi anni ’80 per la Federmeccanica sono anni cruciali, si delinea lo schema interpretativo della stessa, la “visione” dei rapporti politici e sociali che viene elaborando. La fase storica è caratterizzata dalla centralità tecnologica, finanziaria e organizzativa, dall’introduzione dell’automazione e della robotica che l’industria metalmeccanica ha dovuto fare per sopravvivere. In questo quadro, da “sindacato di risposta” come era alle origini, essa assume gradualmente il carattere di “organizzazione di rappresentanza delle imprese metalmeccaniche nel senso più ampio. Ancora verso i sindacato dei lavoratori non c’è dubbio, ma anche verso tutti gli enti e gli organismi che operano influenzando la politica economica e industriale del paese”18. Un sindacato di proposta per dirla in una sola parola. Il ruolo politico imponeva la riconsiderazione di quello sindacale, ormai quasi secondario. La FEDERMECCANICA si rappresentava quindi, anche all’interno della Confindustria, come “l’anima pensante, politica e propositiva della categoria”. Negli anni centrali del decennio ’80 l’associazione elabora un compiuto modello interpretativo della realtà, in cui il suo ruolo diventa spiccatamente culturale, di indirizzo e di discussione all’interno sia del mondo imprenditoriale sia della società politica e della comunità scientifica. Nulla è più eloquentemente dimostrativo dei contributi apparsi in quel periodo sulle riviste o gli Osservatori19 costituiti dal 1983 in avanti. Da quel momento inizia la
17 Cfr. AF, Assemblea della Federmeccanica. Verbale di riunione del 1 luglio 1982. 18 Giulio Sapelli, ordinario Storia dell’Italia contemporanea, Università di Milano, “Modelli culturali e rappresentanza imprenditoriale – il caso Federmeccanica”, novembre 1990. 19 L’”Osservatorio delle relazioni industriali”, interrogò 150 imprenditori metalmeccanici con almeno 20 dipendenti in un campione statistico preso dagli associati e sostanzialmente spiegava loro come migliorare le relazioni con i sindacati e con i dipendenti, scandagliava i vari accordi aziendali e limettevaa confronto
18
pubblicazione di una serie di importanti lavori di ricerca destinati non più agli associati, ma all’opinione pubblica o alla comunità scientifica. Da un punto di vista più prettamente sindacale il fine della Federmeccanica era disinnescare il contenuto eversivo del conflitto del lavoro (gli scioperi continui, a singhiozzo, a gatto selvaggio etc) per renderlo un “conflitto di interessi”, meno impattante e dalle conseguenze più prevedibili. E quindi non l’annichilimento sindacale o dei diritti, che continuavano a difendersi con la legislazione introdotta negli anni ‘70 (vedi Statuto dei lavoratori) bensì si trattava di entrare nell’idea di un “conflitto ragionato, dove “ciascuno misura la sua forza con quella dell’avversario, cosciente che la dipendenza reciproca non ammette se non relazioni funzionali ai propri obiettivi”20. A tal proposito si è anche detto che “il difetto principale - di dieci anni di relazioni industriali - è stato, di credere che non servisse una regolamentazione del conflitto…lasciare libero il conflitto di riaprirsi continuamente ha avuto degli effetti disgregativi non solo per l’organizzazione d’impresa, ma anche per l’organizzazione sindacale. Perché non esiste organizzazione che alla lunga possa reggere senza individuare chi ha livelli di responsabilità, i soggetti capaci di incidere e di avere un’autonomia decisionale. Tutto questo non c’è stato e ha portato, alla lunga, a una disgregazione culminata, dagli anni 80 in avanti, nel declino del peso del sistema di relazioni industriali come sistema di regolazione economico-sociale”21. E quindi mentre viene delineandosi una “cultura della produzione” da parte industriale, fatica ad emergere una nuova e altrettanto complessiva cultura sindacale dopo le rovine e le distruzioni prodotte dalle élites proliferate nell’autunno caldo. Non cresce una cultura interagente e fungibile con quella industriale, così da divenire un unico e solo patrimonio per le “élites di produzione”. Sono invece i lavoratori in quegli anni che, sconfessando in una certa misura le élites sindacali, rendono manifesta la loro propensione al cambiamento. Segnali tuttavia non colti dalle organizzazioni sindacali. Comunque, a prescindere dalla lettura che se ne voglia dare, quasi tutti gli studiosi sono d’accordo nel dire negli anni ‘80 si è lavorato di più che negli anni ’70 e che sono aumentati sia la produttività sia i profitti d’impresa. Nelle due elaborazioni successive, Imprese e lavoro/2 e Imprese e lavoro/3, datate 1986 e 1988, vengono esplicitati le politiche economiche di Federmeccanica. In particolare il secondo documento si prefiggeva di regolare il rapporto tra stato e mondo produttivo in risposta al crescente peso dello stesso. Nel secondo volume ci si spinge a suggerire un nuovo welfare, un welfare diverso, più congruente con le finalità dell’apparato produttivo. Gli industriali, al pari di tutti i cittadini, sono contribuenti e fruitori tracciando la linea di quelli migliori e più performanti. Nell’inchieste dell’Osservatorio si delineava chiaramente un nuovo impetuoso protagonista dell’Italia moderna: il mercato. 20 Giulio Sapelli, ordinario Storia dell’Italia contemporanea, Università di Milano, “Modelli culturali e rappresentanza imprenditoriale – il caso Federmeccanica”, novembre 1990. 21 G. Berta, “La contrattazione come processo di adattamento”, in “Industria e sindacato”, n. 6, 1987.
19
dello stato produttore di servizi e del welfare, “anzi sono fortemente interessati alla loro efficienza, non fosse altro per non essere costretti a surrogarli a loro spese, come accade sempre più frequentemente”22. E quindi da questi documenti si evinceva l’imminenza di elaborare una strategia per i prossimi anni, una strategia non solo orientata alle relazioni industriali, ma che deve prendere in considerazione diversi altri aspetti come il rapporto con le istituzioni troppo a lungo trascurato. È il momento di dire che nelle istituzioni il paese deve ritrovarsi e che le istituzioni devono essere in grado di compiere scelte tenendo conto di tutte le componenti della società. È il momento di sollevare la questione fiscale ma anche previdenziale, di parlare di liberalizzazioni, di efficientamento dei servizi (e dei dipendenti pubblici) ma anche di perimetro dello Stato e spesa pubblica.. Emerge pertanto una volontà Confindustriale (oltre che specifica di Federmeccanica) di misurarsi direttamente con i problemi che di volta in volta sono più urgenti: di volta in volta ricercando le alleanze politiche e partitiche più idonee allo scopo. E quindi impegno politico non teleologico, ma pragmatico. Gli imprenditori, secondo il detto degasperiano non devono essere “Mai soli, ma neppure, oggigiorno, in compagnia di tutti, perché, e le esperienze in tal senso non mancano, è forse peggio che essere soli”. Questo ricercare le alleanze volta per volta è sinonimo, non soltanto di una completa “istituzionalizzazione” della Federmeccanica, ma anche soprattutto di una sua condizione di forza, di stabilità e di consapevolezza ideologica che va al di là dei risultati raggiunti. “non è un’alleanza stabile che gli imprenditori possono guardare, ma alle aggregazioni che nel paese si propongono volta per volta obiettivi nei quali essi ritengono di riconoscersi, in quanto funzionali al consolidamento di una condizione sociale e politica consona allo sviluppo economico”23. In definitiva un atteggiamento propositivo (con sfumature camaleontiche..) che richiama la più importante delle associazioni industriali, la Confindustria ad elaborare una linea generale, sindacale e politica. Con la “fase della politica” si conclude il ciclo iniziato dopo l’autunno caldo della “fase del sindacato”. 2.7) FEDERMECCANICA, PATTO POLITICO E SINDACALE (LA RICERCA DEGLI INTERLOCUTORI) Sul finire degli anni 80 gli imprenditori si misero a tavolino per cercare di individuare le soluzioni politiche che rispondessero alle loro istanze pratiche per dare continuità alla politica rivendicativa (e di risultati)
22 Giulio Sapelli, ordinario Storia dell’Italia contemporanea, Università di Milano, “Modelli culturali e rappresentanza imprenditoriale – il caso Federmeccanica”, novembre 1990. 23 Giulio Sapelli, ordinario Storia dell’Italia contemporanea, Università di Milano, “Modelli culturali e rappresentanza imprenditoriale – il caso Federmeccanica”, novembre 1990.
20
perpetrata nel quindicennio. Dall’analisi del documento Imprese e lavoro/3 si evince una certa lucidità (e anche una qualche attualità) nell’analisi dei soggetti in campo e delle ipotetiche alleanze future. Una discontinuità netta rispetto all’atteggiamento precedente per cui la Confindustria era filo-governativa per definizione ma anche rispetto alle scelte degli anni 2000 in cui sostanzialmente la stessa si ri-appiattirà sulle posizioni dei governi di centro-destra. L’analisi è molto interessante, la riporteremo per sommi capi a conclusione del presente capitolo perché costituisce una fotografia nitida (sebbene di parte) dei tempi, dei pesi e dell’affidabilità dei protagonisti di quasi trent’anni fa. La domanda alla quale cerca di rispondere la Federmeccanica di fine anni ’80 è essenzialmente “con chi camminare”? Chi sollecitare e coinvolgere per una politica economica che riconosca all’impresa la centralità del suo ruolo24? Da qui la riflessione, la valutazione attenta e la necessità di individuare “volta per volta i “compagni di viaggio” i quali, in un certo momento del loro itinerario, vanno nella nostra stessa direzione” e “guardare dove va il compagno di strada e non da dove viene”25. La premessa delle alleanze è la sostanziale inaffidabilità di tutti i soggetti, partitici e sindacali, per inadeguatezza, credibilità, lontananza ideologica o ininfluenza. E quindi la necessarietà, ma anche la difficoltà nel tracciare un programma preciso di alleanze che in tempi misurabili conduca a scambi politici precisi. La riflessione parte dall’elencazione dei soggetti potenzialmente alleati, i gruppi organizzati di interesse che possono essere suddivisi come segue:
1) i sindacati dei lavoratori; ma in realtà solo i sindacati confederali hanno strutture e tradizioni atte a renderli interlocutori possibili. Sebbene posseggano una certa cultura delle alleanze, ci sia una conoscenza reciproca e abbiano nel patrimonio genetico un’esperienza mediatoria non sembrano adatti per un’alleanza attendibile. O meglio, non si conosce fino in fondo il prezzo di quell’alleanza. È chiaro che non si tratterebbe di un’alleanza a senso unico (una nuova edizione dell’assioma “ciò che va bene per la General Motors va bene per l’America”) ma gli imprenditori sarebbero costretti a cedere pezzetti di sovranità in termini di rappresentanze aziendali, raggio di intervento sindacale, contrattazione etc. Inoltre, prosegue la riflessione, in questo specifico momento i sindacati sono stretti tra il nuovo sindacalismo autonomo, ancora operante “per bande” e una base di funzionari, dirigenti e militanti poco disposta a patti e compromessi. In definitiva,
24 la Federmeccanica prende atto che non esiste un partito che ad oggi è in grado di sostenere il ruolo stabile dell’antico “partito dei produttori”) 25 “Imprese e lavoro/3” archivi Federmeccanica, in Giulio Sapelli, “Modelli culturali e rappresentanza imprenditoriale – il caso Federmeccanica”, novembre 1990.
21
sebbene un “patto tra produttori” sembrerebbe lo sbocco privilegiato esso va valutato con cautela: “le alleanze non sono qualcosa che nasce all’improvviso intorno ad un mero calcolo di convenienza, ma sono filtrate da lenti passaggi e lunghe decantazioni”26.
2) I partiti, di cui solo tre o quattro al massimo, sono in grado di elaborare progetti di alleanze ed esprimono, contemporaneamente, il seguito elettorale sufficiente alla impostazione di un piano politico da trasferire nelle diverse sedi che sono in grado di influenzare. Uno, il partito comunista, non è ancora in condizione di essere un alleato credibile per le associazioni imprenditoriali; altri, tradizionalmente vicini, almeno in linea di principio, alle esigenze dell’economia, appaiono molto incerti sulla via da seguire, sembrano cedere a tentazioni radicaleggianti, più volti all’esigenza di sopravvivenza che alla costruzione di impegni connotati da qualche respiro strategico. Per di più, le due ideologie che ispirano i principali partiti, cattolica e comunista, affermano entrambe, per motivi via via convergenti, una posizione solidaristica che ancora tende a valorizzare nella società i bisogni piuttosto che il successo, l’austerità piuttosto che il benessere.
3) I movimenti, ovvero i gruppi sempre più numerosi, diffusi, frazionati che si sono aggregati intorno ad interessi semplici o semplificati. Spesso si danno dei leaders carismatici che raccolgono adepti entusiasti, ma privi il più delle volte, di una ideologia appena credibile che non sia quella elementare della solidarietà, dell’amore, del bene comune, della salvaguardia della natura e dell’ambiente. Si tratta spesso di organismi “saprofiti”27, nel senso che mentre dichiarano di combattere la decomposta società industriale, di fatto approfittano dei mezzi economici e tecnici della stessa per affermarsi e sostenersi. Hanno “grande capacità di penetrazione nei mezzi di comunicazione i quali, alla ricerca esasperata di fatti, di situazioni, di personaggi nuovi e “raccontabili”, attribuiscono loro una rilevanza maggiore di quella effettiva”28. Nelle ultime elezioni i “Verdi” non sono andati oltre un non esaltante (ma esaltato) 2,5% mentre “Dp”, erede del primordiale movimentismo, ha di poco
26 Motivi elettorali (numerici) impediscono che le proposte degli imprenditori siano assunte tout-cour dal governo e dal legislatore (come alcune del sindacato, si pensi allo Statuto dei lavoratori) da qui la necessità di un patto tra produttori ed è chiaro che a quel punto gli interlocutori privilegiati sarebbero i sindacati. 27 “Imprese e lavoro/3” archivi Federmeccanica, in Giulio Sapelli, “Modelli culturali e rappresentanza imprenditoriale – il caso Federmeccanica”, novembre 1990. 28 “Imprese e lavoro/3” archivi Federmeccanica, in Giulio Sapelli, “Modelli culturali e rappresentanza imprenditoriale – il caso Federmeccanica”, novembre 1990.
22
superato l’1%. In definitiva ininfluenti e con una marcata impostazione “anti-industriale”). Il “Movimento popolare” espressione politica organizzata di “Comunione e liberazione”, merita per le sue origini, per il retroterra spiritualistico etc una considerazione più attenta; ha dimostrato di orientare i voti di preferenza nell’area democristiana, “ma soltanto in poche aree del paese, salvo poi pretendere un prezzo altissimo per un contributo che in termini di spostamento reale di suffragio è ancora da dimostrare”29.
4) Le associazioni degli imprenditori non industriali, commercianti, artigiani, banchieri, operatori del terziario e agricoltori. Verso di loro dovrà essere compiuta a breve una “scelta di relazioni”, non essendo produttivo l’atteggiamento finora tenuto che si è risolto in una politica di incontri-scontri. Con loro, anche se non si arrivasse a delle alleanze in senso stretto, sarebbe opportuno considerare almeno un sistema di consultazione che prevenga motivi di conflitto nei quali si inseriscono, a loro vantaggio, i politici30.
Dopo una disanima dei soggetti in campo nel documento ci si spinge oltre, si esaminano al dettaglio, a sostegno delle proprie tesi, le posizione dei vari possibili interlocutori. Il risultato è un punto di vista forte, di parte, ma di indiscutibile interesse politico. Il “Psi”, per esempio, viene tacciato sostanzialmente di inaffidabilità e di “contraddizioni clamorose come l’inversione di 180 gradi compiuta in tema di scelte energetiche e con il plateale abbandono del nucleare”31. Poi il cannocchiale di Federmeccanica si sofferma sul “Pri”, il partito che portò alla Camera Arisio, il leader della “marcia dei quarantamila” e che sostenne il provvedimento per il riconoscimento giuridico della categoria dei quadri che però ha pagato poco (in termini di consensi elettorali) i promotori ed è rimasta poco più che una vittoria simbolica. Quindi nonostante la teorica affinità ideologica e l’attenzione ai ceti produttivi, si finisce per considerare quel partito, ininfluente, limitato e in definitiva autoreferenziale. In conclusione emerge la natura camaleontica dell’associazione che conclude il ragionamento sostenendo che “ora non si vedono leaders capaci, per qualità intellettuali e di piazza, in grado di ripetere esperienze di un passato più o meno lontano e dunque si deve prendere atto che non è ad un’alleanza stabile che gli imprenditori possono guardare, ma alle aggregazioni che nel paese si propongono volta per volta obiettivi nei quali essi ritengono di riconoscersi volta per volta..”32, guardandosi dentro e 29 “Imprese e lavoro/3” archivi Federmeccanica, in Giulio Sapelli, “Modelli culturali e rappresentanza imprenditoriale – il caso Federmeccanica”, novembre 1990. 30 l’ultimo e più recente caso era stato quello delle polemiche tra Confindustria o Confcommercio intorno al tetto pensionistico INPS. 31 “Imprese e lavoro/3” archivi Federmeccanica, in Giulio Sapelli, “Modelli culturali e rappresentanza imprenditoriale – il caso Federmeccanica”, novembre 1990. 32 “Imprese e lavoro/3” archivi Federmeccanica, in Giulio Sapelli, “Modelli culturali e rappresentanza imprenditoriale – il caso Federmeccanica”, novembre 1990.
23
facendo un appello accorato all’unità degli imprenditori “si dovrebbe perdere, in altri termini, il vizio della diversità, che troppo frequentemente corrompe l’unità della politica imprenditoriale, una diversità diretta talvolta ad ottenere l’approvazione di organizzazioni estranee al mondo delle imprese e ai loro interessi o a ricercare una patente di intelligenza che sottende una (supposta) superiorità di una certa componente o di una certa categoria rispetto alle altre. Solo l’unità dei comportamenti può “convertire le idee in leve sociali” per riprendere una definizione di Giovanni Sartori”33.
CAPITOLO 3 3.1) TRASFORMAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI Tutte le organizzazioni sociali sono state oggetto di profondi mutamenti e ripensamenti delle stesse negli ultimi decenni. Nel nostro caso, le associazioni datoriali si presentano come simili al modello originario pur avendo subito importanti cambiamenti dal dopoguerra in avanti. I cambiamenti politici avvenuti in campo europeo ed internazionale hanno mostrato i limite dell’operare tradizionale. Vale la pena di enunciare, solo a spot per ora, alcuni tra i principali fattori di mutamento che hanno condizionato l’essere e lo scegliere della Confindustria e della altre associazioni di rappresentanza imprenditoriale. Il primo elemento è l’indebolimento (e l’allentamento) del collateralismo politico, poi ci sono i mutamenti economici delle forme di impresa, l’indebolimento della contrattazione collettiva, i processi di europeizzazione e globalizzazione e l’influenza sui centri decisionali delle associazioni, poi c’è il problema del reperimento delle risorse, il tentativo delle associazioni di allargare il bacino della rappresentanza (nuovi autonomi), il ricorso a nuove e diverse esperienze di bilateralità. A questo si è accompagnato negli anni, un mutamento profondo anche nelle motivazioni dell’adesione alla Confindustria. Gli associati, come risulta ormai da tutti i rapporti, sono in calando e si affiliano per ragioni sempre più diversificate. Aumenta di fatto l’importanza di dare risposte ai bisogni, della visibilità dell’associazione, della qualità del servizio erogato. Conta sempre di meno il fattore “identità” o “appartenenza”, e sempre di più la ricerca di una nuova rappresentanza basata su efficienza e capacità di dare risposte. (Essendo un lavoro rivolto a dirigenti sindacali CGIL,
33 “Imprese e lavoro/3” archivi Federmeccanica, in Giulio Sapelli, “Modelli culturali e rappresentanza imprenditoriale – il caso Federmeccanica”, novembre 1990.
24
qualche riflessione sul punto si impone dal mio punto di vista). Il funzionario della CONFINDUSTRIA si afferma sempre più come un collaboratore di impresa che la supporta o la guida nell’attività (cresce il rapporto fiduciario nella persona più che nell’organizzazione). Questo pone delle ricadute anche organizzative: aumenta la quota di personale impegnata nell’erogazione di servizi rispetto a quella di coloro che sono impegnati nella rappresentanza tradizionale politico-sindacale. Le nuove esigenze degli iscritti da fronteggiare sono: il credito, la sicurezza, il marketing, la formazione, l’innovazione tecnologica, la promozione, la qualità etc. ed è principalmente su questo terreno che un’associazione viene misurata. L’indebolimento del ruolo storico e lo sbilanciamento a favore della galassia dei servizi induce ad alcune riflessioni sul ruolo della struttura. Questo cambiamento di pelle è talmente pervasivo che ha condizionato anche il terreno dove si svolge la competizione tra le diverse organizzazioni di imprese. La competizione tra le organizzazioni di rappresentanza si sviluppa principalmente sul terreno dei servizi, tant’è che non sono infrequenti casi di imprenditori con la doppia tessera (es. Api più Confindustria). Le organizzazioni imprenditoriali italiane, come si diceva, sono essenzialmente duali: da un lato svolgono attività di lobbing e rappresentanza (ruolo essenzialmente “politico”), dall’altra erogano servizi, di varia natura, per la vita e lo sviluppo dell’impresa associata (ruolo essenzialmente “tecnico”, di “erogazione di servizi”). Esse hanno pertanto due anime: una volta all’arena politica, l’altra al mercato. Le due anime hanno finalità differenti e autonomia finanziaria (anche se recentemente si riscontra anche un riallocazione di risorse a favore di quella dei servizi). Mentre da un punto di vista politico la loro azione negli anni è rimasta immobile e statica ovvero sempre finalizzata al raggiungimento degli interessi (sono cambiati i metodi e le forme, non le finalità), dal punto di vista economico hanno un’elevata innovazione e dinamicità nelle attività, dei servizi e nel ruolo di supporto per l’impresa associata. Forse è anche per questo che le razionalizzazioni in corso (nelle organizzazioni datoriali di ogni ordine e grado) hanno toccato più il versante politico-sindacale. La funzione “politica” si sostanzia nelle attività svolte alla ricerca delle condizioni di favore per i propri associati e quindi: creazione di nuove forme di impresa, gestione di crisi aziendali e riorganizzazioni, utilizzo ammortizzatori sociali, creazione di confini alle attività economiche, le agevolazioni fiscali, assenza di barriere all’ingresso per i nuovi imprenditori, promozione di consorzi di imprese, agevolazioni fiscali, finanziamenti agevolati etc. La funzione “economica” si sostanzia nell’erogazione di servizi come servizi sindacali, servizi fiscali, la consulenza, la formazione, elaborazione
25
di cedolini etc. Dalle due funzioni menzionate, dall’efficacia delle stesse, scaturisce il grado fiduciario e la fidelizzazione degli associati. Altre volte le associazioni hanno operato invece da “imprenditore collettivo” (una sorta di terza funzione alla quale solo accenneremo), quando per esempio hanno organizzato la vendita di alcuni prodotti di alcuni associati all’estero (l’associazione è una sorta di broker che funge da moltiplicatore economico per alcuni gruppi). O quando l’associazione organizza una rete di associati per ottenere prezzi più vantaggiosi nelle materie prima, o quando l’associazione organizza network per la partecipazione a gare di appalti (dove la singola impresa poco può..), o per aggregazioni di tipo organizzativo e finanziario etc. L’insieme di queste attività ne fanno spesso un nuovo soggetto nelle politiche economiche insomma. Fino agli anni 70, si diceva nell’introduzione, le associazioni di imprese non sono state oggetto di studio e si è prestata poca attenzione agli aspetti organizzativi. Solo dagli anni 80 si è incominciato a riconoscere questi soggetti come: “organizzazioni formali specializzate nell’aggregazione, nella selezione, a difesa e promozione nell’arena politica degli interessi e dei fini collettivi degli imprenditori; sono fonte di ordine sociale, svolgendo un’importante funzione nella regolazione dell’economia”34. È chiaro che il ricorso alle associazioni imprenditoriali da parte delle grandi aziende dipende molto dal potere di mercato che loro hanno (o fanno credere di avere). Sempre di più, soprattutto guardando alle nuove affiliazioni, si rivolgono alle associazioni imprenditori che hanno meno forza, meno capacità di incidere e meno capacità organizzative. Il legame con l’associazione sarà tanto più forte quanto maggiore sarà la debolezza strutturale di potere dell’azienda rappresentata. Le organizzazioni datoriali storicamente sono nate e si sono sviluppate essenzialmente per questi motivi: - per meglio fronteggiare la parte sindacale; - per tutelare il potere di investimento e le prerogative sindacali; - per garantire la riproduzione dei rapporti di produzione capitalistici e difenderli dall’offensiva dei sindacati dei lavoratori; - per favorire il trasferimento di compiti relativi alla risoluzione di conflitti, - per perseguire i propri interessi di classe; - per promuovere gli interessi degli associati nei confronti della politica economica del Governo; - per risolvere problemi di azione collettiva; - per fronteggiare l’invadenza dello Stato in alcuni settori economici. Inoltre la collaborazione degli imprenditori attraverso l’associazione è un meccanismo per unire gli interessi a breve del singolo imprenditore con gli
34 Maurizio Catino, ricercatore di Sociologia dei processi economici e del lavoro presso Università degli Studi di Milano-Bicocca, “Le trasformazioni delle associazioni imprenditoriali verso l’attivazione della rete associativa” in Diritto delle Relazioni Industriali, Numero 1/XVI, 2006.
26
interessi a medio lungo termine dell’intero settore di attività economica, in altre parole di coniugare interessi individuali e collettivi. Le associazioni datoriali hanno pertanto una rappresentanza multipla, oltre alla rappresentanza degli interessi di classe devono rappresentare quelli della produzione. La difficoltà nel rappresentare risiede principalmente in questo. L’associazione si trova spesso ad organizzare attori che sono in competizione tra loro e che hanno meno interesse a cooperare reciprocamente, e quindi deve spesso barcamenarsi tra una molteplice e variegata gamma di interessi e una bassa cultura della solidarietà. Spesso e volentieri imprenditori che fanno parte di una stessa associazione hanno addirittura interessi contrapposti e il perseguimento di alcuni obiettivi può danneggiare qualcun altro. 3.2) CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE ASSOCIAZIONI INDUSTRIALI ITALIANE Riserviamo questo paragrafo ad un’analisi delle principali associazioni industriali italiane, perché la riflessione riguarda la Confindustria, ma anche le associazioni concorrenti. L’osservazione comparativa consente di fare alcune considerazioni, anche se solo accennate, di carattere generale, sull’intero sistema di rappresentanza imprenditoriale. 1) Il sistema della rappresentanza italiana è più frammentato rispetto ai modelli europei35. La frammentazione deriva da diversi fattori tra i quali: la caratteristica del sistema produttivo italiano formato da piccole e piccolissime imprese, la presenza elevata di artigiani e commercianti, basso numero di imprese con dimensioni “intermedie” in grado di connettere il mondo della macro-impresa e quello della micro-impresa (sebbene il loro ruolo e la loro incidenza sia progressivamente aumentata). La frammentazione si articola anche in base al settore di attività delle imprese (agricoltura, industria, commercio, servizi etc), in base al tipo di attività e alla natura istituzionale (cooperative, a capitale privato, a partecipazione statale), in base alle affinità politico partitiche. 2) Forte centralismo originario delle associazioni, tutt’ora presente, anche se sfidato da riequilibrio territoriale. Le decisioni, per anni, si sono prese a Roma e sono poi state calate sul territorio senza uno scambio biunivoco con lo stesso. Con l’evolversi del sistema istituzionale e con il divaricarsi delle aree all’interno del paese non è più così marcato. 3) Assenza di differenziazioni funzionali tra le organizzazioni di rappresentanza.
35 La rappresentanza dei datori di lavoro è una giungla assolutamente ricchissima di associazioni diverse tra loro a seconda che si tratti di lavoro pubblico o privato, cooperativo o artigiano, per operai e impiegati o per quadri, etc
27
4) Progressivo indebolimento della storica leadership di Confindustria a beneficio di altre associazioni (le associazioni che rappresentano il lavoro autonomo hanno recentemente preso delle posizioni che si allontanano molto da quelle della Confindustria ma si sono anche conquistate una visibilità che prima non avevano). 5) tendenza alla regionalizzazione per rispecchiare i cambiamenti in
atto a livello istituzionale. (nel dibattito anche interno all’associazione c’è il prevalere della duplice dimensione, che corrisponde a due arene decisionali: Europa e Regioni).
6) Parallela tendenza alla riallocazione delle risorse e alla razionalizzazione dei costi (conseguenza di un calo di risorse non trascurabile). Negli ultimi anni specialmente si è assistito ad un sostanziale blocco del turnover, alla ricollocazione di diversi soggetti e a politiche di risparmio di costi fissi in quasi tutte le realtà territoriali.
3.3) CONTESTO SOCIO-ECONOMICO IN CUI OPERA LA CONFINDUSTRIA E RIPOSIZIONAMENTO RISPETTO ALLA CRISI. Le straordinarie trasformazioni dell’economia italiana con annesse crisi, ristrutturazioni e riorganizzazioni sta avendo ripercussioni importanti sugli organismi di rappresentanza imprenditoriale. Le associazioni datoriali incontrano principalmente tre grandi trasformazioni: la globalizzazione dell’economia, che implica l’aumento del commercio internazionale ma anche le multi localizzazioni e rilocalizzazioni produttive delle imprese italiane in Europa e all’estero. Un secondo fattore riguarda il cambiamento della struttura economica e produttiva indotto dalla terziarizzazione e dalla diffusione delle nuove tecnologie. L’impatto di questi primi due cambiamenti sulle relazioni industriali e sul mercato è già molto forte e la rappresentanza tradizionale viene sconvolta. Un terzo fattore riguarda il cambiamento sociale e politico del nostro paese (come di tutti i paesi industrialmente avanzati) e la crescita della democrazia partecipativa: c’è in corso ovunque una dilatazione dei soggetti decisori e una moltiplicazione dei soggetti che si coinvolgono nelle scelte. Aumentano i player, aumenta il ruolo della società civile. Questi cambiamenti sociali ed istituzionali hanno profonde ripercussioni nel modus operandi delle associazioni datoriali e accrescono il loro ruolo e la responsabilità delle organizzazioni stesse (si pensi alla cosiddetta “responsabilità sociale di impresa”). È importante per le organizzazioni sindacali datoriali suscitare consenso e mediare con l’opinione pubblica. Da qui l’interesse ad esercitare un potere di leadership nel dibattito economico e l’importanza della strategia di comunicazione, delle ricerche economiche e sociali dei centri studi, (finanche alla promozione e sponsorizzazione di eventi culturali). Infine, come ultima trasformazione, la
28
crisi della politica e l’interruzione del rapporto di subordinazione e collateralismo (com’era in passato) che in qualche modo obbliga a prendere una strada propria e a ricercare alleanze diversificate magari solo su alcune battaglie. Certamente le organizzazioni di rappresentanza non possono non risentire negativamente dell’instabilità politica, della conflittualità tra partiti e correnti e del clima da campagna elettorale permanente36 . Il rischio che corrono oggi le associazioni di rappresentanza è quello di inseguire interessi corporativi e quindi ledere o distorcere in alcuni settori e per alcune realtà il principio di concorrenza (cosa che avviene continuamente nei Paesi Scandinavi come in Germania, come in Austria). L’obiettivo delle organizzazioni imprenditoriali è e deve rimanere quello di conseguimento dell’interesse generale. “Esse hanno il compito di proporre una visione complessiva dei problemi dell’impresa nell’ambito di quelli complessivi del paese”37. E quindi superare un’impostazione basata sulla difesa di interessi particolari predeterminati. Si delinea insomma, nelle trasformazioni in corso, un nuovo modello italiano della rappresentanza, più flessibile rispetto ad alcune forme continentali, un terreno dove l’esperienza italiana può costituire una best practice da imitare fuori. 3.4) DILEMMI DELL’ASSOCIAZIONISMO IMPRENDITORIALE L’evoluzione dei processi economici e sociali e l’affacciarsi sulla scena delle economie dei paesi emergenti necessita il garantire un’adeguata competitività al sistema industriale per reggere il confronto e per evitare di essere schiacciati. L’associazionismo industriale confindustriale ha questa mission, l’idea è che non si trovi in una fase di crisi ma bensì che sia attraversato da mutamenti radicali. I tre aspetti caratterizzanti le organizzazioni di rappresentanza sono la rappresentanza per l’appunto, i servizi e l’identità di un organizzazione. Sui primi due si è già detto, il terzo elemento “identità” o “senso del noi” si fonda sulla storia, sulla autorevolezza, sulla credibilità, sulla riconoscimento per il ruolo svolto, ma anche su un comune sentire e intendere l’impresa. Data per acquisita l’importanza della gamma dei servizi offerti dalle associazioni imprenditoriali, la capacità di fare “identità” misura la forza vera e il consenso di un’organizzazione. Confindustria, come si diceva, è stata una coprotagonista della storia del paese, dal 1910 alla ricostruzione post bellica, dal mercato comune europeo al miracolo italiano, nelle grandi ristrutturazioni aziendali come
36 Cosiddetta “crisi della politica e della rappresentanza partitica”. 37 Rita Carisano, direttore del nucleo Marketing Associativo Confindustria, Paolo Garonna, professore di Economia politica presso l’università Luiss G. Carli, Roma, “La transizione del sistema della rappresentanza imprenditoriale: declino o rinascita del “modello italiano” in Diritto delle Relazioni Industriali, Numero 1/XVI, 2006.
29
negli anni 90: la Confindustria si è caratterizzata come un soggetto piuttosto dinamico che ha modificato la propria struttura operativa alle necessità mutevoli delle aziende. Il Codice etico, la Carta dei Valori, e il Bilancio Sociale, il protocollo contro le mafie, sono alcune delle tappe più avanzate dello sviluppo di Confindustria. L’associazione ha recentemente introdotto un criterio organizzativo importante, la cosiddetta geometria variabile che ferme restando alcune regole comuni, può strutturarsi nella maniera che considera più confacente per ottimizzare la sua capacità di rispondere alle domande e alle aspettative dei propri associati. “Le imprese hanno bisogno che l’organizzazione di rappresentanza a cui appartengono elabori ed interpreti la visione che esse hanno e la traduca in una missione in cui tutti si riconoscono”38. Il ruolo delle organizzazioni datoriali devono essere di guida e di cercare di proiettare nel futuro la credibilità italiana e il “marchio Italia”. Inoltre deve individuare i nodi di oggi e gli obiettivi di domani, da qui la centralità dell’innovazione. 3.5) RIDEFINIZIONE DELLA RAPPRESENTANZA IMPRENDITORIALE L’attuale geografia della rappresentanza imprenditoriale ha dei limiti per tre motivi principali: la frammentazione categoriale rispetto ad un sistema d’impresa tendenzialmente omogeneo, l’inefficacia non tanto dell’azione di lobby ma dell’azione politica rispetto al passato (naufragare del concetto di concertazione e di “governo amico”), l’emergere di altri soggetti istituzionali (Authorities) e nuovi soggetti collettivi (terzo settore, associazione dei consumatori) che canalizzano aspettative e soluzioni che la società civile assegnava alle parti sociali ridimensionando le potenzialità monopolistiche delle stesse. La necessità di inventare nuove forme di rappresentanza e di distinguere l’azione di lobby (molecolarità categoriale diffusa) da quella di rappresentanza generale è l’unica che fa modificare le grandi scelte di tendenza dell’economia del welfare e della politica stessa. Le associazioni datoriali devono pertanto rivendicare l’autonomia politica da esercitare di fronte a qualsiasi governo (anche perché secondo l’autore troppo spesso i governi in carica hanno giocato sulla divisioni delle associazioni in campo e volta per volta hanno fatto i loro interessi fingendo di assecondare una piuttosto che l’altra). Alcuni osservatori sostengono che il legame con la politica funzionò poco e male nella prima repubblica e cessa completamente nella seconda: nel conflitto tra capitale e lavoro, si sono avvicendati governi di centro sinistra con un’attenzione particolare al lavoro ma non c’è stato il contraltare dei governi di centro-destra “al sistema delle imprese non è stato assicurato,
38 Gabriele Manzo, direttore Area Organizzazione e Marketing Confindustria , “I dilemmi dell’associazionismo imprenditoriale” in Diritto delle Relazioni Industriali, Numero 1/XVI, 2006
30
nonostante gli allarmi lanciati da tempo, quel clima di fiducia necessario per fare investimenti, favorire qualità e produrre competitività”39. Da qui la necessità di modifiche profonde per evitare il rischio di disaffezione e l’inconsistenza dell’agire e per rilanciare l’azione verso Governo e sindacato. “Cambiarsi è l’unica decisione possibile per imporsi a chi ci guarda dall’esterno e per convincere chi ci sostiene dall’interno”40. 3.6) ELEMENTI COMUNI DI CRITICITA’ TRA ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI E ORGANIZZAZIONI DATORIALI Le riflessioni svolte partono dai mutamenti intercorsi nell’economia e nella società: ci si domanda se e come l’associazionismo (imprenditoriale e sindacale) è cambiato in un periodo di elevata competizione internazionale, di ribaltamento del quadro politico istituzionale, di innovazione tecnologica e di riconversione delle strutture produttive. Ad inizio millennio la “nuova” Confindustria manifestava con iniziative concrete l’intenzione di cambiare alcuni aspetti importanti della politica precedente. Negli primi anni del nuovo millennio infatti la gestione era stata pilotata lungo la linea di un confronto durissimo con le organizzazioni sindacali (proposta di modifica della disciplina dei licenziamenti-art. 18 e politica di aperto collateralismo con il governo di centro-destra), una linea che non aveva prodotto risultati concreti e che non convinceva gli associati. “Paradossalmente proprio le aree più radicali del movimento sindacale avevano finito con il beneficiare di un vasto seguito a causa questa politica più aggressiva, mentre al contrario l’associazionismo imprenditoriale coglieva, sul proprio fronte, risultati che la base datoriale considerava per lo meno incerti”41. Da qui la correzione del quadro di riferimento per le politiche e le strategie e una nuova politica di distensione con le OO.SS. delle quali, in parte, si condividevano anche i problemi. La facilitazione del dialogo, il tentativo di dare risposte comuni, scaturiscono anche, in una certa misura, dalla condivisione di alcuni problemi da parte di qualsiasi soggetto che faccia rappresentanza. Di seguito alcune difficoltà che chiunque eserciti il ruolo della rappresentanza (o sul versante datoriale o sul versante dei lavoratori) deve fronteggiare.
39 Raffaele Morese, presidente di Confservizi, “Per una ridefinizione della rappresentanza imprenditoriale” in Diritto delle Relazioni Industriali, Numero 1/XVI, 2006 40 Raffaele Morese, presidente di Confservizi, “Per una ridefinizione della rappresentanza imprenditoriale” in Diritto delle Relazioni Industriali, Numero 1/XVI, 200 41 Carlo Dell’Aringa, ordinario di Economia politica presso l’Università Cattolica di Milano, Giuseppe Della Rocca, professore associato di Sociologia dei processi economici e del lavoro presso Università degli studi della Calabria, “Le associazioni imprenditoriali oggi” in Diritto delle Relazioni Industriali, Numero 1/XVI, 2006
31
Il declino dei settori tradizionali all’interno dell’industria manifatturiera e l’espansione dei servizi e di nuovi comparti come quello della tecnologia e dell’informazione, ha fatto si che negli attori delle relazioni collettive si sia ristretta la base tradizionale di riferimento e si sia creata la necessità di reclutare nuovi membri, diversi dai tradizionali. Sono cambiati anche i rapporti di impiego, il peso dei tempi pieni e indeterminati diminuisce sensibilmente, questo ha condizionato la membership dei sindacati ma ha coinvolto anche gli imprenditori. La tendenza verso un mercato del lavoro più flessibile è anche il risultato del cambiamento nella struttura delle imprese, meno integrate verticalmente, più legate ad un’economia di reti, più di piccole dimensioni e più polverizzate. In sostanza piccole e piccolissime imprese non sempre sono disposte ad entrare in associazioni dominate dalle grandi così come i loro dipendenti sono meno propensi ad iscriversi al sindacato (“piccolo è bello” non funziona molto per le parti sociali). L’associazionismo sconta un ulteriore problema, la iper-proliferazione della rappresentanza, la diffusione di nuove associazioni, nei più svariati settori, nelle diverse dimensioni d’azienda, che va ad erodere la centralità dei sindacati e dell’associazioni di impresa tradizionali. La competizione di alcune associazioni, sebbene a macchia di leopardo, finisce per complicare un quadro già minato da numerosi fattori. Altro fattore è l’internazionalizzazione delle economie nazionali che minaccia il livello di rappresentanza e di legittimità delle associazioni. L’internazionalizzazione da un lato ridimensiona i benefici di “affiliarsi” ad associazioni che operano su “scala nazionale”, dall’altro intensifica la competizione di mercato, crea nuovi profili di imprese, multinazionali di grandi dimensioni influenzate spesso da esperienze di altri paesi che si confrontano meno o diversamente con gli attori tradizionali. Poi c’è il problema comune dei tempi della mediazione: i rappresentanti sono tenuti a tenere conto di una pluralità di istanze e questo al fine di dar voce ad una platea variegata. Le organizzazioni continuano, com’è nella loro tradizione, ad operare in tempi ritenuti troppo lunghi dagli associati che si aspettano un’accelerazione o comunque un’altra velocità nella risoluzione di problemi o controversie. Il rischio è che di fronte all’attesa le rappresentanze perdano consenso e si opti per forme semplicistiche di auto rappresentanza. “la differenza di tempi tra chi rappresenta e chi è rappresentato è un problema che c’è da sempre è solo che oggi è più ricco di conseguenze pratiche…Le organizzazioni della rappresentanza sono chiamate a visioni più ampie di quelle dei loro rappresentati, visioni in cui devono convergere interessi differenti e tutte le difficoltà che comportano i rapporti con i decisori pubblici.”42
42 Aldo Bonomi, direttore Consorzio AASTER, “Capitalismo di territorio e forme di rappresentanza”, in Diritto delle Relazioni Industriali, Numero 1/XVI, 2006
32
Infine, la crisi del quadro politico e della rappresentanza partitica, l’instabilità dei governi, l’emergere di nuovi soggetti finisce per spiazzare, se non proprio erodere e danneggiare la rappresentanza tradizionale. Insomma le tendenze in atto non schiacciano una forza in favore dell’altra, non producono risultati su un “campo” o sull’altro, anzi, indeboliscono l’azione di entrambe, i risultati conseguibili, la capacità di incidere e di indirizzare le politiche. 3.7) IMPRESA TERRITORIO RAPPRESENTANZA A conclusione del capitolo riportiamo alcuni dati, estrapolati da alcuni questionari somministrati ad imprenditori facenti parte dell’Unione degli industriali della Provincia di Bergamo, tratti dal testo Impresa, territorio, rappresentanza. Strategia di riorganizzazione associativa, perché danno un’idea chiara di quali sono i nodi che affronta quotidianamente la rappresentanza imprenditoriale Confindustriale43. L’intenzione è calare l’analisi teorica svolta nei paragrafi precedenti su alcuni spunti offerti da veri imprenditori. Un lavoro di ricerca solo accennato, per flash, che tuttavia è importante e foriero di diverse sorprese. Il modo migliore per valutare le “performance” di un’associazione imprenditoriale è infatti, sicuramente, sentire l’opinione dei soggetti iscritti e rappresentati dalle stesse. Il fine dell’analisi è, pertanto, squisitamente empirica, ci consegna una realtà imprenditoriale che crede nell’associazionismo Confindustriale, che ne riconosce i meriti ma che, non per questo, non ne evidenzia i limiti e le carenze. Va premesso che la solidità economica e la tradizione industriale fanno di Bergamo un’area forte, ma proprio perché tale essa può e deve interrogarsi sulla propria tenuta e velocità, guardando al futuro, poiché un ciclo di sviluppo si è compiuto e uno nuovo si apre. Tuttavia, in termini comparativi sarebbe curioso vedere le “pagelle” di altre “Confindustrie territoriali”, specialmente in alcune aree depresse44. Dalla valutazione fatta, tramite questionari somministrati a centinaia di imprenditori (campione statistico variegato per dimensione aziendale e settore merceologico), si evince una buona performance per ciò che riguarda “il prodotto servizi”, ritenuto adeguato dall’80% degli intervistati ma anche una buona soddisfazione per ciò che riguarda “il prodotto rappresentanza”, ritenuto adeguato dal 73% degli intervistati. Meno gratificanti le valutazioni per “il prodotto identità”, solo il 60% degli intervistati si dichiara difatti orgoglioso di appartenere all’associazione. 43 La nuova rappresentanza industriale è pioniera di uno sforzo non comune: reinventare i prodotti associativi in un’epoca nella quale le identità sono complesse e frammentate, le rappresentanze deboli, sia da un punto di vista politico che sindacale. 44 Su queste ultime, tuttavia non esistono lavori organici, utili ai fini del ragionamento e della ricerca proposti.
33
La Confindustria ha dalla sua, ampiamente riconosciuto, il valore del cosiddetto “avviamento”, il valore del marchio, “la forza dell’aquilotto”45, di cui è nettamente consapevole l’82% degli intervistati. Alla Confindustria si riconosce anche un importante contributo anche nel mutare il clima culturale italiano in favore della cultura imprenditoriale e il passaggio dall’associazionismo di difesa a quello di promozione. Buona parte degli intervistati individua nella Confindustria e nell’associazionismo di categoria un ruolo preminente nella democrazia del Paese. Dai questionari emergono anche dei suggerimenti, delle strategie che le aziende consegnano all’associazione come: riconoscere la diversità degli associati e calibrare politiche differenziate; essere “un po’ come un azienda quanto ad efficienza ed efficacia del suo operare, un po’ come una sorta di istituzione quanto a ruolo svolto nel gioco della democrazia”46; investire in maniera sempre più pressante sulla comunicazione, a tutti i livelli e con tutti i mezzi, per far sentire forte la propria voce e il proprio punto di vista47; integrazione nell’agire, ovvero lavorare sulle tante componenti singole, molecolari ed egoiste degli associati per portare a sintesi gli interessi. Ciononostante ci sono delle osservazioni critiche che vengono formulate e vale la pena di menzionare, le più importanti sono: una non sufficiente chiarezza sugli obiettivi perseguiti in termini di influenza, rappresentanza e lobby (37% intervistati); la considerazione dell’associazione come “un luogo di poteri più che come un luogo di servizio (32% intervistati); la sensazione che il mondo associativo sia un po’ lontano dall’impresa (29% intervistati). La maggior parte degli intervistati (76%) mette in evidenza come sia difficile portare a compimento le diverse proposte elaborate dalle singole associazioni di rappresentanza perché talvolta si accavallano, gridano troppo forte e c’è una competizione tra associazioni che non fa bene al mondo produttivo. I “distinguo”, a dire degli intervistati, rischiano di sollevare veti e resistenze incrociate (c’è un appello all’unità, se così si può chiamare). Infine il dato che emerge con chiarezza e desta preoccupazione agli osservatori che quasi il 50% degli intervistati stima che la partecipazione e il prestigio dell’associazione sarà in futuro minore o molto minore rispetto ad oggi (consegna quasi una patente di ininfluenza per l’epoca che verrà..)
45 Nadio Delai , Andrea Moltrasio, “Impresa, territorio, rappresentanza. Strategie di una riorganizzazione associativa”, 2011. 46 Nadio Delai , Andrea Moltrasio, “Impresa, territorio, rappresentanza. Strategie di una riorganizzazione associativa”, 2011. 47 Nella specifica della Comunicazione la tabella individua come sia importantissimo il contatto con la stampa locale e nazionale, con le televisioni, con la rete etc, ma si sofferma in modo particolare sulla valutazione di giornali e riviste di fonte Confindustriale che circolano nelle imprese. Le varie pubblicazioni vengono valutate sulla base di questo schema: ricevo regolarmente, leggo regolarmente, passo ai collaboratori, conservo in tutto o in parte, valuto come utile. I punteggi sono molto soddisfacenti, come a dire che si riconosce alla Confindustria un ruolo “culturale/divulgativo” oltre che politico-economico.
34
Nel complesso, stando alla percezione degli industriali (iscritti e non all’associazione), la Confindustria locale risulta più forte ed influente rispetto alle altre associazioni di rappresentanza (Api, Confcommercio, Confagricoltura, Confartigianato), risulta invece più debole se paragonata ad altri soggetti collettivi o pubblici di rilevanza locale (il sistema bancario e il sistema camerale per fare degli esempi). In definitiva i nodi messi in evidenza dagli imprenditori intervistati combaciano in buona parte con le criticità individuate nelle analisi teoriche dei diversi osservatori. Alcune rilevazione fatte dagli studiosi delle organizzazioni datoriali sono corroborate dalle risposte emerse dai questionari, alcune altre non risultano (problema dell’instabilità politica per dirne una), ma va anche precisato le stesse hanno piani diversi. Gli osservatori tirano delle conclusioni da un punto di vista nazionale, gli imprenditori individuano le criticità dell’associazionismo locale (al massimo provinciale), dall’alto di una provincia ricca, industrializzata e, sicuramente più efficiente e strutturata rispetto alla media nazionale.
CONCLUSIONI Il lavoro improntato si dava come fine ultimo una conoscenza sommaria della storia di CONFINDUSTRIA (in particolare Federmeccanica) e dell’associazionismo imprenditoriale, perché comparativamente interessante ai fini dello studio delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Le difficoltà principali, al netto di una certa ridondanza e cortigianeria di alcuni testi, sono legate a dati e materiali non aggiornatissimi. Probabilmente un lavoro di questo tipo condotto con testi “datati” sarebbe risultato comunque attuale anni fa. Il problema è che dopo sei anni di crisi economico finanziaria, sembra sia passata un’era geologica rispetto alla realtà fotografata nella pubblicazioni. D’altro canto, da qualche anno, non escono pubblicazioni in materia, anche perché tutti i soggetti sono probabilmente concentrati nel cercare di capire dove si sta andando piuttosto che a fotografare una realtà che due anni dopo rischia di essere nuovamente, completamente, stravolta. Quindi, con l’osservazione attenta degli attori, con le recenti prese di posizione e con un po’ di immaginazione, si può provare a capire quali rotte sono state condotte negli ultimi anni e quali si condurranno nei prossimi. Partendo dal presupposto, accennato in conclusione del terzo capitolo, che le organizzazioni siano esse padronali o dei lavoratori devono probabilmente fronteggiare la peggior crisi di rappresentanza di tutti i tempi, un calo delle reciproche influenze, una conversione progressiva del ruolo originario. La sensazione, a intuito, è che da almeno un paio d’anni le
35
organizzazioni di rappresentanza parlano la stessa lingua, o meglio si ritrovano (volenti, ma spesso nolenti) nella stessa metà del campo, prediligono alzare insieme la voce, ridarsi delle regole, ridefinire le priorità d’intervento dei vari governi piuttosto che farsi la guerra (almeno in modo aperto). La segreteria Camusso, ha lavorato per una nuova unità sindacale prima e per ricucire con la Confindustria poi, su questa via sembra che anche Squinzi non percepisca come fumo negli occhi il nuovo rapporto con le organizzazioni sindacali. In un clima di emergenza economica, sociale, dei consumi, ma anche democratica (si pensi ai recenti sbilanciamenti per la stabilità di governo, contro le minacce berlusconiane) le parti sociali si sono indubbiamente avvicinate. I governi tecnici prima, la premiership di Letta dopo, il “clima” da grande coalizione, la consapevolezza della presenza importante dell’Europa nelle decisioni strategiche hanno probabilmente stemperato il clima ideologico e traghettato verso una fase nuova, una concordia un po’ forzata dalla cui rottura tutti hanno probabilmente molto da perdere e poco da guadagnare (se non nel brevissimo periodo). L’essere sotto attacco, sotto l’osservazione dell’Europa e la minaccia dello spread, ad un passo dal baratro ha prodotto intese che probabilmente sarebbero state impossibili in altre circostanze. Per venire proprio ai giorni nostri, si pensi a Confindustria e sindacati che insieme contestano la legge di stabilità accusando il premier, con sfumature diverse di aver avuto poco coraggio e di non aver sostanzialmente invertito la rotta e dato risposte all’altezza. E questo poco dopo aver stilano un documento a Genova il 2-3 settembre, quasi una piattaforma sindacale patronale, in cui si richiedeva, congiuntamente, uno sforzo per la crescita. Si pensi al documento sulla rappresentanza (atteso da decenni) dove insieme ad un quadro di regole, le ritrovate parti sociali si danno atto reciprocamente di avere praticamente l’esclusività della rappresentanza. Si pensi alla manifestazione indetta da Fillea-Filca-Feneal nazionali e territoriali ed Ance per la crisi dell’edilizia: il contratto nazionale è ancora bloccato (anche perché con l’emorragia di posti di lavoro in corso in parecchi si chiedono se ha ancora senso o se piuttosto è meglio avere diversi contratti regionali) ma due anni fa circa, si è scesi in piazza insieme per denunciare le storture del sistema48. Si pensi alla discussione in corso per la riapertura delle trattative del contratto dei metalmeccanici???. Si pensi infine alle tante prese di posizione comuni su crescita, fiscalità generale, politica industriale e ammodernamento della pubblica amministrazione. A distanza di pochi mesi i principali “corpi intermedi” italiani, hanno prodotto due documenti “Il piano del lavoro” la CGIL, “Il progetto per l’Italia” la Confindustria che testimoniano uno sforzo comune, ciascuno per il proprio ruolo, di interpretare i cambiamenti in atto e di condizionare la
48 Qualche mese prima a Roma si erano tenuti gli “Stati generali dell’edilizia”, concetto fortemente evocativo per ribadire la necessità di interventi forti.
36
politica economica per uscire dallo stagnazione. Al netto dei contrapposti, legittimi, punti di vista su costo del lavoro, previdenza, mercato del lavoro, perimetro dello stato e orario di lavoro, si scorgono posizioni non distanti (comuni forse è dire troppo..) su: pagamento dei debiti della pubblica amministrazioni, riduzione della tassazione (Irpef e Iva in primis, ma anche detassazione e decontribuzione sebbene in quel caso le differenze ci sono), ruolo degli istituti di credito, efficientamento della pubblica amministrazione, riforma ammortizzatori sociali, abbattimento del costo dell’energia, investimenti su ricerca e sviluppo, ammodernamento e sviluppo infrastrutturale etc. Dai documenti emerge anche una chiara riflessione su ruolo, importanza e consistenza della spesa pubblica, ma anche un’idea comune di lotta all’evasione fiscale49, una rivisitazione dei “costi della politica”, lotta al lavoro nero, alla contraffazione e alle mafie (e al loro ruolo nell’economia reale) fino all’annuncio fatto prima dell’ultima campagna elettorale sulla (vera, presunta o propagandistica) disponibilità degli industriali ad una forte patrimoniale. Non basta, si pensi alla miriade di enti bilaterali, fondi previdenziali, esperienze di sanità integrativa che ci sono in circolazione. Un pluralità di forme (sensate o meno, utili o meno) di cogestione di alcune fette del mercato del lavoro, della previdenza, della sanità. Il proliferare, in buona parte dei contratti nazionali, di forme di questo genere (più caldeggiate da CISL e UIL che dalla CGIL per la verità) impone una riflessionee sfocia, probabilmente, in una stagione negoziale differente, figlia dei tempi anche essa, in cui l’idea di fondo è darsi un CCNL ma anche cogestire enti che consentono forme di assistenza e mutualizzazione. Verrebbe da dire, con la dovuta prudenza, che, appurato il fallimento di un’idea fortemente liberista (in cui lo “Stato” rimaneva confinato agli angoli), la Confindustria si è avvicinata alla “proposte” storiche del sindacato più che viceversa. Verrebbe da aggiungere che su certi temi la Confindustria ha addirittura inseguito il sindacato che ha elaborato per primo proposte concrete che tutto sommato non dispiacciono agli industriali o che comunque ritengono importanti almeno temporaneamente in una determinata fase storica economica (ammortizzatori sociali, patrimoniale ed evasione fiscale sono gli esempi più calzanti). Se dal macro volessimo scendere al micro, anche solo per fare un esempio, la riprova di un clima differente c’è anche sul territorio, almeno per quel che riguarda la mia categoria, dove diverse crisi aziendali sono gestite insieme, gestite “da professionisti” condividendo non la strategia ma l’importanza della conservazione dei posti di lavoro. Insomma analizzando i due documenti ci sono una serie di temi “cari ad entrambi” sui quali impostare una discussione, soprattutto se il dibattito vede coinvolti soggetti terzi come lo Stato e le amministrazioni locali, ma
49 Magari sul tema gli industriali devono riflettere più di quanto può riflettere un “salariato” qualunque.
37
38
anche gli istituti di credito e altri soggetti “agenti” nella sfera economica. E quindi direi che la particolare congiuntura ha schiacciato le posizioni avvicinandole; certo, più che un cambiamento culturale sembra un cambiamento indotto ma è, dal mio punto di vista, assolutamente nitido. Il punto è capire se in caso di “effetto rimbalzo” e di ripresa dell’economia le differenti “visioni” torneranno a divaricarsi. Io credo di si. La storia ci insegna che tra organizzazioni imprenditoriali e sindacali c’è da sempre un rapporto “a fisarmonica” che le vede avvicinare nelle grandi crisi (‘29-‘45 etc) e allontanarsi progressivamente quando le cose vanno meglio e diventa più importante portare a casa i risultati per i propri associati. Bibliografia: Alvino I., La rappresentanza sindacale con specifico riferimento al contratto collettivo di categoria, 2007. Astone F., Il partito dei padroni, 2010 Biagi M., Diritto delle Relazioni Industriali, rivista, Giuffrè Editore, 2006 Castronovo V., Cento anni di imprese, storia di Confindustria 1910-2010, 2010 Delai N. Moltrosio A.., Impresa, territorio, rappresentanza. Strategia di riorganizzazione associativa, 2011. Sapelli G., Modelli culturali e rappresentanza imprenditoriale – il caso Federmeccanica, novembre 1990 Servizio relazioni industriali Confindustria, Costo del lavoro e relazioni industriali. Accordi interconfederali, protocolli d’intesa e accordi quadro, 2000.