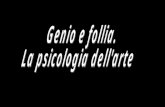Storia Dell Arte e Psicologia in Gombrich
-
Upload
sasha-todini -
Category
Documents
-
view
15 -
download
0
description
Transcript of Storia Dell Arte e Psicologia in Gombrich

Gombrich, Arte e illusione. Studio sulla psicologia della rappresentazione pittorica (1960)
Prefazione all’edizione italiana Legame metodo empirico (usato in questo libro) e discussioni pratiche sull’arte che
precedettero la nascita delle teorie estetiche. Alberti, Leonardo, Vasari consideravano ancora l’arte/scienza della pittura come la tradizionale abilità di creare un’illusione visiva. Ma i trattati di carattere tecnico a cui mi sono richiamato erano più intenti a insegnare questi espedienti che a spiegarli. Nei secoli successivi, nessuno si preoccupò di colmare questa lacuna: dal tardo ’500 in poi la filosofia della bellezza monopolizzò sempre di più la teoria dell’arte, separando i misteri della vera arte dalla semplice padronanza di un mestiere servile (conseguente emancipazione dell’artista dalla schiavitù della corporazione e dal marchio dell’occupazione meccanica; teoria del genio, ecc.). Oggi mi sembra giunto il momento di eliminare quel tabù sociale che sembra aver impedito nei tre ultimi secoli alla teoria dell’arte di studiare più in concreto il meccanismo del mestiere e i suoi fondamenti psicologici. Diventa nuovamente possibile un’analisi della rappresentazione pittorica che prenda a soggetto non solo l’opera dei maestri, ma anche la produzione figurativa nelle sue forme più umili e persino volgari.
La psicologia ha molto giovato a rimuovere le barriere che separavano un tempo le "facoltà più elevate" da quelle "inferiori": studio delle semplici illusioni o del comportamento degli animali; analisi cibernetica (problema trasmissione dell’informazione) di tutti i sistemi di simbolismo, uditivo o visivo, sia musica, parola o immagine. Considero questi recenti sviluppi più utili delle dottrine di quella precedente scuola psicologica che cercava di unire allo studio della percezione quello dell’estetica elementare, intendo alludere alla teoria gestaltica, quale è esemplificata nel libro Arte e percezione visiva di Arnheim. Ritengo infatti che faremmo meglio a tenere separato lo studio delle immagini da quello della bellezza visiva. Inoltre credo che anche nella psicologia della percezione visiva i risultati della scuola gestaltica possono ora essere assorbiti in un atteggiamento più ampio e flessibile.
G. precisa che i problemi di questo libro non sono scaturiti dalla psicologia, ma dalla storia dell’arte e più precisamente dalla storia degli stili (Scuola di Vienna entro cui si è formato). Egli ritiene tuttavia che i risultati della psicologia novecentesca abbiano fatto cadere in disuso molte di queste speculazioni: molto di ciò che leggiamo sul "vedere" e sullo "spazio" dovrà essere riesaminato alla luce di analisi più precise; peraltro, ciò dovrebbe accrescere la nostra curiosità su quelle specifiche funzioni dell’arte che richiedevano lo sviluppo di mezzi illusionistici. Nel porre nuove domande sul legame forma-funzione nell’arte, potremo suscitare nuovi contatti con la sociologia e l’antropologia. Ma ciò, in larga misura, appartiene al futuro.
Prefazione
Psicologia della rappresentazione pittorica: indagine che oltrepassa le frontiere dell’arte per investire i problemi della percezione e dell’illusione ottica. Nel mio libro Il mondo dell’arte avevo tracciato la linea di sviluppo della rappresentazione dai metodi concettuali dei primitivi e degli Egizi, che si basavano su ciò che "sapevano", alle conquiste degli impressionisti, che erano riusciti a fissare ciò che "vedevano". Le miei affermazioni secondo cui nessun artista può dipingere "quel che vede" prescindendo da tutte le convenzioni, avevano un che di dogmatico: il presente libro si propone di giustificare la precedente interpretazione, affinandola alla luce della psicologia odierna.
Le 7 conferenze che tenni nel 1956 (riprese in questo libro) andavano sotto il titolo comune "Il mondo visibile e il linguaggio dell’arte". G. afferma di essersi servito di una serie di testi che rappresentano diverse scuole di psicologia (dalla psicologia gestaltica al comportamentismo). Possibile sospetto di eclettismo; tuttavia, è possibile farsi un’idea del mio orientamento leggendo il saggio di Tolman e Brunswik, The Organism and the Casual Texture of Environnement (1935), che mette in evidenza il carattere ipotetico di ogni processo percettivo. Lo scritto (che ho letto solo dopo aver terminato questo libro) fu composto a Vienna nel 1934, all’epoca in cui Brunswik si prestava a

far da soggetto in una serie di esperimenti di decifrazione delle espressioni facciali sotto la direzione di Ernst Kris e con la mia collaborazione. Fu soprattutto Kris, lo storico dell’arte divenuto psicoanalista, a convincermi dell’utilità di un metodo psicologico (a lui devo la convinzione che la storia dell’arte sarebbe sterile se non fosse continuamente arricchita da uno stretto contatto con lo studio dell’uomo). Lo studio sulla caricatura, compiuto in collaborazione, mi mise di fronte al problema delle implicazioni insite nell’accettare un’immagine come somigliante (i risultati della nostra ricerca si trovano in un saggio del suo libro Psychoanalytic Explorations in Art, 1952).
Negli stessi anni, conoscenza di Popper, che aveva proprio allora pubblicato Die Logik der Forschung (1935; poi riedito in inglese nel 1959 col titolo Logica della scoperta scientifica), nel quale affermava la priorità dell’ipotesi scientifica rispetto alla raccolta di dati sensibili.
Introduzione: La psicologia e l’enigma dello stile L’enigma dello stile si riassume in questo problema, che ha assillato gli storici dell’arte per
molte generazioni: perché epoche e popoli diversi hanno rappresentato il mondo sensibile in modi tanto differenti? Tutto ciò che riguarda l’arte è soggettivo o esistono in materia dei criteri oggettivi? Se tali criteri esistono, se i metodi che si insegnano oggi nei corsi di disegno portano ad imitazioni della natura più fedeli di quelle ottenute dagli Egizi con le loro convenzioni, perché gli Egizi non adottarono questi metodi? E’ possibile che essi vedessero la natura in modo diverso?
Tutti questi interrogativi riguardano la storia dell’arte, ma ad essi non si trova risposta servendosi solo di metodi storici. Il lavoro dello storico dell’arte si basa sulla convinzione, formulata da Wölfflin, che "non tutto è possibile in ogni epoca" (se l’arte fosse solo espressione di una visione soggettiva, non ci potrebbe essere storia dell’arte, non potremmo catalogare un dipinto come cinese o olandese, né potremmo parlare di una testa greca). Spiegare questo fatto non è compito dello storico dell’arte, che si limita a descrivere i mutamenti avvenuti nei secoli; ma allora a chi spetta?
Una delle acquisizioni di cui siamo debitori alla rivoluzione artistica che ha scosso l’Europa
nella prima metà del ’900 è di esserci liberati da un tipo di estetica per cui, dato il criterio della fedeltà al vero, questa capacità avrebbe progredito dai rozzi inizi (vedi Egizi) fino all’illusione perfetta della realtà. Oggi viene considerato un pregiudizio da combattere la convinzione che l’eccellenza artistica coincida con la fedeltà fotografica. Tuttavia, poiché né lo storico dell’arte né il critico vogliono più occuparsi del problema dell’illusione nell’arte, esso è rimasto orfano e negletto. Idea errata oggi diffusa: l’illusionismo, essendo irrilevante sul piano artistico, sarebbe anche molto semplice sul piano psicologico.
In realtà, ogni manuale di psicologia può fornirci esempi della complessità di tale questione. Es. del disegno che può essere visto come un coniglio o come un papero (indipendentemente dal fatto che la forma disegnata sul foglio non ha una somiglianza stretta con nessuno dei 2 animali). Se ci chiediamo che cosa c’è realmente davanti a noi, ci rendiamo conto che non è possibile vedere la forma indipendentemente dalla sua interpretazione, né tener presenti contemporaneamente le 2 interpretazioni opposte; scopriremo inoltre che l’illusione è un’esperienza difficile da analizzare, perché non possiamo osservarci nell’atto di cedere a un’illusione. Es. dello specchio del bagno leggermente velato dal vapore: se disegniamo la nostra testa sulla superficie dello specchio e ripuliamo poi lo spazio nel contorno così ottenuto, ci accorgeremo l’immagine è la metà della nostra testa. Le opere d’arte non sono specchi, ma con essi hanno in comune quella facoltà di trasformarsi che è così difficile definire a parole ( ad es. quando ci avviciniamo e poi ci allontaniamo di nuovo da un quadro).
Quando si tratta di maestri del passato che sono stati insieme grandi artisti e grandi creatori di illusioni, lo studio dell’arte e quello dell’illusione non possono restare separati. Tuttavia, questo libro non vuole essere un appello all’uso di espedienti illusionistici nella pittura d’oggi: che le scoperte della rappresentazione, già vanto degli artisti del passato, siano oggi divenute triviali, nessuno lo vuole negare. Credo però che si rischia di perdere il contatto con i grandi maestri del passato se si accetta la teoria, oggi di moda, che la rappresentazione non abbia nulla a che vedere

con l’arte. Non c’è mai stata in passato un’epoca come la nostra, in cui l’immagine visiva sia stata così a buon mercato: cartelloni pubblicitari, fumetti, rotocalchi, televisione, cinema, involucri dei cibi in scatola, ecc. L’affermarsi di questi mezzi di rappresentazione pone un problema nuovo allo storico e al critico. Proposito fondamentale di questi capitoli è quello di risvegliare il nostro senso di meraviglia di fronte alla capacità dell’uomo di suscitare - mediante forme, linee, ombre, colori - quei misteriosi fantasmi della realtà visiva che chiamiamo immagini (anche quando si tratta di immagini non artistiche come quelle dei fumetti): esigenza, infatti, di integrare lo studio dell’arte con l’analisi del linguaggio visivo. Già assistiamo al costituirsi nelle sue linee generali dell’iconologia, disciplina che studia la funzione delle immagini nelle allegorie e nei simboli e le loro connessioni con "l’invisibile mondo delle idee". Il modo in cui il linguaggio dell’arte si riferisce al mondo visibile è così ovvio e così misterioso che è ancora in gran parte sconosciuto tranne che agli artisti.
Obiettivo principale di Gombrich: analisi dell’elaborazione dell’immagine, cioè come gli
artisti sono arrivati a scoprire alcuni di questi segreti della visione, operando e confrontando, attraverso innumerevoli prove e riprove. Come esperimento secolare della teoria della percezione, l’arte illusionistica merita attenzione anche in un’epoca che ha rinunciato a un’arte del genere per altri modi di espressione.
Vari capitoli di questo libro: serviranno a rendere plausibile l’affermazione che l’arte ha una storia perché gli aspetti illusionistici dell’arte sono non solo il risultato, ma anche gli strumenti indispensabili di quella analisi delle apparenze che l’artista compie.