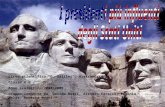STATI UNITI: COME SI UCCIDE IL DIRITTO - ristretti.it · Gli Stati Uniti sonoil paese che come...
Transcript of STATI UNITI: COME SI UCCIDE IL DIRITTO - ristretti.it · Gli Stati Uniti sonoil paese che come...
Gli Stati Uniti sono il paese che come nessun altro si erge a difensore dei diritti
fondamentali dell’uomo, quando questi vengono vilipesi in qualche parte del mondo;
nulla da eccepire se poi anch’esso fosse disponibile ad accogliere tali critiche,
quando altri governi od organismi internazionali rivolgono loro le stesse accuse.
Gli Stati Uniti sono la nazione che come nessun’altra è impegnata a combattere
in casa propria la devianza criminale. Niente da dire se ciò significasse una politica
mirata alla prevenzione del malessere umano e sociale, che scatena tale fenomeno.
Il fatto è che questa lotta viene condotta in termini puramente repressivi e
penitenziari, così come quella per il ristabilimento della “democrazia internazionale”
si traduce troppo spesso in una catena senza fine di “guerre umanitarie”. Da quindici
anni a questa parte, la popolazione carceraria della più grande potenza mondiale si è
triplicata. Con gli ultimi provvedimenti legislativi (la cosiddetta “legge patriottica”)
richiesti e approvati da George Bush dopo l’11 settembre, si è fatto un nuovo passo
in avanti verso un’ulteriore riduzione della tutela delle principali libertà e diritti
riconosciuti ai cittadini all’interno del paese.
Nello stesso modo, con le sue scelte, Washington ignora o depotenzia gran
parte di quelle norme del diritto, con cui la comunità internazionale ha immaginato di
poter affrontare e risolvere le situazioni di crisi e conflitto, senza mettere mano agli
arsenali. Possiamo allora individuare un filo che unisce le azioni che il governo degli
Stati Uniti compie nei confronti del popolo americano, e quelle che impone sul piano
delle relazioni internazionali agli altri popoli? La risposta è sì. Se sul piano geopolitico
ci si sta incamminando verso una militarizzazione dei rapporti interstatuali, facendo
carta straccia di tutti gli accordi e trattati faticosamente sottoscritti durante la guerra
fredda, su quello interno si sta passando ad una vera militarizzazione della giustizia
civile.
Così come all’interno degli States vengono progressivamente demolite le
fondamenta dello “stato di diritto” che prevede un faticoso, ma necessario equilibrio
dei poteri istituzionali, con la stessa determinazione si porta a compimento la
negazione dello “stato di diritto internazionale” attraverso la progressiva
delegittimazione delle istituzioni che lo rappresentano, a cominciare dalle Nazioni
Unite. C’è qualcosa di inedito e inquietante in tale rapporto. Tuttavia sarebbe
azzardato ritenere che tutto questo abbia avuto inizio con la strage delle Torri
Gemelle. Tale evento, al di là del valore reale e significato simbolico che può aver
avuto per ognuno di noi, rappresenta un punto d’accelerazione di un processo già
cominciato da molto tempo e che solo ora appare nella sua pericolosità.
Se come ci viene insegnato ogni giorno dalle vestali del neoliberismo, il primato
delle inflessibili leggi dell’economia fa premio sull’azione politica, cioè sulla volontà
delle istituzioni e della società civile a perseguire il bene comune, non c’è da
meravigliarsi più di tanto che tale assioma veda come un ingombro i diritti e le leggi,
cioè gli strumenti di cui le società si dotano per regolare la convivenza dei cittadini e
promuovere il loro benessere. E da qui a fare carta straccia delle Costituzioni
nazionali e della Carta dei diritti dell’uomo, il passo è breve.
La crisi della rappresentanza politica anche in ragione della frantumazione
corporativa della società, la tendenza al consenso plebiscitario, la subalternità della
sfera pubblica al comando dell’impresa o a insindacabili poteri extranazionali, sono
sintomi evidenti della crisi che sta attraversando la democrazia nei nostri paesi. Così
come la frantumazione su basi etniche, religiose, micronazionali dei vari continenti, la
propensione al comando unico impartito da un solo centro di potere, la dipendenza
degli stati dalle regole della globalizzazione, rappresentano altrettanti sintomi di un
male che sta metastatizzando il corpo dell’umanità tutta.
In questo contesto, le libertà (di parola, d’opinione, di associazione) diventano
un lusso che non ci possiamo più permettere, se vogliamo che il “nostro benessere”
continui a crescere. E così anche i diritti sociali o politici, diventano un di più di cui
poter fare a meno. Lo stesso disordine che questo sistema produce, trasformandosi
in un sentimento condiviso di incertezza, dà la stura ai venditori di “sicurezza
nazionale e internazionale” a buon mercato: alle guerre sociali ed economiche
interne contro i propri popoli – veri e propri conflitti a “bassa intensità” – attraverso i
bombardamenti a tappeto del Fmi, della Banca mondiale, del Wto, o a quelle fuori
casa contro una lista ormai interminabile di nemici della “nostra civiltà”, molti dei quali
figli, ora ripudiati, dei nostri democratici apprendisti stregoni.
Parlando quindi degli Stati Uniti, è come se parlassimo allora di tutti noi, di un
paese né migliore né peggiore di tanti altri, ma che per sua disgrazia, è diventato
l’unica grande potenza militare e politica presente sulla Terra. E questo non è un
bene, per nessuno. Nemmeno per se stessa.
ROBERTO CUCCHINI
DOSSIER
LA LIBERTÀ SACRIFICATA
NEL NOME
DELLA SICUREZZA
R.C.
La guerra al terrorismo può diventare un pretesto per restringere le basi dei
diritti fondamentali delle persone. La “legge patriottica” è il più grave attacco alle
libertà fondamentali degli Stati Uniti, da cinquant’anni a questa parte.
Il Patriotic Act non darà più sicurezza, ma di certo limiterà i diritti dei cittadini
americani e non. Un senatore repubblicano ha affermato, senza mezzi termini, che
“in tempo di guerra è necessario considerare in maniera diversa le libertà civili”.
Benjamin Franklin, circa 250 anni fa, aveva invece detto: “Chi sacrifica la libertà in
nome della sicurezza, non merita libertà né sicurezza”. Ed è ciò che sta avvenendo.
Verso uno stato penale?
Con la legge patriottica, possono venire insediati tribunali militari speciali per
cittadini stranieri accusati di terrorismo, concedendo una discrezionalità assoluta al
governo di decidere chi sarà perseguito e in virtù di quali leggi, e di rivedere
condanne e sentenze violando così il principio di separazione tra potere esecutivo e
giudiziario.
L’Unione americana per le libertà civili, dando voce alla protesta di altre 120
associazioni, ha obiettato che questi nuovi poteri potranno essere usati anche contro
cittadini americani che non risultano sott’inchiesta, contro immigrati che si trovano
legalmente negli Stati Uniti e anche contro coloro le cui attività politiche o civili non
piacciono al governo. La legislazione prevede, infatti, la detenzione obbligatoria di
ogni cittadino straniero definito “presunto terrorista”, che rischia così di rimanere in
carcere per un “tempo ragionevole”, rinnovabile ogni sei mesi, ovvero per un periodo
indeterminato. Subito dopo l’attacco a Manhattan, l’Fbi ha proceduto a oltre mille
arresti e ad alcune migliaia di interrogatori di persone sospette; il governo non ha
fornito per diverse settimane i nomi dei fermati “per attività investigative legate agli
attentati”. Centocinquanta di questi erano stati in realtà fermati a causa di violazioni
del visto d’ingresso, mentre altre centinaia di persone venivano detenute per aver
violato leggi federali o locali o senz’alcuna accusa specifica. Alle varie proteste, gli
inquirenti hanno replicato che gli arresti possono aver prevenuto altri attentati. Al 10
dicembre, i detenuti erano ancora in attesa di giudizio o di specifici capi di
imputazione.
A questo proposito, Amnesty International ha precisato che “sono centinaia le
persone in carcere in violazione dei loro diritti processuali: non sono note le accuse,
non si conosce il luogo di detenzione, non sono state informate le ambasciate. Sono
molte le denunce di maltrattamenti e abusi ai danni dei detenuti…”.
ll Washington Post ha aggiunto che “il dipartimento di Giustizia sta facendo un
uso straordinario dei suoi poteri di arresto e detenzione dei singoli. Sia i giuristi che i
cittadini dicono di non ricordare un altro periodo, in cui tante persone siano state
arrestate e imprigionate senza vincolo d’accusa. E già prima dell’11 settembre
ricordava che “restrizioni della libertà personale, del diritto della libera espressione
delle proprie opinioni, compresa la libertà di stampa, e dei diritti di associazione e di
riunirsi in assemblea, violazioni della privacy delle comunicazioni postali, telegrafiche
e telefoniche; permessi di perquisizione, ordini di confisca e restrizioni sulla proprietà,
sono ritenuti leciti al di là dei limiti legali altrimenti prescritti”. In forza anche dei nuovi
poteri attribuiti, l’Fbi ha iniziato intanto ad indagare anche su organizzazioni che a
suo avviso potrebbero essere “collegate a terrorismo”; tra queste il movimento delle
“Donne in nero”, che lotta contro la violenza in Israele e nei territori palestinesi
occupati. La legge patriottica prevede inoltre il ricorso ad agenti da infiltrare nelle
varie organizzazioni e incoraggia la delazione, criminalizzando chi non informa l’Fbi
dei suoi “ragionevoli sospetti”.
Essa dà anche il potere di ascoltare le conversazioni tra i detenuti e i loro
avvocati. L’American Civil Liberties Union, una delle maggiori organizzazioni
statunitensi di difesa dei diritti civili, ha attaccato duramente la decisione di
controllare i detenuti, in quanto “minaccia di negare la pietra angolare del nostro
ordinamento, il diritto a una difesa legale competente”. Saranno coinvolti in un simile
trattamento quei detenuti “ragionevolmente sospetti di poter usare le comunicazioni
per compiere o facilitare atti di terrorismo”. Ma la possibilità di essere controllati
indurrebbe invece molti detenuti a non parlare chiaramente con il proprio avvocato,
minando così l’efficacia della difesa. I controlli riguarderanno sia le conversazioni
detenuto-avvocato che le telefonate e la posta.
Negli Stati Uniti, ogni anno, vengono già intercettate da funzionari del governo,
due milioni di conversazioni telefoniche.
Quei Tribunali molto “speciali”
Con la nuova legge, Bush ha istituito le commissioni militari speciali, da cui
verranno giudicati gli stranieri in odore di terrorismo. Il decreto prevede, infatti, la
costituzione di corti speciali che hanno il potere di giudicare persone accusate di
attività terroristiche, incarcerate a tempo indeterminato per indagini preventive, senza
diritto a essere valutate da una giuria. Costoro possono essere condannati fino alla
pena capitale con una sentenza emessa all’unanimità dagli ufficiali-giudici, al termine
di un processo almeno in parte segreto e sulla base di prove non ammesse dai
tribunali ordinari. “Chi sarà sospettato di avere legami terroristici, non si merita le
stesse tutele costituzionali dei cittadini americani”. Parola del ministro della Giustizia.
Il New York Times ha scritto: ”Il piano del presidente Bush di utilizzare tribunali
militari segreti per processare i terroristi è un’idea pericolosa. Con un tratto di penna,
ha in sostanza cancellato le norme della giustizia americana, meticolosamente riunite
nel corso di oltre due secoli”. E c’è dell’altro: la legge prevede non solo processi da
tenersi su territorio statunitense contro cittadini non americani, ma l’istituzione di
tribunali speciali militari americani, ovunque ciò venga unilateralmente ritenuto
necessario: su un aereo che sorvola i cieli del Pakistan, dell’Arabia Saudita, o su una
nave al largo delle coste indonesiane o europee. Cioè in tutti quei paesi che sono
sospettati di praticare o coprire i terroristi di turno, a danno della politica estera e
dell’economia statunitense. A questo punto, saranno Bush e il ministro della Difesa
Rumsfeld a decidere chi perseguire e condannare.
Il direttore del Centro per i diritti costituzionali dei cittadini americani e non,
impegnato nelle lotte contro la discriminazione razziale e degli obiettori di coscienza
nella guerra del Vietnam, ha ricordato che ci si trova davanti ad “una violazione delle
norme e dei principi costituzionali che ispirano questo paese. Una discrezionalità
presidenziale che si configura come abuso di potere da parte del presidente”. Questo
perché il concetto di “associazione terroristica” è stato tenuto volutamente ampio e
vago: al suo interno (non per niente si parla già da tempo del “terrorismo ecologico”
di alcune associazioni ambientaliste, di “terrorismo informatico”, ecc.), ci può stare di
tutto.
L’Inghilterra non ha perso tempo nel seguire le orme dell’ex colonia: la nuova
legge antiterrorismo dà alla polizia maggiori poteri e prevede il carcere per atti di
protesta come “rivelare l’itinerario dei treni che trasportano scorie nucleari o rifiuti
tossici”. Greenpeace è avvisata!
Diritto internazionale: quando le regole non valgono per tutti
Da Carter fino a Clinton e Bush junior, tutti i presidenti americani hanno sempre
sottolineato l’importanza dei diritti umani, quando questa retorica serviva per
denunciare l’inefficienza dell’Onu; depotenziamento di cui – è bene ricordarlo – loro
sono stati tra i maggiori responsabili sia sul piano politico che economico.
Gli Stati Uniti hanno usato la legge internazionale, solo quando portava loro
qualche vantaggio o non entrava in conflitto con la propria normativa: se nel ‘79
denunciarono l’Iran alla Corte internazionale di giustizia dell’Aja perché teneva in
ostaggio dei diplomatici americani, quattro anni dopo rifiutarono di riconoscere la
giurisdizione di quella stessa Corte a seguito della denuncia nei loro confronti da
parte del Nicaragua che li accusava di sostenere attività militari e paramilitari
all’interno del proprio territorio nazionale. In tale occasione, Washington aveva
esplicitamente ordinato all’esercito mercenario dei contras antisandinisti (definiti da
Reagan “combattenti per la libertà”) di colpire obiettivi non militari (soft targets),
ovvero i civili indifesi. In sostanza, un via libera ad operazioni terroristiche. Tutti i
commentatori del tempo, sulle maggiori testate americane, lodarono l’efficacia dei
metodi utilizzati al fine “di rovinare l’economia (del Nicaragua) e condurre per procura
una guerra lunga e sanguinosa”.
Pur essendo attaccato dal Golia del continente (armamenti, supporto logistico,
consiglieri militari, istruttori, controllo aereo, ecc. erano tutti made in Usa), Managua
non pensò di bombardare la capitale statunitense come legittimo atto di ritorsione nei
confronti di chi stava massacrando il suo popolo. Così decise di affidarsi al diritto
internazionale e quindi di ricorrere alla Corte internazionale dell’Aja, la quale le diede
ragione, ordinando nel contempo agli Stati Uniti di fermarsi e di ripagare i danni
materiali causati. Washington non solo respinse con sdegno tale sentenza, ma, in
tutta risposta, intensificò gli attacchi omicidi. Pazientemente il Nicaragua si appellò al
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Questo mise a punto una risoluzione che
chiedeva a tutti gli stati, indistintamente, di obbedire al diritto internazionale, ma gli
Stati Uniti posero il loro veto. Allora Managua si rivolse all’Assemblea generale
dell’Onu, dove fu presentata una mozione simile alla precedente, ottenendo
finalmente l’approvazione della maggioranza (153 voti), meno quella di due membri:
Stati Uniti e Israele.
Il passaggio che non approvavano era quello in cui si affermava che “nulla nella
presente risoluzione può in alcun modo pregiudicare il diritto all’autodeterminazione,
alla libertà, all’indipendenza così come rivendicato nella Carta delle Nazioni Unite,
dei popoli privati con la forza del loro diritto, in particolare i popoli soggetti a regimi
coloniali razzisti e all’occupazione straniera o ad altre forme di dominazione
coloniale, né il diritto dei popoli a lottare per questo fine e a cercare e ricevere aiuto”.
In pratica le lotte di liberazione o antirazziste, così come difendere il proprio territorio
da attacchi esterni che ne minacciassero l’integrità, erano legittime.
In sostanza, gli Stati Uniti sono l’unica nazione al mondo condannata per
terrorismo dalla Corte internazionale, che si è rifiutata di sottostare al diritto
accogliendo una risoluzione, la cui richiesta a tutti i governi era semplicemente quella
di rispettare le leggi in vigore.
R.C.
RESPONSABILITÀ E SANGUE
La complicità diretta o indiretta di Washington in atti di aggressione nei confronti
di altri popoli e paesi non ha mai trovato una sanzione giudiziaria, se non nel caso
del Nicaragua.
Le vicende legate all’aiuto politico, economico o militare offerto dagli Stati Uniti
a vari governi autoritari o dittatori militari, o in alcuni casi all’intervento diretto nelle
zone d’operazioni con propri “consiglieri militari”, sono ampiamente conosciute e
certificate da documenti provenenti dalla stessa Amministrazione americana.
Dai crimini di guerra compiuti in Vietnam e accertati dal Tribunale Russell
(1967), a quelli sostenuti nel giardino di casa (Salvador, Honduras, Haiti, Guatemala,
Panama), dove alla fine dei vari conflitti sono stati contati 200mila cadaveri, torturati
o mutilati, milioni di orfani e profughi. Dal cono sud dell’America latina (Argentina,
Cile, Bolivia, Brasile, Uruguay, Paraguay), al Sudafrica dell’apartheid; dall’Indonesia
di quel Suharto che nel ’65, con l’aiuto americano, sterminò quasi 600mila oppositori
politici e che gli Usa continuarono ad appoggiare sino al ’99, nell’aggressione a
Timor Est, all’ex alleato Saddam Hussein, quando gassava 5mila curdi proprio
mentre si batteva quale fedele amico dell’Occidente contro il pericolo khomeinista. Al
premier turco Ecevit, che continua a seguire le orme del dittatore di Baghdad,
facendo scorrere sangue curdo.
Quando all’ex segretario di stato, Madeleine Albright, fu chiesto cosa pensasse
delle stime di mezzo milione di bambini iracheni morti a causa delle sanzioni, che il
suo governo sosteneva con vigore insieme alla Gran Bretagna, dopo circa nove anni
dalla fine della guerra del Golfo, rispose: “Pensiamo che ne valga la pena”.
R.C.
L’INDISPONIBILITÀ DI WASHINGTON
Decine di dichiarazioni e convenzioni, negli ultimi cinquant’anni, hanno visto lo
scarso sostegno di Washington: si è mostrata indisponibile a sottomettersi alle norme
internazionali che le imponevano di accettare quelle stesse condizioni minime, di cui
reclamava il rispetto da parte degli altri stati.
La discussione sulla Corte penale internazionale (1998) ha visto gli Stati Uniti
porre delle condizioni che hanno intaccato l’indipendenza del tribunale, indebolendo
il fatto che alcuni crimini vengano sottoposti al principio di giurisdizione universale,
siano in pratica perseguibili ovunque indipendentemente della nazionalità
dell’imputato, della vittima e del luogo ove il crimine è stato commesso. L’America ha
fatto di tutto per eliminare la capacità della Corte di agire senza il consenso dello
stato, di cui è cittadino l’eventuale autore del crimine.
Ci sono solo due paesi al mondo che non hanno ratificato la Convenzione sui
diritti dei fanciulli: la Somalia e gli Stati Uniti. Essi sono inoltre tra i pochissimi a non
aver ratificato la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione
contro le donne, mentre lo hanno fatto con quella sulla prevenzione e la punizione
del crimine di genocidio (1988), ben quarant’anni dopo averla sottoscritta. Hanno
aspettato 28 anni prima di ratificare quella sull’eliminazione di tutte le forme di
discriminazione razziale, mentre sono arrivati al 72° posto nella ratifica della
Convenzione contro la tortura.
Solo nel ’92 e in coda a 109 paesi, hanno detto di sì alla Convenzione sui diritti
civili e politici, 26 anni dopo la sua adozione da parte delle Nazioni Unite. Tuttavia
hanno anche espresso una riserva, che vincola i giudici americani a quelle parti che
siano compatibili con la legge interna. Il trattato internazionale proibisce, ad esempio,
la condanna a morte per coloro che non abbiano compiuto i 18 anni al momento del
delitto: gli Stati Uniti sono uno dei quattro paesi che ancora mandano a morte chi ha
compiuto un delitto da minorenne. Così la pena capitale non risparmia né i minori al
momento del reato, né i disabili mentali.
Tra le ultime Convenzioni non ratificate da Washington vanno ricordate quella
per la messa al bando delle mine antipersona e quella per il controllo internazionale
del commercio delle armi leggere.
R.C.
DOSSIER
A SCUOLA DI TERRORISMO:
ALLIEVI E
CATTIVI MAESTRIR.C.
Il giorno stesso in cui gli aerei statunitensi e britannici cominciavano a
bombardare l’Afghanistan, il presidente Bush affermava che “qualsiasi governo, se
sponsorizza fuorilegge e assassini di innocenti, diventa esso stesso fuori legge e
assassino”. Una posizione che non si può che condividere. Basta che valga per tutti.
Da 55 anni, Washington ospita un campo di addestramento dal quale sono
usciti diplomati, ufficiali che nella loro carriera hanno certamente ucciso molte più
persone di quelle sepolte dal crollo delle Torri Gemelle. Fino al gennaio del 2001, si
chiamava “Scuola delle Americhe”. Si trova a Fort Benning, in Georgia. È il centro
d’addestramento americano più noto. Altri 150 sono sparsi sul territorio degli Stati
Uniti e all’estero. Dalla Scuola delle Americhe sono stati licenziati 60mila poliziotti,
ufficiali e soldati provenienti dai vari paesi dell’America latina. Dalle sue aule sono
usciti a pieni voti torturatori, omicidi, dittatori e terroristi di stato che hanno
attraversato la storia di quel continente (vedi box).
Ora la Scuola è stata chiusa per essere immediatamente riaperta sotto altro
nome. Vi si insegna la pianificazione per le operazioni civili-militari, di pace e
antidroga, i soccorsi in caso di disastri, varie iniziative “a favore dei diritti umani”.
Insomma, le stesse materie che venivano offerte ai corsisti dalla vecchia Scuola delle
Americhe.
Non è tutto. Nel ’93, alcuni miliziani arabi della jihad erano stati addestrati
all’uso delle armi presso un’associazione di tiro a segno nello stato del Connecticut.
Tuttavia l’istruzione ufficiale e formale negli Stati Uniti era stata avviata già dal 1980,
sotto l’amministrazione Carter, un anno dopo l’inizio della guerra degli afgani contro
le truppe sovietiche, che avevano invaso il paese. Alcuni ufficiali scelti dei Berretti
Verdi, veterani del Vietnam, diedero così inizio alle attività di preparazione per la
nuova guerra in Asia meridionale. A questo scopo, esistevano alcuni centri di
addestramento paramilitare: uno gestito direttamente dalla Cia, a Camp Peary, che
avrebbe svolto un ruolo fondamentale nell’addestramento degli specialisti in
terrorismo.
Ce n’erano poi altri, come Harvey Point, in North Carolina o Fort A.P. Hill, in
Virginia. In quest’ultimo, come anche a Camp Picket, sempre in Virginia, i Berretti
Verdi e la Marina statunitense prepararono gli ufficiali dei servizi segreti pachistani e
talvolta direttamente i mujaheddin. In diversi casi, le tecniche lì acquisite sarebbero
state utilizzate dai fondamentalisti islamici egiziani e algerini dopo il ritorno nei loro
paesi dei veterani della guerra contro i sovietici, tra la fine degli anni ’80 e i primi anni
’90. Così come alcuni degli allievi egiziani dei centri di Camp Peary, Camp Pickett e
Fort Hill, avrebbero a loro volta addestrato i volontari in partenza per la jihad afgana.
Due pesi, due misure
Girato il vento della storia, le “forze del male”, preparate scrupolosamente sul
territorio americano, avrebbero utilizzato le loro conoscenze per colpire i loro vecchi
maestri. Tuttavia Fort Benning o Fort Bregg, Camp Peary o Camp Hill non sono
campi di addestramento di al-Qaeda, anche se ci assomigliano molto. Quindi nessun
governo occidentale democratico, coinvolto nella campagna “Libertà duratura”,
penserà mai di far chiudere queste autentiche Università del terrorismo di stato
internazionale. Il terrorismo esiste solo quando è rivolto contro di noi, e non quando è
da noi utilizzato contro gli altri. Così i miliziani dell’Uck quando si battevano contro i
serbi, erano “combattenti per la libertà”; quando invece rivolsero le loro armi per le
stesse ragioni contro la Macedonia, alleata degli Usa, diventarono da un momento
all’altro terroristi assassini.
L’Anc (African National Congress) era per Washington un’organizzazione
terroristica, quando si batteva contro l’apartheid in Sudafrica; poi il suo leader,
Nelson Mandela, è diventato un Nobel per la pace e un capo di stato. Per gli inglesi,
terroristi erano quelli dell’Irgun, gruppo armato ebraico; Begin, il comandante
dell’organizzazione, in seguito è diventato primo ministro israeliano. Ora, per Tel
Aviv, i terroristi sono quelli dell’intifada. Basta che cambi la contingenza storica e
l’interesse politico di parte, che uno si può trovare sulla lista nera e subito dopo
elevato a stimato statista. Eppure basterebbe così poco per fare chiarezza: applicare
anche per gli atti di guerra compiuti da Washington la definizione che di terrorismo ne
hanno dato i documenti statunitensi: “L’impiego calcolato della violenza o della
minaccia di violenza per conseguire obiettivi di natura politica, religiosa o ideologica.
Il tutto compiuto per mezzo dell’intimidazione, della coercizione o con la diffusione
della paura”. Se usassimo questa definizione, non potremmo non denunciare come
azioni terroristiche molte di quelle portate avanti dal grande fratello d’oltreoceano. È
improbabile però che ciò avvenga.
Oggi l’imperativo è un altro: si deve dimenticare, anzi si deve far dimenticare.
Allora non fa scandalo, non suscita quella giusta indignazione morale e politica che ci
si potrebbe aspettare dall’opinione pubblica, la proposta di legittimare la tortura, nel
senso di inserirla come strumento di indagine poliziesca, ovviamente contro i
presunti terroristi. Legittimarla, cioè dare veste legale ad una pratica che è stata e
continua ad essere ampiamente praticata da polizie di stato anche di governi
“democratici”, forze armate paramilitari e gruppi criminali. Opinionisti, avvocati,
docenti universitari, ex agenti della Cia, politici americani – dopo l’11 settembre – non
hanno usato mezze parole. ”È ora di pensare alla tortura”; “La tortura è brutta, ma in
certe circostanze può essere il male minore”. Su alcuni organi di stampa, si è
ventilata l’ipotesi di poter ricorrere a “misure di pressione”, appunto fino alla tortura,
nei casi in cui si debbano avere informazioni utili a impedire nuovi attentati. Basta
seminare. Qualcosa si raccoglierà.
R.C.
BOX
DIPLOMA DI PERFETTI ASSASSINI
Alcuni famosi diplomati della Scuola delle Americhe: il colonnello Lima Estrada,
responsabile dell’assassinio di Juan Gerardi, vescovo di Città del Guatemala;
Roberto D’Abuisson che a capo dei suoi squadroni della morte, uccise il vescovo
Oscar Romero; 19 dei 26 soldati che nel ‘89 massacrarono i gesuiti di San Salvador;
istruttori cileni della polizia segreta di Pinochet; i dittatori argentini Viola e Galtieri, i
panamensi Noriega e Torrijos, il peruviano Alvarado e l’ecuadoregno Rodriguez; il
capo di uno squadrone della morte nel Perù; quattro dei cinque ufficiali che
comandavano un battaglione in Honduras che controllava le truppe paramilitari;
l’ufficiale comandante del massacro di Ocosigo, avvenuto in Messico nel ’94, agli
inizi della rivolta zapatista.
Gli uomini istruiti alla Scuola delle Americhe sono oggi impegnati nella guerra in
atto in Colombia. Human Rights Watch, due anni fa, rivelò che sette uomini
provenienti sempre da Fort Benning, attualmente a capo di gruppi paramilitari
colombiani, hanno organizzato e diretto rapimenti, sparizioni, omicidi e massacri. Nel
febbraio del 2001, un altro militare addestrato là è stato condannato per complicità
nelle torture e uccisioni di trenta contadini compiute dalle forze speciali di Bogotà.
R.C.
DOSSIER
CARCERI USA: QUANDO LA PENA
È UN BUSINESS
ROBERTO CUCCHINI
Se Dostojevski sosteneva che "la qualità della società si misura dalla qualità
delle sue prigioni", il modello penitenziario made in Usa ne è la sua traduzione reale.
Ma in senso negativo. Scrivendo del suo sistema repressivo, ogni anno Amnesty
International denuncia le brutalità compiute dalle forze di polizia, aggiungendo poi
che "le carceri statunitensi sono spesso teatro di gravi abusi e sono sovente
caratterizzate da condizioni di vita molto dure. Maltrattamenti e torture sono
ampiamente diffuse, anche ai danni di minori e di donne. In molti penitenziari, i
detenuti sono vittime di abusi fisici e sessuali sia da parte delle guardie sia da parte
di altri reclusi. Inoltre, sono stati segnalati frequenti abusi nell'utilizzo di strumenti
elettrici, spray irritanti e dispositivi di costrizione".
Ogni anno ci sono migliaia le denunce contro le forze dell’ordine; queste hanno
colpito e ucciso persone sospette, che non opponevano alcuna resistenza. Il
dipartimento di polizia di San Diego ha identificato ben 94 casi di morti in custodia
avvenute tra il 1982 e il ’92 a seguito di tali sistemi.
Attualmente, negli Stati Uniti, ci sono poco meno di due milioni di detenuti su
una popolazione di 275 milioni di persone. Si stima che la tendenza sia in ulteriore
crescita, tanto che si paventa uno scenario a dir poco inquietante: un americano ogni
20, nella sua vita, avrà buone probabilità di finire almeno una volta dietro le sbarre.
Se poi al numero dei carcerati veri e propri, sommiamo i condannati che
usufruiscono della libertà sulla parola (685mila), o di uno stato di sorveglianza
(3.260.000), vedremo che quasi sei milioni di cittadini della più ricca potenza
mondiale sono sotto tutela penale.
Se ancora nel '75 il numero dei detenuti non andava oltre le 380mila unità, solo
dieci anni dopo era raddoppiato (740mila), per superare il milione e 600mila nel '95,
con un incremento annuo dell'8%, lungo tutto il decennio. In sostanza, tra gli anni '80
e '90, il numero dei carcerati è triplicato. Nel '97 si poteva contare un numero di
imprigionati da sei a 10 volte superiore a quelli dei paesi europei. Nel Sud Africa
dell'apartheid, paradossalmente, la pena carceraria è stata comminata con minor
frequenza che nell'America di oggi. E riguardava ovviamente la popolazione nera.
Come negli Stati Uniti. Infatti dal 1989, per la prima volta nella sua storia, i neri
rappresentano la maggioranza dei prigionieri, benché non superino il 12% della
popolazione; se il 60% dei carcerati è composto dalle minoranze etniche, quasi la
metà è afroamericana. Nel '95, su 22 milioni di neri in età adulta, 767mila stavano
dietro le sbarre, 999mila erano in libertà vigilata e 325 erano rilasciati sulla parola.
Anche il numero delle donne imprigionate è sensibilmente cresciuto, passando
dalle 5.600 del '70 alle 75mila del '97. E anche in questo caso, quelle di colore sono
le più colpite. Quasi 3mila condannati stanno aspettando di percorrere per l'ultima
volta il miglio verde che lì porterà davanti dal boia.
Da un punto di vista statistico, il numero di carcerati vede gli Stati Uniti al
secondo posto dopo la Cina e prima della Russia. Anche se l'Europa non è stata a
guardare; copiando l'esempio del "grande fratello" d'oltreoceano, negli ultimi
vent'anni, il tasso di detenzione è aumentato del 20-30%. In Italia del 20%.
MENO REATI E…PIÙ CARCERATI
È fin troppo facile pensare che l'aumento delle carcerazioni sia la logica
conseguenza dell'incremento delle infrazioni alle leggi. Il senso comune vede di solito
nel popolo dei reclusi un indicatore di criminalità. Più reati, più gente in cella.
Un'equazione a prova di bomba. Ma non è così.
Se è vero che negli Stati Uniti, dalla metà degli anni '70, c'è stato un vertiginoso
balzo in avanti nel numero dei detenuti, quello delle vittime, cioè dei reati commessi,
ha continuato a decrescere. Dal '73 al '90, il tasso di quelli contro la persona è sceso
del 24,5%, mentre i reati contro la proprietà del 26,1%. La spiegazione di questa
apparente contraddizione sta nel fatto che è aumentata la durezza della sanzione
penale. L'aumento del numero di persone che finiscono in cella, è l’effetto di politiche
penali più severe e non la necessaria conseguenza di un aumento dei reati. Così si
finisce dentro anche per atti, per i quali sarebbero possibili pene alternative. Qualche
esempio: nello stato della Georgia, un ragazzo di 11 anni è stato incarcerato per aver
minacciato la sua insegnante. Uno di 12 per aver molestato una persona con una
telefonata. Una ragazza di 14 anni è finita in prigione per aver fatto dei graffiti su un
muro. Si può essere imprigionati a 16 anni per aver trasgredito le regole fissate dal
padre e per non voler andare a scuola. Sono stati buttati in cella ragazzi scappati da
casa o accusati di "minacce terroristiche", solo perché avevano imprecato contro i
propri professori.
Il numero di persone rinchiuse nei vari istituti correzionali del paese è passato
da 17.300 (1975) a 48.300 (1985), per raggiungere quota 130mila nell'95. Fa buon
gioco la manipolazione delle paure dell'opinione pubblica allo scopo di creare, un
giorno sì e uno ancora sì, una "emergenza sicurezza" permanente. Anche noi italiani
ne sappiamo qualcosa... Ciò che conta, in questo caso, non sono i dati reali sulla
criminalità, ma la percezione che l'uomo della strada ha di questo fenomeno.
Sull'onda di tutto questo, in America si sta affermando una vera e propria "lobby
delle prigioni": gruppi di faccendieri, di imprenditori di carceri private, interessati ad
aumentare i propri profitti, si danno da fare perché le nuove procedure, le norme per
la libertà sulla parola o i nuovi stanziamenti in materia carceraria, non entrino in
conflitto con i loro interessi, facendo pressione sul governo e sulla magistratura a
favore di un incremento delle carcerazioni. Gli appaltatori delle prigioni, i fornitori
delle forze dell'ordine e il sindacato delle guardie sono riusciti a far approvare una
legge, che allunga i termini della detenzione. Così le celle non rimarranno mai vuote.
Nella capitale della California, il sindacato delle guardie degli stabilimenti di
pena, è la corporazione più forte, più importante di quella del tabacco e
dell'agricoltura. Grazie alla sua influenza, lo stipendio di un secondino supera del
30% quello di un docente incaricato universitario.
DEI PROFITTI E DELLE PENE
Tra il 1979 e il '90, la spesa dei vari stati della confederazione nel settore
carcerario è aumentata del 325% in ordine al funzionamento e del 612% in ordine
alla costruzione, con un ritmo tre volte maggiore di quello della spesa militare a livello
nazionale. Secondo stime credibili, il bilancio di gestione del sistema penitenziario
statunitense si aggira sui 20 miliardi di dollari l'anno e ogni anno si spendono circa
sei miliardi di dollari per costruire nuove celle. L'Amministrazione Clinton non si è
discostata molto dai suoi predecessori repubblicani. Mentre tagliava le spese sociali,
faceva costruire 213 nuove prigioni (senza contare quelle private); così il personale
delle sole carceri federali e di stato è passato da 264mila a 347mila dipendenti, pari
ad un aumento del 31%. Tra tutte le attività, nell'ultimo decennio, la formazione e
l'assunzione di guardie è quella che ha visto la più rapida crescita.
La vittoria del neoliberismo alla fine ha interessato anche questo settore: le
privatizzazioni del sistema penitenziario erano iniziate già negli anni '80 con un
considerevole aumento dei contratti tra società private, stati e città per sistemare i
detenuti e gestire le prigioni. Questo perché, come recita l’ideologia tuttora in auge,
tutto quello che il "pubblico" può fare, l'impresa privata lo può fare meglio e a costi
inferiori.
Prigione vuol dire denaro. Negli States, lo chiamano il correctional business: è
una specie di speculazione affaristica sulle disgrazie altrui. L'amministrazione della
pena è diventata, come tutto del resto, una fonte di profitti. Maggiore è la "domanda"
di internamento, maggiore l'offerta; il problema è di poter vendere bene la merce
"pena" e far funzionare a regime l'industria del controllo sulle "classi pericolose": i
poveri, i disoccupati, gli afroamericani, i giovani delle periferie urbane, gli immigrati
"clandestini".
Nel 2000, cinque società si dividevano la gestione di 120 stabilimenti di pena
privati per un totale di 120mila detenuti. Anche se il numero di imprese che dominano
questo mercato, si riduce in pratica a due società: la Correctional Corporation of
America e la Wackenhut Corrections Corporation.
Queste gestiscono una trentina di carceri di minima e media sicurezza. Il resto
del mercato è in mano a piccole compagnie, che vendono prigioni a comunità rurali,
le quali vedono in esse un’opportunità per nuovi posti di lavoro e maggiori entrate
fiscali. La Wackenhut amministra attualmente 11 carceri, in pratica il 22% del
mercato dei posti-cella affidati ai privati; inoltre ne gestisce altre due in Australia,
mentre cerca di penetrare anche sui "mercati" latinoamericano, asiatico ed europeo.
Nel 1999, il suo giro d'affari ammontava a 2,2 miliardi di dollari e controllava il 55%
del mercato penitenziario privato non statunitense.
La Correctional Corporation è invece considerata la pioniera nella costruzione e
nell'amministrazione degli istituti di pena privati; sta gestendo 21 prigioni, cioè il 51%
del mercato interno, soprattutto negli stati del Sud (Texas, Tennessee, Florida, New
Mexico), dove la privatizzazione delle carceri si è andata sviluppando a partire dagli
anni '80 e oggi rappresenta un vero e proprio settore industriale con una crescita del
35% l'anno. Ma non solo: come l'industria manifatturiera, oltre ad aver stabilito
rapporti anche con la Gran Bretagna e l'Australia, è disponibile a spostare le sue
"aziende" oltre il confine messicano, dove possono essere impiantate delle
autentiche maquilladoras penitenziarie. Lo stato dell’Arizona ha in progetto la
costruzione di una prigione privata in Messico, per 2mila detenuti chicanos. Quotata
alla borsa di Wall Sreet, la Correctional Corporation rappresenta la quinta società sul
mercato finanziario newyorkese.
Stiamo parlando di due "multinazionali delle sbarre". Alcune previsioni danno
per certo che, entro il 2003, la percentuale del vantaggioso mercato della detenzione
negli Usa crescerà più del doppio. Già dal 1983 al '96, i posti letto nelle prigioni
private sono passati a 87.072 (+ 48%). Le previsioni ci assicurano poi che, entro il
2006, raggiungeranno quota 350-400mila. E qui balzano all’occhio alcune cifre: nei
primi anni del decennio scorso, il costo medio di un letto carcerario era di 53.100
dollari contro i 42mila degli anni '87-88.
Come buona regola di ogni sistema produttivo che si rispetti, a questo punto
entra in campo l'indotto. Esistono più di cento ditte specializzate soltanto nella
progettazione di carceri, che guadagnano dai quattro ai sei miliardi di dollari l'anno
con il mercato di questo genere di edilizia. Sul Correction Today, una pubblicazione
edita dall’Associazione penitenziaria statunitense, si possono leggere inserzioni del
tipo: costruttori "chiavi in mano", servizi di gestione penitenziaria, bracciali elettronici,
armi speciali, sistemi di controllo per detenuti pericolosi, una perfetta show-room per
un giro d'affari valutato in miliardi di dollari all'anno. Ci troviamo di fronte ad una vera
"economia del controllo repressivo".
Negli ultimi anni, prigioni e istituti per minori hanno dato in gestione a fornitori
privati una serie di servizi, compresa la ristorazione, la sanità, l'assistenza
psicologica, l'orientamento professionale, l'istruzione e il trasporto dei carcerati.
Naturalmente il "privato" è sinonimo, per principio, di creatività: via le uniformi
paramilitari e il rozzo vocabolario che puzza troppo di caserma. Con maglioni color
cammello che portano il marchio della ditta, le guardie che diventano "tecnici della
sicurezza aziendale" o "residenti supervisori", le prigioni che si trasformano in
"imprese di correzione" e i carcerati che vengono chiamati "residenti", il gioco è fatto.
Ciò che conta, è l'idea innovativa: il logo.
QUALITÀ E PREZZO
In questo nuovo sistema penitenziario, tolta la funzione che istituzionalmente e
moralmente spetterebbe allo stato, ciò che rimane è l'efficienza. Com’è possibile
lasciare ai privati la gestione della pena, senza che venga sacrificato il fine della
privazione della libertà, che è (o dovrebbe essere) il recupero e la reintegrazione
sociale del recluso? E quali strumenti esistono per verificare se gli interessi collettivi
sono nei fatti sacrificati a quelli delle compagnie private che gestiscono il sistema
carcerario?
Al di là della propaganda sul "più efficienza, miglior qualità del servizio, minor
costo", tanto utilizzata per convincere che "privato è bello", anche negli States ci si
sta accorgendo che i gestori privati dell'industria penitenziaria non solo non
garantiscono i tanto sbandierati risparmi, ma soprattutto svolgono un lavoro
sacrificando la "qualità" dello stesso: se la pena è pura e semplice detenzione,
ingabbiamento associato più alla violenza repressiva che alla fornitura di beni sociali
e materiali, allora la soluzione può apparire economicamente conveniente. Ma se,
come dovrebbe essere in una moderna civiltà fondata sul diritto, alla detenzione
deve accompagnarsi anche il recupero parziale o totale del carcerato, le sue
eventuali cure, il sistema privato entra in contraddizione con se stesso, poiché
"rieducare" significherebbe perdere dei potenziali futuri "clienti".
Questo sistema non è interessato a persone che escono per sempre dal giro
del crimine, ma a potenziali utenti che ci devono cascare di nuovo per pagare, con
una pena ancora più dura della precedente, il nuovo debito contratto.
Un solo esempio: i funzionari di una della due maggiori società private
americane, la Wackenhut Corporation, sono stati accusati di essersi appropriati
indebitamente di più di 700mila dollari dei fondi pubblici del Texas. Fondi statali,
destinati a programmi di riabilitazione dalla tossicodipendenza, usati invece per
acquistare telefoni cellulari e per viaggi privati in Inghilterra.
La Correction Corporation ha costruito e gestito il primo carcere femminile
privato al mondo, situato nel bel mezzo del deserto del New Mexico. In questa
prigione, le donne soffrono discriminazioni e deprivazione sensoriale a causa del
regime di isolamento a cui sono soggette. La compagnia si è rifiutata di provvedere
ai programmi educativi, ricreativi e lavorativi, così come al servizio postale. Se
risparmio ci dev’essere, va fatto allora, come in qualsiasi altro comparto produttivo,
soprattutto sugli stipendi del personale, sul loro regime sanitario e pensionistico, sulla
loro "professionalità". È quasi inevitabile dunque che una guardia pagata male non
solo faccia male il suo lavoro (come ogni lavoratore dipendente), ma cerchi anche di
arrotondare lo stipendio con qualche extra: ad esempio spacciando droga tra i
detenuti, o favorendo fughe.
Inoltre, mentre nel settore pubblico c'è sempre il rischio di scioperi che possono
coinvolgere il personale di sorveglianza, in quello privato è più facile che tra le
clausole poste dal governo per concedere l'appalto della gestione di una prigione, ci
sia il divieto di esercitare tale diritto; in caso contrario, il contratto potrebbe essere
scisso unilateralmente o il secondino scioperante licenziato.
LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL CONTROLLO SOCIALE
Il "sistema industriale delle carceri" è quindi uno di quelli in maggiore crescita.
Non solo per quanto riguarda l'aspetto immobiliare, ma anche per l'alta tecnologia
impiegata all'interno delle prigioni.
In primo luogo, la schedatura. L'espansione delle banche dati ha fatto in modo
che negli Usa ci siano 50 milioni di schede criminali riguardanti ormai 30 milioni di
persone, pari a quasi un terzo della popolazione maschile del paese. Un sistema di
controllo diffuso, insinuante, che non interessa solo chi è incappato nei rigori della
legge, ma che si allarga "a rete" tirando dentro familiari, parenti prossimi, vicini di
casa, conoscenti. Se uno è un "criminale", è possibile che infetti l'ambiente, ricerchi e
riceva complicità; per questo deve essere monitorato per poi essere "bonificato".
Data poi la forbice che si è aperta tra le pene inflitte e la complessiva capacità
ricettiva del sistema carcerario – tra domanda e offerta c'è sempre un relativo
squilibrio –, l'industria high tech ci dà una mano, realizzando prodotti sofisticati che
permettono una diversa gestione della detenzione.
Tra quelle di sorveglianza, le tecnologie più in uso sono ovviamente quelle
elettroniche e, in primo luogo, il cosiddetto "braccialetto", conosciuto anche in Italia e
utilizzato per assicurare il controllo del condannato fuori dal carcere. È collegato ad
un apparecchio telefonico; se il sorvegliato si allontana dalla sua abitazione,
trasformata così in una vera prigione, il collegamento con il telefono si interrompe e
nella caserma di polizia suona l'allarme.
Le tecnologie di "seconda generazione", in fase di sviluppo, vengono progettate
invece per seguire l'individuo 24 ore su 24. Contemplano dispositivi che permettono
di registrare il ritmo cardiaco, la pressione, il tasso di adrenalina e l'eventuale
presenza di alcool o droga nel sangue.
Gli strumenti per la sorveglianza elettronica di "terza generazione", le cui
ricerche sono in corso, non prevedono un uso per la semplice sorveglianza del
"soggetto pericoloso", ma anche un'interazione con lo stesso. Il sistema indicherà,
infatti, se la persona controllata è sul punto di commettere qualche infrazione; nel
qual caso, sarà possibile intervenire sul suo organismo attraverso segnali sonori,
scariche elettriche o altro. Il sistema elettronico sarà in grado di avvisare, punire o
tentare di impedire l'infrazione.
Anche la famosa Mitsubishi – sì, proprio quella delle auto, delle moto e degli
stereo – non ha perso l'occasione di lucrare sulle disgrazie altrui. Già da dieci anni
offre un kit completo che contiene non solo il tradizionale bracciale, ma anche un
telefono collegato con un trasmettitore televisivo e uno strumento per misurare il
livello di alcool nel sangue.
L'INDUSTRIA DELLE SBARRE
L'apparato penitenziario americano svolge un compito molto preciso riguardo
alle fasce socialmente più deboli della popolazione: si tratta di quella moltitudine di
persone in tutto o in parte escluse dal mercato del lavoro dipendente regolare, o da
un'assistenza pubblica che si sta avvicinando al sistema di carità.
La "criminalizzazione della miseria" prima e la carcerazione poi, rappresentano
gli strumenti ideologici e pratici per ridurre artificialmente il livello stesso della
disoccupazione, sottraendo dal mercato del lavoro decine di migliaia di persone: gli
esuberi. L'altro risvolto della medaglia è rappresentato invece dall'incremento
dell'occupazione nel settore dei beni e dei servizi carcerari. Si è valutato che, nel
decennio passato, le prigioni Usa hanno ridotto di due punti il tasso di
disoccupazione, assorbendo le "eccedenze". Qualche ricercatore si è spinto ad
affermare che l'alta proporzione della popolazione incarcerata riduce il dato
percentuale della disoccupazione statunitense, ma il mantenimento di questo stesso
livello costringerà ad espandere sempre più il sistema penale.
Una buona parte dei detenuti nelle prigioni americane, sia pubbliche che
private, rappresentano un autentico mercato del lavoro parallelo. In California, dal
1990, una nuova legge prevede che le imprese private possono utilizzare il lavoro dei
detenuti. Ciò che una volta veniva prodotto all'esterno, ora può essere fabbricato
dalle mani di un carcerato che riceve un salario pari al 20% di quello minimo
convenuto, mentre l'amministrazione ne trattiene l'80%. Non si tratta più di un lavoro
volontario, ma di un obbligo sancito per legge che definisce il dovere del prigioniero
di lavorare per pagare i "servizi", di cui usufruisce. Di conseguenza, le prigioni non
sono solo privatizzate, ma producono lavoro a basso costo, diventando, soprattutto
nelle aree rurali del paese, una parte sostanziale delle economie locali.
Ad esempio, alla prigione di Lochart, gestita dalla Weckenhut, lavorano in
subappalto altre tre compagnie private. Una di queste, la Lochart Technologies Inc.,
che produce componenti meccanici, con il lavoro dei detenuti è riuscita a finanziarsi
la costruzione di una fabbrica, chiudendo quindi i propri impianti di Austin (Texas),
licenziando i dipendenti e traslocando nella fabbrica-carcere tutti i suoi macchinari.
Quei disoccupati potrebbero un domani far parte della nuova classe operaia della
"industria delle sbarre".
Molte corporazioni transnazionali stipulano contratti con gli States per produrre
merci e mettere su centri di televendita. La Twa e l'Eddie Bauer Sorting Groups
utilizzano i detenuti ai centralini telefonici, per ricevere prenotazioni e ordini. La
Microsoft ha fatto impacchettate, avvolgere nel cellofan e spedire dai reclusi il suo
Windows 95.
Lo stato della California ha prodotto un video a sostegno del programma per
costruire fabbriche nelle sue prigioni. Lo slogan è: "Perché andare lontano, quando
puoi avere una forza lavoro disciplinata a casa tua?".
Per non lasciare soltanto gli Stati Uniti a fare la parte del brutto anatroccolo,
possiamo affermare che questa logica è imperante anche nelle Repubbliche dell’ex
Unione Sovietica e in Cina. Nel primo caso, la produzione nei luoghi di detenzione
rappresenta una parte vitale dell'economia, responsabile di 8,5 miliari di rubli di
entrate l'anno. Dal sistema concentrazionario cinese escono invece merci per un
valore di circa 100 milioni di dollari l'anno. Beni che vengono venduti in tutto il
mondo.
Se è così, allora non può non farci riflettere quanto ha scritto Nils Christie, noto
criminologo norvegese: "I lager nazisti e i gulag sovietici non erano frutto di menti
criminali: erano soprattutto il prodotto della razionalizzazione tecnica del controllo sui
diversi. Allora fu l'ideologia a legittimarli. Oggi è il mercato, il business che c'è dietro,
rischia di legittimare questo sistema".
ROBERTO CUCCHINI
AUSTRALIA: LE PRIVATIZZAZIONI
NON RISOLVONO, ANZI
Il governo australiano ha completato il suo piano di privatizzazione del sistema
penitenziario dello stato di Victoria: in esso è recluso l'80% delle donne imprigionate.
Le compagnie che sono state interessate a quest’operazione di "privatizzazione
della pena", sono l'Australian Correctional Management (Acm), la Corrections
Corporation of Australia (Cca) e il Group 4 Remand Services Ltd. (vedi box Gran
Bretagna).
La prima, che attualmente sta gestendo già due prigioni e ha vinto l'appalto per
una nuova da 600 posti a West Sale, è di proprietà della statunitense American
Warkenaut Corporation (vedi articolo).
Ma le cose non stanno andando del tutto lisce. In una di queste carceri, si sono
succedute ultimamente rivolte e agitazioni a causa del personale di guardia privo
d'esperienza, costretto a dure condizioni di lavoro e per giunta mal pagato. I detenuti,
dal canto loro, hanno più volte protestato per l'assenza di qualsiasi programma
educativo e di formazione, per l'affollamento e la mancanza di servizi. Il consumo
diffuso di droghe e le morti violente fanno da corollario a tutto ciò.
Solitamente nelle prigioni private australiane non vengono trasferiti casi
particolarmente difficili: detenuti che richiedano particolari protezioni, che abbiano
tendenza suicide, problemi psichici o che necessitano di sorveglianza medica a
lungo termine. È un po' come nelle nostre cliniche private che si prendono in carico
l'ammalato con l'appendicite, mentre i casi più impegnativi li passano ai nosocomi
pubblici.
R.C.
I LABOUR COME I TORY:
CARCERI PRIVATIZZATE IN UK
A partire dal 1991, il sistema carcerario britannico è stato investito da un
radicale programma di privatizzazione; si prevede che nel prossimo decennio
verranno inaugurate una ventina di nuove carceri, a riprova di come il governo
laburista punti sulla continuità della linea inaugurata negli anni '90.
Sono quattro le maggiori imprese che si disputano il fiorente mercato della
detenzione: il Group 4 Remand Services Ltd. (emanazione del gruppo svedese
Securitas International e leader del mercato) che attualmente gestisce due
penitenziari. La Ukds (United Kingdom Detention Services, affiliata al colosso
statunitense Correction Corporation of America e alla impresa di ristorazione
francese Sodexho); la Premier Prisons (nata dall'alleanza fra l'americana Wackenhut
(vedi articolo) e l'inglese Serco, responsabile del tristemente noto centro di
detenzione per immigrati di Gatwick); infine la Securicor, il cui direttore generale,
fratello di un ex deputato tory, gode di ampie aderenze presso la Direzione della
polizia metropolitana e Scotland Yard.
R.C.