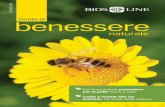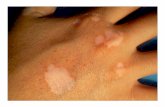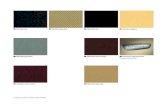Sotto pelle
-
Upload
0111edizioni -
Category
Documents
-
view
233 -
download
0
description
Transcript of Sotto pelle
In uscita il 31/3/2015 (15,00 euro)
Versione ebook in uscita tra fine marzo e inizio aprile 2015
(3,99 euro)
AVVISO
Questa è un’anteprima che propone la prima parte dell’opera (circa il 20% del totale) in lettura gratuita.
La conversione automatica di ISUU a volte altera l’impaginazione originale del testo, quindi vi
preghiamo di considerare eventuali irregolarità come standard in relazione alla pubblicazione
dell’anteprima su questo portale.
La versione ufficiale sarà priva di queste anomalie.
www.0111edizioni.com
www.quellidized.it
www.facebook.com/groups/quellidized/
SOTTO PELLE Copyright © 2014 Zerounoundici Edizioni
ISBN: 978-88-6307-874-9 Copertina: immagine Shutterstock
Prima edizione Marzo 2015 Stampato da
Logo srl Borgoricco – Padova
5
1. La promessa
Sembrava già tutto così diverso. Le nuvole gonfie, l’aria fredda, la partenza programmata nel dettaglio e il cuore in gola. Lo sentivo battere dentro di me, pieno di attese. L’unico pensiero che smussava lievemente la mia felicità era rivolto a Emma, a casa nostra e non con me. Ma così avevamo deciso. Due giorni all’anno, tutti gli anni. Due giorni per noi, soli. Una follia, un capriccio d’amore, un’iniezione di vita. L’unica cosa possibile, inevitabile, irrinunciabile. Scesi di corsa dall’autobus per dirigermi rapidamente sulla panchina prescelta. Avrei aspettato lì, come l’anno prima. Il vento mi tagliava le gambe. Mi faceva scudo la maxibag da viaggio pronta a esplodere. Nervosa, giocavo dondolando i tacchi delle mie décolleté, avanti, indietro, tenendo le punte sempre rialzate. Avevo curato ogni dettaglio del mio look: il trucco, l’abbigliamento, l’intimo. Ero certa di non avere tralasciato nulla. Avevo passato ore e ore a pensare ai particolari da quando c’eravamo salutati, l’anno prima. Mi stringevo sempre più nel mio impermeabile. Era in ritardo. Odio il ritardo ma a lui avrei perdonato qualsiasi cosa. Iniziò a piovere. Presi il mio ombrellino da viaggio e mi rannicchiai lì sotto. Venni invasa da mille pensieri e sentivo scricchiolare le mie certezze. Potevo aver preso un abbaglio? Questo no, ne ero più che certa. L’agitazione iniziò a invadere ogni cellula. Un brivido gelido mi preannunciò che qualcosa era andato storto. La fiducia totale e anche irrazionale che avevo deposto in lui albergava, nonostante gli eventi, in me. Sentii dei passi avvicinarsi. Spostai con un sorriso l’ombrello ma non era lui. La protezione per la pioggia cadde a terra e volò via danzando nel vento. Io mi tramutai all’istante in una statua di ghiaccio. Lo riconobbi subito. Non poteva essere altri che suo figlio. Mark. Mi fu tutto chiaro, anche se non volevo ascoltarmi. Il mio sguardo rimase fisso su di lui. «Marta?».
6
«Sì, sono io». L’acqua ci scivolava addosso senza tregua. Mi disse: «Possiamo andare…?» indicando un caffè al di là della strada. Mi alzai senza rispondere. Tutte le pozzanghere sembravano cercarmi. Mi aprì la porta e io mi trascinai dentro. Rimasi in attesa, come una bambola di pezza dimenticata su una mensola. Registrai un suo movimento e mi accodai. Scivolai sulla sedia. Il calore del locale si schiantò sul mio viso. Sentivo rimbalzare le gocce che abbandonavano il bordo del soprabito per suicidarsi sul pavimento. Poi riuscii ad alzare lo sguardo. Misi a fuoco l’immagine dinnanzi a me e sentii scendere, gonfie e silenziose, delle lacrime lungo tutto il viso. «Papà non c’è più». E poi il silenzio. Non so dire quanto tempo trascorse. Silenzio. Sentivo i suoi occhi addosso mentre io non riuscivo a guardare altro che un graffio inciso nel tavolino di legno davanti a me. Mi sembrava un burrone dentro il quale finire. «Mi ha lasciato una busta da consegnarti» e la allungò sul tavolo coprendo per intero la fessura dove ero scivolata con la mente. La avvicinai a me lasciandola scorrere leggermente sul piano d’appoggio. Mi tremavano anche le mani. Non ero ancora riuscita a dire nulla. Ero come vuota, assente. «Mio padre prima di andarsene mi ha dato delle indicazioni che ho voluto rispettare. Questo non vuol dire che condivida o sia contento del vostro incontro né tantomeno del nostro». La sua voce si era fatta dura, tagliente. «Mia madre non sa nulla». Fece una pausa. «Se non ti dispiace ora io andrei» aggiunse alzandosi. Il rumore stridulo della sedia mi scosse. «Aspetta Mark, aspetta un attimo, per favore». Suonò come una supplica. E lo era. «Io vorrei sapere quando è successo, come… qualcosa, ti prego dimmi qualcosa», e gli afferrai la mano con un movimento disperato. Si sedette nuovamente. Era nervoso e visibilmente a disagio. Anche io lo ero. Non erano di certo le condizioni ideali per parlare. Mi passai le mani sulla faccia come per ricomporre velocemente qualcosa andato a pezzi, appoggiai i gomiti al tavolino e presi la testa fra le mani. Sospirai profondamente. «Ti ascolto» aggiunsi con un filo di voce. Mi sembrò ammorbidirsi un po’, non so come mai, fu una sensazione. Sospirò anche lui. «È morto in ospedale il 12
7
settembre. Lo scorso luglio gli fu diagnosticato un tumore fulminante ai polmoni. Ha lottato. Senza farcela. Si è consumato e spento». Fece una pausa. «Mi ha raccontato di te appena ha capito che non sarebbe riuscito a esser qui oggi. So che vi eravate fatti una promessa. So che hai aspettato tanto su quella panchina. Oggi come un anno fa. So tante cose che mi fanno arrabbiare. Avrei voluto stracciare quella busta e non venire oggi ma non ci sono riuscito». «Grazie per non averlo fatto e grazie per essere ancora qui. Capisco la tua sofferenza». Le mie parole lo urtarono e si affrettò ad aggiungere: «Non ho altro da dire». «Vorrei andare a trovarlo… insomma…». Attesi una sua reazione che non tardò. «Non se ne parla nemmeno. Torna a casa. Dimentica mio padre». Era gonfio di rabbia. Gli sorrisi, scossi la testa e bisbigliai: «È impossibile. Semplicemente impossibile. Tu non hai idea di cosa tuo padre significhi per me». Ero certa che si sarebbe ancor più irrigidito ma non mi importava. «Io domani andrò al cimitero da tuo padre. Fosse l’ultima cosa che faccio in vita mia. Lo troverò anche senza il tuo aiuto, non importa quanto tempo ci vorrà. Non tornerò mai in Italia senza avergli fatto visita, senza averlo salutato». Mi fissava con disprezzo. Mi faceva sentire colpevole, sporca e io avevo la sensazione di annegare. Non riuscivo a essere lucida. «Fa’ come vuoi» ringhiò fra i denti e, in un attimo, svanì nel nulla. La cameriera, che aveva seguito la scena da lontano, senza probabilmente capire nulla, mi guardò come per voler essere rassicurata. Tremavo. Non mi ero ancora fermata. Ordinai un tè caldo, nell’illusione di potermi scaldare.
8
2. Libero di ballare
Entrare in quella stanza è stato come rivedere un film 3D. Tutto era come l’anno prima. Stesso copriletto a righe oro e bordeaux, stessa disposizione di ogni cosa, dalla poltroncina imbottita in tinta, agli asciugamani piegati sul letto. Il quadro sopra la testata trapuntata. La lista minibar appoggiata sulla scrivania, a fianco una cartelletta di velluto contenente carta intestata dell’albergo e una busta commerciale. Sopra, in obliquo, una penna nera con i dati dell’hotel stampati color oro. Lo specchio, sulla parete opposta, mi fissava. Tutto come se qualcuno avesse fermato il tempo. E invece chissà quante persone erano state lì dentro in un anno. Turisti, coppie, famiglie, gente in affari. Chissà. Io, però, mi trovavo in quella stanza sola. Sola come non mai. La testa era pesante, il cuore sanguinante, i piedi ghiacciati. Non avevo il controllo della situazione. Angoscia e disperazione si nutrivano di ogni mio atomo. Dopo essere stata ferma immobile nell’anticamera per qualche minuto, mi lasciai cadere sul letto. Inerme. Nella mano, stretta stretta, la busta. Mi sembrava che tutto intorno a me girasse. Forse per l’insostenibile senso di nausea e vertigine. Non avevo nessuna voglia di reagire al dolore. Nessuna. Lo lasciavo libero di ballare dentro me. Persi del tutto la cognizione del tempo fissando un punto immaginario del controsoffitto. Poi il cellulare squillò. All’improvviso. Fu come una scossa, perché mi ricordai il motivo che mi aveva obbligato a togliere la modalità silenzioso che tenevo quotidianamente. Emma. Balzai in piedi con uno scatto felino e in un secondo stavo rovistando nella borsa. Come pensavo. Emma. «Pronto?». «Mammmmmma ciao! Come stai?». «Bene amore mio, e tu? Hai mangiato? Dove sei?». «Sono a casa, con il papà. È qui. Papaà?».
9
«Emma?». «Sì mamma?». «Come è andata oggi alla scuola materna?». «Bene! Ti ho fatto un disegno! Sei tu in farmacia!». Sentii un brusio in sottofondo. Poi aggiunse: «Adesso ti passo il papà». Udii il rumore inconfondibile della mia porta d’ingresso. Si gonfia sempre un po’ la cornice di legno con l’arrivo dell’autunno e dell’umidità, così stride sul pavimento. «Ciao Marta...». «Ciao». «Dove sei? Forse è il caso di darmi qualche spiegazione». Silenzio. Deglutii e presi fiato. «Ti spiego meglio quando torno». «Sei con un uomo?». «No». «Non capisco. Ma mi hai scritto che…». «Gabriele, ti spiego quando torno. Forse starò via qualche giorno in più». «Quando mi chiami Gabriele c’è qualcosa che non va». La sua voce si fece più sottile. «Arrivo Emma, sono al telefono con la mamma. Arrivo, un attimo!». Poi mi disse: «Tua sorella oggi era agitata. Credo senta la tua mancanza». «Umm… dille che la saluto! Dai un bacio a Emma da parte mia. Le ho preparato in camera i vestiti per questi giorni e la caccia al tesoro con i cuori. Sparsi per tutta la casa ma lei lo sa. Li ha già trovati?». «Alcuni sì. Manchi anche a lei». «Lo so. Lei a me. Ci sentiamo domani». Mi si strozzava la gola. «Va bene. Ciao». Era rassegnato, consapevole di non poter pretendere di più. Interruppi la comunicazione. Quel bagno di realtà riportò un’apparente calma. La voce di Emma risuonava sempre come melodia alle mie orecchie. Mi mancava tanto. Avrei voluto poterla stringere per avere una boccata d’ossigeno. I vestiti umidi iniziavano a infastidirmi oltremodo. La busta mi chiamava a gran voce dal letto, dove era rimasta, ma io non volevo
10
sentire. Mi spogliai e mi infilai nella vasca bollente. I muscoli contratti del collo non volevano sciogliersi. Erano annodati stretti, quasi cuciti insieme. Buttai la testa all’indietro e sott’acqua. Una parte di me voleva smettere di respirare.
11
3. Ci sei sempre stata
Tamponai i capelli bagnati con un asciugamano. Sapeva di ammorbidente e disinfettante insieme. Poi mi strinsi il telo bagno più grande attorno al corpo. Non avendo con me un rassicurante pigiama mi sedetti così sul letto. Presi la busta a me destinata. La annusai. Sapeva di lui. Ricominciai a piangere. Cercai di mantenere la calma chiudendo gli occhi di tanto in tanto. Sentii lo spessore del contenuto. Mi incuriosiva e mi pietrificava allo stesso tempo. Poi radunai tutte le mie energie e la aprii. Dispiegai i fogli e nell’ordine vi erano riposti una lettera, un disegno, una fotografia e un foglio stampato, firmato in calce. Non avevo mai visto la sua calligrafia. Mi faceva uno strano effetto. Non mi ero mai chiesta come univa le lettere, come riempiva il foglio, quanta pressione esercitava sulla pagina con la penna. Così mi sorprese. Aveva un tratto deciso e delicato. Armonioso direi, anche se a volte rigido e spigoloso, specie sulle doppie. Procedetti per ordine, come per rispettare il volere di Wolf. In un’altra circostanza avrei guardato subito le fotografie. La lettera mi paralizzò. Mi si congelarono le vene. C’era lui in ogni sfumatura. E sono certa che spruzzò “Roma” di Laura Biagiotti sulla carta. Lo stesso profumo portato per una vita. Il primo profumo che mi eccitò. Caro amore mio, se riceverai questa lettera è perché tutto è andato come doveva andare. Pensavamo di poter essere noi a decidere, di essere diventati immortali ma non è così. Mio figlio Mark ha messo da parte il suo dolore in nome dell'affetto che prova per me e questa è una delle vittorie di oggi. Ti ha raggiunta. Ha portato la mia voce da te. Potrei scriverti per ore e raccontarti quanto mi sei mancata, quanto ti ho pensata, quante e quante volte ho rivissuto i nostri due giorni
12
insieme. Li ho analizzati, assaporati e rivisti mille e più volte, specie nel dolore e nella sofferenza degli ultimi mesi. Come morfina calmavano il mio tormento. L'unica cura per la mia mente. L'unico calmante all'idea di non poterti più abbracciare, di non sentire il tuo profumo, di non toccarti, guardarti, averti. Scommetto che indossi il tuo soprabito cammello con la cintura legata stretta in vita, i tacchi alti e hai con te occhiali grandi. Non hai tagliato i capelli quest'anno, ti sei però occupata molto di loro per renderli, se possibile, ancora più belli. Ora avrai anche tutta la faccia sporca di rimmel perché i tuoi cosmetici naturali non sono waterproof. Non hai ancora capito che non ti serve il mascara, i tuoi occhi sono i più belli del mondo. E non piangere caro amore mio tu avrai sempre noi. Non me. Noi. Siamo stati legati con un filo invisibile: da quando ci siamo incontrati non ci siamo mai persi. Ci sei sempre stata. Ci sei ora, mentre cerco di salutarti come meriti. Ci sei da sempre. Eri in tutte le donne che guardavo con interesse, eri in mia moglie, eri nei nomi che ho scelto per i miei figli che iniziano per M. Ci sei sempre stata. Quella ragazzina bellissima ha segnato la mia vita, senza saperlo. Sempre presente. In un angolino riservato della mente e del cuore come, un alone vitale, un’aurea intima. Sempre. Fino a quando ti ho rivista. Ancora bellissima. Mi sei esplosa dentro. Non potevo lasciarti andare. Ed è stato tutto perfetto: ogni tuo gesto, espressione, suono, movimento. L'unico incastro possibile con il mio corpo e con la mia anima. Per questo mio figlio è arrabbiato con me. Perché sa che esisti. Non accetta gli eventi e i miei sentimenti e lo posso capire. È accusatorio ma non esistono colpe in questa storia. Tu eri mia prima di essere di qualsiasi altro, io ero tuo prima di conoscere qualsiasi altra. Non c'è nulla da aggiungere. È dannatamente semplice, forse per questo paradossalmente difficile.
13
So che avevamo promesso di non parlarne con nessuno ma questa è l'unica soluzione che ho trovato e, a dire la verità, con Mark volevo proprio essere onesto. Come con me stesso. Voglio che mi ricordi così. Quindi della nostra storia qualcosa sa. So che con il tempo capirà e so che anche vedere e incontrare te lo aiuterà. Avevamo due compiti per oggi. Disegnare un tatuaggio per noi e proporre una canzone solo nostra. Non sono stato alle regole e spero mi perdonerai. A 48 anni e poco da vivere ho fatto il mio primo e unico tatuaggio. Mi ha aiutato Mark a trovare un tatuatore, «Ma bravo eh!» come avevi chiesto tu. Trovi disegno e una mia foto nella busta insieme al testo della canzone che candido. Non so se diventerà la nostra ma continuo ad ascoltarla e visualizzo solo te quindi posso dirti che è… solo per te. Non so come concludere questo fiume di parole. Posso solo dirti che tutti i miei pensieri portano a te. So che non esistono parole per consolarti. Il mio cuore è tuo. Io sono tuo come ci siamo già raccontati e come sai. I love you. Tuo, Wolf Sotto la lettera trovava posto il disegno. Una W o una M. E mi sciolsi in un pianto a dirotto. Non riuscivo a respirare. Annaspavo. Mi sembrava di perdere il contatto con la realtà. Ero scivolata in un incubo mai sognato. Troppo cupo e terrificante perfino per il mio subconscio. Cosa avevo perso se non una parte di me. La mia parte gemella, doppia, speculare e complementare. Quando vidi il disegno, sentii ancor più affondare la lama della disperazione nel mio petto. L’idea era stata la stessa. Il mio prototipo era un po’ più piccolo e arrotondato. La sua iniziale era invece netta geometrica, con una leggera ombra quasi a formare una doppia lettera. Un gioco di lettere, una sopra l’altra: due iniziali. Lui era mio. Aveva ragione. Eravamo noi. E la fotografia che, nell’immaginario, aveva scattato di me era precisa e corretta. Tutto quadrava. La mia proiezione era, invece, tutta sbagliata. Dovevamo essere lì in due. Nell’albergo di un anno prima, nel letto di un anno prima. Come un anno prima. Dovevamo godere delle poche ore che
14
avevamo deciso di concederci, dovevamo essere felici. Dannatamente felici, pazzamente felici. In paradiso. Invece tutto aveva ormai cambiato forma e colore. Tranne noi. Guardai la fotografia. Com’era bello. Irresistibile. Sorrideva in un primo piano, dritto verso l’obiettivo, prendendosi il volto fra le mani e sul polso destro, in vista, la M o la W. Entrambe interpretazioni possibili per noi che c’eravamo vissuti. Passai il disegno con l’indice così come i contorni della fotografia. La mia mente oscillava fra il nero del presente e il roseo passato, sovrapponendo immagini e scene. Dolore e amore, in un chiaroscuro senza senso. Fissai la fotografia tutta la notte, ascoltando Solo per te dei Negramaro, la canzone che avevo sul mio iPod ma che io non avevo eletto a inno della nostra storia.
Solo per te convinco le stelle a disegnare nel cielo infinito qualcosa che somiglia a te solo per te io cambierò pelle per non sentir le stagioni passare senza di te come la neve non sa coprire tutta la città come la notte non faccio rumore se cado è per te come la neve non sa coprire tutta la città come la notte non faccio rumore se cado è per te
15
è per te è per te è per te come la notte non faccio rumore se cado è per te come la notte non faccio rumore se cado è per te come la notte non faccio rumore se cado è per te come la notte non faccio rumore se cado è per te.
Dopotutto i Negramaro lo avevano portato a pochi passi da me. Il 13 luglio, a San Siro. Era lì. Me lo aveva promesso. Avrebbe accompagnato sua figlia Marianna a Milano al loro primo concerto insieme e sarei andata anch’io. Così c’eravamo accordati. E così feci, trascinando la mia amica Denise anche in questa avventura. Tenendo tuttavia nascosto il motivo più vero. Poterlo vedere anche solo per un secondo. Non accadde ma io ero convinta fosse lì. Forse, invece, non aveva vissuto quel momento. Forse era già troppo debole per farlo. Forse era così grande il desiderio di percepirlo vicino a me, dentro me da immaginare tutto il resto. La stampata del testo era firmata in fondo. Accanto, in piccolo, I love Y. Aveva studiato ogni dettaglio. Tanti piccoli riferimenti sotterranei ai nostri pochi momenti insieme. Quando fu giorno, mi abbandonai al cuscino per poche ore. Al risveglio un obiettivo da raggiungere: trovare Wolfang.
16
4. Peonie rosa
La sala colazioni era piccola e riservata. L’anno prima non ci avevo messo piede. Non che avessi voglia di mangiare, ma mi sentivo debole e stanca e dovevo recuperare un po’ di energie per la mia impegnativa missione. Iniziai a pensare a un piano d’azione. Mi serviva una cartina e non l’avevo con me. Avrei chiesto consulenza alla receptionist per avere una mappatura dei cimiteri cittadini. Sarei partita da lì per poi decentrarmi verso le periferie. Avevo già raccolto i capelli in uno chignon, tipico di quando non ho tempo da perdere e, battagliera, intendo schiantarmi verso il mio obiettivo. Mi servivano delle scarpe sportive e dei jeans. Sicuramente avrei camminato per tutto il giorno. Senza sosta, senza tregua. Motivo in più per costringermi a mangiare un cornetto. Stringevo la tazza del tè sperando potesse confortarmi. Invano. Il mio frastuono interiore alterava la mia percezione del mondo intorno a me. Dovevo, in fretta, lavorare anche sulla mia capacità di concentrazione, per non perdere dettagli e informazioni utili. Chiamai all’appello tutte le mie energie. Dovevo farcela. Avevo persino svuotato la borsa in modo inusuale. Il peso mi avrebbe inutilmente affaticata. Con passo sicuro mi diressi verso la receptionist. Formulai la richiesta di avere una cartina dettagliata ed esplicitai i luoghi di mio interesse. Anomali, me ne rendevo conto. Stese sul bancone la mappa cittadina e iniziò a cerchiarli con un tratto leggero, quando si interruppe. I suoi occhi erano puntati dietro di me e prese a parlare in tedesco. La lasciai fare mentre girai la cartina verso di me per poter avere una panoramica più concreta di quanto già segnato. Poi percepii la sua testa riccioluta inclinarsi con un gesto impercettibile verso di me. «Mi scusi signora ma la persona alle sue spalle chiede di lei». Mi voltai con movimenti incerti, rallentati e vidi Mark. Fermo. Immobile davanti a me. «Non sono qui per te. Chiariamoci subito» esordì.
17
Mi voltai di nuovo verso la receptionist, questa volta grintosa e dinamica, la ringraziai per la cortesia dimostratami. Feci scorrere la carta cittadina sul marmo lucente e mi spostai rapida in direzione dei due divani posti a pochi passi di distanza. Mark mi seguì. Fece questo sforzo. Ci sedemmo uno di fianco all’altra senza fiatare, mantenendo una postura rigida e imbarazzata. Poi mi voltai di scatto e lo guardai fisso negli occhi. «Che ci fai qui?». «Voglio tutelare mia madre. Tutto qua». «Tutelare tua madre? Ma cosa dici?». «Oggi è il giorno di chiusura dei ristoranti di famiglia e sicuramente mia mamma andrà al cimitero. Come tutti i mercoledì. Non vorrei mai trovasse te sulla tomba di papà». “Ci manca solo questo”, pensai fra me e me. «Quindi?». «Quindi ti porto io al cimitero. Adesso. Solitamente mia madre si trattiene in casa per un po’ prima di uscire per commissioni varie e per andare da papà». Sentivo della differenza di tono ed espressione quando parlava di sua madre e di suo… papà. Come se avesse voluto difenderli entrambi da me, ma per uno era troppo tardi. Avvolgeva il termine papà in un fazzoletto di dolcezza tutto suo. I nostri sguardi si incrociarono di nuovo. «Va bene, grazie». Non mi rispose. Uscimmo dall’hotel senza parlare. Aveva lo stesso passo di suo padre, la stessa andatura scanzonata, nonostante gli eventi, l’umore, la destinazione. Fra noi due silenzi. Tutt’intorno i rumori della città mi colpivano, ma senza distrarmi da chi condivideva con me il marciapiede. Assomigliava terribilmente al ragazzo che mi aveva rubato il cuore tanti, tanti anni prima. I suoi occhi, i capelli, la struttura fisica e l’inconsapevolezza di essere straordinariamente bello. Giungemmo in un piccolo parcheggio. Una 500L gialla ci sorrise con le quattro frecce. E io che credevo che tutti i tedeschi comprassero solo veicoli di marchi legati alla loro bandiera. Salii. Mise in moto. Il cielo sopra noi era cupo. Le nuvole si gonfiavano e si smontavano in una rincorsa ciclica. Senza sosta. Disfai lo chignon
18
che non mi permetteva di appoggiare la testa al sedile. Le vetrine dei negozi scorrevano al mio fianco. Dal finestrino cercavo di capire la direzione, la distanza, la posizione della nostra destinazione. Ma l’orientamento non è mai stato il mio forte. Non mi restava altro che affidarmi al mio accompagnatore silenzioso. Terribilmente silenzioso. Cercai di rompere il ghiaccio. «Manca tanto?». «No. È qua. Dietro l’angolo». Spinsi lo sguardo più in là per intravedere ciò che volevo. Preparai gli occhiali. Li appoggiai sulla nuca. Avrebbero trattenuto i capelli dal vento che scompigliava anche gli alberi. Parcheggiò vicino all’ingresso laterale. Feci un respiro enorme che anche Mark avvertì perché si girò a guardarmi. Era dal divano dell’albergo che praticamente non mi considerava. Non voleva essere lì. Questo era evidente. Scesi dall’auto. «Ma dove vai?». «A comprare dei fiori». Non mi voltai per paura di vedere un gesto di negazione da parte sua. Io volevo dei fiori. Entrai nel cubo vetrato posto al lato del cimitero. Tutto era in ordine, non una foglia fuori posto. Ordinai ciò che volevo. Uscii rapidamente e lo raggiunsi con passo veloce. Ero felice perché avevo trovato ciò che desideravo. Mi guardò storto ma feci finta di nulla. Entrammo. Percorremmo i sentieri lastricati. Mi sono sempre sembrati dei labirinti i cimiteri. Avvolti nel silenzio sentivo solo il battito nel mio cuore e i nostri passi. Il sole fece capolino fra le nuvole. «Siamo arrivati» mi avvisò, anche se io avevo già visto la sua foto. Aveva scelto quella che aveva destinato anche a me. Mi sorrideva mentre mi avvicinavo a lui. Mark si era tenuto a qualche passo di distanza. Non riuscii a trattenere il pianto. Mi girai e, indicando il vaso portafiori, chiesi: «Posso?» chiudendo la domanda con la voce strozzata. Mark si allontanò per fare una breve telefonata mentre io disposi con cura le mie peonie rosa. Quella sera in albergo, un anno prima, sdraiati sul letto, ci facemmo milioni di domande, semplici e anche più complesse. Fu lì che scoprì che le peonie sono il mio fiore preferito.
19
Mi raccolsi con dedizione e chiusi gli occhi che lacrimavano senza sosta. lo sentii vicino e gli feci una promessa. Poi, all’improvviso sentii: «ScheiBen, oh merda!». Mi voltai. Mark mi affiancò velocissimo. «Non girarti. Non girarti! Sta arrivando mia nonna». Panico. «Adesso mettiti gli occhiali. Dammi la mano e non dire nulla. Se riesci sorridi appena». Poi una signora curva ci raggiunse. I due parlarono fra loro. Cercai di seguire la conversazione ma senza successo. A un certo punto si interruppero. E guardarono entrambi nella mia direzione. La signora allungò la sua mano nodosa verso di me. Sorrisi. C’era tanta tenerezza nel mio sguardo, ma gli occhiali non lo fecero intravedere. Mi disse qualcosa e Mark rispose al posto mio prendendomi la mano. La sua era calda, rassicurante; la mia come al solito fredda e un po’ tremante. Poi salutò sua nonna con un bacio sulla fronte. Io feci un cenno con la mano e un gran sorriso. Sgattaiolammo via con fare furtivo. Era andata bene, tutto sommato. «Cosa ti sei inventato?». «Che sei una mia amica». «Strano posto dove portare gli amici». Sgranai gli occhi per sdrammatizzare ma non funzionò. «Infatti la nonna avrà subito pensato che sei molto speciale per me e adesso non mi darà tregua». Poi aggiunse: «E, peggio ancora, lo dirà a mia madre che è tutta concentrata a vivere le nostre vite». Appena uscimmo mi lasciò la mano. «Contenta?!». Di sicuro era ironica la sua domanda ma non ci badai e rimasi legata al significato letterale per rispondergli. «Beh… io sì, sono contenta. Grazie per avermi accompagnato. Mi dispiace però di averti complicato le cose…». «Io ora devo andare. Puoi prenderti un taxi, ok?» mentre parlava si stava già allontanando da me. «Ok!» risposi. «E se mi vede tua nonna mentre aspetto il taxi che le dico?».
20
Fermò la sua camminata. Alzò in un gesto di nervosismo le braccia per poi abbandonarle di colpo. «Corri che non ho tempo!». Salimmo di corsa in macchina. «Ti lascio a metà strada». Poi squillò il suo telefono ma non rispose. Era un ragazzo in gamba e stavo cercando un modo per dirglielo quando arrestò l’auto. «Buon rientro in Italia, bye bye» mi disse con tono sarcastico. «Grazie» stetti al gioco e risposi a tono. Poi aggiunsi «Mi ricordi tantissimo tuo padre». Mentre parlavo afferrai il portafoglio e presi un mio biglietto da visita. Dietro segnai il numero del mio cellulare. Aprii la portiera e lasciai il biglietto sul sedile. «Nel caso ti serva una comparsa nei teatrini di famiglia!». Stavo per chiudere la portiera quando mi chinai e aggiunsi: «Tuo padre a vent’anni aveva il tuo senso dell’umorismo, un po’ noir, ma soprattutto sapeva ridere. Spero sia così anche per te. Buone cose e grazie!». Chiusi la porta e iniziai a camminare, senza voltarmi. Solo al semaforo, poco più avanti, mentre stavo attraversando la strada, mi accorsi che Mark era ancora là. La macchina non era sfrecciata via a tutta velocità come era facile immaginare. Guardai per un po’ nella sua direzione mentre iniziò a diluviare. Mi riparai in un minimarket etnico per avere indicazione su come tornare in albergo. Ne approfittai per comprare dell’acqua, una scatola di latta con biscotti al burro per Emma e un ombrellino. Quando uscii la macchina non c’era più. Non ero orgogliosa della mia reazione. Avrei preferito salutarlo senza tensioni. Avevo visto tante somiglianze e volevo raccontargliele, ma Mark non perdeva occasione per mantenermi a distanza. Con le parole e con i suoi silenzi. Forse avrei dovuto capirlo di più. Non era semplice la situazione che si era trovato a gestire. Forse. Forse io avrei dovuto aiutarlo di più a capire. Ormai le cose erano andate così.
21
5. Fragile e forte
Tornai in quella camera con una promessa nel cuore. Avevo sentito Wolf di nuovo vicino dopo il grande vuoto della sera prima. Una pace apparente mi investì. Dovevo prepararmi al rientro a casa che sarebbe stato faticoso. Ritornare a una normalità ancor più normale, forse banale, senza segreti, senza sogni. Anzi, avrei dovuto giocare le mie carte e raccontare tutto a Gabriele ma non ero preoccupata: qualsiasi cosa mi attendeva l’avrei vissuta, gestita e affrontata. Mi sentivo fragile e forte allo stesso tempo. Emma, con i suoi abbracci e con i suoi baci, avrebbe curato parte delle mie ferite. Mi svestii e, nuda, mi infilai sotto le coperte. Chiusi gli occhi e mi apparvero subito i suoi, a fissarmi. Li sbarrai di nuovo. Faticavo ancora a credere che davvero non c’era più. Poi il pensiero volò alla signora incontrata la mattina. Sicuramente era sua madre. Stessi occhi. Stesso sguardo e una giocosa complicità con Mark. Provai a immaginare la sua sofferenza. È contro natura perdere un figlio, vederlo spegnersi. Sapere che se ne andrà. Guardarlo soffrire, inerme. Mi spaventai nel misurare il dramma che aveva vissuto. Allungai la mano sul comodino e presi l’iPod. Misi le cuffie e mi feci cullare dalla musica. Mi calmai lentamente per poi sprofondare fra i cuscini. Mi svegliai un po’ confusa. Avevo vissuto le ultime ore davvero senza dominare il tempo e schiacciata dal destino. Riordinai le mie cose con calma. Avevo fatto degli acquisti un paio di giorni prima di partire e li abbandonai in albergo. Avevano perso di significato. Erano diventati inutili. Non aveva senso riportarli con me. Non li avrei mai usati in nessun’altra situazione. Erano per lui e lui non c’era più. La sottoveste di pizzo nero non mi servì. Le candeline profumate non mi servirono. Le mie fantasie non mi servirono. La malinconia mi prendeva all’improvviso e mi divorava. Di tanto in tanto si mischiava alla sensazione di completezza che ancora lui mi
22
dava. E alla certezza che se un’anima può vagare all’infinito come spirito, allora lui era con me. Sarebbe stato in alcuni momenti con me. La mia personalissima idea di Dio mi rassicurò. Domani avrei dovuto ringraziarlo per il sostegno. Forse meglio dopodomani perché nel frattempo la ferita viva si riaprì e ricominciò a sanguinare. Di nuovo.
23
6. Aria di casa
Rientrai a casa. C’erano disegni dappertutto: attaccati ai mobili, sullo specchio dell’anticamera, sulle ante della cucina, sul vetro del camino spento. Per terra un tappeto formato dai cuori che io avevo nascosto per casa prima di partire. Emma li aveva uniti con tanti frammenti di scotch. La casa era vuota. Stranamente silenziosa. Guardai l’orologio. Un quarto d’ora e Denise sarebbe rientrata con Emma. Andai in camera per riporre le décolleté nella scarpiera e infilare tuta e calze antiscivolo. Dovevo prepararmi a un turnover di giochi, vecchi e nuovi, di racconti e rincorse, di baci e sorrisi. Dovevo prepararmi a lei. Mentre stavo accendendo il bollitore, sentii la chiave girare nella serratura. «Mamma? Ci sei?». Non risposi subito per creare un pizzico di suspense. «Eccomi!» e corsi goffamente da lei. La abbracciai così forte che avrei potuto romperla. «Come stai amore mio?». Mi rispose con la fretta dei bambini: «Bene, bene. Vieni a vedere il tappeto che ti ho fatto!». «Wow che bello? Ti ha aiutato la zia Denny?». «No. Papà». Il bollitore ci chiamò. «Tè per tutte?». E in coro, come consuetudine, «Sì!». Sul tavolo avevo posto la scatola di latta per Emma. Adorava le scatole. Ci custodiva le cose più assurde: carte di caramelle, sassolini, pigne, biglietti di compleanno. Tutto rigorosamente archiviato. Scatola nuova, raccolta nuova. Chissà cosa si sarebbe inventata. «Che bella scatola! Che c’è dentro?». «Aprila!». «Biscotti! Quando finiscono posso tenerla?». «È tua».
24
«Mamma allora se è mia posso svuotarla subito? Devo correre a metterle dentro un’altra cosa». Accettai la sua richiesta solo perché volevo stare un po’ sola con Denise. La sentivo fremere. Era ansiosa, agitata. «Ma si può sapere cosa stai combinando?». «È una lunga storia». «Beh vedi di fare in fretta un riassunto esaustivo perché non mi alzo da qui, intesi?». «C’è un altro uomo nella mia vita, o meglio c’era... ecco non agitarti». Sapevo che avrebbe iniziato a gironzolare per casa come una gatta infastidita. «Perché non me lo hai detto? Chi è? Gabriele lo sa?». «Dai siediti che mi fai girare la testa. Non te l’ho detto perché era un segreto». La sentii ringhiare mentre la tensione dentro me saliva vertiginosamente. «È un ragazzo che ho conosciuto più di vent’anni fa e incontrato di nuovo un anno fa. Cioè è un uomo che avevo conosciuto da ragazzina…. Beh, insomma, hai capito e... e ora è morto». Si bloccò. «Eh?». «Sì, Denise, è morto. Avevamo appuntamento a Monaco ma non è arrivato». «Non sarà venuto» disse per alleggerire la situazione. «No è morto! All’appuntamento è venuto suo figlio e… ti spiegherò meglio quando siamo sole» aggiunsi quando vidi tornare Emma in cucina. Nella sua scatola aveva già riposto qualcosa ma l’avrebbe tenuta segreta per un po’. «Quando arriva papà?». «Fra poco Emma, vedrai». A Denise tornò in mente la domanda che era rimasta in sospeso. Lampeggiava come un’insegna neon a caratteri cubitali sulla sua faccia. Così mi voltai verso di lei e le dissi: «Sa qualcosa ma in realtà non sa nulla». In effetti non sapevo proprio rispondere a quella domanda meglio di così. Gli avevo scritto un biglietto confuso prima di partire. La telefonata non era stata chiarificatrice. Ma mio marito e io avevamo dei tempi tutti nostri. Il nostro rapporto aveva subito degli scossoni lungo la
25
strada percorsa insieme. Il risultato più bello era sicuramente nostra figlia. E per questo avrei dovuto ringraziarlo per sempre. Poi avvertimmo tutte e tre il doppio clacson risuonare nel vialetto di casa. E sapevamo per certo cosa volesse dire: Gabriele stava rientrando. «Papà è tornato! È tornata anche la mamma! Evviva!» gridò Emma ad alta voce. Pian piano si avvicinò a Denise e le sussurrò: «E stasera mi butto in mezzo nel lettone e dormo lì!». Ne seguì una risatina sottile. Denise, nel mentre, radunò di fretta tutte le sue cose per scappare a gran velocità. «Denise grazie per la tua disponibilità. Grazie per essere stata con Emma. Grazie per l’aiuto che sempre mi dai!». «Sai che per me Emma è come una figlia. Vuoi che la porti a dormire da me?». «No, grazie. Stasera è importante stare tutti insieme. Per lei ma anche per noi tutti» conclusi e me la strinsi in un abbraccio. Uno dei nostri. Uno di quelli che arrivano al cuore, che sanno di fiducia, complicità, amore. Delle braccia così, con delle sensazioni così, sono difficili da trovare. Abbracci così sono alimentati dalla vita insieme, una sempre al fianco dell’altra, dall’adolescenza in poi. Si aprì la porta dietro noi. «Ciao Gab, io scappo devo ancora andare a fare la spesa. Ciao Emma» gridò e poi aggiunse piano, guardando me, «Ciao, ci sentiamo domani» e si defilò nella penombra. «Ciao Marta». «Ciao». Emma ci guardava a distanza. «Tu corri qui a baciare il tuo papà preferito!» e aprì le braccia per accoglierla. Sapevo che non ne avremmo parlato subito, anzi avremmo toccato o analizzato l’argomento solo quando Emma avrebbe deciso di farsi rapire dal sonno. Era bello respirare aria di casa. Non credevo mi avrebbe fatto quell’effetto. Mi sentivo quasi salva nel mio limbo domestico. Come un cavaliere ferito nelle mura del suo castello. «Sei stata da tua sorella?». «Non ancora».
26
«Vai che ti aspetta, lo sai». «Non stasera. Passerò da lei domani pomeriggio». «Guarda che devi solo attraversare il vialetto, ti ricordi?». Il tono si faceva aspro e provocatorio. «Domani pomeriggio». Fui categorica e ferma. Non poteva capire la mia resistenza. Per Gabriele mia sorella era un altro disabile da accudire, far giocare, cambiare, pulire, rendere felice, divertire. Per me era mia sorella. Con tutto quello che ne comporta. «Mamma cosa si mangia stasera? Cuciniamo insieme?». Emma adorava cucinare. Era il suo gioco e la sua attività preferita, da proporre sempre, con tutti. «Certo amore. Apriamo il frigo e…» attesi la conclusione del nostro motto culinario che, difatti, non tardò. «Cuciniamoooo!» e si infilò euforica in cucina. A dire la verità tutte e due amavamo stare ai fornelli e spadellare insieme era molto divertente. «Pasta al pesto mamma! Ricetta tradizionale però». «Va bene Emma. Dimmi cosa devo preparare sul tavolo». «Allora: pasta, fagiolini, patate, sale». Guardò gli ingredienti schierati sul tavolo e, chinando il capo verso destra, esclamò «e il pesto mamma!». La cena fu servita con il contorno speciale dei racconti di Emma. La scuola materna, da grande, era ricca di responsabilità e impegni. I bambini appena inseriti le sembravano piccoli e indifesi. Aveva un grande senso della cura e dell’accudimento. Come suo padre. Forse anche come me, nonostante non ne avessi fatto una ragione di vita, una missione o un lavoro. Gabriele e io c’eravamo conosciuti nel centro diurno disabili che frequentava Alessandra in occasione della festa di Natale. Panettone e bollicine per tutti. All’epoca non capivo cosa ci fosse da festeggiare in un posto così anche se tutti, in quel momento, sembravano felici. Tutti gli utenti tranne mia sorella. Tutti i parenti tranne me. Alessandra non faceva cenni, non emetteva suoni, non si agitava sulla sua carrozzina. In quell’occasione chiesi espressamente a mia madre di non portarla più. Lì, in quella dimensione era irriconoscibile. Non era lei. Come al solito non mi ascoltò. Quando si trattava di Alessandra non ascoltava mai
27
nessuno. Come se lei sola sapesse davvero cosa era giusto per sua figlia, cosa pensava, cosa sentiva. Come se Alessandra fosse ancora legata a lei da un cordone ombelicale diventato un cappio per entrambe. «Mamma mi metti il pigiama?». «Certo Tesoro. Va bene quello a fiorellini?». «Sì! Stasera posso addormentarmi con te?». «Va bene, corri a lavare i denti». Ci infilammo sotto le coperte, incastrate in un dolce abbraccio. Mi piaceva annusarle il collo. Sapeva ancora di bimba. Con il naso le sfioravo la pelle, con tocchi delicati. Le sussurravo la stessa frase tutte le sere: «Sei la mia preferita nel mondo, lo sai?». Lei, a occhi chiusi, faceva un cenno affermativo con il capo e si abbandonava completamente a me. Poi mi trattenni un po’ a guardarla. Mi sembrava un angelo. Le ciglia lunghe, il naso come un puntino e i capelli sottili che disegnavano nuvole sul cuscino. Emma era in assoluto la persona più importante della mia vita. Solo una madre può capire una madre. Non basta essere donne. Non basta vedere nascere una vita. Mi apparve alla mente la madre di Wolf. I brividi si impossessarono di me. Anche lei sicuramente aveva osservato suo figlio, bambino, mentre aveva gli occhi chiusi nel sonno. Come Emma, ora. Per poi rivederlo, quarant’anni dopo, con gli occhi sbarrati, per sempre. Una sofferenza insostenibile. Contro natura. Gabriele ci raggiunse in camera. Lo guardai e gli feci un cenno, indicando la porta. Mi sfilai dal letto con attenzione. Emma era crollata fra le braccia della notte. Le augurai sogni d’oro con la mente e con il cuore. La camera da letto era collegata con un piccolo corridoio alla zona giorno. Lasciai la porta aperta nel caso Emma chiamasse. La cucina era separata dal salotto. Era un cubo di vetro collegato al resto della casa. «Ci sediamo nell’acquario, ti va? Così preparo una camomilla. Ne vuoi anche tu?». Il termine “acquario” lo coniammo ancor prima di vederlo, già dal progetto che Sergio, il marito di Denise, ci fece, dodici anni prima. Emma faceva ridere tutti quando diceva, con serenità, che noi mangiamo in un acquario.
28
«Va bene. Una tazza anche per me». Stringeva fra le mani il biglietto che gli avevo scritto prima di partire. Mi spiace non avertene parlato. Ti dico sempre tutto ma questa volta proprio non posso, sono legata a una promessa. Starò via due giorni. Ho avvisato Denise. Andrà lei a prendere Emma. Voglio vivere un sogno. Senza colpe, senza rimpianti. Non so se potrai capire, so che potrai perdonare. Marta Il bollitore prese a fischiare, quasi a reclamare una conversazione che tardava a iniziare. «Lui chi è?». «Senti Gab è una storia difficile da spiegare». Vidi la sua faccia diventare scura, cupa. «Non voglio ferirti. Non è stata una ripicca, davvero». «Senti adesso stiamo parlando di questa storia, non di altro. Cerca di stare sul pezzo. Chi è!?». Si era irrigidito e, come era facile prevedere, feci uscire dalla mia bocca una frase fra il sarcastico e il provocatorio, giocando in difesa: «Non è un tuo amico di calcetto se è questo che ti preoccupa!». «Marta!» esclamò come per ammonirmi. «Ho conosciuto questa persona vent’anni fa. L’ho incontrata per puro caso un anno fa. Non l’ho più rivista e non la rivedrò mai più». Mi si velarono gli occhi quando misi l’accento sul “più”. «Che convinzione!». «Direi, visto che è morto. E per stasera non aggiungerei altro, se sei d’accordo. Magari la camomilla la bevo più tardi, notte» e mi alzai pronta a scappare. «Ci sei andata a letto?». «Un anno fa. E adesso che lo sai? Pensi che abbiamo pareggiato i conti? Ti senti sollevato? Non fare paragoni, Gab, non fare paragoni perché non sai di cosa sto parlando». «Spiegami Miss perfezione, spiegami, ti ascolto». Non parlai. «Resta il fatto che ci sei andata a letto. E allora forse così perfetta non sei!».
29
«Guarda che lo dici tu che sono perfetta, io non ho mai aspirato al titolo. So di non esserlo. Ma non per questa storia che, credimi, non c’entra nulla con noi». «Eh, certo, sei solo mia moglie!». «Vedo che adesso te lo ricordi! Non te lo ricordavi quando aspettavo Emma eh?». Imboccai il corridoio. Mi bruciava ancora quella storia. Non so se per l’affetto che comunque provavo per Gab o se per la delusione di quella triste scoperta che mi aveva messo in ginocchio. Una bambina piccola piccola da imparare a conoscere, gestire, difendere e una delusione grande grande che non riuscivo a comprendere, che aveva minato tutte le mie certezze, e un uomo che non riuscivo a perdonare, a gestire, ad affrontare. Rientrai presto al lavoro per cercare di recintare i miei pensieri. Gab prese il congedo di paternità. Questo fu uno dei punti fermi per cercare di risanare un rapporto che non sapevo neanche più definire. Tanto nel mondo delle cooperative, del sociale, del no profit tutto è normale. Anche un uomo che svezza la propria figlia, che si destreggia con pappe e pannolini. Tornassi indietro non lo rifarei. Quanti momenti mi sono persa con Emma.
30
7. I ricordi non muoiono
Il giorno dopo mi svegliai di buon’ora. La nottata era stata perlopiù insonne. Avevamo riesumato ancora gli spettri di famiglia che aleggiavano sopra di me come corvi affamati. La ragazza che si scopava mio marito sapeva che era sposato, che sarebbe diventato padre e non se ne era curata. Malgrado la sua fresca laurea in scienze dell’educazione. Chissà se aveva mai frequentato un seminario sulla famiglia. Chissà se lei è riuscita a lavarsi la coscienza. Chissà se aveva una coscienza. Gab dalla sua non era da meno. Si rese conto troppo tardi che il gioco lo aveva travolto. Non riuscì a fermarsi. Non riuscì a salvarci. Arrivata in farmacia mi abbottonai il camice e mi posizionai nella mia area di pertinenza. Cosmesi naturale e farmaci omeopatici. Una scelta di vita. Come tante altre. Quella mattina Monza mi sembrava incantata. Una leggera nebbia accompagnava i miei passi per le vie del centro. Il sole tentava di trafiggere la foschia e faceva sembrare tutto surreale. Le mie colleghe mi aggiornarono sulle novità dei rappresentanti e sulle variazioni di prezzo di alcuni articoli. Finsi interesse, come sempre. La parte del lavoro che mi interessava maggiormente erano i prodotti galenici, sempre meno richiesti in un mondo dove non si ha tempo di aspettare o di ritornare. Basta uno spot pubblicitario per credere ai miracoli della scienza. Io, invece, ho sempre creduto alla ricerca nella storia, al potere delle piante, all’equilibrio fra uomo e natura. Forse poteva sembrare che credessi ancora alle favole ma non mi importava. Forse mi faceva sembrare agli occhi dei più una moderna strega e, di questo, mi importava ancora meno. Sapevo che Alessandra mi stava aspettando ed ero ancora indecisa su cosa dirle. Avrei cercato di capire com’era il clima prima di agire. Gli equilibri fra mia madre e mia sorella erano davvero fragilissimi e
31
spesso venivano a me attribuite responsabilità sulle loro reazioni. Specie su quelle di Alessandra. Era così da sempre. “Non vedi come si agita tua sorella, cosa le hai detto? – perché non dici niente a tua sorella? – non stare così addosso a tua sorella! – perché non tocchi mai tua sorella? – perché non esci con tua sorella? Stai attenta che si fa male tua sorella!”. Un’infinità di esempi, dove io implicitamente o esplicitamente sbagliavo, non capivo, giudicavo, non ero adeguata. Il via vai dei clienti riempiva la mia giornata di domande, consigli, sguardi perplessi e, qualche volta, richieste imbarazzate che facevano pensare a un siparietto piccante. Sbottonai il camice e lo appesi con cura. Lo scenario all’esterno della farmacia era completamente cambiato. Le luci del corso principale avevano preso il sopravvento. Il tragitto in macchina mi mostrava le case in lontananza come fossero un presepe. Parcheggiai nel vialetto. Gab era già a casa con Emma, secondo i turni della comunità. Raggiunsi la porta di casa dei miei genitori e di Alessandra. Gab e io avevamo costruito una dependance nel giardino dei miei. Le risorse economiche a disposizione quando avevamo deciso di sposarci erano davvero esigue. Così decidemmo di accettare l’offerta ricevuta. Questa scelta, però, continuava a farmi sentire ospite in casa di altri, nonostante il mutuo, nonostante il supporto che comunque potevo dare ai miei genitori stanchi e consumati. Doppio toc toc alla porta e aprii. «Ciao sono io». Sentii mia sorella ruggire dalla sua stanza. «Marta non potevi venire ieri? Alessandra ti aspettava ed era agitata. Sentila. Ti costava tanto?». «Ciao mamma. Ciao» sottolineai il saluto per farle capire che mi era mancato il suo. «Ieri ero troppo incasinata. Ho anche una vita mia, ti sei accorta?». «Sì, sì... non ti posso dire niente, come al solito». «Dai mamma non ti lamentare. Arrivo Ale» le urlai per farla calmare. Percorsi il corridoio per raggiungerla. Chiusi la porta dietro di me. Sapevo che mi aspettava un monologo. Lei avrebbe però partecipato con gli occhi. E con il cuore. Era già sdraiata a letto con la TV accesa. Si calmò. Era in attesa. Attenta.
32
«Ale ci sei? Come va?». Agitò la mano come per dirmi “Salta i preamboli e arriva al sodo”. «Prima di partire ti avevo confidato il mio segreto». Agitò la mano per confermare. «Ti avevo detto che avrei raggiunto Wolf a Monaco». Iniziò a sbavare. Un rigagnolo sottile al lato della bocca aperta. Lo faceva sempre quando era emozionata. «Ecco, ci sono andata, ma non l’ho visto. Ti starai chiedendo perché. Vedi è un po’ complicato. Anzi a dire la verità è molto semplice. Ale sei sicura che vuoi sapere cos’è successo?». Agitò la mano e mi guardò fissa negli occhi come a implorarmi di raccontarle tutto. Io non volevo turbarla troppo ma sapevo che non avrebbe creduto a una bugia. Sapeva leggere molto bene le persone. Erano gli altri che non riuscivano a capire lei. «È morto. Ho conosciuto suo figlio Mark che è uguale a lui. Ti ricordi come era bello vero? Ti ricordi come ridevi quando ci vedevi insieme? E urlavi come una matta quando passavamo sul bagnasciuga per andare a fare il bagno!». Si agitò di nuovo e una lacrima raggiunse il rigagnolo vicino alla bocca, gonfiandolo un po’. «Ale non fare troppo rumore, altrimenti la mamma non riesce a stare lontana». Si sforzò di contenersi mordendo il piumino. «Se ne è andato Alessandra. Mi sento così sola». Sapevo che lei poteva capirmi. «Però Alessandra, l’anno scorso è stato tutto bellissimo e questo non cambierà». Lo dissi per consolarmi e per consolarla. Sapevo che era in pena per me. «I ricordi non muoiono. Mi fanno compagnia. Ci fanno compagnia». Per sdrammatizzare le sussurrai nell’orecchio: «E ricordati: aveva il culo più bello d’Europa, come vent’anni fa!». L’ombra sul suo viso scomparve e rise, a modo suo. La salutai con un bacio sulla fronte. «Notte Tata». Era tanto che non la chiamavo così. Mi fece un cenno di congedo e si girò, di nuovo, verso la TV. «Mamma io vado!». «Insomma sei sempre di corsa, non ti fermi mai». «Mamma e tu non sei mai contenta». Diedi un bacio in fronte anche a lei. Papà dormiva già sul divano. Le strizzai anche una chiappa per strapparle un sorriso. Con quella mossa ci riuscivo sempre. Uscii e la luce accesa dell’acquario mi guidò a casa. Fine anteprima.Continua...