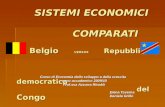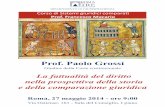Sistemi Giuridici Comparati
-
Upload
antonio-comentale -
Category
Documents
-
view
217 -
download
3
description
Transcript of Sistemi Giuridici Comparati

SISTEMI GIURIDICI COMPARATIGAMBARO-SACCOProf.ssa Autorino-Prof.Sica
I CAPITOLOLA COMPARAZIONE GIURIDICA
Oggetto della comparazione
Le soluzioni giuridiche variano da un luogo ad un altro proprio perchè le regole giuridiche non sono identiche ovunque. Solo con il XX secolo si è riconosciuto che i vari sistemi positivi sono essenzialmente diversi, ma allo stesso tempo pienamente legittimi. Allora è sorto l’interesse a misurarne le affinità e le divergenze. In un primo tempo la comparazione considerò come proprio scopo quello di ricavare dalle istituzioni una base comune, ma questa visione è da respingere perché la comparazione deve stabilire in quale misura le regole coincidono e in quale differiscono.
La comparazione nella formazione del giurista
Il primo pericolo è il rischio di un insegnamento troppo positivo e territoriale, poco aperto alla problematica. L’insegnamento valido è proprio quello problematico, che insegni non tanto una soluzione quanto un modo di ragionare. Lo studio della comparazione offre al discente uno strumento epistemologico perché lo aiuta a scoprire le discontinuità fra regola e definizione, enunciato e applicazione; in secondo luogo permette di affrontare con competenza la ricerca del modello giuridico migliore. Ma mentre il filosofo dà al giurista il modello migliore, il comparatista offre il modello completo. La prima fase di comparazione si fa coincidere con il 900 con la nascita delle prime cattedre di diritto comparato in Inghilterra e Francia, dove i comparatisti cercano non il diritto naturale e ideale, ma il diritto vigente nell’ambito dei singoli istituti nei vari ordinamenti. Perché un istituto fa parte di un sistema, e non lo si può conoscere se non si fa riferimento al sistema in cui esso è inserito
Il metodo: varietà dei formanti dell’ordinamento.
Il comparatista non formula interpretazioni sue, proprie, perché se coesistono più interpretazioni egli non deve rifiutarne nessuna, poiché tutte costituiscono dati veri e reali. Al comparatista interessa tanto la formulazione legale quanto la regola estratta e formulata dagli interpreti. Obiettivo del comparatista è quello di cercare nel modello di riferimento un meccanismo perfetto in altri ordinamenti (es. il trust-negozio giuridico art.2645 ter.VI Libr.cod.civile). Il comparatista si deve limitare ad affermare le contraddittorietà fra i diversi formanti senza valutare soggettivamente: così facendo si limitano le comparazioni come “avvicinamento” dei sistemi. Un’altra via possibile era quella che il confronto, la comparazione poteva avvenire non solo come “avvicinamento” dei sistemi, ma anche come contrasto. Un’altra via è quella secondo cui (prima con la CEE e poi con l’UE), dall’obiettivo dell’unificazione del diritto si passa all’ “armonizzazione” del dirittoI civilisti erano particolarmente legati al dogma (contratto,famiglia, ecc..) , ed avevano una visione assolutistica del diritto. Con i formanti invece cade l’idea della perfezione immutabile delle categorie giuridiche, rendendole relative. Per il giurista di un paese non vi può essere contrasto tra l’interprete e il legislatore: è questo il principio della non contraddizione dei formanti. Per il privatista invece questo non accade perché dottrina e giurisprudenza possono differire. La norma può non essere conforme all’idea di un determinato gruppo, o della maggioranza (come sull’adozione, fecondazione assistita). La contraddizione dei formanti non si può inquadrare nelle vecchie regole, ma si individua leggendo e ponendo a confronto due sistemi contrapposti. Il

principio del “verum ipsum factum” porta ad una neutralità del comparatista, perché la storia ha una sua verità, che deve essere necessariamente una verità oggettiva. La comparazione non può essere sleale o errata, perché gli schemi precostituiti offrono una visione distorta della realtà (questa è la funzione del “ verum ipsum factum”)Quindi in un preciso sistema egli distinguerà una norma legale e una non legale: l’una e l’altra appartengono ad un solo ordinamento giuridico, ma fanno parte di due insiemi distinti, e ognuno di questi insiemi costituisce un formante dell’ordinamento. I sistemi giuridici moderni hanno un gran numero di formanti: legali (uno a livello costituzionale, altri a livello di norma ordinaria, legale, regolamentare ecc..), alcuni formanti giudiziari, alcuni formanti dottorali. Quindi la comparazione consente di misurare le distanze che intercorrono fra un formante e l’altro e se il sistema in esame è più compatto o più diffuso.
I singoli formanti
In un sistema giuridico moderno si distingue un formante legislativo, un formante dottrinale (o dottorale) e un formante giurisprudenziale; ma ci sono distinzioni ulteriori. Nella sentenza infatti, si può distinguere la regola effettivamente praticata dal giudice e la regola di diritto (massima) che il giudice enuncia per motivare la sua decisione. Ad esempio, la frase “chi detiene e intende essere usufruttuario è possessore” è preceduta, logicamente, dalla proposizione “l’usufrutto è un diritto reale”. Quest’ultima proposizione è una argomentazione, e cioè un formante dell’ordinamento. Nell’ordinamento poi troviamo dichiarazioni non precettive cioè declamazioni (es. l’affermazione che il dovere di difendere la patria è sacro). Un formante importantissimo è la legittimazione: mentre la norma giuridica è un precetto, la legittimazione che la sostiene è una teoria, una verità. Ovviamente i vari formanti di un ordinamento tendono ad influenzarsi.E’ una regola il criterio in base al quale il giudice decide, mentre è una definizione la massima enunciata dal giudice. Le contraddizioni fra regole ed enunciazioni si colmano ricorrendo a finzioni, presunzioni assolute e definizioni accomodanti, per affermare l’identità di due fatti disomologhi (la nozione “dichiarazione tacita” implica l’equazione silenzio = dichiarazione) .
I crittotipi
Alcuni formanti del diritto nascono già verbalizzati, cioè mediante parole, come la definizione dottorale; ma altri non vengono espressi. Proprio questi modelli impliciti sono i crittòttipi. Dato che attraverso la comparazione ci si rende conto che leggi identiche in vigore in due aree diverse danno luogo a soluzioni applicative diverse , oppure quando soluzioni applicative identiche sono prodotte da leggi diverse, allora si deve concludere che oltre alla legge vi è un ulteriore criterio di decisione non verbalizzato che influisce sulla soluzione, ovvero il crittotipo. E’ una formula vana e astratta, un meccanismo complesso più facilmente spiegabile con esempi pratici: ad esempio nell’istituto della separazione per divorzio in Francia, da una prima regola per cui erano riconosciuti sia all’uno che all’altro coniuge l’istituto della colpa, lo schema colpa-sanzione cade, ed è proprio qui che emerge il crittotipo, una regola emersa ed effettivamente applicata in modo differente dalla disciplina scritta, e ciò è accaduto anche in Italia con la riforma del 1975. Il crittotipo è un meccanismo che offre gli indizi necessari per capire come cambiano e si evolvono gli ordinamenti giuridici. La scoperta di un crittotipo sarà facilitata quando una nozione implicita in un sistema è esplicita in un altro.Altro esempio di crittotipo è la dignità intesa come libertà di scelte individuali che può portare alla creazione di un modello “eccellente” (esempi tipici – caso Indiana contro Ward: imputato con disabilità mentale a cui viene concessa difesa autonoma, quindi dignità libertà di sceltaautodeterminazione); la maggioranza però non ammette all’imputato di autodeterminarsi e quindi si ha la percezione che in America arriva il modello europeoprotezione multilevel dei diritti fondamentali.

I problemi di lingua
A volte un sistema utilizza nozioni e parole che non avendo riscontro nel diritto di un paese diverso, non lo hanno nemmeno nei concetti noti ai giuristi di questo paese. Ad esempio categorie proprie del diritto inglese e americano (equit, estoppel) non hanno un corrispondente nel diritto europeo e continentale. Quindi bisognerà tenere presente che il vocabolo giuridico appartiene contemporaneamente sia ad un sistema linguistico sia ad un sistema giuridico che si esprime con parole sue (ad esempio il termine detenzione così come appare in Francia e in Italia non compare nel diritto svizzero che usa il termine possession).
La traduzione
Le differenze fra le norme giuridiche dei diversi sistemi creano delle difficoltà di traduzione. Con la traduttologia, dal confronto di significati si passa al confronto dei concetti. La parola francese “contrat” fa pensare alla parola inglese “contract”, però in Inghilterra non si chiamano contracts gli accordi di tipo liberale (cioè le donazioni), dunque i due concetti non corrispondono. Altre difficoltà di traduzione possono derivare da figure retoriche come la sineddoche (es. “incontro di volontà” per dire incontro di due dichiarazioni e due volontà). Inoltre in un sistema due parole possono avere diversi livelli di interpretazione, ovvero una generica e una elastica (es. il fatto illecito può definirsi genericamente, come un comportamento antigiuridico, o ricondurre elasticamente alla colpevolezza, al nesso causale e al danno). Si parla in tal caso di un genotipo (definizione meno puntuale) e di un fenotipo (definizione più circostanziata).Il giurista del rinascimento si esprimeva in latino, ma quando si formarono le lingue giuridiche francese, tedesche, italiane ecc.., ognuna di queste versioni assegnò a vocaboli scelti il compito di tradurre le corrispondenti espressioni latine, assicurando così l’omogeneità dei termini. Ma a volte il comparatista traduttore non può tradurre dei concetti (come estoppel) .
Famiglie di sistemi
Fra diversi sistemi possono esistere differenze superficiali, come accade in sistemi affini quali quello francese e quello belga post-indipendenza, e differenze profonde come tra il diritto cinese e quello norvegese che non hanno grandi punti in comune. Le differenze più profonde sono quelle che possono scomparire solo nei lunghi periodi, perché inglobano la mentalità e i procedimenti logici dell’interprete. Esse riflettono spesso regole non scritte, osservate spontaneamente dagli interpreti, come quelle crittotipiche che sono presenti nello spirito dell’interprete in modo inconsapevole. Per cui egli è nell’impossibilità di vagliarle criticamente.
La sistemologia
Se il comparatista redige un inventario dei dati saldi di un sistema, fa un vero e proprio ritratto dei connotati propri dell’ordinamento preso in esame. La sistemologia è appunto la disciplina che si occupa della raccolta dei dati utili a comparare, a prendere ora la tendenza a ragionare in base a regole giuridiche di dettaglio, ora lo stile delle leggi ora la qualità della produzione letteraria, ovvero di elementi che si ricollegano spesso con la storia del diritto del paese preso in esame.
Le famiglie di sistemi e i raggruppamenti proposti da R.David
Il comparatista raggruppa gli ordinamenti secondo le loro rassomiglianze. Una prima schedatura proposta da R. David , adottata negli anni sessanta, ha contrapposto i sistemi romano-germanici ai sistemi socialisti, a quelli di common law inglese, a quelli musulmani, indiani e cinesi. La famiglia romano-germanica involge i sistemi che si sono sviluppati nel continente europeo dal XIII secolo ad

oggi: questi ad oggi sono sistemi codificati, ed importante è il fatto che i giuristi dell’area si sono formati in università con insegnamenti di diritto giustinianeo e diritto canonico. I sistemi così formati ebbero imitatori verso l’Est, l’Asia, l’America latina e l’Africa. I sistemi socialisti invece incominciarono ad esistere con lo strapotere di Lenin che diffuse l’esperienza socialista fino alla Cina, Vietnam , Cuba. L’Inghilterra è la culla di una terza grande famiglia dove i re normanni insediarono corti regie che dovevano giudicare secondo il common-law, ovvero un diritto che si supponeva essere comune a tutto il regno, da radicare in via consuetudinaria: per cui il giurista inglese si formava a contatto con la pratica del common-law e non sul diritto romano. Questo diritto si diffuse negli Stati Uniti, Canada, India, Australia, Nuova Zelanda e molti paesi africani. Oltre ai paesi che adottano queste grandi famiglie di sistemi, R. David evidenzia altre soluzioni adottate da altri paesi come la Sari’a islamica, i sistemi asiatici (indiano, cinese e giapponese) e quelli africani. Alcuni ordinamenti invece sono stati classificati come misti, perché presentano elementi romanistici e altri di tipo anglo americano (Scozia, Quebec, Sud Africa e Israele).Però la ripartizione di David ha ricevuto varie critiche: alcuni comparatisti hanno negato validità alla sua sistemazione fuori dall’area del diritto privato, altri hanno rivendicato un posto a parte alla famiglia latino-americana, altri la contestano per il suo carattere eurocentrico, troppo incentrato sull’Europa e l’America, residuando in un capitolo a parte della sua opera gli ordinamenti extra-europei. David inoltre insiste sulla dicotomia tra sistemi di common law e sistemi romanisti, una divergenza che ormai riguarda soltanto l’apparato concettuale e didattico che non il contenuto delle norme.
I problemi posti dalla classificazione
Per raggruppare i sistemi è necessario classificarli, e per far ciò bisogna necessariamente guardare alla storia, alla politica, al grado di importanza che assumono le varie fonti in ogni paese. L’opera di classificazione è molto delicata in quanto i sistemi giuridici sono in continua evoluzione. Molti sistemi infatti accolgono nel loro interno una molteplicità di modelli che si spartiscono strati sociali del paese o i vari settori del diritto o i vari formanti dell’ordinamento. Nessun sistema è pienamente fedele ad un unico modello (nel diritto comune, il modello giustinianeo era diverso da quello canonistico, così come nel diritto inglese il modello common law è diverso dal modello equity. Il sistema è qualcosa di reale (perché ad esempio nel Nord America si usa una stessa definizione di istituto) e storicamente presente, variabile e concreto, mentre il modello è qualcosa di astratto che è difficile da intuire (il modello francese è tale, ad esempio, perché ci si riconduce a qualcosa di astratto che gli fa acquisire importanza, offrendo qualcosa).
CAPITOLO IILA DIVERSITA’ E L’UNIFORMITA’ DEL DIRITTO
Esistono differenze tra un sistema e l’altro in quanto esiste la variazione, madre della diversità. E’ per questo che esistono contrapposizioni notevoli nei caratteri dei diversi modelli.
1. Diritto con, o senza, il legislatoreQuesta prima distinzione riguarda la presenza o l’assenza nell’ordinamento, di organi o di autorità dotate di una competenza legislativa generale (Parlamento e Autorità costituente) che crea qualsiasi norma giuridica. Ma prima del 18° secolo si supponeva che la produzione del diritto fosse compito riservato a Dio, oppure svolto mediante una spontanea condotta ad una regola non scritta (es.

consuetudinaria). Queste soluzioni si ritrovano rispettivamente nel pensiero islamico (ma non nella prassi) e in quello africano.
2. Diritto con o senza, il giuristaNei sistemi in cui manca il giurista, manca anche una terminologia giuridica specialistica, concetti nitidi e rigorosi. Il giurista esiste per la prima volta nell’antica Roma, e prima di allora non esiste dottrina giuridica, per cui l’elaborazione scientifica ha avuto il merito di adottare la nozione unitaria di diritto: ius.
3. Diritto con o senza, lo statoIl comparatista deve sapere che lo stato nasce non prima del 3500 a.C. (Egitto, Mesopotamia, India e Cina), e prima di allora mancava anche un’autorità centralizzata. Oggi esistono anche delle società in cui le strutture statuali non sono operanti. Si distinguono società a “potere centralizzato” e società a “potere diffuso”, dove le prime corrispondono alla regola, e le seconde all’eccezione. Inoltre in alcune aree geografiche il diritto fa a meno dello Stato (America, Australia, Africa e Asia) in quanto è un diritto a carattere tradizionale, praticato da autoctoni all’insaputa dello Stato, o con la piena approvazione dello Stato. In Cina e Giappone, la regolazione dei conflitti a carattere privatistico si svolge in larga misura senza l’intervento dello Stato.
Diritto e soprannaturale
L’imperatore veniva legittimato, con l’incoronazione, dal potere spirituale. Il soprannaturale può immettersi nella sfera del diritto condizionando le fonti o legittimandole, o attraverso formulazioni verbalizzate rivelate da Dio, o attraverso norme manifestate dalla pratica dei credenti, quindi ispirata dalla fede.
Il Pluralismo giuridico
Quando una comunità meno avanzata tecnologicamente, e sfornita di potere politico, si trova immersa in una società dominata da un’ etnia più avanzata, sorgono dei problemi. Ciò è avvenuto con le colonizzazioni degli europei in America, Oceania, Asia e Africa. Questi eventi hanno lasciato due diversi esiti:
1. Alcune minoranze autoctone sono circondate da una maggioranza legata alla tradizione giuridica occidentale.
2. Dopo la decolonizzazione, gli autoctoni costituiscono la totalità (o la maggioranza) della popolazione del paese, ma molti di essi non vogliono rigettare i modelli occidentali conosciuti nei contatti con le culture europee o americane.
Nel primo caso si parla allora di un diritto “sommerso” , e la soluzione del pluralismo giuridico può avere un riconoscimento. L’etnia dominante riserva esplicitamente alla minoranza la possibilità di praticare la propria regola giuridica (Canada, Oceania e Groenlandia). Nel secondo caso invece sono possibili accostamenti di un modello di tipo europeo e un modello di tipo autoctono. La libertà del diritto autoctono può essere garantita dalla presenza di corti di diritto tradizionale.
La mutazione giuridica: Il soggetto della mutazione
Il diritto muta da sempre, e il giurista si serve dell’evoluzione per spiegare il divenire giuridico. Innanzitutto la mutazione colpisce uno dei formanti dell’ordinamento per poi diffondersi sugli altri (ad esempio per via di immediata imitazione). Infatti il diritto italiano dal 1865 al 1930, era derivato da modelli francesi, ma la dottrina giuridica italiana dal 1900 in poi era influenzata dalla scienza tedesca ( di qui la presenza delle parole negozio giuridico e fattispecie nel linguaggio giuridico italiano).

Le cause della innovazione
La causa di un mutamento può consistere in certi casi in un fenomeno appartenente al mondo del diritto (una norma vecchia ha assunto un carattere anomalo rispetto al sistema, e perciò viene abrogata o disapplicata) oppure può consistere in un dato extra-giuridico (come l’affermazione di un nuovo indirizzo politico o di una nuova religione. Alla base delle mutazioni giuridiche ci sono fattori economici, strutture sociali e evoluzione della lingua. La rivoluzione economica non impone il rifacimento integrale del diritto: ad esempio l’era della schiavitù si chiude escludendo la persona umana dalla cerchia delle cose che possono formare oggetto di proprietà. In qualche caso l’innovazione opera grazie ad una tendenza all’analogia.
L’uniformazione giuridica
L’evoluzione non è l’unica causa della mutazione del diritto, perché le forme culturali (religione, lingua, diritto) possono essere imitate. Quindi il diritto di un’ area specifica può mutare per effetto della diffusione di un modello esterno nell’area considerata. Il diritto romano si è diffuso in Germania, modelli francesi si sono diffusi in Italia, Russia e Africa, e modelli inglesi si sono diffusi in America. La nascita di un modello originale è un episodio molto più raro di una imitazione: infatti dal 1804 in poi sono entrati in vigore centinaia di codici civili nel mondo, ma di questi solo quattro o cinque possono considerarsi originali.
L’epoca dell’unificazione
Nel mondo occidentale le diversità vanno riducendosi nel campo del diritto pubblico e del diritto privato, e l’imitazione rende uniforme il diritto civile, processuale, penale e amministrativo.L’uniformazione delle norme evita disparità di trattamento e incentiva gli scambi: essa è lo sbocco naturale della comparazione.
Uniformazione
Nonostante ciò ci sono delle contestazioni all’unificazione in nome delle tradizioni nazionali e in nome della storia, perché l’uniformazione non è sempre un bene. Talora essa sacrifica l’identità culturale dell’area portatrice del modello più debole. L’uniformità imposta funge da ostacolo allo sviluppo e al progresso. Chi crede all’uniformità non deve rinunciare al progresso e, dunque alla variazione.Nel corso del ventesimo secolo si è creata un’ uniformità di regole intorno al divorzio, all’adozione, alla comunione degli acquisti, alla elettività del parlamento. Talvolta regole uniformi vengono schermate dietro definizioni diversissime (ad esempio se A vende a B una cosa mobile, e prima che ne avvenga la consegna al compratore A vende a C questa stessa cosa e gliela consegna, C acquista la proprietà? La risposta per il sistema francese, tedesco e inglese sarà la stessa. In Francia A, dopo aver venduto a B, non è più proprietario, ma la regola “possesso vale titolo” assicura a C, acquirente in buona fede, una speciale protezione. In Germania A vendendo a B, non perde la proprietà della cosa perché non gliel’ ha consegnata, perciò C diventa proprietario se non ha agito con dolo. In Inghilterra la vendita da A a B trasferisce la proprietà, ma poiché a non ha consegnato la cosa a B, se ne desume che è incaricato di alienare la cosa al terzo.)Queste disparità nelle spiegazioni potrebbero sparire senza creare problemi operativi.

CAPITOLO TERZOLA TRADIZIONE GIURIDICA OCCIDENTALE
L’opposizione tra common law e civil law
La tradizione di common law raggruppa quelle esperienze che storicamente hanno il loro ceppo nel diritto inglese medievale e moderno: si tratta della tradizione giuridica anglosassone, che accomuna l’Inghilterra, l’Irlanda, il Canada (eccetto il Quebec), gli Stati Uniti, l’Australia e la Nuova Zelanda. Essa inoltre influenza anche il diritto di altri paesi che sono stati dominati dal diritto inglese.La tradizione di civil law raggruppa le esperienze dell’epoca medievale nell’Europa continentale. Questa seconda tradizione si presenta meno compatta perché ha conosciuto nella sua storia, metamorfosi più accentuate rispetto all’evoluzione del common law, per cui qui si distinguono una tradizione latina, una germanica, una nordica, una post-socialista ed una latino-americana.La tradizione di common law si sviluppa storicamente in Inghilterra a partire dal 1066 dalla giurisprudenza delle corti ivi istituite dai re normanni e dai loro successori. La tradizione di civil law si sviluppa dal diritto romano e dalla riscoperta compiuta nell’XI secolo ad opera di Irnerio e dei professori dell’Università di Bologna: si usa parlare anche di una “tradizione romanistica” la quale accomuna tutte le tradizioni giuridiche dell’Europa continentale, nonché quelle delle America Latina, ma anche della Turchia e del Giappone.Ma bisogna fare attenzione perché la tradizione di common law e quella di civil law non sono due entità ben distinte e perfettamente separate. Si definisce tradizione giuridica l’insieme dei modi di pensare, applicare e insegnare diritto, che siano storicamente radicati nella mentalità giuridica: questa definizione sottolinea come la storia ci insegna come non sia mai esistita una civiltà inglese separata da una civiltà europeaDifferenze : Civil Law-Fonti Diritto positivo codicistico scritto-Formazione del giurista banchi universitari- Radice Parlamentare, la legge proviene dalle Camere che garantiscono la democraticità e certezza del diritto-Maggiore staticità del diritto-Selezione del giudice con concorsoCommon Law-Fonti sentenze dei giudici e gerarchia delle fonti-Formazione del giurista senza formazione fino al 700, poiché vi erano corporazioni con insegnamento molto meno teorico, ovvero pratico.-Base diritto consuetudinario, “stare decisis” principio del precedente vincolante- Diritto casistico giurisprudenzialecase law, regole applicate al singolo caso-Selezione del giudice con nomina-Dottrina più rilevante
Con il passare del tempo però questa distinzione va riducendosi perché i sistemi di civil hanno una tendenza crescente ad attribuire un ruolo di rilevanza alla giurisprudenza (si pensi alla Corte di Cassazione e alle sentenze della Corte Costituzionale); nel common law si assiste ad una progressiva legiferazione (si pensi al Codice Commerciale degli Usa)
Le origini culturali della contrapposizione tra common law e civil law, e i motivi del suo ripensamento.

Nei primi anni del XX secolo i dati usati come criteri di classificazione, detti “demarcatori sistemologici” riguardavano l’assetto delle fonti. Era l’epoca in cui la codificazione del diritto civile in Germania aveva dato forte impressione, in quanto per tutto l’800 la dottrina tedesca reagiva rigorosamente all’idea di codificazione. E grande sorpresa suscitava il rifiuto di ricorrere alla codificazione nei sistemi di common law: perciò si disse che la differenza essenziale tra la famiglia di civil law e common law consistesse nel fatto che i sistemi della prima erano sistemi di diritto codificato, mentre i diritti dei paesi di common law non lo erano.Inoltre i primi anni del XX secolo segnarono anche l’epoca del più rigoroso positivismo legislativo, in quanto la maggior parte dei giuristi era fedele all’idea che l’unica fonte del diritto fosse la legge in senso formale: quindi grande sorpresa suscitava l’apprendere che, mediante il criterio del “precedente vincolante”, la giurisprudenza fosse considerata una fonte del diritto nei sistemi di common law. Poiché però la teoria ortodossa del common law considerava che la decisione giudiziale non era creativa di nuove regole di diritto, ma svolgeva solo una funzione ricognitiva di norme consuetudinarie latenti, si disse allora che la seconda grande differenza tra i due sistemi consisteva nel fatto che gli uni erano sistemi di diritto scritto e gli altri di diritto cinsuetudinario non scritto. Queste percezioni non sono più attuali. Infatti addirittura alcune corti supreme di paesi di civil law come la Cassazione in Francia sono attentissime al valore dei propri precedenti. In definitiva oggi nessun aspetto del sistema delle fonti pare idoneo a costituire un demarcatore sistemologico tra le esperienze di common e di civil law. In quanto i sistemi delle due famiglie giuridiche sembrano convergere.
L’avvento del costituzionalismo e l’emersione dei sistemi giuridici misti
Inoltre nel corso del XX secolo è venuto meno il principio dell’onnipotenza della legge come unica fonte legittima del diritto nazionale. Oggi molti stati europei si sono dotati di costituzioni rigide che prevedono un sindacato di costituzionalità sulle leggi da parte della Corte Costituzionale, ripetendo sostanzialmente il modello americano, ed implica il livello di legalità costituzionale superiore alla volontà del singolo Parlamento. Ancora, molti sistemi giuridici europei attuali, partecipano all’Unione Europea, e sono soggetti a tale ordinamento giuridico. La democrazia rappresentativa è ugualmente presente in tutti gli ordinamenti giuridici occidentali dalla seconda metà del XX secolo, concretizzandosi, in modo uniforme. E’ sulla strada dei valori che si pone l’indagine comparatistica, per cui le esperienze di common law e di civil law appaiono dotate di radici comuni. Esistono congruenze tra i valori di civiltà e i principi giuridici. Tutto ciò mostra come non ci sia un netto demarcatore sistemologico tra i due sistemi, ma allo stesso tempo rinunciare alla demarcazione sembra una follia. Di ciò è testimonianza l’interesse della categoria dei sistemi giuridici misti : esperienze giuridiche che sono state influenzate sia dal modello di common law che da quello di civil law. Sono il frutto di una sovrapposizione di modelli su un sostrato di altro modello in seguito ad esempio ad una dominazione politica inglese o americana. I sistemi giuridici misti traggono quindi origine da un fenomeno di circolazione dei modelli per imposizione; ma anche quando i paesi dominati hanno avuto piena indipendenza politica hanno conservato quasi tutti gli aspetti del common law assimilati nel periodo precedente. L’aspetto interessante di questi sistemi è che essi sono pienamente sistemi occidentali, pur non potendo essere ascritti né all’una né all’altra delle due tradizioni principali.
La nozione di tradizione giuridica occidentale
Agli inizi della comparazione giuridica moderna, i grandi storici del diritto come Maitland erano convinti della netta differenza tra common e civil law, perché l’origine causale delle istituzioni inglesi è inevitabilmente un accadimento storico avvenuto in Inghilterra, e quindi diverso dai fatti storici dell’Europa continentale. Inoltre due ricostruzioni storiche meritano di essere accennate: una

prima rileva come nell’alto Medioevo, ovvero tra V e XI secolo, si sia creata in Europa una vasta area di diritto comune, nel senso che tutti i territori utilizzavano gli stessi moduli organizzativi e procedurali. Così la diversità tra civil law e common law si sarebbe sviluppata a partire da un ceppo comune alto medievale, e ciò spiegherebbe la consonanza di valori di fondo e allo stesso tempo la diversità delle forme di espressione. La seconda ricostruzione storica rivolge l’attenzione tra l’XI e il XII secolo : questa visione concepisce sia la tradizione di civil law che quella di common law come espressioni di una medesima tradizione giuridica di fondo, chiamata tradizione giuridica occidentale. Essa si sarebbe sviluppata all’epoca della riforma gregoriana, sotto lo sforzo di rifondazione della chiesa di Roma. Caratteri della tradizione giuridica occidentale: - il diritto è relativamente autonomo rispetto alla religione e alla politica, nel senso che queste ultime possono influire sul primo, ma non sono il diritto. – l’amministrazione dello spazio giuridico viene affidata ad un ceto di professionisti che esercitano attività legali. – il patrimonio di queste conoscenze e di queste tecniche da loro utilizzate diviene un formante organizzativo del sistema. – il diritto viene concepito come un insieme coerente, ossia un sistema integrato e capace di riprodurre sé stesso, di svilupparsi attraverso il tempo. – le singole regole possono essere comprese solo se sono collocate nel contesto di procedure e istituzioni concettualmente coordinate. – la legalità è superiore alla sovranità, nel senso che la volontà politica non può sovvertire l’ordine legale, perché la pura volontà soggettiva del sovrano non è sufficiente a fondare una regola di diritto. Quindi, per capire a fondo le differenze tra le due branche della tradizione giuridica occidentale, si deve procedere secondo una periodizzazione storica, che distingua:
1) Un periodo formativo (XII - XIV secolo);2) Il periodo del consolidamento (XIV – XVIII secolo);3) Il periodo delle rivoluzioni (seconda metà del XVIII secolo sino al primo conflitto mondiale,
coincidendo con il diffondersi della prima rivoluzione industriale);4) Il periodo contemporaneo (anni 30 del XX secolo, in coincidenza con l’età degli Stati
sociali).
Essa è un “esperienza” giuridica, perché è un sistema aperto e rifiuta la chiusura nella codificazione. Così i valori affermati nell’ambito dell’Europa e trasportati con le colonizzazioni oltre oceano fanno si che gli interessi tendano ad essere tutelati nella medesima maniera.