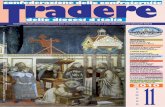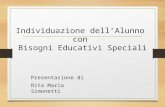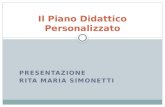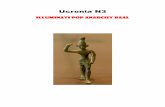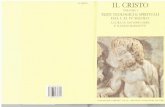simonetti
-
Upload
armando-editore -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
description
Transcript of simonetti

Patrizia simonetti
iL GioRnaLisTa RadioFonico
Istruzioni per l’uso

Sommario
Introduzione: Perché la radio 7
il mito del giornalista 10
Giornalista si nasce o si diventa? 13
Fare informazione 15
La notizia 16
La fonte 19
L’elaborazione della notizia 22
Il giornalista radiofonico 24
La diretta 26
il linguaggio radiofonico 28
La voce 30
La notizia radiofonica 34
i sonori 36

il servizio radiofonico 38
L’intervista 41
Gli speciali radiofonici 48
Il Giornale Radio 49
La rassegna stampa in radio 53
La redazione 56
Lo studio radiofonico 58
Tutte le strade portano all’ordine: giornalisti Pubblicisti, Professionisti, Praticanti 59
Come comportarsi durante la pratica giornalistica 64
L’esame di idoneità professionale 68
Giornalisti cercasi 72
i contratti 75
contributi e assicurazione 78
Link utili 79

7
IntroduzionePeRché La Radio
ho sempre avuto una grande passione per la radio. anzi, posso affermare con certezza che la radio “è” la mia passione. Quando ero ancora una ragazzina – erano proprio gli anni dell’esplosione delle radio libere – la tenevo accesa anche mentre facevo i com-piti. ogni tanto mia madre entrava in camera mia per chiedermi: “ma come fai a studiare con questa musica?”. il bello era che non solo riuscivo a studiare con “quella musica”, ma non ero in grado di farlo senza. La radio nella mia stanza, quando c’ero, era sempre accesa. e non ascoltavo solo le canzoni: mi piaceva sentir parlare i conduttori dei programmi, i dJ, riconoscevo le loro voci, sapevo i loro nomi, gli orari in cui trasmettevano, conoscevo tutte le emittenti, soprattutto quelle “private”. allora non seguivo mol-to i giornali radio, ma soprattutto le classifiche musicali, i giochi – a volte anche partecipando e vincendo qualcosa! – e pensavo: “quando sarò grande, lo farò anch’io”. e così fu.
appena diplomata – erano i primi anni 80 – mi misi in cerca di una radio che mi permettesse di “imparare il mestiere”. il mio pri-mo “provino” fu un disastro. il “direttore artistico” dell’emittente in questione mi fece leggere un breve testo per poi dirmi: “lascia stare, non sei proprio portata”. Tornai a casa con una tristezza in-finita nel cuore. Eppure parlavo un italiano perfetto! Ricordo che da bambina mia nonna mi portava in giro per le case delle “vec-chiette” a leggere a voce alta il Vangelo perché solo io – diceva – lo facevo così bene e in modo così chiaro. e nonostante fossi

8
romana, lo zio di mia madre mi chiamava “la bergamasca”, un modo un po’ particolare per dire che parlavo bene e senza alcuna inflessione dialettale. E quanti applausi quando recitavo le poesie di natale! Tutti affermavano che avevo una bellissima voce. in-somma, non riuscivo a capacitarmi di quell’insuccesso.
ci misi un po’, ma poi mi ripresi e tentai ancora. Riuscii ad entrare in una piccola emittente di quartiere di proprietà di un tipo alquanto strano che ci viveva dentro: arrivavo la mattina che lui ancora dormiva, accendevo una specie di mixer, mi infilavo le cuffie, aprivo il microfono, mettevo un disco sul piatto e via con chiacchiere e dediche – all’epoca andavano molto di moda – di ragazzi e ragazze, ma anche di persone più mature che, chissà perché, invece di telefonarsi tra loro, chiamavano me per man-darsi saluti e messaggi da un palazzo all’altro attraverso la mia voce. Fu un successo! anche se non prendevo una lira... ed io cominciai a crederci. Quando mi sentii un po’ più sicura di me, iniziai a cercare di meglio. da allora passai di radio in radio, sem-pre più grandi e importanti – giungendo pure in Rai – lavorando fianco a fianco con alcuni di quei conduttori che anni prima ascol-tavo con ammirazione, considerandoli inarrivabili. Alla fine degli anni ’80 ero tra i conduttori di Radio Radio che al suo interno aveva solo due giornalisti per alcune edizioni dei GR e che per le altre edizioni si serviva di un’agenzia di stampa radiofonica. Quando la radio chiuse per un periodo e mandò tutti a casa, i due giornalisti vennero “assorbiti” dall’agenzia. Poco dopo riuscii anch’io ad entrarci, dapprima come speaker poi, piano piano, con non poca fatica, guadagnando la redazione. Fu allora che nacque la mia passione per il giornalismo, ma rigorosamente radiofo-nico. Passarono anni prima che diventassi una giornalista vera e propria, ma arrivò anche il momento dell’esame, che superai, e dell’iscrizione all’albo dell’ordine dei Giornalisti. Lavorai in quell’agenzia per vent’anni conducendo giornali radio, realizzan-do interviste, come inviata a conferenze stampa, concerti e mani-

9
festazioni, divenendo poi la responsabile della redazione “cultura e spettacolo”. scrissi anche molti articoli per alcuni quotidiani locali serviti per un periodo dall’agenzia, ma la mia passione re-stò sempre la radio.
Tutto ciò per dire che la radio, per farla, bisogna amarla. e ca-pirla. La radio non è solo una televisione senza schermo. Provate ad oscurare la vostra TV, oppure semplicemente a voltarle le spal-le, ed ascoltatela. c’è qualcosa che non va, vero? non riuscite a capire tutto ciò che accade, qualcosa non fila, non c’è completez-za, l’audio non basta. Quello della radio invece sì: non servono le immagini, tutto è chiaro, sembra quasi di vederlo. La radio ha il suo linguaggio e le sue tecniche che sopperiscono perfettamente alla mancanza del video, a volte superandolo e lasciando spazio alla fantasia e all’immaginazione. Tutto ciò è fantastico! ma, na-turalmente, non nasce dal nulla e va tenuto ben presente quando si fa radio e soprattutto quando si fa informazione radiofonica. e per farla bene non basta la passione per la radio, ci vuole anche quella per il giornalismo, una passione “reale”, non certo priva di sogni e ideali, ma consapevole dei pregi e dei difetti di ciò che si ama. Per amarlo di più.

10
Il mito del giornalista
“che lavoro fai?”.“La giornalista”.“Fico!”.ecco. Questa è una delle più comuni reazioni che si scatenano
al solo pronunciare la parola “giornalista”. a me è capitato più volte e capita tuttora, ma ho sempre smorzato gli entusiasmi, e continuo a farlo, aggiungendo:
“insomma...”. e di solito il mio interlocutore chiede stupito:“Perché? non è il lavoro più bello del mondo?”.ed io, per non ripetere un altro “insomma” (il giornalista deve
vantare un vasto vocabolario di sinonimi e significati affini), ri-spondo:
“dipende”. dopo tutto il discorso sulla passione per la radio, potrei sem-
brare contraddittoria. non è invece questa la mia intenzione. non voglio infatti spegnere il desiderio di intraprendere la carriera di giornalista, radiofonico o no, ma va sempre tenuto presente quel “dipende”. che purtroppo spesso non “dipende” da voi.
non è detto infatti che, una volta conquistato “il titolo”, sarà tutto “rose e fiori”. Potreste diventare i giornalisti più bravi del mondo, disposti a lavorare sodo e ad impegnarvi con tutta l’ani-ma, ma, se la ruota non gira, il vostro non sarà certamente un me-stiere “fico”. Le delusioni vanno messe in conto. Se non trovate

11
il vostro ambiente ideale di lavoro – che certo da qualche parte esiste – potreste non avere mai la possibilità di sfruttare al meglio le vostre capacità e di sviluppare le vostre potenzialità. magari vorreste occuparvi di un settore e venite invece costretti a curarne un altro, vi piacerebbe scrivere per un giornale ma trovate lavoro in una radio, vorreste fare gli inviati ma siete assegnati alla con-duzione, sareste bravissimi – e lo sapete – a redigere notiziari o a produrre servizi, ma siete bloccati alla ricerca di spunti per altri colleghi o a scartabellare i vari comunicati in arrivo.
e non è salutare, soprattutto in un momento come questo, la-sciare un posto di lavoro alla ricerca di uno migliore, anche se mi sentirei di consigliarlo.
e soprattutto non è detto che se anche riusciste a diventare giornalisti nella testata che avete sempre sognato, potreste segui-re e inseguire tutto ciò che vi piace nei posti più belli del mondo. Perché, diciamolo: è questo il “mito” del giornalista. nell’im-maginario collettivo il giornalista ha la valigia sempre pronta, si sposta continuamente per il mondo per cercare o raggiungere l’oggetto del suo servizio in luoghi bellissimi, realizza facilmente e senza alcun problema il suo lavoro e torna trionfante avendo guadagnato soldi e fama. cominciamo a sfatarlo, questo mito. Quello appena descritto è solo un ritratto molto ottimista di un inviato fortunato. L’inviato non sempre, anzi all’inizio quasi mai, viene mandato dove realmente vorrebbe andare e raramente in posti da cartolina dove riprendere, registrare o scrivere tranquil-lamente di ciò che vuole. spesso viene invece spedito in città e Paesi tutt’altro che ameni, magari noiosi, scomodi da raggiunge-re, ad intervistare persone o a riferire fatti verso i quali non nutre alcun interesse personale. a meno che non venga mandato in Pae-si dove regnano guerre o disordini. in questo caso, che dire? Fare l’inviato di guerra è per molti il massimo della professione. ma non tutti hanno questa possibilità. e non tutti amano il rischio. se poi sognate di diventare giornalisti famosi, davvero non è facile.

12
detto ciò, se ricorderete sempre la parola “dipende”, sarete già un passo avanti. diventare giornalista si può, non è certo l’impre-sa più ardua del mondo, ma è una bella conquista. e le conquiste più belle sono quelle costate fatica.

13
Giornalista si nasce o si diventa?
come per molti altri mestieri e professioni, ci si chiede spesso se giornalista si nasce o si diventa. io credo che qualche caratteri-stica innata debba esserci. altre, comunque necessarie, si possono conquistare.
Tra le prime metterei senz’altro la curiosità. Tutto risulterà più facile e naturale se “per carattere” si è interessati a ciò che accade intorno e ci si pongono continuamente delle domande cercando le rispettive risposte. soprattutto se non ci si accontenta di ciò che succede davanti ai propri occhi, ma ci si muove per andare a scoprire storie e fatti lontani. ancora meglio se si è portati a divul-gare questi avvenimenti, se si ama raccontare un evento al quale si è assistito per dividere la propria esperienza, fornendo dettagli e particolari. Per raccontare bene le cose, è necessario che piaccia farlo. e che piaccia sapere tutto ciò che si può sapere, essere natu-ralmente portati ad informarsi, leggendo il giornale, guardando i TG, ascoltando i GR, navigando in internet.
un’altra “dote innata” che potrebbe rivelarsi utile al giornalista è la vivacità, intesa come “non pigrizia” e “non abitudinarietà”. Bi-sogna “trottare”, soprattutto agli inizi della carriera, spostarsi da un posto all’altro spesso senza preavviso, lavorare oltre l’orario stabili-to, cambiare turno, essere pronti ad andare in redazione nei fine set-timana, nei giorni festivi, di mattina presto e di sera tardi, essere ben disposti verso i cambiamenti improvvisi e non farsi prendere dall’an-sia. alcune persone non reggono il ritmo, ma ci si può “allenare”.

14
non guasta neanche una sana “faccia tosta”. non è un buon segno sentirsi in imbarazzo e arrossire quando si incontrano per-sone nuove, fare fatica a socializzare con la gente, bloccarsi al cospetto di un personaggio importante o che, a torto o a ragione, si ritiene “superiore”. il giornalista deve essere infatti in grado di affrontare con lucidità e razionalità qualunque interlocutore, soprattutto se lo deve intervistare. L’insicurezza non è una buo-na alleata: intanto perché trapela facilmente e la persona che il giornalista ha di fronte può farsi subito un’idea sbagliata di lui, credendolo incompetente e poco professionale, il che inciderà notevolmente sul reciproco rapporto, mettendo in pericolo la va-lidità dell’intervista da realizzare. E poi perché, almeno finché non si diventa “direttori” – cosa che auguro a tutti coloro che in-traprendono questa carriera – si avranno sempre dei superiori cui dover rendere conto e se non si instaura un rapporto di reciproco rispetto, la vita non sarà facile. naturalmente può capitare che in un’occasione non ci si senta all’altezza della situazione, magari a ragione, in quanto non si è preparati a sufficienza per affrontarla o non se ne ha avuto il tempo. in quel caso i propri timori possono essere giustificati, ma andranno controllati.
ad aiutare in questi frangenti potrebbe essere anche la pron-tezza di riflessi, altra caratteristica che si rivelerà molto utile.
Quasi superfluo aggiungere che sarebbe meglio saper parlare e scrivere in un italiano corretto e, nel caso del giornalista radio-fonico, vantare una buona dizione. ma queste sono qualità che se non si posseggono per natura, con un po’ di impegno e di pazien-za, si possono acquisire, come vedremo in seguito.
Le proprie caratteristiche tuttavia non bastano. il giornalismo ha le sue regole. e valgono per tutti. il giornalista è in primo luo-go “un giornalista”, poi può essere radiofonico, televisivo, lavo-rare per la carta stampata o per internet. ma le nozioni e le regole fondamentali sono uguali per tutti e bisogna conoscerle.

15
Fare informazione
il giornalista è colui che informa. Può sembrare un’afferma-zione banale, ma non lo è. anche indicare una strada o svelare il costo di un prodotto in vendita è “informare”, ma ciò non signifi-ca che il vigile o il commesso di turno siano giornalisti. L’infor-mazione giornalistica è infatti ben altro. si tratta di dare notizie, ovvero rivelare e raccontare ciò che accade intorno a noi, ed an-che molto più lontano, in modo preciso, veritiero e interessante. e, soprattutto, obiettivo. in questo modo si fa “notizia”.

16
La notizia
La notizia è un evento raccontato, ovvero la comunicazione di un fatto, un accadimento, un’azione compiuta da qualcuno o da qualcosa e le sue conseguenze. Può essere breve (di poche righe o battute) o lunga e dettagliata, può riguardare la politica, la cronaca, la cultura, lo spettacolo, lo sport, il costume, il sociale: dipende dall’argomento e dall’ambito in cui si è verificato l’even-to che si riporta.
Tra tutte le notizie di cui quotidianamente si viene in possesso in ogni redazione, bisogna sempre sceglierne alcune tralasciandone altre. a meno che non si disponga di un giornale di mille pagine, di un sito altrettanto corposo o di una radio che dia ininterrottamente notizie 24 ore su 24 e, soprattutto, di mille giornalisti al proprio servizio! inoltre, come detto precedentemente, la notizia per essere considerata tale deve essere interessante. cos’è infatti che rende un evento qualunque una “notizia”? Quali, dunque, i criteri di “notizia-bilità”? L’interesse, appunto. o meglio, l’interesse comune o quan-tomeno di molti. Quali caratteristiche costituiscono l’interesse?
L’effetto dell’avvenimento, ad esempio, la vicinanza a chi leg-gerà o ascolterà la notizia, la novità, la stranezza, la particolarità, la tempistica (è successo pochi minuti fa), il coinvolgimento di un personaggio celebre o noto, il coinvolgimento di un cospicuo numero di personaggi.
un elementare esempio di cronaca: se un tizio cade in strada e si sbuccia un ginocchio, interesserà indubbiamente alla madre

17
o alla moglie, ma al resto del mondo non importerà assolutamen-te nulla. ma se il tizio cade e muore, magari persino in modo apparentemente inspiegabile, l’interesse può diventare comune. ci si sbuccia spesso un ginocchio cadendo, ma non sempre si muore. Per cui ci si chiederà come sia potuto accadere, quando, dove e perché. e se la persona cui è accaduto è un protagoni-sta del mondo politico o dello spettacolo, l’interesse sarà ancora maggiore. L’evento è infatti un accadimento che non si verifica spesso e ovunque. c’è poi un vecchio detto usato nell’ambiente giornalistico per spiegare sinteticamente cos’è una notizia: se un cane morde un uomo – a meno che questi non muoia – non è una notizia perché si sa che i cani a volte mordono. ma se un uomo morde un cane, diventa una notizia perché è insolito e, speriamo, poco probabile che accada.
ci sono invece notizie che per loro natura vengono considerate interessanti perché influenzano la vita e la quotidianità di ognuno di noi, come quelle politiche, economiche, meteorologiche. ma anche in questi casi va usato il buonsenso: se un uomo politico starnutisce, non è una notizia. ma se lo fa in faccia ad un collega, magari in Parlamento, e quest’ultimo gli molla un ceffone, la no-tizia c’è. se in inverno nevica, non è una grande notizia. ma se la neve blocca la circolazione stradale, provoca valanghe o vittime o se accade ad agosto, la notizia c’è. e così via.
La notizia data “per primi” e “in esclusiva” è detta “scoop”. Per le redazioni radiofoniche può ad esempio arrivare dal corri-spondente o da un testimone e va data velocemente.
altro punto fondamentale: la notizia dev’essere attendibile, per cui va sempre verificata. Quindi prima di diffondere una no-tizia, bisogna sempre chiedersi da chi o come se ne è venuti a conoscenza e se si è certi dell’affidabilità di chi l’ha fornita. Se la risposta alla seconda domanda è un “no” o un “chissà”, si po-trebbe ad esempio provare a controllare con una telefonata ad una persona o ad un’istituzione coinvolta, oppure la testata potrebbe

18
mandare sul posto un corrispondente o un inviato a verificare. L’importante è essere sicuri che non sia una “bufala”.
È vero che oggi la maggior parte delle notizie arrivano da in-ternet e che la velocità del lavoro di giornalista, soprattutto ra-diofonico, non permette sempre queste verifiche. Almeno, però, si controlli che la pubblichino più fonti, ad esempio più siti o più giornali e, se non si è ancora sicuri ma bisogna divulgarla per for-za, si usi il condizionale o una parola che lasci il dubbio, come: “sarebbe accaduto, avrebbe detto, sembra o sembrerebbe che...” e si scriva o si dica che: “al momento la notizia non è tuttavia confermata”.
Il modo più efficace e corretto per assicurarsi la veridicità del-la notizia è controllarne l’origine, ovvero “verificare la fonte”.

19
La fonte
La fonte è appunto la persona o l’organismo che “fornisce” la notizia.
anche se il giornalista radiofonico apprende le notizie per lo più dalle “agenzie di stampa”, queste vengono definite come “fonti secondarie”: la principale è l’ansa, ma ce ne sono molte altre, come l’adnKronos, l’agi, l’asca, ecc.
Queste agenzie sono delle “aziende” che raccolgono tutte le informazioni possibili, le elaborano, ma non sempre rendendole “pronte all’uso”, e forniscono dietro abbonamenti, quindi a pa-gamento, una serie quasi infinita di notizie alle varie testate gior-nalistiche i cui addetti le leggono da un monitor sotto forma di lanci, dispacci, take o flash. in testa ad ogni lancio c’è sempre la data e l’orario, il luogo e il titolo, alla fine c’è spesso scritto “fine dispaccio”: vuol dire che quell’evento, almeno per il momento, si è concluso e non c’è altro da dire. ma attenzione: potrebbero arrivare nuovi lanci di quella stessa notizia se si verificassero altri eventi correlati al primo o se si venissero a sapere ulteriori par-ticolari dettagli: in quel caso la notizia “evolve”. ad esempio, se un lancio di agenzia informa che un uomo ha ucciso una donna a coltellate, questa è una prima notizia. ma bisogna aspettarsi sicuramente almeno un altro lancio relativo a quell’evento nel momento in cui si verrà a sapere il nome dell’uomo, il motivo del suo gesto e magari del suo arresto. Queste si chiamano “notizie in divenire”. si saprà mai quando la notizia è “chiusa”, ovvero

20
quando non possono arrivare più nuovi particolari su quell’even-to? in realtà no, può sempre accadere qualcosa da aggiungere, per cui bisogna sempre controllare l’uscita di nuovi dispacci relativi a quel determinato fatto che si va a raccontare.
a volte le agenzie non elaborano neanche le loro informazioni pur di darle in tempo reale: in questo caso arriverà solo una riga, il cosiddetto “flash di agenzia” al quale, ovviamente, seguiranno altri lanci con sempre maggiori dettagli. I flash di agenzia sono sempre da tenere in alta considerazione perché riguardano eventi solitamente molto importanti e “urgenti” e si riconoscono facil-mente perché sull’unica riga che spesso fa anche da titolo c’è scritto proprio “flash” e ci sono dei segni, come dei “più” o degli “asterischi”.
come già detto, si possono utilizzare come fonti “secondarie” di notizie anche altri mezzi di informazione, come siti internet, giornali, emmittenti televisive o radiofoniche, tenendo però pre-sente che hanno già “elaborato” a loro modo la notizia in que-stione. in quel caso si perde un po’ di tempismo, ma si viene in possesso di informazioni per lo più già verificate. Ma sarebbe sempre meglio controllare.
Le fonti cosiddette “primarie” sono invece le istituzioni e le forze dell’ordine: dispongono di “uffici stampa” – anch’essi com-posti da giornalisti – proprio per diffondere notizie che li riguar-dano attraverso i cosiddetti “comunicati stampa” che arrivano nelle redazioni solitamente via mail o via fax.
Anche gli uffici stampa in genere sono fonti di notizie: quelli di aziende, istituti culturali, case discografiche, organizzazioni, associazioni, ecc.
altre fonti primarie sono i giornalisti che si trovano sul po-sto dell’evento. Parliamo, come vedremo meglio in seguito, dei “corrispondenti”, giornalisti che lavorano per la testata ma che vivono o risiedono in un’altra città o in un altro stato e che non solo vengono chiamati in causa dalla redazione quando nel luogo

21
in cui si trovano si verifica un evento interessante, ma sono tenuti ad allertare essi stessi la redazione quando, dove vivono, acca-de qualcosa che potrebbe interessare la testata per cui lavorano. Fonte primaria è anche l’“inviato”, che però lavora in redazione e viene mandato sul posto al verificarsi dell’evento.
anche un “testimone” può essere una fonte primaria: qualcu-no che assiste a un fatto e lo comunica a un’agenzia di stampa, a un giornale o ad una radio.