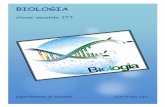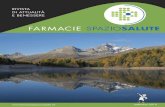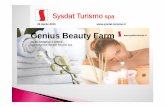SCHEDA GENERALE - ittvt.edu.it V ITT/Doc finale_5A_inf_2014_2015.pdf · scolastico 2014-2015 e ha...
Transcript of SCHEDA GENERALE - ittvt.edu.it V ITT/Doc finale_5A_inf_2014_2015.pdf · scolastico 2014-2015 e ha...



SCHEDA GENERALE
ANNO SCOLASTICO 2014/2015 CLASSE 5A SPEC. INFORMATICA
1. OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
- Possedere una visione equilibrata e consapevole della società
- Sapersi orientare nel mondo del lavoro e dello studio;
- Possedere capacità logico-discorsive;
- Progettare ed organizzare la propria attività di lavoro e di studio;
- Esercitare l'autocontrollo e il senso critico;
- Possedere una adeguata preparazione di base;
- Rielaborare autonomamente i contenuti delle discipline;
- Possedere un valido metodo di studio;
• GIUDIZIO SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI EDUCATIVI PROGRAMMATI IN
AMBITO PLURIDISCIPLINARE
• AREA LINGUISTICO-STORICO-LETTERARIA
L'acquisizione dei contenuti fondamentali dei programmi non è per tutti sufficiente.
Partecipazione alle lezioni non sempre continua e attiva.
(b) AREA TECNICO-SCIENTIFICA
Nel complesso accettabile l’acquisizione dei contenuti fondamentali dei programmi.
• PRESENTAZIONE E STORIA DELLA CLASSE
a) DATI SUGLI ALUNNI
• alunni n◦……………… 29…………….. ripetenti n◦ ……… 5 ……. pendolari n0.. 8 • Capati…..
b) CONTINUITA’ DIDATTICA
- gli alunni hanno avuto tutti lo stesso percorso didattico nell'ultimo triennio SI [ ] NO [X]
- il gruppo docente nell’ ultimo triennio e' stato stabile? SI [ ] NO [X ]
• OMOGENEITA' DELLA CLASSE
Nella classe si evidenzia l'esistenza di sottogruppi di alunni per quanto concerne
- il comportamento disciplinare [X]
- Le capacità di elaborazione [X]
- La provenienza socio-culturale [X]
- L'impegno e la frequenza [X]
La classe è omogenea rispetto agli interessi e alle attitudini SI[ ] NO[X ]
Le capacità di apprendimento della classe sono mediamente
insufficienti [ ] sufficienti [ ] discrete [X] buone [ ]
L'impegno degli alunni è mediamente
non soddisfacente [ ] sufficiente [X] buono [ ]
La frequenza degli alunni è mediamente

non soddisfacente [] sufficiente [ X ] buona [ ]
Il comportamento disciplinare della classe è mediamente
non soddisfacente [ ] sufficiente [X ] buono [ ]
• CONTENUTI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
A questo punto dell’anno gli argomenti relativi alla programmazione delle varie discipline è
SONO STATI SVOLTI TUTTI QUASI TUTTI IN PARTE
ITALIANO [ ] [X] [ ]
STORIA [ ] [X] [ ]
INGLESE [ ] [X] [ ]
INFORMATICA [ ] [X] [ ]
TECNOLOGIE E PROGETT. DI SIST. [ ] [X] [ ]
MATEMATICA [ ] [X] [ ]
GESTIONE PROGETTO E ORG. IMPRESA [ ] [X] [ ]
SISTEMI E RETI [ ] [X] [ ]
ED.FISICA [ ] [X] [ ]
RELIGIONE [ ] [X] [ ]
GLI EVENTUALI TAGLI SONO STATI MOTIVATI DA
MANCANZA DI TEMPO [X ]…(Italiano e Storia, Informatica, Sistemi, Matematica, GPOI) ATTIVITA INTERDISCIPLINARI [ ]
SCARSO IMPEGNO DEGLI STUDENTI [GPOI,] LIVELLO DI PREPARAZIONE INIZIALE INADEGUATO [ ]
• MAGGIORE ATTENZIONE AD ALCUNI ARGOMENTI [ Sistemi , Informatica]
5. SCELTE METODOLOGICHE OPERATE E LORO MOTIVAZIONE
VEDERE LE SCHEDE ALLEGATE DELLE SINGOLE DISCIPLINE
7. OBIETTIVI PROGRAMMATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA' PER LE DISCIPLINE
VEDERE LE ALLEGATE SCHEDE DELLE SINGOLE DISCIPLINE
8. PROGRAMMAZIONE DI INIZIO ANNO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
a) HA COSTITUITO UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER TUTTE LE DISCIPLINE SI [X ] NO[ ]
b) E' SERVITA COME GUIDA AL LAVORO DIDATTICO
PER QUANTO RIGUARDA I CONTENUTI SI[X] NO [ ] IN PARTE[ ]
PER QUANTO RIGUARDA I METODI SI[X] NO [ ] IN PARTE[ ]
PER QUANTO RIGUARDA LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE SI[X] NO [ ] IN PARTE[ ]
c) HA SUBITO IN ITINERE MODIFICAZIONI SI[ ] NO[ X ] ( ILLUSTRARE)
d) CONTRIBUTI OFFERTI ALLA PROGRAMMAZIONE DALLE COMPONENTI ALUNNI E GENITORI
ALUNNI SIGNIFICATIVI [ ] NON SIGNIFICATIVI [ ] PARZIALMENTE SIGNIFICATIVI [X]
GENITORI SIGNIFICATIVI [ ] NON SIGNIFICATIVI [X ] PARZIALMENTE SIGNIFICATIVI [ ]

9. VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI
CRITERI SEGUITI:
Griglie di valutazione con USO di descrittori [X]
Raccolta di dati durante le interrogazioni [X]
Sistematica raccolta di dati [X]
Raccolta di dati relativi non solo alle nozioni possedute,ma anche ad altri [X]
aspetti della personalità(capacità critica,proprietà di linguaggio,partecipazione,creatività)
Comunicazione dei voti [X]
Altro
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………
b) METODI IMPIEGATI (** Indicare le materie)
Interrogazioni orali [X] ** tutte le materie
Prove scritte individuali.... [X] per le materie che lo prevedono
Prove pratiche di gruppo [X] sistemi , GPOI , TP
Prove/relazioni indiv.di lab. [X] informatica, sistemi, TP, GPOI
Questionari [X] tutte le materie tranne religione, ed. fisica.
Prove strutturate [X] Informatica, matematica
Altro
• SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA
E'stata somministrata una simulazione della prima prova a fine aprile
comprensiva delle tipologie A, B, C, D dell'esame di stato secondo le modalità
e i tempi prescritti dalla normativa degli esami di Stato. Testo e griglia di
valutazione della prova sono allegati al presente documento.
• SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA
Gli studenti hanno effettuato all'inizio del mese maggio una simulazione della
seconda prova dell'esame di stato secondo le modalità e i tempi prescritti dalla
normativa degli esami di Stato. Testo e griglia di valutazione della prova sono
allegati al presente documento.
• SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA
Gli studenti hanno effettuato una simulazione della terza prova scritta a metà
aprile d’esame con quesiti a risposta singola, tipologia “B”. La prova
presenta domande relative alle seguenti materie: Matematica, Storia,
Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici, Inglese e Sistemi e Reti.
Non è presente la materia Informatica, in quanto il c.d.c. ritiene che sia
sufficiente la seconda prova scritta per valutare le competenze acquisite dagli
studenti nella disciplina. Si consiglia di mantenere le stesse discipline e si
allega il modello della prova.

METODOLOGIA CLIL
La DNL (disciplina non linguistica) scelta per la metodologia CLIL è stata
INFORMATICA, in quanto la docente, pur non essendo ancora in possesso delle
necessarie competenze linguistiche e metodologiche all'interno dell'organico
dell'Istituzione scolastica, è l'unica del CdC ad aver frequentato il corso di
approfondimento linguistico di 120 ore organizzato dal Miur e ad essere in attesa dei
corsi metodologici. La programmazione dei moduli e la modalità di realizzazione sono
rimandate alla relazione finale e alla programmazione disciplinare allegata a questo
documento.
Poiché la disciplina DNL veicolata in Lingua straniera costituisce materia della 2°
Prova dell’Esame di Stato, che sarà svolta esclusivamente in lingua italiana,
l'accertamento linguistico per la verifica delle competenze della disciplina DNL
veicolata in Lingua straniera non è oggetto né della Terza Prova, né del Colloquio, dal
momento che il docente non è membro interno della Commissione d'Esame.
• ATTIVITA' PARASCOLASTICHE
a) A livello di istituto ( corsi o particolari attività di approfondimento, attività sportive, partecipazione a spettacoli teatrali,
conferenze sulla salute e sull'orientamento, educazione alla salute, corsi …. )
Un gruppo di alunni ha partecipato negli anni precedenti al progetto “Assemblaggio
PC stand alone e in rete”, e ad altri corsi pomeridiani offerti dal POF nell’arco del
triennio, relativi alle materie tecniche della specializzazione (SilverLight,
programmazione Java)
La classe ha seguito le attività di orientamento ordinario programmate per l’anno
scolastico 2014-2015 e ha partecipato lo scorso anno a una visita tecnica alla web farm
di Aruba di Arezzo e al computer Olivetti 9300 all'ISIS di Bibbiena.
L'intera classe lo scorso anno scolastico, ha partecipato, ad un progetto nazionale
denominato “ Network Scuola-Impresa” in partenariato con le società Telecom Italia
ed il consorzio Elis, uno di loro ha vinto SUMMER CAMP in palio offerto da
TELECOM.
Lo stesso ragazzo ha vinto ripetutamente la borsa di studio , messa a disposizione
nell'ambito del concorso "VITERBO CHE STUDIA" da Rotary Club di Viterbo e
dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma.
Alcuni hanno partecipato al progetto “Nonni su INTERNET” in qualità di tutor,
organizzato dalla Fondazione Mondo Digitale.
Tutta la classe ha partecipato al progetto “ABC” Regione Lazio.
La maggior parte della classe ha anche aderito al progetto FIXO, che fornisce agli
studenti, da parte della scuola, un servizio di placement individualizzato (sette ore

individuali per studente con un docente tutor) e varie iniziative di orientamento al
lavoro o al proseguimento degli studi, il tutto assistito da Italia Lavoro.
12. OSSERVAZIONI SULLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE E I SUSSIDI DIDATTICI
Dotazioni sufficienti per tutte le materie.
13. COLLABORAZIONE SCUOLA FAMIGLIA
La scuola ha mantenuto rapporti scuola-famiglia nei limiti del possibile, tenendo
comunque presente l’autonomia dei ragazzi maggiorenni.
14. PARTECIPAZIONE~STUDENTESCA ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI
Giudizio sulle attività partecipative effettuate (assemblee di classe, assemblee di Istituto, comitato studentesco)
La partecipazione degli studenti alle attività istituzionali è stata continua e propositiva, e
si è sempre mantenuta nei termini del dialogo aperto e democratico.
15. COMPORTAMENTO E GRADO DI COLLABORAZIONE RISCONTRATI NEGLI ALUNNI
a) partecipazione al dialogo educativo NON SUFFICIENTE [ ] SUFFICIENTE [X]
b) spirito di collaborazione NON SUFFICIENTE [ ] SUFFICIENTE [X]
c) impegno a migliorare NON SUFFICIENTE [ ] SUFFICIENTE [X]
d) ALTRO ……… [ ]
16. PROFITTO RAGGIUNTO DAGLI ALUNNI
Il profitto raggiunto dagli alunni può ritenersi complessivamente quasi sufficiente. Le
differenze rispecchiano i diversi livelli d’impegno, di preparazione di base e di capacità, infatti
in qualche caso il livello raggiunto è buono o discreto, mentre il resto della classe evidenzia un
livello di preparazione appena sufficiente.
In particolare un piccolo gruppo va segnalato per i risultati scolastici raggiunti, impegnato a
realizzare insieme un buon progetto educativo, in un caso addirittura verso l’eccellenza
personale. Gli studenti di tale gruppo si sono distinti per continuità, serietà partecipazione e
capacità intellettive. Gli altri studenti non sempre sono stati continui nella partecipazione e
nel lavoro, ma sollecitati, hanno risposto positivamente soprattutto nell’ultimo periodo con
capacità di recupero o di sensibile miglioramento. I risultati finali sono altrettanto
diversificati e per molti alunni la preparazione complessiva si arresta ad una sufficienza
superficiale; essi sono giunti a tali risultati minimi verso la fine dell’anno scolastico in
preparazione dell’esame, attraverso un lavoro accelerato di ripresa degli argomenti
disciplinari e ad una più assidua presenza in classe.
17. CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI
a) capacità espositive insufficienti [ ] mediocri[ ] sufficienti[ x ] discrete [ ] buone [ ]
b) proprietà di linguaggio insufficiente [ ] mediocri[] sufficiente [ x ] discreta [ ] buone [ ]
18. PARTICOLARI SITUAZIONI DI CARRIERA SCOLASTICA, DI CREDITO SCOLASTICO O FORMATIVO
E OGNI ALTRO ELEMENTO DI GIUDIZIO
Gli studenti ripetenti hanno sostenuto gli esami integrativi relativi alle nuove materie
d’indirizzo (STA e TP).
Si rimanda alla documentazione allegata dagli studenti interessati

VITERBO 5 Maggio 2015
IL COORDINATORE del C.d.C. IL PRESIDE

RELAZIONE FINALE DI ITALIANO E STORIA
Classe 5° A informatica e telecomunicazioni
A.S. 2014/2015
Situazione della classe
La classe 5^ A informatica è stata formata comprendendo allievi provenienti dalla 4^ A informatica
dell’istituto più 4 ripetenti della ex 5^ A dell’anno scolastico precedente. All’inizio dell’anno si è
aggiunto un allievo proveniente da altro istituto.
All’interno del gruppo classe non vi sono presenti allievi con disabilità .
Il comportamento e l’approccio allo studio della classe è stato mediamente interessato e poche volte
opportunistico, in qualche caso e limitatamente ad alcuni allievi si sono verificati momenti in cui
l’assenza strategica è stata la soluzione per trarsi dai problemi, tuttavia una parte piuttosto
consistente del gruppo classe ha mostrato di partecipare con attenzione e collaborazione alle attività
proposte mettendo in luce buone capacità di organizzazione.
Dal punto di vista didattico hanno mostrato soprattutto attenzione a tematiche di carattere generale e
scarso interesse a rielaborare autonomamente i contenuti letterari, si può dire che studiare per il 6
era la massima aspirazione della maggioranza del gruppo classe nonostante ci siano stati casi di
allievi che hanno svolto in maniera egregia i lavori richiesti. Per Storia l’interesse è stato
sensibilmente più alto vista la capacità magnetica di alcune tematiche trattate durante l’anno
scolastico.
Per quanto riguarda la condotta in generale non ci sono stati momenti di criticità, seppur il
comportamento sia stato spesso vivace, data le scarse dimensioni dell’aula e la voglia di interagire
fra di loro, l’atteggiamento verso gli adulti non ha mostrato quasi mai momenti di difficoltà.
Motivo di soddisfazione a consuntivo dell’anno è che 2 o 3 allievi hanno studiato
indipendentemente dall’ambiente e dai risultati e hanno continuato fino alla fine.
I criteri del programma di italiano
Nella programmazione di Italiano si è cercato di scegliere e distribuire in un itinerario coerente
opere e autori della letteratura italiana dalla fine dell’800 fino alla 2^ metà del 900 c mettendo in
atto una didattica modulare capace di conciliare due esigenze prioritarie :
La coerenza e l’autonomia delle singole scelte modulari
La possibilità di definire alcuni elementi di continuità e di linearità fra le diverse scelte
In altre parole si è tentato di affrontare un autore attraverso le sue opere in modo esauriente,
mettendo in evidenza di quella produzione letteraria : la genesi, il rapporto con il contesto, le
principali caratteristiche tematiche e formali, alcuni rapporti con la produzione letteraria anteriore o
contemporanea.
Si è cercato inoltre di stabilire nessi, relazioni, linee di percorrenza attorno ad alcuni nodi
problematici volti a delineare elementi di continuità o di rottura della tradizione letteraria.
Pertanto gli itinerari resi in moduli omogenei e raccordabili tra loro sono stati :
I GENERI: saggistica, poesia, narrativa, teatro
LE PROBLEMATICHE STORICO-LETTERARIE : lo sviluppo della lingua, il fantastico,
la tragedia, la novella
I GRANDI TEMI DELL’UOMO : l’individuo e la società, i percorsi dell’io, l’amore
I criteri del programma di storia
programmazione di storia della classe 5^ A informatica è stata svolta seguendo le indicazioni
programmatiche del ministero e precisamente seguendo due direttrici :

La modularità degli argomenti come unità di apprendimento in sé compiuti
L’attenzione alla storia settoriale che per il corso di informatica coincide con uno sguardo
approfondito sulle problematiche storiche dell’industria sia mondiali che europee.
Proprio per la marcata caratterizzazione del programma si è preferito incentrare l’attenzione sugli
avvenimenti che hanno contrassegnato gli eventi storici del 900 dal punto di vista dello sviluppo
economico e scientifico e valutando la stretta relazione con gli eventi della storia generale. In
concreto viene allegata la costruzione dei moduli con gli schemi degli obiettivi, dei contenuti, dei
metodi e della valutazione.
DIVISIONE MODULARE DEL PROGRAMMA DI ITALIANO
Modulo 1
L’età del Positivismo: le nuove tendenze poetiche e il trionfo del romanzo
Risultato atteso : Stabilire relazioni tra le correnti artistiche e le situazioni politiche, sociali,
economiche
OBIETTIVI CONTENUTI TESTI METODOLOGIA
E STRUMENTI
VERIFICA
Competenze
Dimostrare
consapevolezza della
storicità della lingua e
della letteratura.
Leggere, comprendere
ed interpretare testi
letterari.
Padroneggiare gli
strumenti espressivi e
argomentativi
indispensabili per
gestire in vari contesti
l’interazione
comunicativa verbale.
Produrre testi di vario
tipo in relazione ai
differenti scopi
comunicativi.
Saper stabilire nessi tra
la letteratura ed altre
discipline o domini
espressivi.
Collegare tematiche
letterarie e fenomeni
della contemporaneità.
Problematiche
Processo storico e
tendenze evolutive
della letteratura, a
partire da una
selezione di autori
e testi
emblematici.
Testi, autori e
principali
movimenti
culturali della
letteratura italiana
del periodo con
riferimenti alle
letterature di altri
paesi: Carducci, la
Scapigliatura, il
Verismo.
Collegamenti del
Verismo italiano
con produzioni
letterarie e
artistiche di ambito
europeo.
La letteratura
intesa come
paesaggio e analisi
Vol. 3.1
E. e J. De
Goncourt . “un
manifesto del
naturalismo” p.60
E: Zola: “L’alcol
inonda Parigi”
p.64
L.Capuana:
“Scienza e forma
letteraria”:
l’impersonalità”
p.75
H. Ibsen: “La
presa di coscienza
di una donna”
p.115
G. Verga
“Rosso Malpelo”
p.170
“I vinti e la
fiumana” p.185
“il mondo arcaico
Libro di testo
Dizionari
Biblioteca
Quotidiani
Atlanti
cineforum
Individuali
Per gruppi
Test strutturati
Saggi di carattere
argomentativo

della nuova società
industriale e delle
classi sociali ai
margini del
progresso.
Gli autori italiani e
lo sviluppo
dell’oggettività
narrativa.
Metodi e strumenti
per l’analisi e
l’interpretazione
dei testi letterari.
e l’irruzione della
storia” p.195
“valori e interesse
nei Malavoglia “
p.200
“La conclusione
del romanzo”
p.206
“Libertà” p.217
Modulo 2
La fine del Secolo XIX: l’arte e la cultura decadente in Europa e in Italia, i poeti simbolisti,
Pascoli e D’Annunzio.
Risultato atteso : Cogliere, attraverso l’analisi, le differenze e le sfumature soprattutto fra esponenti
contemporanei della corrente letteraria.
OBIETTIVI CONTENUTI TESTI METODOLOGIA
E STRUMENTI
VERIFICA
Competenze
Dimostrare
consapevolezza
della storicità della
lingua e della
letteratura.
Leggere,
comprendere ed
interpretare testi
letterari.
Padroneggiare gli
strumenti espressivi
e argomentativi
indispensabili per
gestire in vari
contesti
l’interazione
comunicativa
verbale.
Produrre testi di
vario tipo in
relazione ai
differenti scopi
comunicativi.
Saper stabilire nessi
Problematiche
L’irrazionalismo
come unica forma di
pensiero per
spiegare il mondo
Gli scrittori e la
società borghese, i
rapporti
dell’intellettuale con
l’industria editoriale
Il rifiuto verso il
pubblico borghese.
La visione
simbolica
dell’universo: i
poeti Simbolisti
Il ruolo sociale del
poeta: Carducci,
Pascoli,
D’Annunzio
G.Carducci
“Pianto antico”
p.128
“Alla stazione in
una mattina
d’autunno” p.138
G.D’Annunzio:
“Andrea Sperelli e
Elena Muti” p.
351
“La sera
fiesolana” p.377
“la pioggia nel
pineto” p.384
G.Pascoli:
“una poetica
decadente” p.418
“X agosto” p.440
Libro di testo
Dizionari
Biblioteca
Quotidiani
Atlanti
cineforum
Individuali
Per gruppi
Test strutturati
Saggi di carattere
argomentativo

tra la letteratura ed
altre discipline o
domini espressivi.
Collegare tematiche
letterarie e
fenomeni della
contemporaneità.
“Italy” p.464
“il gelsomino
notturno” p.472
Modulo 3
La lirica del primo Novecento fra sperimentazione e innovazione: avanguardie, Futurismo,
Crepuscolarismo
Risultato atteso : Riconoscere la poetica di una corrente attraverso lo studio e l’analisi di opere e la
Individuazione di figure retoriche
OBIETTIVI CONTENUTI TESTI METODOLOGIA
E STRUMENTI
VERIFICA
Competenze
Dimostrare
consapevolezza
della storicità della
lingua e della
letteratura.
Leggere,
comprendere ed
interpretare testi
letterari.
Padroneggiare gli
strumenti espressivi
e argomentativi
indispensabili per
gestire in vari
contesti
l’interazione
comunicativa
verbale.
Produrre testi di
vario tipo in
relazione ai
differenti scopi
comunicativi.
Saper stabilire nessi
tra la letteratura ed
altre discipline o
domini espressivi.
Collegare tematiche
letterarie e
Problematiche:
L’avanguardismo e
il manifesto
futurista
Rapporto fra poeta e
popolo
Le dichiarazioni di
poetica delle
correnti letterarie
L’antiretorica nella
poesia e nella
società
Il senso profondo
della condizione
umana nella poesia
ermetica
L’intellettuale
moderno diviso fra
scelta razionale e
istintività naturale
F.T.Marinetti
“Manifesto del
futurismo” p.519
“manifesto tecnico
della letteratura”
p.522
S.Corazzini
“Desolazione di
un povero poeta
sentimentale”
p.564
Libro di testo
Dizionari
Biblioteca
Quotidiani
Atlanti
cineforum
Individuali
Per gruppi
Test strutturati
Saggi di carattere
argomentativo

fenomeni della
contemporaneità.
Modulo 4
L’età del dubbio: Svevo, Pirandello, Joyce, Woolf, Kafka
Risultato atteso : Individuare le caratteristiche essenziali del sistema narrativo del genere letterario
OBIETTIVI CONTENUTI TESTI METODOLOGIA
E STRUMENTI
VERIFICA
Competenze
Dimostrare
consapevolezza
della storicità della
lingua e della
letteratura.
Leggere,
comprendere ed
interpretare testi
letterari.
Padroneggiare gli
strumenti espressivi
e argomentativi
indispensabili per
gestire in vari
contesti
l’interazione
comunicativa
verbale.
Produrre testi di
vario tipo in
relazione ai
differenti scopi
comunicativi.
Saper stabilire nessi
tra la letteratura ed
altre discipline o
domini espressivi.
Collegare tematiche
letterarie e
fenomeni della
contemporaneità.
Problematiche
Storicizzazione del
tema: comprendere
la funzione della
persistenza o
discontinuità dei
valori
nell’immaginario
collettivo e nei vari
modelli culturali di
dell’epoca
Comprendere
analogie e
differenze nonché i
confronti fra le idee
dell’autore e
l’ideologia
prevalente nella
società
Riconoscere la
continuità e gli
influssi tra la
letteratura europea e
quella italiana
La centralità
dell’uomo e dei suoi
bisogni
La memoria e il
tempo vissuti come
individui e
collettivamente
La critica dei valori
sociali e il loro
rifiuto
I.Svevo :
“Il fumo” p.653
“la morte del
padre” p.658
“la salute malata
di Augusta” p.667
“Psico-analisi”
p.674
L.Pirandello:
“un’arte che
scompone il reale”
p.711
“Ciaula scopre la
luna” p.725
“la nuova identità
di Mattia
Pascal”p.748
“La
rappresentazione
tradisce il
personaggio”
p.811
Vol 3.2 T.Mann: “Il bel
fanciullo e il
mare” p.28
F.Kafka: “l’incubo
del risveglio” p.34
J.Joyce: “il
monologo di
Molly” p.52
V.Woolf:
“L’erosione del
Libro di testo
Dizionari
Biblioteca
Quotidiani
Atlanti
cineforum
Individuali
Per gruppi
Test strutturati
Saggi di carattere
argomentativo

Modulo 5
La poesia del ‘900 in Italia: Ungaretti, Montale, Quasimodo, Saba
Risultato atteso : Approfondire la genesi delle tematiche poetiche che caratterizzano il vissuto di un
Autore
OBIETTIVI CONTENUTI TESTI METODOLOGIA
E STRUMENTI
VERIFICA
Competenze
Dimostrare
consapevolezza
della storicità della
lingua e della
letteratura.
Leggere,
comprendere ed
interpretare testi
poetici dal punto di
vista tematico,
stilistico e
strutturale.
Padroneggiare gli
strumenti espressivi
e argomentativi
indispensabili per
gestire in vari
contesti
l’interazione
comunicativa
verbale.
Produrre testi di
vario tipo in
relazione ai
differenti scopi
comunicativi.
Conoscere i
contenuti delle
maggiori opere
degli autori del
modulo e
riconoscere gli
elementi propri
della produzione
poetica di ognuno
Analizzare la genesi
e lo sviluppo della
poesia di ogni
autore
confrontandola con
il vissuto storico
Esaminare le
tematiche affrontate
in altre arti
espressive
Ricostruire le tappe
rilevanti della
produzione poetica
e le ideologie che le
hanno ispirate
Comprendere
attraverso la lettura
di testi significativi
le caratteristiche
della poetica di
U.Saba: “A mia
moglie” p.130
“la capra” p.134
“Ulisse” p.145
G.Ungaretti: “in
memoria” p.169
“il porto sepolto”
p.171
“sono una
creatura” p.175
“Mattina” p.183
“Soldati” p.184
S.Quasimodo:
“ed è subito sera”
p.213
“alle fronde dei
salici” p.216
e. Montale :
Libro di testo
Dizionari
Biblioteca
Quotidiani
Atlanti
cineforum
Individuali
Per gruppi
Test strutturati
Saggi di carattere
argomentativo
Il personaggio al
centro della trama:
lo sconfitto
all’interno di un
ordine sociale
Il capovolgimento
della società
moderna: dal
grandioso al
quotidiano
tempo” p.61

Saper stabilire nessi
tra la letteratura ed
altre discipline o
domini espressivi.
Collegare tematiche
letterarie e
fenomeni della
contemporaneità.
ciascuno scrittore e
confrontarla con la
tipologia
dell’intellettuale del
1° dopoguerra
Confrontare affinità
e divergenze nella
trattazione tematica
tra i vari autori
Individuare in altre
arti espressive i temi
affrontati dagli
scrittori
“non chiederci la
parola” p.241
“meriggiare
pallido e assorto”
p.243
“spesso il male di
…” p.245
“la casa dei
doganieri” p.268
“non recidere
forbice…” p.288
Modulo 6
Il Secondo dopoguerra e l’esperienza della ricostruzione in Italia: Levi, Moravia, Fenoglio,
Calvino, Pasolini,
Risultato atteso : Approfondire la genesi delle tematiche politiche e storiche alla base
dell’esperienza letteraria degli autori.
OBIETTIVI CONTENUTI TESTI METODOLOGIA
E STRUMENTI
VERIFICA
Competenze
Dimostrare
consapevolezza
della storicità della
lingua e della
letteratura.
Leggere,
comprendere ed
interpretare testi
letterari.
Padroneggiare gli
strumenti espressivi
e argomentativi
indispensabili per
gestire in vari
contesti
l’interazione
comunicativa
verbale.
Problematiche
Saper esaminare le
produzioni
letterarie degli
autori del modulo
Realizzare paragoni
fra la letteratura e le
altre arti espressive
Comparare lo
sviluppo del
Neorealismo
letterario italiano
con le esperienze e
le correnti presenti
in Europa Comprendere
attraverso la lettura
di testi significativi
A.Moravia:
“l’indifferenza di
Michele” p.381
B.Fenoglio: “Il
settore sbagliato
della parte giusta”
p. 422
P.Levi: “Il canto
di Ulisse” p.441
P.P.Pasolini:
”Rimpianto del
mondo
contadino…”
p.718
Libro di testo
Dizionari
Biblioteca
Quotidiani
Atlanti
cineforum
Individuali
Per gruppi
Test strutturati
Saggi di carattere
argomentativo

Produrre testi di
vario tipo in
relazione ai
differenti scopi
comunicativi.
Saper stabilire nessi
tra la letteratura ed
altre discipline o
domini espressivi.
Collegare tematiche
letterarie e
fenomeni della
contemporaneità.
dei vari autori la
società del periodo
e l’immaginario
letterario del tempo
Contestualizzare
nel tempo e nello
spazio i diversi
autori e le
tematiche
Confrontare affinità
e divergenze nella
trattazione di una
tematica tra i vari
autori
La letteratura
neorealista e la
produzione
letteraria ‘oltre’ il
Neorealismo
I.Calvino:
“ Tutto in un
punto” p.764
“la letteratura fra
realtà e finzione”
p.769
Modulo 7 Dante Alighieri, Cantica del Paradiso:
Canti I°, VI°,
Prof Francesco Maria Cocilovo

DIVISIONE MODULARE DEL PROGRAMMA DI STORIA
Modulo 1
Il primo Novecento
Obiettivo generale atteso : Sviluppare la consapevolezza dei nessi molteplici fra storia settoriale e
storia generale
OBIETTIVI CONTENUTI METODI E
STRUMENTI
VERIFICHE
Competenze
Saper fare confronti tra
passato e presente
relativamente ai
concetti e ai contesti
affrontati
Saper fare l’analisi
guidata di fonti,
documenti e testi
storiografici di varia
complessità
Individuare peculiari
aspetti socio-
economici e culturali
della storia (qui con
particolare riferimento
al progresso
scientifico, tecnologico
e socio-politico di
inzio secolo) e
utilizzarli come
strumento per cogliere
relazioni/differenze fra
passato e presente
Acquisire una
progressiva
consapevolezza civica
nello studio dei
caratteri sociali e
istituzionali del tempo
passato (qui con
particolare riferimento
alla riflessione sul
tema delle “pari
opportunità” e della
giustizia sociale)
Tematiche
Conoscere i principali
avvenimenti politici,
militari e culturali del
primo Novecento
Conoscere e comprendere i
concetti-chiave di
positivismo, progresso,
rivoluzione sociale ed
economica, per analizzare i
fenomeni di
industrializzazione,
modernizzazione e società
di massa
Conoscere e comprendere i
concetti di imperialismo,
nazione e nazionalismo, per
analizzare la politica
interna ed estera degli Stati
europei ed extra-europei
del primo Novecento
Conoscere e comprendere
le cause economiche,
politiche e sociali che
portarono al primo conflitto
mondiale, per analizzarne
gli esiti
Conoscere e comprendere i
motivi del crollo del regime
zarista, per analizzare la
dinamica storica della
rivoluzione russa
Brainstorming
Lezione frontale
Libro di testo
Materiale fornito in
fotocopia
Schemi e mappe
Verifica intermedia
Verifica finale sul modulo

Modulo 2
I totalitarismi e la Seconda guerra mondiale
Obiettivo generale atteso : Stabilire relazioni concettuali tra i campi di studio economici e storici
OBIETTIVI CONTENUTI METODI E
STRUMENTI
VERIFICHE
Competenze
Acquisire le
competenze relative ai
contenuti del modulo
Schematizzare
mediante diagrammi
temporali i fatti storici
individuando le durate
delle strutture
economiche, politiche
e sociali
Mettere in relazione i
fatti storici
Tematizzare un fatto
riconoscendo i
soggetti, fatti, luoghi
che lo costituiscono
Raccogliere,
classificare
informazioni da fonti
diverse e compararle
Tematiche
Conoscere i principali
avvenimenti politici,
socio-economici, militari
e culturali della prima
metà del secolo XX
Conoscere e comprendere
le cause e le conseguenze
della crisi economica del
’29, analizzare le politiche
d’intervento messe in atto
sia in America sia in
Europa
Conoscere, comprendere e
analizzare i tratti distintivi
del Regime fascista
instaurato in Italia
Conoscere e comprendere
i concetti-chiave di
totalitarismo e dittatura
per analizzare i due
modelli politici del
nazismo e dello
stalinismo
Cogliere le complessità
insite nei differenti
contesti extra-europei per
comprendere i fenomeni
di mutamento e
trasformazione in atto tra
le due guerre
Conoscere e comprendere
le cause economiche,
politiche e sociali che
portarono al secondo
Brainstorming
Lezione frontale
Libro di testo
Materiale fornito in
fotocopia
Schemi e mappe
Verifica intermedia
Verifica finale sul modulo

conflitto mondiale, per
analizzare le diverse fasi e
l’esito della guerra in
Europa e nel mondo
Modulo 3
Il Mondo bipolare
Obiettivo generale atteso: Riconoscere, analizzare e valutare attraverso gli strumenti storiografici i
fenomeni sociali
OBIETTIVI CONTENUTI METODI E
STRUMENTI
VERIFICHE
Competenze
Utilizzare le conoscenze
acquisite per tematizzare e
strutturare la molteplicità
delle informazioni,
dimostrando di saper
interrogare, interpretare e
valutare le fonti
Saper individuare e
descrivere persistenze e
mutamenti
(continuità/discontinuità;
innovazione, cesura, crisi,
rivoluzione ecc.)
Individuare peculiari aspetti
socio-economici e culturali
della storia (qui con
particolare riferimento alla
contrapposizione del fra
modello capitalista e modello
comunista di sviluppo
industriale) e utilizzarli come
strumento per cogliere
relazioni/differenze fra
passato e presente
Acquisire una progressiva
consapevolezza civica nello
studio dei caratteri sociali e
istituzionali del tempo
passato (qui con particolare
riferimento alla riflessione
sulle diverse idee di
Tematiche
Conoscere i principali
avvenimenti politici,
socio-economici,
militari e culturali
degli anni Cinquanta-
Settanta del secolo XX
Conoscere e
comprendere i concetti
chiave di Guerra
fredda e bipolarismo,
per delineare i tratti
distintivi del nuovo
panorama mondiale e
per evidenziare il ruolo
dei nuovi organismi
internazionali in
campo economico,
politico e militare
Analizzare i fattori
della crescita
economica mondiale
del ventennio
Cinquanta-Settanta e
delineare i tratti
distintivi del nuovo
sistema produttivo e
dello sviluppo della
società dei consumi
Conoscere e
comprendere i fattori
che contrassegnarono i
mutamenti politici,
Brainstorming
Lezione frontale
Libro di testo
Materiale fornito in
fotocopia
Schemi e mappe
Verifica intermedia
Verifica finale sul
modulo

“democrazia” e sul tema
dell’integrazione europea e
delle istituzioni che ne sono
state e ne sono veicolo)
economici e sociali
dell’Italia tra il 1948-
1970
Modulo 4
Il mondo globalizzato
Obiettivo generale atteso: Attitudine a problematizzare tenendo conto delle dimensioni temporali e
spaziali dei fatti e dell’attualità di certi fenomeni storici
OBIETTIVI CONTENUTI METODI E
STRUMENTI
VERIFICHE
Competenze
Utilizzare le capacità
analitiche per elaborare in
modo autonomo quanto
appreso esponendo attraverso
un uso specifico del linguaggio
storico
Uso di fonti attraverso le
forme della narrazione in
rapporto a contenuti specifici
Individuazione di aspetti
socio-economico-culturali
utilizzando gli strumenti di
relazione passato/presente
Progredire nella
consapevolezza che gli eventi
passati sono in relazione alle
sfide poste dall’era della
globalizzazione
Tematiche
Conoscere i principali avvenimenti
della fine del sec XX e primo
decennio del XXI
Comprendere e analizzare le cause
che hanno portato alla fine del
mondo bipolare e il passaggio alla
globalizzazione
Comprendere e analizzare i conflitti
e le trasformazioni politico, sociali
che nel mondo hanno generato
nuovi scenari e nuovi equilibri
internazionali
Analizzare i tratti distintivi della
globalizzazione economica, per
capire la delocalizzazione, la
deindustrializzazione e la
terziarizzazione.
Delineare i tratti distintivi del
modello di sviluppo economico del
sec XXI
Brainstorming
Lezione
frontale
Libro di testo
Materiale
fornito in
fotocopia
Schemi e
mappe
Verifica
intermedia
Verifica
finale sul
modulo
Prof. Francesco Maria Cocilovo

Relazione finale per la classe V A informatica
Anno scolastico 2014/2015
Materia: lingua Inglese
Insegnante: Nicoletta Salani
La classe V a informatica è composta da una studentessa e da 27 studenti e si
presenta alquanto disomogenea dal punto di vista della preparazione e delle
competenze raggiunte che risultano nel complesso accettabili. La continuità
didattica con questa classe è di tre anni con la metà della classe e di cinque con
l’altra parte. Durante gli scorsi anni scolastici, fino al terzo, la classe ha reagito
positivamente ed ha mostrato un certo impegno e voglia di migliorare. Il quarto e
l’anno in corso diversamente sono stati caratterizzati da una certa resistenza
generale verso le attività didattiche e comunicative e soprattutto verso lo studio.
Questo atteggiamento ha frammentato il percorso ed ha comportato un andamento
generalmente faticoso. Nonostante tutte le difficoltà incontrate, una parte dei
ragazzi ha sempre cercato di colmare le lacune e di migliorare soprattutto
l’esposizione orale che in alcuni casi rappresentava un ostacolo insormontabile. Si è
anche cercato di lavorare sulla comprensione del testo e la formulazione di frasi
semplici indispensabili per la terza prova.
Alla fine dell’anno quindi la classe può essere divisa in tre principali fasce di livello:
una sufficiente, una nel complesso discreta e l’ultima composta da rari casi di
eccellenza.
Il programma svolto comprende una buona parte di testi legati alla specializzazione
della classe ed un gruppo di testi connessi con la civiltà. Questo anno si è scelto di

trattare la civiltà americana in quanto quella inglese era stata presa in
considerazione lo scorso anno.
In questi ultimi due anni (quanto e quinto) la classe è stata coinvolta in un progetto
che tende a stimolare l’uso dell’inglese nella comunicazione ed a motivare gli
studenti alla partecipazione agli esami internazionali B1 e B2. I ragazzi hanno avuto
la possibilità di assistere alle lezioni di un madrelingua una volta alla settimana. Il
testo utilizzato per tale scopo è Tell me more (Zanichelli). Alcune verifiche svolte
durante l’anno si riferiscono alla valutazione di tali competenze.
L’insegnante
Prof.ssa Nicoletta Salani

CLASSE: 5°A Informatica
MATERIA: Inglese INSEGNANTE: Prof.ssa Nicoletta Salani
Testo: NEW SURFING THE WORLD Pagina
The U.S.A Introduction 90
Different regions, different cultures.
Different regions, different cultures 118. 119
The Northeast New England, The Pilgrim fathers 120
The mid-Atlantic states 122
Philadelphia 122
Washington D.C. 123
New York city The Big Apple 124
The Civil Rights Movement
The Civil Rights Movement 112
The March to Montgomery 112
Martin Luther King 112
Black Movement 113
The Fifties The Affluent Society 158
The ‘Beat Generation’ 159
The ‘Cold War’ 159
The Conquest of the West
Westward expansion 132
The frontier 133
The pioneers and the Indian wars 133
North and South The America Civil War 138
Reconstruction in the post-slavery South 139
Segregation 139
Testo: TOTALLY CONNECTED Pagina
Operating systems Database managers 143
What can database manager do? 145
DBMs 152
Program Development
What is a computer program 204
Software in perspective 205
The first step: understanding the problem 207
Developing the algorithm 209
Writing the program 211
Documenting the program 214
Testing and debugging the program 215
Errors 217
Flowcharting 220
A subprogram 226
Our wired world Types of Newtork
Local-Area Newtork (LANs) 276
Metropolitan-Area Network (MANs) 276
Wide-Area Network (WANs) 277
Storage –Area Network (SANs) 277
Personal Area Network (PANs) 277
Topologies Physical topology 284
Logical topology 284

RELAZIONE FINALE PER L’INSEGNAMENTO DI MATEMATICA
Classe: 5ª A Informatica a.s. 2014/2015
Docente: EMANUELA POMI
N° ore settimanali: 3 + 1 (modulo orario)
N° ore effettive di lezione svolte (fino al 07 maggio): 80 + 27
N° ore previste entro la fine dell’a.s.: 91 + 4
BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E STRATEGIE DI LAVORO
La classe VAi, che ho seguito per l’intero triennio, è sempre stata caratterizzata da una buona vivacità
che con il tempo e la consuetudine, a volte purtroppo è anche degenerata in atteggiamenti
eccessivamente “disinvolti”; il rapporto fra gli studenti invece è stato improntato al rispetto reciproco e
non sono mancate situazioni di avvicinamento nel segno della compensazione. La classe, attualmente
composta da 29 ragazzi con un’unica presenza femminile, ha subito quest’anno un notevole
cambiamento perché si sono aggiunti 5 studenti ripetenti, che si sono subito ben integrati, ma la gestione
degli spazi e dei tempi è stata piuttosto complicata e faticosa. Gli studenti nel complesso, hanno
mantenuto un sufficiente impegno nello studio sebbene non tanto costante quanto piuttosto intensificato
in prossimità di verifiche orali o scritte e con qualche eccezione, naturalmente; sporadici casi in cui si è
palesato un marcato disimpegno. Anche la partecipazione alla didattica è stata attiva e propositiva e,
sempre in termini generali, si è riscontrata una discreta assiduità nella frequenza alle lezioni. L'interesse
nei confronti della disciplina è stato complessivamente accettabile, buono per alcuni allievi che hanno
mostrato curiosità intellettuale e desiderio di affermazione, eccellente in un caso anche per il livello di
approfondimento e la costanza di studio.
Per cercare di raggiungere gli obiettivi didattici programmati in sede di Dipartimento ho utilizzato la
lezione frontale generalmente solo per l’introduzione e la spiegazione di nuovi argomenti guidando poi i
ragazzi verso la scoperta dei metodi, delle applicazioni e delle conseguenze (lezione laboratoriale).
Laddove è stato possibile le lezioni teoriche sono state condotte partendo da situazioni problematiche
iniziali (problem solving), per cercare di coinvolgere gli studenti nella ricerca della soluzione e
comunque sempre corredate da esempi esplicativi, preferibilmente svolti alla lavagna dagli stessi allievi
opportunamente guidati. L’insegnante ha assecondato, indirizzato e valorizzato, il lavoro cooperativo
dei gruppi che spontaneamente si sono creati in classe, mentre a causa della eccessiva numerosità non è
stato possibile curare all’attività individuale come si sarebbe voluto, ossia con frequenti verifiche
singole e puntuali volte a monitorare le conoscenze e competenze acquisite dallo studente, per dargli la
possibilità di autovalutare le proprie capacità e soprattutto per fornire ulteriori spiegazioni ed
approfondimenti laddove ce ne fosse bisogno. Durante le lezioni che non prevedono spiegazioni ci sono
state fasi di eventuali chiarimenti, correzione dei compiti, verifiche orali, verifiche scritte sempre seguite
dalla correzione e discussione sui problemi incontrati dagli studenti, attività di esercitazione e
consolidamento, lezioni di recupero. L’ora di modulo orario è stata impiegata prevalentemente per il
recupero o come tempo aggiunto da dedicare allo svolgimento dei compiti in classe.
Nel corso di questi anni , ho cercando di legare ogni singolo argomento alle conoscenze pregresse,
pertanto anche temi del primo biennio potevano essere richiamati in quanto utili nelle applicazioni del

nuovo argomento; ho mostrato agli studenti varie possibili tecniche risolutive spiegandone il diverso o il
più opportuno utilizzo, infine ho privilegiato la fase applicativa rispetto a quella puramente teorica per
favorire il consolidamento delle acquisizioni.
CONTENUTI Il programma svolto, che è quello previsto all’inizio dell’anno, è specificato negli allegati.
STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI
Le verifiche sono state orali, scritte. Le prove scritte sono state sostanzialmente compiti tradizionali
(esecuzione di esercizi) e questionari con test a risposta aperta e chiusa.
Sono state verificate:
- la conoscenza di regole, termini e proprietà
- la comprensione dei concetti, di relazioni, di procedure
- l’applicazione delle tecniche nelle diverse situazioni.
Le prove scritte mi hanno consentito di valutare la conoscenza dei concetti specifici, l’abilità di
risoluzione di esercizi, la capacità di motivare i passaggi logici. Attraverso i colloqui orali mi ero
proposta di favorire anche l’uso del linguaggio specifico al fine di valutarne la padronanza, ma i risultati
ottenuti, devo ammettere, in generale sono deludenti.
Agli alunni sono stati di volta in volta esplicitati i criteri di valutazione, che hanno tenuto conto della
quantità e qualità delle conoscenze e della correttezza ed efficacia dei metodi risolutivi.
Nella valutazione sommativa ho tenuto conto inoltre degli interventi sia alla lavagna che dal posto, della
partecipazione all’attività didattica, della costanza nell’impegno, del livello iniziale e del ritmo di
apprendimento.
Sulla base della programmazione iniziale e delle indicazioni emerse alle riunioni per materie, la
valutazione è stata condotta secondo i seguenti criteri:
2: interesse e partecipazione nulli, conoscenze e abilità applicative quasi nulle.
3: interesse e partecipazione scarsi, conoscenze sporadiche, abilità applicative molto scarse.
4: interesse e partecipazione scarsi, conoscenze frammentarie, abilità applicative scarse.
5: interesse e partecipazione saltuari, abilità applicative limitate.
6: interesse e partecipazione accettabili, conoscenza dei nuclei essenziali del programma,
abilità applicative generalmente autonome in problematiche semplici.
7: interesse e partecipazione continui, conoscenza completa e consapevole del programma,
abilità applicative nelle problematiche note.
8: interesse e partecipazione costruttiva, conoscenze complete e approfondite, abilità
applicative in contesti diversi.

9-10: interesse profondo e partecipazione proficua, conoscenze complete approfondite e
ampliate, abilità applicative in contesti diversi e rielaborazioni critiche personali.
OBIETTIVI COGNITIVI
Ci si è proposti di far raggiungere a ogni alunno i seguenti obiettivi:
conoscenza consapevole dei vari argomenti;
comprensione delle loro implicazioni e connessioni;
applicazione con esercitazioni frequenti e varie.
QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE
È piuttosto complesso effettuare una sintesi degli obiettivi raggiunti perché la classe è caratterizzata da
vistose differenze in ordine alle capacità, alla preparazione di base e all’interesse. Si può sicuramente
affermare che nel complesso la classe ha seguito con continuità il lavoro proposto, ma i risultati
raggiunti sono assai difformi; uno studente ha mostrato nel triennio una buona propensione verso la
materia e un impegno sistematico nello studio distinguendosi così per l’eccellente profitto, un altro
piccolo gruppo di allievi è riuscito ad impadronirsi di un metodo di studio efficiente e ben organizzato
che ha permesso loro di raggiungere buoni risultati, mentre il resto della classe evidenzia un profitto
medio appena sufficiente e, quindi solo relativamente a casi semplici, oppure con qualche suggerimento,
questi ragazzi riescono a portare a termine lo svolgimento degli esercizi proposti.
Viterbo 07 Maggio 2015 L’insegnante
Emanuela Pomi

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
“Leonardo da Vinci“
VITERBO
a.s. 2014/2015 Classe 5ªAi
Programma di Matematica
Integrali indefiniti.
(Vol 5_ CAPITOLO 19_Trattazione teorica da pag. 1354 fino a pag. 1369; esercizi relativi)
Obiettivi: Comprensione del concetto di Integrale indefinito.
Corretto uso delle tecniche di calcolo.
Integrale indefinito.
Proprietà dell’integrale indefinito.
Integrali immediati di funzioni elementari.
Integrali immediati di funzioni composte.
Integrazione di funzioni razionali fratte (con denominatore di 1° o 2° grado).
Integrazione per sostituzione (solo semplici casi).
Integrazione per parti [con dim.].
Integrali definiti.
(Vol 5_ CAPITOLO 19_Trattazione teorica da pag. 1370 fino a pag. 1380, esclusa pag. 1375; esercizi
relativi)
Obiettivi: Comprensione del concetto di Integrale definito.
Calcolo dell’integrale definito.
Integrale definito di una funzione continua.
Proprietà degli integrali definiti (escluse quelle che lo caratterizzano come
operatore lineare ed ereditate dall’integrale indefinito).
Teorema della media [con dim.].
La funzione integrale.
Teorema fondamentale del calcolo integrale (o Teor. di Torricelli-Barrow) [con dim.].
Formula fondamentale del calcolo integrale (o di Newton-Leibniz) .

Calcolo delle aree.
(Vol 5_ CAPITOLO 19_Trattazione teorica pag. 1381-1382; esercizi relativi)
Obiettivi: Applicazione dell’integrale definito alla risoluzione di semplici problemi geometrici
Utilizzare il calcolo integrale per calcolare aree di superfici piane.
Calcolo dell’area del trapezoide.
Calcolo dell’area di una superficie piana compresa tra due funzioni.
Funzioni di due variabili.
(Vol 4_ CAPITOLO 16_ Trattazione teorica pag. 1175, pag. 1181-1182, pag. 1185, da pag
1187 a pag 1192; esercizi relativi limitatamente alle funzioni intere razionali)
Obiettivi: Comprensione del concetto di funzione in due variabili.
Derivate parziali e abilità di calcolo.
Determinazione e classificazione dei punti stazionari di funzioni algebriche razionali intere.
Definizione di funzioni di due variabili: definizione di dominio.
Derivate parziali del primo ordine.
Derivate parziali del secondo ordine.
Teorema di Schwarz. (*) (solo enunciato)
Massimi e minimi assoluti e relativi (punti estremanti).
Determinante hessiano. (*)
Punti stazionari (massimi, minimi relativi o punti di sella): determinazione dei punti
stazionari e classificazione con il determinante hessiano della funzione. (*)
Equazioni differenziali.
(Vol 5_ CAPITOLO 20_ Trattazione teorica da pag. 1466 fino a pag. 1470, pag. 1473-1474, da pag 1476
a pag. 1480; esercizi relativi)
Obiettivi: Saper riconoscere e risolvere i vari tipi di equazioni differenziali.
Integrale generale e integrale particolare di un’eq. differenziale.
Teorema di Cauchy. (per le eq. diffenziali del primo ordine ) (*)

Equazioni differenziali del primo ordine:
equazioni del tipo y’=f(x),
equazioni a variabili separabili,
equazioni lineari [con dim.] (*)
Equazioni differenziali del secondo ordine:
equazioni del tipo y’’=f(x),
equazioni lineari omogenee a coefficienti costanti,
equazioni lineari non omogenee a coefficienti costanti:
)(''' xpybyay con termine forzante p(x) di tipo polinomiale.
Testo in adozione:
M. Bergamini - A. Trifone- G. Barozzi MATEMATICA.verde
(*) Argomento in corso di svolgimento da completare nel entro la fine dell’a.s.
avendone informato gli studenti.
Viterbo 07/05/15 L’ insegnante
Emanuela Pomi

INFORMATICA
RELAZIONE CONCLUSIVA Anno scolastico 2014/2015 Docente: Lina Deriu
L'attuale classe quinta e' composta da ventinove studenti (ventotto ragazzi e una sola ragazza) ed ha vissuto nel corso del triennio un curriculum di studi regolare per quanto riguarda l'insegnamento dell'informatica. Nonostante questo la classe si presenta eterogenea , evidenziando in questa disciplina diversi livelli di attitudine, interesse e impegno. L'interesse nei confronti della disciplina è da considerarsi complessivamente più che sufficiente, buono per i pochi allievi particolarmente dotati che hanno mostrato curiosità intellettuale, voglia di apprendere e costanza di studio, mentre il resto della classe, ha a volte palesato una certa discontinuità di studio.
Contenuti Obiettivo generale del programma e' stato quello di fornire le competenze e le metodologie necessarie ad analizzare, realizzare e documentare un progetto software con l’uso di basi di dati , cercando di sviluppare la capacità critica necessaria al dimensionamento dei problemi nei vari settori d'applicazione. E’ stata trattata in modo approfondito la parte relativa alla modellazione concettuale e logica di una base di dati e la conoscenza del linguaggio standard SQL. Il software DBMS di laboratorio è stato “MSACCESS”, scelto per la semplicità, diffusione d’uso e di conseguenza il linguaggio di interfacciamento ai dati è stato Visual C#, e per l’implementazione delle pagine Web dinamiche si è utilizzata la tecnologia ASP.NET. Proprio a riguardo delle problematiche relative alla programmazione client/server e alla distribuzione di applicazioni INTERNET, il tempo dedicato alla realizzazione di web server application, seppur sufficiente, non è stato così importante quanto avrei voluto, soprattutto a causa della concomitanza di numerosi eventi scolastici ai quali la classe ha partecipato. Gli studenti sono stati messi al corrente delle nuove modalità della seconda prova dell’Esame così come raccomandato dal Miur. In particolare la simulazione della seconda prova ha tenuto conto di tali modifiche e si allega sia il testo che la griglia di valutazione.
Metodologia CLIL La DNL (disciplina non linguistica) scelta per la metodologia CLIL è stata INFORMATICA, e pur non essendo ancora in possesso delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche all'interno dell'organico dell'Istituzione scolastica, sono stata l'unica del CdC ad aver frequentato il corso di approfondimento linguistico di 120 ore organizzato dal Miur che si è completato alla fine di dicembre e ad essere in attesa dei corsi metodologici. Le lezioni previste dalla programmazione iniziale secondo la metodologia CLIL hanno riguardato “Data Base Conceptual Modeling” e parzialmente “ “Data Base Logical Modeling”, ma le ore dedicate sono state poche sia perché era la prima volta che usavo la metodologia, sia perché perchè ho preferito dedicare lo scarso tempo a disposizione per trattare tutti gli argomenti previsti dalla programmazione iniziale con il giusto livello di approfondimentoin lingua italiana. Comunque in ogni occasione, data la natura della materia, sono stati fatti richiami linguistici in inglese per consentire agli studenti di acquisire un adeguato glossario di termini tecnici.
Rendimento La classe nel corso del triennio ha sempre dimostrato interesse alle lezioni, ma lo scarso lavoro individuale e qualche momento di maggiore rilassamento hanno condizionato il rendimento di una parte di loro, soprattutto nell'analisi e nella progettazione tecnica. Il profitto generale può ritenersi nel complesso sufficiente. Un piccolo gruppo ha raggiunto una buona preparazione, dovuta all'impegno, all'interesse personale e all'attitudine, mentre il resto della classe ha raggiunto un livello di conoscenza nel complesso sufficiente. Rimane però da dire

che alcuni studenti hanno evidenziato un rendimento mediocre soprattutto a causa di un impegno discontinuo o, in rarissimi casi, a causa di una modesta predisposizione alla materia.
Comportamento Il comportamento degli studenti è stato sempre cordiale e rispettoso delle regole di comportamento. A questa maturità, però non sempre e non per tutti ha corrisposto un’ uguale maturità nell'affrontare e seguire le regole didattiche. Il comportamento relativo agli adempimenti scolastici infatti si è differenziato, evidenziando un gruppo ristretto che si è impegnato seriamente e con continuità, nell'arco di tutto il triennio, partecipando attivamente a tutti i progetti professionalizzanti, agli stage proposti e alle iniziative extra scolastiche, mentre un altro gruppo ha dimostrato a volte discontinuità soprattutto nello studio individuale, nella frequenza e nel rispetto delle consegne e scadenze.
L’insegnante Lina Deriu

I.T.S.I.G. 'LEONARDO DA VINCI'
VITERBO
INFORMATICA GENERALE APPL.TECNICO-SCIENTIFICHE E LABORATORIO Programma svolto nella classe V/A sez. Informatica Anno scolastico 2014/2015 Insegnante: Lina Deriu Codocente: Giosuè Silvestro ________________________________________________________________________
__ DATA BASE
• (Libro di testo ”Le basi di dati e il linguaggio SQL” di A.Lorenzi e D.Rossi ATLAS, pag 42-158):
• • Problematiche relative all’archiviazione tradizionale e al passaggio alla
memorizzazione integrata dei dati • La ridondanza e l'inconsistenza dei dati nell'archiviazione tradizionale • I tre livelli di modellazione dati • La modellazione dei dati concettuale • Caratteristiche di un DBMS • Caratteristiche dei linguaggi per database
• • La progettazione concettuale:
• il modello semantico dei dati • Le entità e le loro possibili associazioni: 1 a 1 , 1 a N, N a M • Le associazioni ricorsive • Modello E-R • Regole di lettura
• Concetto generale di un DBMS:
• I modelli logici: relazionale e cenni all’architettura dei modelli gerarchico e reticolare • compiti di un DBMS • DDL, DML e DCL •
• Il modello relazionale: •
• I concetti fondamentali del modello relazionale
• La derivazione delle relazioni dal modello E-R: rappresentazione di entità ed associazioni con il modello relazionale
• Concetto di chiave primaria, chiave candidata, chiave secondaria e chiave esterna. • Gli operatori principali del modello relazionale : selezione, proiezione e
congiunzione (join interni ed esterni, left join e right join e self join) • La normalizzazione: 1FN, 2FN, 3FN e Forma normale di Boyce-Codd • Integrità referenziale, DBMS e funzioni del DBMS

• Il linguaggio SQL: •
• Concetti di SQL standard • Identificatori e tipi di dati • Principali istruzioni DDL (CREATE TABLE, ALTER TABLE, CREATE INDEX, FROP
INDEX) • Principali istruzioni DML (INSERT, UPDATE E DELETE) • Le query SQL
• SELECT e operazioni relazionali nel linguaggio SQL (selezione, Join e proiezione)
• Le funzioni di aggregazione (SUM,COUNT, MIN, MAX, AVG) • Ordinamenti e raggruppamenti (clausole ORDER BY, GROUP BY E
HAVING) • Le condizioni di ricerca (BETWEEN, IN, LIKE, IS NULL) • Le interrogazioni nidificate (clasusole ANY, ALL, IN, EXISTS)
• I comandi per la sicurezza(GRANT e REVOKE) • Le viste (CREATE VIEW e DROP VIEW) •
• Data base in rete (fotocopie del testo “Progettazione dei database, Linguaggio SQL e dati in rete" di A. Lorenzi e E. Cavalli ATLAs, pag 371-412)
• • Web server e ambiente di lavoro nella tecnologia ASP.net • La tecnologia ASP.net • Gli oggetti delle pagine ASP.net • Accesso ai dati con ADO.net • I controlli per la visualizzazione dei dati • Uso dei comandi SQL nelle pagine ASP.net •
• Metodologia CLIL (fotocopie fornite dal docente) •
• The E-R model to describe data, • Entities, attributes and relationship 1:1, 1:N, N:M. • The rules of E-R diagram. • Relational database
LABORATORIO (appunti dei docenti e libro di testo pag.181- 204):
Il linguaggio HTML
• Introduzione all’HTML
• Studio ed utilizzo dei TAG principali
• inserimento di immagini in una pagina web
• I Moduli in Html Creazione e gestione dei metodi
• Target dei collegamenti Ipertestuali
• Gestione degli eventi
• Javascript
• tipi di dati
• strutture di controllo
• funzioni
• Gestione degli eventi

• Gestione dell’input e dell’output
L’ambiente ACCESS
• Creazione di un database in SQL
• Creazione e gestione di tabelle in SQL
• L’integrità referenziale in SQL
• Gestione Query in SQL
•
Tecnologia ASP.NET
• Script lato Server in C#;
• Costruzione di pagine ASP.net
• Accesso ai dati con ADO.net
• I controlli per la visualizzazione dei dati
• Uso dei comandi SQL nelle pagine ASP.NET
• Costruzione di siti web dinamici con l'accesso ai dati in ASP.NET
• Realizzazione di semplici applicazioni per la gestione di basi di dati con l’uso dei controlli
standard;
LIBRI DI TESTO E MATERIALI USATI
• Libro di testo: “Le basi di dati e il linguaggio SQL” - di A.Lorenzi e D.Rossi – ed. ATLAS
• Fotocopie del testo “Progettazione dei database, Linguaggio SQL e dati in rete” • di A. Lorenzi e E. Cavalli ed. ATLAS
• Appunti dei docenti
_______________________________________________________________________ Il Docente Gli studenti Il Codocente

ISTITUTO TECNICO STATALE SETTORE TECNOLOGICO “Leonardo da Vinci”
VITERBO
________________________________________________________________________
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO 2014/2015
- CLASSE 5^AI –
DISCIPLINA: SISTEMI E RETI
________________________________________________________________________
La classe, costituita da 29 alunni (1 femmina e 28 maschi), si è dimostrata molto vivace; le norme
della vita scolastica sono state abbastanza rispettate e solo un numero ristretto di studenti, che si è
assentato con una certa frequenza, ha avuto bisogno di ripetuti richiami e stimoli per essere
maggiormente coinvolto durante le ore di lezione.
Dal punto di vista didattico, nel complesso, gli studenti seppur impegnati e motivati al lavoro
scolastico e all’apprendimento in modo eterogeneo, in riferimento alla programmazione curriculare,
hanno conseguito i seguenti obiettivi, espressi in termini di macro-competenza:
1. configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti;
2. scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;
3. descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di
telecomunicazione;
4. gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali
di gestione della qualità e della sicurezza;
5. utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare;
6. analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale
e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro,
alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.
Le attività svolte in linea generale, secondo i tempi e le modalità programmate (si rimanda al

“documento di programmazione”), sono state articolate in: lezioni frontali e partecipate,
esercitazioni scritte e pratiche al computer, attività di gruppo, monitoraggio dello svolgimento delle
esercitazioni, discussioni guidate per la correzione degli esercizi svolti a scuola/casa, interventi di
recupero e proposte di approfondimento (per gli alunni più motivati).
Per valutare l'efficacia dell'intervento didattico e verificare il raggiungimento degli obiettivi
prefissati, sono state utilizzate diverse tipologie di prove: interrogazioni individuali, prove semi-
strutturate, lavori individuali e/o di gruppo in aula e/o in laboratorio, esercizi svolti a casa/in classe,
monitoraggio continuo delle attività pratiche svolte al computer.
Le prove sono state valutate in base agli indicatori espressi nelle rubriche approvate in sede di
Collegio dei Docenti.
Durante l’anno scolastico, gli studenti si sono potuti avvalere dei seguenti sussidi, utili ai fini
dell’apprendimento: libro di testo, schemi, “risorse Web”, dispense e raccolta di esercizi del
docente, lavagna, proiettore e computer.
Discreti sono stati infine, i rapporti con le famiglie soprattutto in occasione dei ricevimenti generali.
I DOCENTI
Prof.ssa Rebecca Pietrella
Prof. Giosuè Silvestro

DISCIPLINA: SISTEMI E RETI
________________________________________________________________________
Classe: 5^ AI
Anno scolastico: 2014/2015
Testi di riferimento:
E. Baldino, R. Rondano, A. Spano, C. Iacobelli, “INTERNETWORKING SISTEMI E RETI” – Secondo biennio, ed. Juvenilia Scuola
E. Baldino, R. Rondano, A. Spano, C. Iacobelli, “INTERNETWORKING SISTEMI E RETI” – Quinto anno, ed. Juvenilia Scuola
________________________________________________________________________
PROGRAMMA SVOLTO
Modulo 1: I fondamenti del networking
Competenze di ambito
Abilità Conoscenze
Rif. macro-
competenza:
N.1, N.2, N.4, N.5
Comprendere il funzionamento di una architettura di rete a strati
Classificare una rete e i servizi offerti con riferimento agli standard tecnologici
Gestire le reti secondo le normative
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese
Modelli standard di riferimento per le reti: Architettura di rete;
Protocolli e PDU, servizi e
primitive;
Modello ISO/OSI;
Architettura TCP/IP;
Enti internazionali che
definiscono standard in ambito
TLC
Modulo 2: Il livello Transport dell’architettura TCP/IP
Competenze di ambito
Abilità Conoscenze
Rif. macro-
competenza:
N.1, N.2, N.4, N.5
Comprendere il funzionamento di una architettura di rete a strati
Capire come funzionano i livelli alti dello stack TCP/IP
Usare i numeri di porta opportuni per le comunicazioni Client-Server tra applicativi
Scegliere il tipo di protocollo di trasporto in base al grado di affidabilità, velocità e alla sicurezza del servizio che si vuole offrire
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese
Servizi di indirizzamento del livello Transport
Funzionalità di multiplexing e demultiplexing
Un protocollo di trasporto connectionless: UDP
Un protocollo di trasporto connection-oriented: TCP
Fasi di una comunicazione TCP
Confronto tra i protocolli UDP e TCP
Controllo delle porte (comandi di rete in ambiente Windows)

Modulo 3: Il livello Application dell’architettura TCP/IP
Competenze di ambito
Abilità Conoscenze
Rif. macro-
competenza:
N.1, N.4, N.5
Comprendere il funzionamento di una architettura di rete a strati
Scegliere il tipo di protocollo in base all’applicazione che si vuole utilizzare
Sviluppare applicazioni che utilizzano i protocolli del livello application
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese
Livello Application e i suoi protocolli FTP: il protocollo per il trasferimento di
file
HTTP: il protocollo per le applicazioni
Web
SMTP, POP3 e IMAP4
DNS e la risoluzione dei nomi
Sviluppo di applicazioni in ambiente Windows che utilizzano il protocollo
SMTP
Modulo 5: La gestione delle reti e dei sistemi
Competenze di ambito
Abilità Conoscenze
Rif. macro-
competenza:
N.1, N.2, N.3, N.4,
N.5
Scegliere gli strumenti più adeguati per mantenere sotto controllo la rete
Utilizzare gli strumenti per il troubleshooting in ambiente Windows
Sviluppare applicazioni per interrogare/gestire i dispositivi di una rete locale
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese
Strumenti per la gestione della rete
Problem solving e troubleshooting Strumenti per il troubleshooting in
ambiente Windows
Sviluppo di applicazioni in linguaggio c# per interrogare/gestire i dispositivi di una rete locale
Modulo 4: La qualità del servizio (QoS)
Competenze di ambito
Abilità Conoscenze
Rif. macro-
competenza:
N.1, N.4, N.5
Classificare una rete e i servizi offerti con riferimento agli standard tecnologici
Scegliere la configurazione di rete che meglio soddisfi le richieste di QoS delle applicazioni
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese
Reti multi servizio Problematiche connesse alla gestione
dei flussi critici
Service Level Agreement
Tecniche per la qualità del servizio Meccanismi di trattamento del traffico
Integrated Services e Differentiated Services

Modulo 6: La sicurezza delle reti e dei sistemi
Competenze di ambito
Abilità Conoscenze
Rif. macro-
competenza:
N.1, N.2, N.3, N.4,
N.5, N.6
Identificare le fonti di rischio
Riconoscere, utilizzare e implementare le tecnologie/tecniche per garantire la sicurezza e l’integrità dei dati, dei sistemi e della rete
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese
Gestione dei rischi
Sicurezza fisica
Sicurezza dei dati e dei programmi
Controllo degli accessi
Password
Sicurezza in rete
Crittografia: algoritmi e chiave Crittografia a chiave simmetrica
Crittografia a chiave asimmetrica
Crittografia ibrida
Autorità di certificazione per la
gestione delle chiavi
Sintesi di messaggi
Gateway e servizi integrati: proxy, firewall, NAT e DMZ
Firma digitale
Sviluppo di applicazioni in linguaggio c # per la gestione delle problematiche relative alla sicurezza
Modulo 7: La scheda Arduino
Competenze di ambito
Abilità Conoscenze
Rif. macro-
competenza:
N.1, N.2, N.3, N.5
Individuare le caratteristiche della scheda utilizzata
Scegliere una scheda in base alle caratteristiche funzionali
Programmare una scheda
Origini
Caratteristiche
Ambiente di programmazione (Sketch)
Programmazione di una scheda per l’accensione/spegnimento di led
Programmazione di una scheda per l’interazione con un sensore di temperatura
I DOCENTI
Prof.ssa Rebecca Pietrella
Prof. Giosuè Silvestro

ISTITUTO TECNICO STATALE SETTORE TECNOLOGICO “Leonardo da Vinci”
VITERBO
________________________________________________________________________
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
ANNO SCOLASTICO 2014/2015
- CLASSE 5^AI –
DISCIPLINA: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI
________________________________________________________________________
La classe ha risposto in maniera adeguata al dialogo educativo e soltanto un numero ristretto di
studenti ha avuto bisogno di ripetuti richiami e stimoli per essere maggiormente coinvolto durante
le ore di lezione.
Dal punto di vista didattico, nel complesso, gli studenti seppur impegnati e motivati al lavoro
scolastico e all’apprendimento in modo eterogeneo, in riferimento alla programmazione curriculare,
hanno conseguito i seguenti obiettivi, espressi in termini di macro-competenza:
1. sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza;
2. scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;
3. gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di
gestione della qualità e della sicurezza;
4. gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali;
5. configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti;
6. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
Le attività svolte in linea generale, secondo i tempi e le modalità programmate (si rimanda al
“documento di programmazione”), sono state articolate in: lezioni frontali e partecipate,
esercitazioni scritte e pratiche al computer, attività di gruppo, monitoraggio dello svolgimento delle
esercitazioni, discussioni guidate per la correzione degli esercizi svolti a scuola/casa, interventi di
recupero e proposte di approfondimento (per gli alunni più motivati).
Per valutare l'efficacia dell'intervento didattico e verificare il raggiungimento degli obiettivi

prefissati, sono state utilizzate diverse tipologie di prove: interrogazioni individuali, prove semi-
strutturate, lavori individuali e/o di gruppo in aula e/o in laboratorio, esercizi svolti a casa/in classe,
monitoraggio continuo delle attività pratiche svolte al computer.
Le prove sono state valutate in base agli indicatori espressi nelle rubriche approvate in sede di
Collegio dei Docenti.
Durante l’anno scolastico, gli studenti si sono potuti avvalere dei seguenti sussidi: libro di testo,
schemi, “risorse Web”, dispense e raccolta di esercizi del docente, lavagna, proiettore e computer.
Abbastanza soddisfacenti, soprattutto dal punto di vista qualitativo, sono stati infine, i rapporti con
le famiglie, in occasione dei ricevimenti generali.
Viterbo, _________________ I DOCENTI
Prof.ssa Rebecca Pietrella
Prof. Giosuè Silvestro

DISCIPLINA: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI
________________________________________________________________________
Classe: 5^ AI
Anno scolastico: 2014/2015
Testi di riferimento:
C. Iacobelli, M. Ajme, V. Marrone, F. Beltramo, “Progettazione tecnologie in movimento” – Secondo biennio, ed. Juvenilia Scuola
C. Iacobelli, E. Baldino, F. Beltramo, R. Rondano, “Progettazione tecnologie in movimento” – Quinto anno, ed. Juvenilia Scuola
________________________________________________________________________
PROGRAMMA SVOLTO
Modulo 2: I fondamenti del “ciclo di sviluppo del software”
Competenze di ambito
Abilità Conoscenze
Rif. macro-
competenza:
N.1, N.3, N.4, N.6
Identificare le fasi di un progetto nel contesto del ciclo di sviluppo
Progettare e documentare le fasi di sviluppo software
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese
Utilizzare un tool di documentazione dei casi d’uso di un sistema
Ingegneria del software
Ciclo di vita del software
Manutenzione e gestione del progetto
Approccio metodologico ai progetti
Modelli di processo (strutturato e object oriented)
Progettazione con UML
La modellazione funzionale: il diagramma dei casi d’uso
Funzionamento di un tool per la documentazione dei casi d’uso di un sistema
Modulo 1: I fondamenti della programmazione concorrente
Competenze di ambito
Abilità Conoscenze
Rif. macro-
competenza:
N.1, N.2, N.3, N.5
Comprendere le potenzialità della programmazione concorrente
Scegliere le tecniche più appropriate per la gestione dei problemi di sincronizzazione
Progettare applicazioni in modalità concorrente gestendo i problemi di sincronizzazione
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese
Richiami al modello a processi per la gestione della CPU e alle tecniche di sincronizzazione tra processi concorrenti
Processi “leggeri”: i thread
Soluzioni single threading e multithreading
Realizzazione di un thread
Stati di un thread
Utilizzo dei thread
Implementazione di un thread in linguaggio C#
Multithreading in C#
Tecniche di sincronizzazione dei thread

Modulo 3: La specifica dei requisiti software
Competenze di ambito
Abilità Conoscenze
Rif. macro-
competenza:
N.1, N.3, N.4, N.6
Analizzare e identificare i requisiti di un sistema
Riconoscere i collegamenti dei requisiti di un sistema alle funzionalità realizzate
Scegliere software applicativi in relazione ai requisiti specificati
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese
Raccolta dei requisiti
Gestione dei requisiti
Definizione e documentazione dei requisiti
Identificazione della soluzione tecnologica in relazione ai requisiti specificati
Modulo 5: La progettazione dei siti web
Competenze di ambito
Abilità Conoscenze
Rif. macro-
competenza:
N.1, N.3, N.4,
N.6
Progettare e documentare le fasi di realizzazione di un sito web
Realizzare applicazioni orientate ai servizi
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese
Progettazione di un’interfaccia web Principi di usabilità e accessibilità
Elementi di progettazione di un sito web Studio di fattibilità e analisi dei
requisiti
Progetto generale del sito (schema
gerarchico e multidimensionale)
Raccolta e organizzazione delle
informazioni
Definizione degli scenari di utilizzo
Soluzioni per la pubblicazione,
aggiornamento e promozione
Analisi di un progetto di un sito
I DOCENTI
Prof.ssa Rebecca Pietrella Prof. Giosuè Silvestro
Modulo 4: Le architetture per le applicazioni Web
Competenze di ambito
Abilità Conoscenze
Rif. macro-
competenza:
N.1, N.3, N.4,
N.6
Individuare le componenti di un’architettura per la realizzazione di servizi
Sviluppare applicazioni per reti locali o servizi a distanza
Sviluppare applicazioni client-server con i socket
Sviluppare web services
Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese
Architetture per il software (1-tier, 2-tier, 3/n-tier e il modello Client-Server)
Architetture basate sui servizi: Service Oriented Architecture
Web Services
Simple Object Access Protocol
Sviluppo di applicazioni client-server in linguaggio c#, mono e multi-thread, per l’invio/elaborazione/risposta di numeri e
stringhe

ITT ex- I.T.I.G.S. "L. Da Vinci" - V I T E R B O
classe 5 ° A / INF - anno scol. 2014/ 2015
Breve relazione su aspetti specifici relativi alla materia:
GESTIONE PROGETTO ORGANIZZAZIONE IMPRESA
Prof. Marcello POLEGRI - Prof. Angelo GIGLIOTTI
Generalità
La classe è piuttosto numerosa (29 allievi) e sono cinque quelli ripetenti (in quanto non ammessi all’esame nell’anno precedente), oltre uno pervenuto nella classe per la prima volta quest’anno, proveniente da altro istituto e altro indirizzo di studio.
La classe, oltre quanto predetto, ha avuto un percorso movimentato: la terza, già abbastanza numerosa, si ottenne dall’accorpamento di due seconde, in quarta si aggiunsero numerosi ripetenti della corrispondente classe dell’anno precedente.
Questa materia è presente solo al quinto anno. Va segnalato che la classe, salvo un piccolo gruppo, ha seguito le attività senza particolare
entusiasmo, sia per la parte teorica che pratica, raggiungendo la maggior parte, ma
faticosamente, le abilità fondamentali richieste.
Anche la fortuità del calendario scolastico, unita a numerose attività extracurriculari, avendo
l’unica ora di teoria alla sesta del venerdì e le due ore di pratica in laboratorio alle due ultime ore
del sabato, non è stata favorevole né all’impegno continuativo , né alla completezza di svolgimento
delle attività previste.
Infine, per qualche settimana, sono mancati i laboratori, per necessità di manutenzione
straordinaria.
Contenuti
“Gestione Progetto e Organizzazione d’Impresa”, di seguito GPOI, tratta
fondamentalmente temi legati alla vita e gestione di una impresa, collocata in un contesto
economico e, nel suo ambito, l’impostazione e gestione di progetti.
Per la parte “Impresa”, sono stati impostati concetti e pratiche sistemistiche, concetti
fondamentali di economia come contesto, processi organizzativi interni, conoscenza dei principi di
documentazione e qualità, sicurezza del lavoro.
Per la parte “Progetto”, sono state previste due sezioni: la prima di principi e metodi di
impostazione del progetto (WBS, OBS, RBS, CBS, ecc.), la seconda di monitoraggio dello stesso
(diagrammi da tecniche reticolari, scheduling, ecc.).
Il programma svolto, contenente gli argomenti trattati prima del 4 maggio e quelli che si
intende trattare fino al termine delle lezioni, è allegato. In merito è necessario avvertire che alcuni
argomenti, previsti inizialmente per completezza di trattazione, comunque non fondamentali, sono
stati omessi o solo negli approfondimenti o del tutto per mancanza di tempo (dovuta a molteplici
circostanze non prevedibili inizialmente, come già anticipato, che hanno determinato varie
perturbazioni sulla continuità ed esaustività, quali diversi periodi in concomitanza di festività

ravvicinate, convergenza di attività integrative e progetti interni/esterni, visite tecniche e
d’istruzione (la cui realizzazione si determina con certezza dopo gennaio, ecc.). Questi eventi, che
si sono verificati nel corso dell’intero anno, non hanno pregiudicato comunque l’unitarietà della
programmazione né penalizzato un quadro organico della materia.
Per quanto riguarda l'attività pratica in laboratorio, questa ha cercato di consolidare tecniche apprese in aula, approfondire temi citati in aula e rimandati a esercitazioni pratiche, far apprendere soprattutto tecniche di impostazione e gestione dei progetti, su cui si è preferito puntare su un approccio prevalentemente laboratoriale e pratico.
Gli strumenti utilizzati nelle diverse esercitazioni sono stati: Word Processor, Spread Sheet, INTERNET e WEB (nei limiti della sua disponibilità), Flow Charting e Drawing Program, ProjectLibre (versione opensource di MSProject, leader di mercato per la gestione computerizzata dei progetti e delle loro fasi di monitoraggio).
Le esemplificazioni, nei limiti del possibile, sono state improntate a problematiche del settore tecnologico, elettronico-telematico, informatico.
Comportamento
Il comportamento della classe, salvo il fatto di essere comunque molto numerosa, con tutte
le ovvie conseguenze del caso, quale l’induzione alla dispersività, può essere definito
sostanzialmente regolare e rispettoso, sia nei confronti del personale che della scuola nel suo
complesso.
Non sono risultate gradite alcune, limitate e limitatamente individuali, prese di posizione di
taluni peraltro inconsistenti, pretestuose e inutilmente polemiche riguardo ad alcuni aspetti
organizzativi della vita didattica e del dialogo educativo.
Il rispetto delle regole istituzionali e di convivenza è stato comunque adeguato ed
accettabile, nella stragrande maggioranza degli allievi.
Profitto
La risposta della classe è stata piuttosto diversificata e pur non essendo stata sempre (per
soggetti e periodi) brillante comunque può essere considerata soddisfacente, almeno
mediamente.
Riguardo al profitto, nel complesso, solo parte degli allievi ha dimostrato nel corso
dell'attività in classe di seguire con un certo interesse, mantenendo, in sede di verifica, risultati
coerenti.
Gli altri o hanno conseguito risultati molto modesti o non hanno conseguito risultati
adeguati, oltre che per il mancato interesse anche per il mancato impegno, cui si è unita una non
sufficiente applicazione a casa.
Per maggior dettaglio possiamo distinguere quattro gruppi nella classe:
Il primo, poco consistente, con impegno, serietà, continuità e profitto buono o eccellente
(almeno uno studente ha dimostrato eccellenza con assoluta continuità).
Il secondo, più numeroso del precedente, senza particolari evidenze ma sufficientemente
diligente da conseguire sempre risultati di profitto almeno mediocri ma talvolta anche discreti.
Il terzo, comprendente la maggior parte dei ripetenti, corrispondente a circa un terzo della

consistenza della classe, senza alcun interesse per la materia, senza cenni di impegno e
applicazione, neppure nella cura delle attività pratiche, ha conseguito fino a questo momento
risultati di profitto decisamente scarsi.
Il quarto gruppo, di due allievi, si è sottratto fino a questo momento ad ogni verifica, sia dei
contenuti teorici che delle abilità pratiche.
Nessun allievo, seppure invitato con proposte, si è impegnato in ricerche, progetti, studi,
approfondimenti da presentare all’esame, che coinvolgessero, anche parzialmente, questa
materia.
Sussidi didattici
Il testo usato, ancorché in prova e non adottato, appare, al momento, adeguato alla
programmazione ed alle linee guida ministeriali e copre abbastanza efficacemente sia gli aspetti
teorici che pratici. In particolare, supporta adeguatamente la parte di gestione e monitoraggio dei
progetti con software MSProject. Pertanto, dispense e appunti fotocopiati consegnati sono stati
limitati e si sono rivolti particolare cura e dettaglio alla esposizione (in forma scritta) delle
esercitazioni da svolgere in laboratorio, favorendo, metodologicamente, attitudini alle prove scritte
d’esame.
E’ stato utilizzato il laboratorio di “Sistemi e Reti”. I sussidi tecnologici disponibili a livello di
laboratorio sono stati abbastanza idonei per le esercitazioni pratiche di carattere locale. Al
momento la disponibilità di efficace videoproiezione in aula non è adeguata.

ITT ex-I.T.I.G.S. “L.da Vinci” – Viterbo * indir.: INFORMATICA * clas. 5A/I * a.s.: 2014/15 * finale
materia:GESTIONE PROGETTO ORGANIZZAZIONE IMPRESA
docente: Marcello POLEGRI * codocente: Angelo GIGLIOTTI
P R O G R A M M A S V O L T O
Legenda: A=abilità C=conoscenze - note = = da svolgere fra 05/05/15 e termine delle lezioni
Modulo: M_GPOI_5 [ SISTEMA IMPRESA ]
Descrizione: Saper progettare una impresa. Saper leggere sommariamente un bilancio preventivo e/o consuntivo
d’impresa. Impostare un budget e valutare la redditività della gestione d’impresa con il diagramma di pareggio. Valutare
convenienze/problemi dei diversi tipi di organizzazione aziendale.
U.D Abilità / Conoscenze A/C Riferimenti note
.1 Generalità sul sistema impresa C Appunti + T pg140-141
.2 Modello, contabilità e controllo C Appunti + fotocopie + T
pg142
Elaborare modelli di contabilità: uso di foglio elettronico,
situazione-stato patrimoniale, prospetto costi-ricavi
A Appunti e fotocopie
.3 Tecniche di costing (Full e Direct). Esercitazioni pratiche C
A
Appunti + T pg142-143
.4 Budget e diagramma di redditività (break even point) C
A
Appunti + T pg144-145
.5 Elaborare budget e valutare la redditività A Appunti + T pg146-147
.6 Organizzazione dell’impresa. Organigramma. Risorse e
funzioni aziendali (anche con riguardo al sistema
informativo)
C Appunti + T pg148-155
Modulo: M_GPOI_5 [ ECONOMIA ]
Descrizione: Conoscere i principi dell’economia quale ambiente e contesto per l’impresa. Dimensionare i volumi di produzione. U.D Abilità / Conoscenze A/C Riferimenti note
.1 Elementi fondamentali di economia (micro e macro) C Appunti + fotocopie
.2 Domanda/Offerta e dinamica del prezzo C Appunti + T pg126-133
.3 Capacità produttiva: generalità e tecniche C T pg134

.4 Capacità produttiva: applicazione delle tecniche A T pg136-137
.5 Cenni su: produzione e distribuzione, logistica A T pg136-139
Modulo: M_GPOI_5 [ IMPRESA: PROCESSI_MODELLI ]
Descrizione: Analizzare e rappresentare, anche graficamente, l’organizzazione dei processi produttivi e gestionali delle imprese di settore. U.D Abilità / Conoscenze A/C Riferimenti note
.1 Cenni su definizione, caratteristiche e classificazione di
processi – Diagrammi di flusso
C T pg170-174 e 178-179
.2 Cenni su ICT, nuove tecnologie e processi innovativi
(New economy)
C T pg188-195 e lettura
pg156-161
Modulo: M_GPOI_5 [ PROJECT MANAGEMENT: PRINCIPI E REGOLE ]
Descrizione: Conoscere il paradigma del Project Management. Saper identificare ed applicare le metodologie e le
tecniche della gestione per progetti. Saper gestire un progetto, correlato con l’economia e l’organizzazione d’impresa,
secondo le procedure e gli standard.
Prerequisiti : Definizione di Progetto. Saper individuare gli elementi fondamentali del ciclo di progetto (TP:classe 3^).
U.D Abilità / Conoscenze A/C Riferimenti note
.1 Definizione del Project Management C Appunti + T pg2-11
.2 Cenni su:Strumenti manuali e software per la gestione
del Project Management (Gantt, PERT, CPM,
SpreadSheet, Project, …) e fasi del PM
C Appunti + T pg12-21
.3 WBS (Work Breakdown Structure): scomposizione del
progetto e codifica
A Appunti + T pg22-23
.4 Matrice delle responsabilità di progetto (OBS) A Appunti + T pg24-25
.5 Analisi delle risorse: tempi, personale, materiali, costi
diversi): RBS e CBS
A Appunti + T pg26-33

Modulo: M_GPOI_5 [ PROJECT MANAGEMENT: STRUMENTI DI GESTIONE/CONTROLLO]
Descrizione: Acquisire conoscenza ed abilità d’uso di strumenti software per la gestione completa di un progetto. Acquisire conoscenza ed abilità d’uso di tecniche di controllo fra cui CPM, PERT, Gantt, analisi degli scostamenti. Conoscere le tecniche di valutazione delle prestazioni in un ciclo di progetto.
U.D
Abilità / Conoscenze A/C Riferimenti note
.1 Introduzione ad uno strumento software per gestione/
monitoraggio progetti ( ProjectLibre, simil MSProject)
A T pg42-55
.2 Rappresentazione della WBS (composizione del
progetto)
A
.3 Allocazione delle risorse A
.4 Gestione dei costi A
.5 CPM del planning delle attività. Regole costruttive.
Calcolo del cammino critico.
A
.6 Diagramma di GANTT. Regole costruttive. A T pg89-90
.7 Tecniche di monitoraggio e controllo del progetto: tempi
e costi - Esercitazione
A T pg80-85
T pg72 e successive
Modulo: M_GPOI_5 [ DOCUMENTAZIONE_CERTIFICAZIONE_QUALITA’ ]
Descrizione: Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. Applicare le norme e le metodologie relative alla certificazione di qualità del prodotto e /o del processo. U.D Abilità / Conoscenze A/C Riferimenti note
.1 Concetto di documento tecnico e sue caratteristiche,
concetto di manuale e cenni di gestione documentale
C Appunti + T pg230-235
.2 Identificare ed organizzare un documento tecnico
(codice, versione, revisione
A Appunti + T pg236-237
T pg239-240
.3 Conoscere le principali metodologie di certificazione
della qualità e Riconoscere le norme ISO
A Fotocopia (sintesi T
pg258-287)
Modulo: M_GPOI_5 [ SICUREZZA DEL LAVORO ]
Descrizione: Conoscenza della problematica di sicurezza dell’ambiente di lavoro e delle figure professionali. Impegni in capo all’Impresa per individuare i rischi connessi alla sicurezza negli ambienti di lavoro. Saper realizzare le principali condizioni ergonomiche relative a un posto di

lavoro. U.D Abilità / Conoscenze A/C Riferimenti note
.1 Definizione di: concetto della sicurezza (Pericolo,
Danno, Rischio) sul lavoro e protezione ambientale;
Normativa; Prevenzione e Protezione; Segnalazione per
la sicurezza nell’ambiente di lavoro
C Appunti + T pg294-303
.3 Cenni sulle figure della sicurezza nell’Impresa.
Caratteristiche e rischi del posto lavoro informatico
C T pg304-309 e pg310-315
Lettura T pg316-323
Testo di riferimento
Codice T: es.:
consigliato
Autori: C.Iacobelli,
M.Cottone, E.Gaido,
G.M.Tarabba
titolo: GESTIONE PROGETTO
ORGANIZZAZIONE
D’IMPRESA
Ed.: Juvenilia
Scuola
altro: volume unico per
5° anno) - 22.90 € -
isbn:978-88-7485-455-4
Docente (Ing. Marcello POLEGRI)
…………………………………………………… Codocente (Prof. Angelo GIGLIOTTI)

I.T.T. “Leonardo Da Vinci” VITERBO
RELAZIONE DI EDUCAZIONE FISICA
Classe 5 A Informatica Insegnante:
A.S. 2014/2015 Prof. Rossella Lodesani
La classe sebbene composta da numerosi alunni, grazie al buon compotamento è riuscita a svolgere in
maniera proficua il programma di attività proposte dall’insegnante. Tutti si sono mostrati volenterosi e
interessati e fin dall’inizio dell’anno scolastico si è instaurato un rapporto di collaborazione che ha
consentito un lavoro interessante e costruttivo. Pur partendo da livelli diversi, dovuti sia alle caratteristiche
strutturali, sia al proprio vissuto motorio, quasi tutti gli alunni sotto l’aspetto pratico hanno raggiunto una
discreta padronanza delle proprie espressioni ginnico-sportive. La preparazione raggiunta ha dato come
risultato la capacità di valutare le proprie possibilità e di migliorarle con l’impegno permettendo la
conoscenza di strumenti utili a stilare un piano di lavoro motorio personale. Un gruppo di alunni si è
distinto durante l’anno per l’impegno, in una attività di potenziamento generale e specifico riferito alla
Pallavolo, partecipando anche al torneo del triennio pomeridiano.
Gli obiettivi della parte pratica, previsti nel piano didattico-educativo, sono stati sviluppati e raggiunti in
modo adeguato dalla maggioranza degli alunni. La verifica e la valutazione si sono basate soprattutto sulla
partecipazione alle attività; sul rendimento come impegno di lavoro e sui significativi miglioramenti
compiuti da ogni alunno rispetto ai livelli iniziali. Il profitto della classe è da considerarsi soddisfacente.
L’insegnante Rossella Lodesani

I.T.T. “Leonardo da Vinci” Viterbo
Anno Scolastico 2014/2015
Il programma di Educazione Fisica ha riguardato nei primi periodi il conseguimento da parte dei ragazzi delle capacità coordinative e condizionali, indispensabili per affrontare richieste più specifiche riguardanti i giochi sportivi della Pallavolo e del Calcetto Fulcro del primo periodo di lezioni sono state quindi le seguenti esercitazioni:
Corsa lenta in equilibrio di ossigeno
Corsa con variazione di ritmo Corsa in progressione Andature atletiche a carattere generale e giochi di andature Stretching ed elasticità muscolare Esercitazioni coordinative Esercitazioni di forza Esercitazioni di scioltezza articolare
Nel periodo successivo sono stati introdotti i Giochi sportivi con particolare
attenzione all’acquisizione delle abilità legate ai fondamentali della pallavolo.
Pallavolo
Movimenti senza palla ed anticipo motorio, battuta, bagher, palleggio, schiacciata,
muro, difesa, schemi semplici di attacco e difesa.
Tennis Tavolo
Fondamentali individuali e partite di singolo e doppio.
Calcetto
Fondamentali individuali e di squadra.
Un gruppo di alunni si è distinto durante l’anno per l’impegno, in una attività di
potenziamento generale e specifico.
Rossella Lodesani

ISTITUTO TECNICO STATALE SETTORE TECNOLOGICO “Leonardo da Vinci”
VITERBO
Relazione annuale a.s. 2014/2015
Docente: Giuseppe Pedica
Disciplina:Religione Classe: 5° A Informatica
Profilo della classe
Il gruppo classe ha dimostrato globalmente nel corso dell'anno scolastico un buon desiderio di
apprendere i contenuti proposti ed un atteggiamento dialogico e recettivo nei confronti dell'attività
didattica . Gli studenti hanno partecipato con abbastanza impegno e interesse alle attività proposte.
Il loro atteggiamento è stato corretto e responsabile: rispettoso delle regole
della buona educazione.
La maggior parte del gruppo classe ha seguito le lezioni in modo adeguato affrontando con
attenzione le attività proposte.
Il livello generale della classe risulta buono per la maggior parte degli studenti.
Rispetto all’inizio dell’anno vi sono stati miglioramenti,nell’attenzione e nella
partecipazione,anche per quegli studenti all’inizio meno coinvolti.
Nel suo complesso,questi studenti, hanno raggiunto i livelli previsti in termini di conoscenze,
abilità e competenze. Il grado e la profondità dell’apprendimento individuale degli studenti ha risentito della particolare
situazione di vita di ognuno di loro,nelle molteplici dimensioni
personali: interiore,familiare e sociale,…
Obiettivi in termini di conoscenze, abilità, capacità e competenze
I contenuti disciplinari proposti hanno avuto come punto di riferimento il
raggiungimento e lo sviluppo degli apprendimenti previsti dalle Linee Guida per l’insegnamento
della Religione negli Istituti Tecnici e la programmazione collegiale dell’Istituto e dei Consigli di
classe.
Le tematiche sono sempre state presentate con uno stile interdisciplinare, favorendo il dialogo e il confronto,evitando visioni unilaterali e promuovendo così comportamenti personali e sociali
coerenti con i principi della Costituzione e rispettosi del bene comune.
Gli allievi conoscono le linee essenziali degli argomenti trattati.
Riconoscono il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni
interpersonali,alla vita sociale e pubblica.
Gli allievi hanno dimostrato di sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un positivo senso critico e
un personale progetto di vita.
Gli studenti riconoscono la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella
valutazione e trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo con
altre religioni e sistemi di significato. Ciascuno studente ha sviluppato conoscenze,abilità e competenze disciplinari relativamente alle
personali potenzialità,capacità e originalità del presente.
Metodologie didattiche
Durante l’anno scolastico sono stati privilegiati alcuni metodi,in misura e proporzioni diversi in
conseguenza dei contenuti disciplinari sviluppati e della sensibilità del gruppo classe. Metodo antropologico esperienziale
Metodo fenomenologico
Lezione dialogica, lezione frontale, il problem solving.
Metodo analogico: rappresento, quindi imparo.
Metodo attivo fondato sull’agire. Metodo iconico: vedo e sento, quindi imparo.
Strategie di intervento

Al fine di perseguire gli obiettivi prefissati e di far acquisire le conoscenze e competenze sopra elencate, sono state utilizzate le seguenti strategie:
-Instaurare con la classe un clima disteso, sereno, aperto al dialogo ed alla collaborazione.
-Coinvolgere gli allievi, responsabilizzarli e stimolarli per far emergere il loro potenziale.
-Sviluppo di un problema con discussione e ricerca della soluzione.
-Presentazione dei problemi a mezzo della lezione frontale, discussione guidata. -Uso di mezzi audiovisivi.
Materiale e attrezzature didattiche
Libro di testo,supporto di schede didattiche, appunti, mappe concettuali.
Inoltre, per avviare o approfondire alcuni temi si sono impiegati mezzi audiovisivi e
informatici.
Tipologie di verifiche
Ha costituito modalità di verifica l'osservazione sistematica, durante l'anno scolastico, soprattutto
degli episodi significativi, sul rendimento dei singoli allievi, sulla capacità di proposta a livello
morale personale e interpersonale,sull’uso efficace degli strumenti.
Nelle prove orali( sia domande brevi, brevi sintesi, richiesta di commenti, interrogazioni vere e
proprie ) si è tenuto conto dell'ampiezza delle conoscenze, della correttezza linguistica, della
fluidità espositiva, nonché della capacità di operare collegamenti e confronti.
Le interrogazioni brevi, gli interventi degli alunni durante le lezioni, spontanei o sollecitati dal
docente, sono invece stati adottati come strumenti per la verifica formativa.
Le verifiche sommative sono state effettuate attraverso interrogazioni orali individuali, nelle quali
veniva richiesta agli allievi l’esposizione formale dei saperi sviluppati.
Criteri di valutazione
Verifica del grado di interesse, dell'assiduità alle lezioni, impegno e partecipazione dimostrati. Livello di conoscenza degli apprendimenti: conoscenze e abilità apprese e delle competenze
acquisite.
Grado di positiva evoluzione del comportamento in ordine al dialogo educativo.
La valutazione finale considera i livelli di partenza dei singoli alunni ,dei progressi o regressi
rilevati.
Conoscenza dei contenuti e del linguaggio specifico della disciplina. Capacita di creare collegamenti all’interno della disciplina e/o con altre discipline
Contenuti disciplinari
Organizzati in Unità di apprendimento
1.Le relazioni. Innamoramento e amore L’amore nel mondo contemporaneo
L’amore nella bibbia
Il matrimonio cristiano
L’amore presso le culture del passato
Relazioni interpersonali: psicologia maschile e femminile
I linguaggi d’amore principali 2.La coscienza,la legge,la libertà
La coscienza personale e collettiva
La coscienza morale e il primato della coscienza
Riferimenti biblico-teologici
Le regole morali e i valori
Lo sviluppo della coscienza morale e collettiva Casi di coscienza nella storia
Coscienza e liberta: Testimoni di libertà
3.L’etica sociale:pace,giustizia e solidarietà
Lo sfruttamento dell’uomo

Lo sfruttamento dell’ambiente
Nuove forme di sfruttamento
La pace,opera da costruire
Testimoni di pace
La sfida della povertà
Carità e solidarietà Lo sviluppo sostenibile,l’economia solidale
L’etica del lavoro
Interculturalità,multiculturalità,mondialità.

56
Simulazione 1^ prova Esame di Stato
P000 - ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
PROVA DI ITALIANO
(per tutti gli indirizzi: di ordinamento e sperimentali)
Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte.
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO
Primo Levi, dalla Prefazione di La ricerca delle radici. Antologia personale, Torino 1981
Poiché dispongo di input ibridi, ho accettato volentieri e con curiosità la proposta di comporre anch’io
un’«antologia personale», non nel senso borgesiano di autoantologia, ma in quello di una raccolta,
retrospettiva e in buona fede, che metta in luce le eventuali tracce di quanto è stato letto su quanto è stato
scritto. L’ho accettata come un esperimento incruento, come ci si sottopone a una batteria di test; perché
placet experiri e per vedere l’effetto che fa. 5 Volentieri, dunque, ma con qualche riserva e con qualche tristezza. La riserva principale nasce appunto al
mio ibridismo: ho letto parecchio, ma non credo di stare inscritto nelle cose che ho letto; è probabile che il
mio scrivere risenta più dell’aver io condotto per trent’anni un mestiere tecnico, che non dei libri ingeriti;
perciò l’esperimento è un po’ pasticciato, e i suoi esiti dovranno essere interpretati con precauzione.
Comunque, ho letto molto, soprattutto negli anni di apprendistato, che nel ricordo mi appaiono stranamente 10 lunghi; come se il tempo, allora, fosse stirato come un elastico, fino a raddoppiarsi, a triplicarsi. Forse lo
stesso avviene agli animali dalla vita breve e dal ricambio rapido, come i passeri e gli scoiattoli, e in genere a
chi riesce, nell’unità di tempo, a fare e percepire più cose dell’uomo maturo medio: il tempo soggettivo
diventa più lungo.
Ho letto molto perché appartenevo a una famiglia in cui leggere era un vizio innocente e tradizionale, 15 un’abitudine gratificante, una ginnastica mentale, un modo obbligatorio e compulsivo di riempire i vuoti di
tempo, e una sorta di fata morgana nella direzione della sapienza. Mio padre aveva sempre in lettura tre libri
contemporaneamente; leggeva «stando in casa, andando per via, coricandosi e alzandosi» (Deut. 6.7); si
faceva cucire dal sarto giacche con tasche larghe e profonde, che potessero contenere un libro ciascuna.
Aveva due fratelli altrettanto avidi di letture indiscriminate; i tre (un ingegnere, un medico, un agente di 20 borsa) si volevano molto bene, ma si rubavano a vicenda i libri dalle rispettive librerie in tutte le occasioni
possibili. I furti venivano recriminati pro forma, ma di fatto accettati sportivamente, come se ci fosse una
regola non scritta secondo cui chi desidera veramente un libro è ipso facto degno di portarselo via e di
possederlo. Perciò ho trascorso la giovinezza in un ambiente saturo di carta stampata, ed in cui i testi
scolastici erano in minoranza: ho letto anch’io confusamente, senza metodo, secondo il costume di casa, e 25 devo averne ricavato una certa (eccessiva) fiducia nella nobiltà e necessità della carta stampata, e, come
sottoprodotto, un certo orecchio e un certo fiuto. Forse, leggendo, mi sono inconsapevolmente preparato a
scrivere, così come il feto di otto mesi sta nell’acqua ma si prepara a respirare; forse le cose lette riaffiorano
qua e là nelle pagine che poi ho scritto, ma il nocciolo del mio scrivere non è costituito da quanto ho letto.
Mi sembra onesto dirlo chiaramente, in queste «istruzioni per l’uso» della presente antologia. 30
Primo Levi (Torino 1919-87) è l’autore di Se questo è un uomo (1947) e La tregua (1963), opere legate alla
esperienza della deportazione, in quanto ebreo, nel campo di Buna-Monowitz presso Auschwitz, e del lungo
e avventuroso viaggio di rimpatrio. Tornato in Italia, fu prima chimico di laboratorio e poi direttore di
fabbrica. A partire dal 1975, dopo il pensionamento, si dedicò a tempo pieno all’attività letteraria. Scrisse
romanzi, racconti, saggi, articoli e poesie.

57
A proposito di La ricerca delle radici, Italo Calvino così scrisse in un articolo apparso su «la Repubblica»
dell’11 giugno 1981: «L’anno scorso Giulio Bollati ebbe l’idea di chiedere ad alcuni scrittori italiani di
comporre una loro «antologia personale»: nel senso d’una scelta non dei propri scritti ma delle proprie letture
considerate fondamentali, cioè di tracciare attraverso una successione di pagine d’autori prediletti un
paesaggio letterario, culturale e ideale. […] Tra gli autori che hanno accettato l’invito, l’unico che finora ha
tenuto fede all’impegno è Primo Levi, il cui contributo era atteso come un test cruciale per questo tipo
d’impresa, dato che in lui s’incontrano la formazione scientifica, la sensibilità letteraria sia nel rievocare il
vissuto sia nell’immaginazione, e il forte senso della sostanza morale e civile d’ogni esperienza».
1. Comprensione del testo
Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo.
2. Analisi del testo
2.1 Quali sono per Levi le conseguenze degli «input ibridi» (r. 1) e dell’«ibridismo» (r. 7)?
2.2 Spiega le considerazioni di Levi sul «tempo soggettivo» (r. 13).
2.3 Perché si leggeva molto nella famiglia di Levi? Spiega, in particolare, perché leggere era «una sorta
di fata morgana nella direzione della sapienza» (r. 17).
2.4 Soffermati su ciò che Levi dichiara di avere ricavato dalle sue letture (rr. 24-29). In particolare,
spiega l’atteggiamento di Levi nei confronti della «carta stampata» (r. 26).
2.5 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza.
3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano e approfondiscila con opportuni collegamenti al
libro da cui il brano è tratto o ad altri testi di Primo Levi. In alternativa, prendendo spunto dal testo che ti è
proposto, proponi una tua «antologia personale» indicando le letture fatte che consideri fondamentali per
la tua formazione.
TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE”
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti)
CONSEGNE
Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o
in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue
conoscenze ed esperienze di studio.
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi.
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi
che l’articolo debba essere pubblicato.
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo.
1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO
ARGOMENTO: L’Uomo e la guerra
1. Noi vogliamo cantare l'amor del pericolo, l'abitudine all'energia e alla temerità.
2. Il coraggio, l'audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra poesia.
7. Non v'è più bellezza, se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo può essere un
capolavoro. La poesia deve essere concepita come un violento assalto contro le forze ignote, per ridurle a
prostrarsi davanti all'uomo.
9. Noi vogliamo glorificare la guerra - sola igiene del mondo - il militarismo, il patriottismo, il gesto
distruttore dei libertari…
Da Manifesto del Futurismo “Le Figaro”, 20 febbraio 1909

58
Dalla caserme il mondo era tuttavia assai lontano. Per Fabio, come per gli altri, uscire, entrare in una scena
diversa, la vita di tutti i giorni, erano evasioni che si cancellavano subito al primo squillo do tromba. La
verità era la vita in comune, le operazioni della caserma, l’attesa del tenente e del maggiore, le grida e i
comandi durante l’istruzione. Si usciva in fretta, non si era aspettato che il segnale dell’uscita, ma era come
evadere in un mondo fittizio. L’umanità viveva e si agitava davanti a loro per due o tre ore al giorno; dopo di
che si allontanava come un ricordo. Infine, la stessa vita della caserma, le operazioni che vi si compivano,
avevano perduto ogni significato preciso; il movente generale di tutto questo si era smarrito giorno per
giorno nei dettagli; alla fine la cosa più importante era imparare a comandare e a ubbidire. Proprio questo
fatto, di occuparsi interamente dei dettagli, di non essere altro che strumenti docili ad una voce, era la
disciplina. Fuori cominciavano a gridare. Viva la guerra! E abbasso la guerra! Gridavano al passaggio dei
soldati. Di quanto accadeva fuori i meno informati erano costoro; non ne avevano, anzi, nessuna curiosità,
l’idea di un mondo che si muovesse dietro ad sua volontà non la concepivano più; aspettavano.
(Corrado Alvaro Vent’anni Milano Bompiani 1953)
[ Lo scrittore calabrese Corrado Alvaro, chiamato alle armi nel 1914, prese parte ai combattimenti sul
Carso, riportando una ferita che per qualche tempo gli impedì l’uso della braccia. Da quella amara
esperienza nacque il resoconto memoriale Vent’anni.]
E’ ipocrita stupirsi di sentire e vedere, nel video incriminato, soldati italiani che sparano, bestemmiano, si
eccitano nel fuoco della battaglia, si compiacciono di mirare giusto; è così che accade in guerra nella
tensione dello scontro e col sentimento della possibilità di morire. E’ falso e retorico criticare tutto questo
standosene comodamente a casa, senza aver mai provato quel momento. E’ anche ipocrita parlare di
“Missione di pace”: si può ritenere che l’intervento bellico in Iraq sia giusto e serva ad impedire possibili
future violenze peggiori, ma si tratta pur sempre di un intervento bellico; se si trattasse di intervenire solo
con mezzi pacifici, si manderebbero le Orsoline e non i carabinieri e i bersaglieri, allo stesso modo i militari
italiani morti vanno onorati come soldati caduti in una guerra e non come scolaretti periti in un attentato.
Non ci si può neppure indignare che il nemico spari loro addosso perché si è intervenuti proprio per imporre
un certo ordine con la forza e non ci si può meravigliare se questo nemico, denunciato sin dall’inizio come
feroce, sanguinario e pericoloso per il mondo intero, non si comporta come un agnellino.
(C. Magris “Gli ipocriti della guerra” In Corriere della sera 12 Dicembre 2005)
I sostenitori della scuola realista della relazioni internazionali amano sottolineare che ben difficilmente le
comunità umane sarebbero in grado di mantenere la coesione – ed essere disponibili a sacrificare i propri
interessi e la proprie passioni per il bene comune – senza lo stimolo di una minaccia esterna. Si tratta di un
dato politico psicologico che, sappiamo, è ben chiaro ai dirigenti politici, soprattutto non democratici, che,
quando un nemico non c’è, lo inventano[…] Vuol dire quindi che una comunità internazionale organizzata
istituzionalmente su basi multiple, meno conflittuali e più dialogiche, imploderebbe per mancanza
dell’elemento unificante, del “nemico”? pensiamo che questo sia evitabile […]Le sfide e i nemici non
mancano e vanno dagli squilibri sociali, alla droga, dal deterioramento dell’ambiente […] alle grandi
pandemie. Si tratta di nemici comuni che , se a livello politico, qualcuno avesse la capacità di articolare un
nuovo paradigma di coesione e lotta, potrebbero facilmente fornire un equivalente funzionale alla
tradizionale coesione “esogena” fornita da nemici più o meno reali. E lo farebbero suscitando forza e non
violenza, coesione e non divisione, se non quella di un pacifico dibattito sui dati scientifici e le preferenze
politiche.
(R. Toscano La violenza, le regole, Torino Einaudi 2006)

59
Cima Quattro il 23 dicembre 1915
Un’intera nottata
buttato vicino
a un compagno
massacrato
con la sua bocca
digrignata
volta al plenilunio
con la congestione
delle sue mani
penetrata
nel mio silenzio
ho scritto
lettere piene d’amore
Non sono mai stato
Tanto
attaccato alla vita
G. Ungaretti, Veglia, 1915
E come potevamo noi cantare
con il piede straniero sopra il cuore,
fra i morti abbandonati nelle piazze
sull’erba dura di ghiaccio, al lamento
d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero
della madre che andava incontro al figlio
crocifisso sul palo del telegrafo?
Alle fronde dei salici, per voto,
anche le nostre cetre erano appese,
oscillavano lievi al triste vento.
S: Quasimodo, Alle fronde dei salici, 1945
Guernica di P. Picasso 1937

60
Trittico della guerra di Otto Dix 1929/32
2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO
ARGOMENTO: Nutrire il pianeta
«Con quale spirito andiamo verso Expo? Non possiamo concentrarci solamente sui milioni di turisti
che arriveranno a Milano, ma dobbiamo occuparci di quei contadini e allevatori che vivono in
sofferenza, del land grabbing che in Africa distrugge le vite di migliaia di contadini scacciandoli
dalla loro terra, complici i governi canaglia. È sacrosanta la battaglia del made in Italy, ma
dobbiamo aprire gli occhi al mondo, perché ci sono eccellenze in ogni angolo del pianeta. Questa è
la visione che l’Expo deve fare propria». E continua con un auspicio: «Vorrei un’Expo più sobria,
meno attenta ai grandi padiglioni, alla grande kermesse, ma che abbia anche il coraggio di dire le
cose come stanno, che si apra ai contadini. Che accolga a braccia aperte anche gli umili, i poveri,
perché loro più di altri hanno il diritto di venire all’Expo. E allora mi auguro che con un colpo di
reni le persone che sono a questi tavoli facciano in modo che i prossimi giorni siano di confronto e
di dialettica. Facciamola finita con questa separazione tra scienza ufficiale e saperi tradizionali: solo
con il dialogo supereremo queste divisioni e costruiremo una prospettiva condivisa che ci farà
uscire da questa situazione. Se non si cambia il sistema, ben difficilmente consegneremo alle
prossime generazioni una speranza di vita degna. Quindi, che la Carta di Milano non sia un mero
documento, ma un vero inizio ».
www.slowfood.it “Intervento di Carlo Petrini” del 7/2/2015
Ogni giorno i governi europei e quelli dei Paesi in via di sviluppo; imprese multinazionali e istituzioni
finanziarie sono impegnate, in prima linea e dietro le quinte, nell’accaparramento di terra (land grabbing).
Leggi, politiche, investimenti, finanziamenti compongono la fitta trama di incentivi che promuovono il furto
di terra a spese delle comunità locali, principalmente nei Paesi meno sviluppati.
Una rete globale del land grabbing nella quale anche il nostro Paese gioca un ruolo di primo piano. Ad
esempio, con le sue istituzioni che avvallano politiche scellerate come quelle sui biocarburanti che negli
ultimi anni hanno spinto decine di imprese europee a realizzare coltivazioni agro-energetiche su migliaia
di ettari soprattutto in Africa. Oppure con le sue aziende che vanno nei Paesi poveri ottenendo a prezzi
stracciati il controllo su enormi superfici di terra per realizzare progetti agro-industriali dagli impatti
devastanti per le economie e le comunità locali.
Ne è un esempio la Tampieri Financial Group s.p.a. che sta realizzando un investimento agricolo in
Senegal su 20.000 ettari, nella riserva naturale dello Ndiael, incontrando la ferma opposizione delle

61
comunità che vivono in quella terra e che grazie ad essa ricavano il proprio sostentamento, in particolare
attraverso l’allevamento.
www.actionaid.it : land grabbing
Siamo nel pieno della stagione della lattuga nella valle di Salinas, in California, dove si produce il 70 per
cento circa degli ortaggi a foglia verde venduti negli Stati Uniti. Nel corso della mattinata, una processione di
camion carichi di insalata parte dagli stabilimenti agroindustriali della vallata in direzione nord, est e sud.
Nel frattempo un altro camion, un portacontainer, arriva alla centrale di smistamento dei rifiuti di Sun Street,
non lontano dall’abitato di Salinas. Il conducente si ferma su una pesa, poi deposita il malconcio container su
una piattaforma. Un colpo di leva, uno sbuffo di aria compressa, e 25 metri cubi di lattughe e spinaci
piombano a terra, formando un enorme mucchio alto circa due metri. Confezionati in cassette e buste di
plastica, gli ortaggi appaiono freschissimi e in perfette condizioni. Eppure sono condannati alla discarica per
una serie di difetti: confezioni sbagliate o non correttamente sigillate, contenuto diverso da quello indicato
sull’etichetta, involucri strappati…
Chiunque veda una scena simile non può fare a meno di rammaricarsi: distruggere una montagna di cibo
intatto è un peccato, anzi un delitto. Eppure non è che una piccola parte dello spreco. Nel corso della
giornata, la centrale di smistamento riceverà altri 10-20 carichi analoghi di ortaggi perfettamente
commestibili, provenienti dalle aziende di produzione e confezionamento della zona. Da aprile a novembre,
il dipartimento preposto allo smaltimento dei rifiuti solidi della valle di Salinas manda in discarica da due a
quattro tonnellate di verdure appena raccolte. E questo è solo uno dei molti centri di smistamento rifiuti delle
vallate agricole della California.
Elizabeth Royte, National Geographic, 29 novembre 2014
Allora: per non sprecare che consigli pratici si possono dare? Li chiedono in tanti: dove faccio la spesa? Che
cosa conviene acquistare? Cosa e come preparo da mangiare? Cosa conviene fare in casa e fuori? Domande
banali, eppure sembra che negli ultimi anni si sia perso il buon senso, quello dei nostri nonni…
Partiamo dunque dal capostipite di tutti i decaloghi moderni, almeno per noi. È quello degli abitanti di
Lussino, marinai dell’isola dalmata. Un vero e proprio manifesto per una società contro lo spreco, molto
attuale nonostante siano passati due secoli…
1. No sta viziar i fioi [Non viziare i figli]
2. Che non i sapia tanto dei afari e dei soldi de casa [Non devono sapere molto degli affari
e dei soldi di casa]
3. Nel vestir e nel magnar l’utile ma non el superfluo; che ghe sia un vestito de festa;
quando el capoto o la giaca o la cravata se frugai, feli rovesciar, litomerà quasi navi [Nel
vestire e nel mangiare l’utile ma non il superfluo; che ci sia un vestito della festa; quando il
cappotto o la giacca o la cravatta sono lisi fateli rovesciare, ritorneranno quasi nuovi]
4. I fioi devi finir quel che se meti nei piati [I bambini devono mangiare tutto ciò che hanno
nel piatto]
5. In casa non se ga mai niente de butar via [In casa non ci deve essere nulla da buttare
via]
6. Che la vita sia austera e parsimoniosa, no butar mai via i soldi [la vita deve essere
austera e parsimoniosa, i soldi non si devono mai buttare via]
7. Stè atenti ale luci de casa: studar sempre in premura [State attenti alle luci di casa,
vanno sempre spente]
8. Usè le vece buste de letera rovesciade per far la malacopia [le buste da lettera
rovesciate vanno usate come brutta copia]
9. Stè atenti ale invidie dei parenti [State attenti alle invidie dei parenti]
10. No stè mai star con le man in man: in giro sè sempre qualcosa de far [Non state mai
con le mani in mano: in giro c'è sempre qualcosa da fare].
Andrea Segrè, Cucinare senza sprechi (2012), Ponte delle Grazie, Milano

62
IL SILENZIO DELLE PIANTE
di Wisława Szymborska
La conoscenza unilaterale tra voi e me
si sviluppa abbastanza bene.
So cosa sono foglia, petalo, spiga, stelo, pigna,
e cosa vi accade in aprile, e cosa in dicembre.
Benché la mia curiosità non sia reciproca,
su alcune di voi mi chino apposta,
e verso altre alzo il capo.
Ho dei nomi da darvi:
acero, bardana, epatica,
erica, ginepro, vischio, nontiscordardimé,
ma voi per me non ne avete nessuno.
Viaggiamo insieme.
E quando si viaggia insieme si conversa,
ci si scambiano osservazioni almeno sul tempo,
o sulle stazioni superate in velocità.
Non mancherebbero argomenti, molto ci unisce.
La stessa stella ci tiene nella sua portata.
Gettiamo ombre basate sulle stesse leggi.
Cerchiamo di sapere qualcosa, ognuno a suo modo,
e ciò che non sappiamo, anch’esso ci accomuna.
lo spiegherò come posso, ma voi chiedete:
che significa guardare con gli occhi,
perché mi batte il cuore
e perché il mio corpo non ha radici.
Ma come rispondere a domande non fatte,
se per giunta si è qualcuno
che per voi è a tal punto nessuno.
Cespugli, boschetti, prati e giuncheti –
tutto ciò che vi dico è un monologo
e non siete voi che lo ascoltate.
Parlare con voi è necessario e impossibile.
Urgente in questa vita frettolosa
e rimandato a mai.
da La gioia di scrivere di Wislawa Szymborska

63
Immagini tratte dai film “La grande abbuffata” e “Un americano a Roma”
3. AMBITO STORICO - POLITICO
ARGOMENTO: Il ruolo dei giovani nella storia e nella politica. Parlano i leader.
DOCUMENTI
«Ma poi, o signori, quali farfalle andiamo a cercare sotto l’arco di Tito? Ebbene, dichiaro qui, al cospetto di
questa Assemblea e al cospetto di tutto il popolo italiano, che io assumo, io solo, la responsabilità politica,
morale, storica di tutto quanto è avvenuto. (Vivissimi e reiterati applausi — Molte voci: Tutti con voi! Tutti
con voi!) Se le frasi più o meno storpiate bastano per impiccare un uomo, fuori il palo e fuori la corda; se il
fascismo non è stato che olio di ricino e manganello, e non invece una passione superba della migliore
gioventù italiana, a me la colpa! (Applausi). Se il fascismo è stato un’associazione a delinquere, io sono il
capo di questa associazione a delinquere! (Vivissimi e prolungati applausi — Molte voci: Tutti con voi!)»
Benito MUSSOLINI, Discorso del 3 gennaio 1925
(da Atti Parlamentari – Camera dei Deputati – Legislatura XXVII – 1a sessione – Discussioni – Tornata del 3 /1/ 1925
Dichiarazioni del Presidente del Consiglio)
«Diciamo le cose come stanno. I giovani che vengono al nostro partito devono essere stabilmente conquistati
ai grandi ideali del socialismo e del comunismo, se non vogliamo che essi rimangano dei «pratici», o,
peggio, dei politicanti. Essi devono acquistare la certezza – volevo dire la fede – che l’avvenire e la salvezza
della società umana sta nella sua trasformazione socialista e comunista, e questa certezza deve sorreggerli,
guidarli, illuminarli in tutto il lavoro pratico quotidiano. […] Quanto alle grandi masse della gioventù, quello
cui noi aspiriamo è di dare un potente contributo positivo per far loro superare la crisi profonda in cui si
dibattono. Non desideriamo affatto staccare i giovani dai tradizionali ideali morali e anche religiosi. Prima di
tutto, però, vogliamo aiutarli a comprendere come si svolgono le cose nel mondo, a comprendere il perché
delle lotte politiche e sociali che si svolgono nel nostro paese e sulla scena mondiale, e quindi il perché delle
sciagure della nostra patria e della triste sorte odierna della sua gioventù. Tutto questo non si capisce, però,

64
se non si riesce ad afferrare che quello a cui noi assistiamo da due o tre decenni non è che la faticosa
gestazione di un mondo nuovo, del mondo socialista, che si compie suscitando la resistenza accanita di un
mondo di disordine, di sfruttamento, di violenza e di corruzione, il quale però è inesorabilmente condannato
a sparire.»
Palmiro TOGLIATTI, Discorso alla conferenza nazionale giovanile del PCI, Roma, 22-24 maggio 1947
(da P. TOGLIATTI, Discorsi ai giovani, Prefazione di E. Berlinguer, Roma 1971)
«Il potere si legittima davvero e solo per il continuo contatto con la sua radice umana, e si pone come un
limite invalicabile le forze sociali che contano per se stesse, il crescere dei centri di decisione, il pluralismo
che esprime la molteplicità irriducibile delle libere forme di vita comunitaria. I giovani e i lavoratori
conducono questo movimento e sono primi a voler fermamente un mutamento delle strutture politiche ed un
rispettoso distacco; i giovani chiedono un vero ordine nuovo, una vita sociale che non soffochi ma offra
liberi spazi, una prospettiva politica non conservatrice o meramente stabilizzatrice, la lievitazione di valori
umani. Una tale società non può essere creata senza l’attiva presenza, in una posizione veramente influente,
di coloro per i quali il passato è passato e che sono completamente aperti verso l’avvenire. La richiesta di
innovazione comporta naturalmente la richiesta di partecipazione. Essa è rivolta agli altri, ma anche e
soprattutto a se stessi: non è solo una rivendicazione, ma anche un dovere e una assunzione di responsabilità.
L’immissione della linfa vitale dell’entusiasmo, dell’impegno, del rifiuto dell’esistente, propri dei giovani,
nella società, nei partiti, nello Stato, è una necessità vitale, condizione dell’equilibrio e della pace sociale nei
termini nuovi ed aperti nei quali in una fase evolutiva essi possono essere concepiti.»
Aldo MORO, Discorso all’XI Congresso Nazionale della DC, 29 giugno 1969
(da A. MORO, Scritti e discorsi, Volume Quinto: 1969-1973, a c. di G. Rossini, Roma 1988)
«L’individuo oggi è spesso soffocato tra i due poli dello Stato e del mercato. Sembra, infatti, talvolta che egli
esista soltanto come produttore e consumatore di merci, oppure come oggetto dell’amministrazione dello
Stato, mentre si dimentica che la convivenza tra gli uomini non è finalizzata né al mercato né allo Stato,
poiché possiede in se stessa un singolare valore che Stato e mercato devono servire. L’uomo è, prima di
tutto, un essere che cerca la verità e si sforza di viverla e di approfondirla in un dialogo che coinvolge le
generazioni passate e future. Da tale ricerca aperta della verità, che si rinnova a ogni generazione, si
caratterizza la cultura della Nazione. In effetti, il patrimonio dei valori tramandati e acquisiti è sempre
sottoposto dai giovani a contestazione. Contestare, peraltro, non vuol dire necessariamente distruggere o
rifiutare in modo aprioristico, ma vuol significare soprattutto mettere alla prova nella propria vita e, con tale
verifica esistenziale, rendere quei valori più vivi, attuali e personali, discernendo ciò che nella tradizione è
valido da falsità ed errori o da forme invecchiate, che possono esser sostituite da altre più adeguate ai tempi.»
GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica Centesimus annus nel centenario della Rerum novarum, 1° maggio 1991
(da Tutte le encicliche di Giovanni Paolo II, Milano 2005)
4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO
ARGOMENTO: Enrico Fermi, fisico.
«Due dati ci permettono di valutare l’importanza del campo di ricerca aperto da Enrico Fermi con il suo
lavoro. Il primo riguarda i premi Nobel, una misura rozza ma efficace dell’importanza di un determinato
settore della ricerca scientifica e dei progressi in esso conseguiti: più di dieci Nobel per la fisica sono
stati attribuiti a scoperte relative alle interazioni deboli. Se Fermi non avesse ottenuto il Nobel per le sue
ricerche sui neutroni ne avrebbe ben meritato uno per la scoperta delle interazioni deboli. Una seconda
valutazione dell’importanza della scoperta di Enrico Fermi si può dedurre dal fatto che oltre la metà

65
degli esperimenti attualmente in corso o in preparazione con acceleratori di particelle — al CERN di
Ginevra, al Fermilab di Chicago, a Stanford come a Frascati come a Tsukuba in Giappone o a
Novosibirsk in Russia — sono dedicati a studiare vari aspetti delle interazioni deboli. La stessa
prevalenza degli studi sulle interazioni deboli si riscontra nei programmi sperimentali dei grandi
laboratori sotterranei, come quello italiano del Gran Sasso, quello giapponese di Kamioka, ed altri
ancora nel Canada e negli Stati Uniti. La teoria di Fermi delle interazioni deboli è ormai confluita nella
più generale teoria delle particelle elementari che va sotto il nome di “Modello Standard”. […] È però
importante ricordare che la teoria di Fermi mantiene ancora oggi il suo valore, sia per la validità delle
soluzioni proposte sia come stimolo per una serie di ricerche che hanno impegnato i fisici per quasi
settant’anni, e che ancora li impegneranno nei decenni a venire. In questa teoria si riflette la grandezza
di Fermi, la firma di un grande maestro.» Nicola CABIBBO, Le interazioni deboli, in Carlo BERNARDINI - Luisa BONOLIS (a cura di), Conoscere Fermi
nel centenario della nascita 29 settembre 1901 - 2001, Editrice Compositori, Bologna 2001
«Enrico Fermi nasce a Roma nel 1901. La sua produzione scientifica inizia nel 1921 e termina con la sua
morte nel 1954. All’inizio della sua attività, la fisica conosce due sole forze fondamentali della natura, la
gravitazione e l’elettromagnetismo, e due sole particelle elementari costituenti la materia, i nuclei di
idrogeno (protoni) e gli elettroni. A metà degli anni Cinquanta le forze fondamentali sono diventate quattro,
con l’aggiunta delle interazioni nucleari forte e debole, e le particelle elementari note sono ormai una
trentina. In poco meno di trent’anni la concezione della materia subisce un mutamento così radicale e
inusitato da rendere tale periodo, per la rapidità e la quantità delle conoscenze acquisite, forse unico nella
storia del pensiero scientifico occidentale. Le ricerche di Fermi segnarono profondamente questo trentennio,
non solo per la quantità e l’importanza dei risultati ottenuti ma soprattutto per il loro ruolo storico. Esistono
infatti traguardi scientifici di enorme valore che giungono al termine di lunghe e pazienti ricerche e che
coronano un ben definito progetto iniziale, ma ci sono anche scoperte apparentemente meno straordinarie che
obbligano a inattese risistemazioni del sapere acquisito, scardinano principî metodologici e conoscenze
unanimemente accettate e imprimono alla ricerca direzioni nuove e del tutto impreviste. Nel suo itinerario di
scienziato […] Fermi raggiunse entrambi gli obiettivi.» Giuseppe BRUZZANITI, Enrico Fermi. Il genio obbediente, Einaudi, Torino 2007
«Dalla lettura dei giornali di qualche settimana fa avrai probabilmente capito a quale genere di lavoro ci
siamo dedicati in questi ultimi anni. È stato un lavoro di notevole interesse scientifico e l’aver contribuito a
troncare una guerra che minacciava di tirar avanti per mesi o per anni è stato indubbiamente motivo di una
certa soddisfazione. Noi tutti speriamo che l’uso futuro di queste nuove invenzioni sia su base ragionevole e
serva a qualche cosa di meglio che a rendere le relazioni internazionali ancora più difficili di quello che sono
state fino ad ora. I giornali hanno pubblicato un certo numero di dettagli sul lavoro di questi ultimi anni e tali
dettagli, naturalmente, non sono più segreti. Ti interesserà sapere, se non lo sai già dai giornali italiani, che
verso la fine del 1942 abbiamo costruito a Chicago la prima macchina per produrre una reazione a catena con
uranio e grafite. È diventato d’uso comune chiamare queste macchine «pile». Dopo la prima pila
sperimentale molte altre ne sono state costruite di grande potenza. Dal punto di vista della fisica, come ti
puoi immaginare, queste pile rappresentano una ideale sorgente di neutroni che abbiamo usato tra l’altro per
molte esperienze di fisica nucleare e che probabilmente verranno usate ancora di più per questo scopo ora
che la guerra è finita.» Lettera di Enrico Fermi a Edoardo Amaldi del 28 agosto 1945 (in Edoardo AMALDI, Da via Panisperna all’America,
Editori Riuniti, Roma 1997)
«Vorrei discutere con voi la crisi che la scienza attraversa da due anni a questa parte. In larga misura questa
crisi è dovuta all’improvvisa consapevolezza, di parte dell’opinione pubblica e del Governo, del tremendo
ruolo che la Scienza può avere nelle cose umane. L’importanza di questo ruolo era già nota. Ma il
drammatico impatto portato dalla costruzione della bomba atomica lo ha portato nella pubblica
consapevolezza in maniera così vivida che gli scienziati si sono trovati, inaspettatamente e talora contro la
propria volontà, ad essere sotto i riflettori […] C’è una grande penuria di uomini di scienza ben preparati
[…] Ora le iscrizioni di studenti nei dipartimenti scientifici sono tornate a essere abbondanti. Spero che ben

66
pochi di questi studenti siano attratti dal nuovo fascino che la scienza ha acquistato. La professione del
ricercatore deve tornare alla sua tradizione di ricerca per l’amore di scoprire nuove verità. Poiché in tutte le
direzioni siamo circondati dall’ignoto e la vocazione dell’uomo di scienza è di spostare in avanti le frontiere
della nostra conoscenza in tutte le direzioni, non solo in quelle che promettono più immediati compensi o
applausi.» Discorso tenuto da Enrico Fermi nel 1947 (in Giulio MALTESE, Ritorno a Chicago: Enrico Fermi e la nascita della
fisica delle alte energie nel secondo dopoguerra (1946-1954), in Atti del XXI Congresso Nazionale di Storia della
Fisica e dell’Astronomia, Dipartimento di Fisica, Univers.della Calabria, Arcavacata di Rende (CS), 6,7,8 giugno 2001)
TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO
Diritto di voto e partecipazione dei cittadini alla vita dello stato nell’Italia del XX secolo. Il Candidato,
esaminando i fatti più significativi, illustri l’evoluzione del diritto di voto e della partecipazione politica dei
cittadini nel nostro paese nel corso del Novecento.
TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE
“Le religioni producono sia violenza che nonviolenza. In quanto tensione, ricerca, relazione con qualcosa o
qualcuno colti come un assoluto, esse sono tentate di intransigenza, di totalitarismo esclusivista, di
imposizione violenta…Il potere, più violento è, più si appropria dell’avallo delle religioni, manipolandole.
Le religioni, più sono deboli, più si rendono disponibili a servire il potere” ( Enrico Peyretti, Dieci tesi su
"Religioni, violenza, nonviolenza").
Alla luce delle affermazioni sopra riportate il candidato analizzi con opportuni riferimenti e commenti il
ruolo che possono avere oggi le religioni e il rapporto che stabiliscono con la società e il potere.

67
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE ITALIANO: tema
Punteggio espesso in decimi
INDICATORI
PUNTEGGI Basso Medio Alto
Competenze linguistiche
Punteggiatura, ortografia, morfosintassi
0-0,5-1 1,5-2 2,5-3
Proprietà lessicale
Contenuto
Pertinenza e completezza dei contenuti
0-0,5-1 1,5-2 2,5-3
Capacità di elaborazione logico/critiche e creative
Sviluppo e coerenza delle argomentazioni
0-0,5-1 1,5-2 2,5-3 3,5-4 Elaborazione personale e capacità espressive
Griglia di valutazione prove scritte italiano: saggio breve e articolo di giornale
Punteggio espresso in decimi
INDICATORI
PUNTEGGI Basso Medio Alto
Competenze linguistiche
Punteggiatura, ortografia, morfosintassi
0-0,5-1 1,5-2 2,5-3
Proprietà lessicale
Contenuto
Pertinenza e completezaa dei contenuti
0-0,5-1 1,5-2 2,5-3
Capacità di elaborazione logico/critiche e creative
Sviluppo e coerenza delle argomentazioni - Elaborazione personale e capacità espressive - Ricerca delle informazioni e gestione dei testi
0-0,5-1 1,5-2 2,5-3 3,5-4

68
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE ITALIANO: analisi del testo
Punteggio espresso in decimi
INDICATORI
PUNTEGGI Basso Medio Alto
Competenze linguistiche
Punteggiatura, ortografia, morfosintassi
0-0,5-1 1,5-2 2,5-3
Proprietà lessicale
Conoscenze
Corretta applicazione delle conoscenze riguardanti gli aspetti formali del testo
0-1-1,5 2-2,5 3-3,5-4 Adeguato ricorso alla
biografia, poetica dell'autore e al contesto di riferimento
Capacità di elaborazione logico/critiche e creative
Sviluppo e coerenza delle argomentazioni - elaborazioe
personale e capacità espressive
0-0,5-1 1,5-2 2,5-3
Capacità analitiche e sintetiche (corretta e chiara esposizione dei contenuti del testo)

M.I.U.R. – Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Tecnico Tecnologico “Leonardo da Vinci”
Via A.Volta 01100 Viterbo 0761/309657
Progetto Formazione personale docente per gli Esami di Stato
(Interventi formativi di cui al D.M. n. 23/2013 e al D.M. n. 351/2014)
A.S. 2014/2015
SIMULAZIONE SECONDA PROVA
INDIRIZZO: INFORMATICA
C.C. A042
ISTITUTO TECNICO – SETTORE TECNOLOGICO
TIPOLOGIA E
PRIMA PARTE
Un portale vuole gestire un gioco online che si articola su diversi temi. Gli utenti possono iscriversi delineando il proprio profilo. Per far questo devono scegliere un nickname inesistente, una password e fornire le proprie informazioni anagrafiche , alcune obbligatorie quali il cognome, il nome, l’indirizzo, la nazione e un'email, altre opzionali quali il messaggio di presentazione, la foto, un hobby e altre informazioni di tipo generale. E’ invece obbligatoria la domanda da proporre e la risposta da fornire in caso di password dimenticata per l’invio automatico della password all’e -mail registrata , il consenso alla manipolazione dei propri dati per la tutela della privacy e l’eventuale consenso a fornire i dati sensibili a terzi. Solo successivamente, possono decidere di giocare. Il gioco si articola in diversi temi, ognuno dei quali è caratterizzato da una descrizione, un’ambientazione (il luogo in cui si svolge il gioco) e da una serie di personaggi, propri di quel tema. Di ogni personaggio è nota la descrizione e l’immagine sia al femminile che al maschile. Ogni utente, quando decide di giocare, deve scegliere il tema, il personaggio e il genere, che rappresenteranno il suo avatar. Ogni tema è suddiviso in stanze che rappresentano il livello del gioco. In ciascuna di esse verrà archiviato il livello ed un numero che rappresenta il bonus massimo necessario per passare al livello successivo. In ogni stanza il personaggio potrà compiere diverse azioni (le modalità di gioco esulano dal contesto) e per ogn i azione si ricevono un certo numero di punti, positivi o negativi (bonus/malus) a seconda dell’esito dell’azione; quando la somma del bonus/malus delle azioni di una stanza raggiunge il bonus massimo previsto dalla stanza, l’utente passa automaticamente al livello successivo. Il candidato, dopo aver effettuato le ipotesi aggiuntive fornisca:

1. Un’analisi del contesto da modellare; 2. Lo schema concettuale dei dati (ER); 3. Lo schema logico di tre tabelle significative derivate dal modello concettuale; 4. La codifica in linguaggio SQL della creazione delle tre tabelle del punto 3) 5. Le seguenti interrogazioni SQL:
a. Dato un nickname fornire la lista dei personaggi scelti come avatar; b. Fornire il nome del personaggio più scelto dagli utenti,
indipendentemente dal genere; c. Per ogni tema visualizzare il totale massimo di bonus ottenibili in tutte le
stanze di quel tema.
6. l’architettura del sito web del gioco che deve consentire a un utente di: a. Iscriversi o accedere al portale; b. Scegliere temi e personaggi; c. Visualizzare le classifiche personali.
7. La codifica in un linguaggio lato server a scelta del candidato di una opzione del
sito.
SECONDA PARTE
Il candidato scelga e svolga due quesiti tra i quattro proposti.
QUESITO N.1
Parlare delle tecnologie hardware e software utilizzate per gestire database nel Web, facendo riferimento all’esperienza maturata in questo ultimo anno. QUESITO N.2
Dopo aver descritto brevemente i vari tipi di modelli logici di database che si sono evoluti nel tempo, il candidato si soffermi sul modello relazionale, spiegando, con l’ausilio di esempi, gli operatori dell’algebra relazionale. QUESITO N.3
Dopo aver definito brevemente “cosa è” e “a cosa serve” un modello concettuale, si parli, aiutandosi anche con degli esempi, dei costituenti di quest’ultimo. QUESITO N.4
L'Alternanza Scuola Lavoro è il contesto più significativo in cui uno studente può sperimentare le proprie competenze misurandosi con il mercato del lavoro. Descrivi brevemente quali sono gli obblighi che nei percorsi di alternanza sono tenuti a rispettare il Datore di Lavoro e il Beneficiario. Descrivi inoltre la tua esperienza di ASL a partire dai contenuti del Piano Formativo Personalizzato con particolare riguardo a:
1. obiettivi professionali e attività previste e concordati da tutor aziendale e tutor interno;

2. aderenza del piano con il percorso aziendale effettivamente effettuato descrivendo le conoscenze acquisite o consolidate durante lo svolgimento dell’attività formativa nel contesto lavorativo in merito a processi produttivi e/o prodotti.
DURATA DELLA PROVA 6h

CRITERI DI VALUTAZIONE
PRIMA PARTE
Descrittore competenza Indicatore
Punteggio max
Descrittore valutazione
Analisi generale e funzionale del sistema
(punteggio massimo 2/15):
individuare il contesto del problema/sistema e tutte le funzioni che il sistema informativo deve espletare, sia in locale che in remoto;
analizzarne criticamente informazioni e relazioni che ne derivano;
proporre vincoli integrativi coerenti con il testo e con la realtà da automatizzare.
0,2
(non risponde)
Il candidato non risponde
0,8
(scarso)
Il candidato ha gravi difficoltà ad individuare il contesto del problema e le funzioni che il sistema informativo deve
espletare, sia in locale che in remoto; è assente o inadeguata un'analisi critica delle informazioni e le relazioni
individuate sono sbagliate o inefficienti, i vincoli integrativi o non esistono o non sono coerenti con la realtà da
automatizzare.
1,2
(insufficiente)
Il candidato ha difficoltà ad individuare il contesto del problema e tutte le funzioni che il sistema informativo deve
espletare, sia in locale che in remoto; l'analisi critica delle informazioni e relazioni che ne derivano è carente e i vincoli
integrativi o non esistono o non sono coerenti con la realtà da automatizzare.
1,47
(sufficiente)
Il candidato individua il contesto del problema, ma con qualche errore o omette alcune funzioni che il sistema
informativo deve espletare, sia in locale che in remoto; l'analisi critica delle informazioni e relazioni che ne derivano è
semplificata e i vincoli integrativi, se proposti, sono riduttivi o non sempre coerenti con la realtà da automatizzare.
1,73
(buono)
Il candidato individua, in modo adeguato il contesto del problema e le principali funzioni che il sistema informativo deve
espletare, sia in locale che in remoto; l'analisi critica delle informazioni e relazioni che ne derivano è complessivamente
corretta e i vincoli integrativi, se proposti, sono coerenti con la realtà da automatizzare.
2
(ottimo)
Il candidato individua, in modo corretto ed originale il contesto del problema e le funzioni principali, che il sistema
informativo deve espletare, sia in locale che in remoto; l'analisi critica delle informazioni e relazioni che ne derivano è
corretta ed approfondita e i vincoli integrativi sono coerenti con la realtà da automatizzare, consentendo
un'ottimizzazione generale della soluzione.
Descrittore competenza Indicatore Descrittore valutazione

Punteggio max
Analisi dati (punteggio massimo 4/15)
Il candidato è in grado di:
documentare e schematizzare lo schema concettuale prescelto per l’organizzazione dati tramite opportuni formalismi;
evidenziare eventuali associazioni esistenti tra i dati ed eventuali vincoli d’integrità relativi alle singole proprietà.
0,2
(non risponde)
Il candidato non risponde
1,6
(scarso)
Il candidato ha gravi difficoltà a documentare e schematizzare lo schema concettuale prescelto per l’organizzazione.
Sbaglia spesso i formalismi e le associazioni esistenti tra i dati.
2,4
(insufficiente)
Il candidato ha difficoltà documentare e schematizzare lo schema concettuale prescelto per l’organizzazione. Non usa
correttamente i formalismi e non evidenzia correttamente le associazioni esistenti tra i dati.
2,9
(sufficiente)
Il candidato documenta e schematizza lo schema concettuale prescelto per l’organizzazione, ma commette errori e
non sempre usa correttamente i formalismi. Non sempre evidenzia correttamente le associazioni esistenti tra i dati.
3,47
(buono)
Il candidato documenta e schematizza in modo adeguato lo schema concettuale prescelto per l’organizzazione e usa
correttamente i formalismi. Evidenzia in modo adeguato le associazioni esistenti tra i dati.
4
(ottimo)
Il candidato documenta e schematizza in modo corretto e completo lo schema concettuale prescelto per
l’organizzazione e usa correttamente i formalismi. Evidenzia correttamente ed efficientemente le associazioni esistenti
tra i dati.
Descrittore competenza Indicatore
Punteggio max
Descrittore valutazione
Modellazione logica (punteggio massimo 1/15)
Il candidato è in grado di:
documentare ed implementare lo schema dell’organizzazione dati precedentemente proposto tramite un modello logico a scelta del candidato
derivare il modello logico dal modello concettuale dei dati in modo corretto e coerente;
0,2
(non risponde)
Il candidato non risponde
0,4
(scarso)
Il candidato documenta e implementa lo schema logico commettendo gravi e diffusi errori e/o omettendo informazioni
importanti. La derivazione del modello da quello concettuale non è corretta e/o è incoerente rispetto al modello
concettuale proposto.
0,6
(insufficiente)
Il candidato documenta e implementa lo schema logico commettendo molti errori e/o omettendo informazioni
importanti. La derivazione del modello da quello concettuale non è corretta e/o è incoerente rispetto al modello
concettuale proposto.

0,76
(sufficiente)
Il candidato documenta e implementa lo schema logico commettendo alcuni errori e/o omettendo qualche
informazione. La derivazione del modello da quello concettuale non è sempre corretta e/o non completamente
coerente rispetto al modello concettuale proposto.
0,87
(buono)
Il candidato documenta e implementa lo schema logico in modo complessivamente corretto senza omettere
informazioni fondamentali. La derivazione del modello da quello concettuale è complessivamente corretta e coerente
rispetto al modello concettuale proposto.
1
(ottimo)
Il candidato documenta e implementa lo schema logico in modo corretto e completo. La derivazione del modello da
quello concettuale è corretta e coerente rispetto al modello concettuale proposto.
Descrittore competenza Indicatore
Punteggio max
Descrittore valutazione
Codifica delle definizioni e manipolazioni della base
di dati (punteggio massimo 3/15)
Il candidato è in grado di:
definire la struttura della base di dati in linguaggio SQL
formalizzare le interrogazioni alla base di dati richieste dal testo in linguaggio SQL.
0,2 Il candidato non risponde
1,2
(scarso)
Il candidato commette gravi errori nel definire correttamente la struttura della base di dati in linguaggio SQL. Commette
gravi errori nel codificare le interrogazioni richieste dal testo in linguaggio SQL.
1,8
(insufficiente)
Il candidato non è in grado di definire correttamente la struttura della base di dati in linguaggio SQL. Commette molti
errori nel codificare le interrogazioni richieste dal testo in linguaggio SQL.
2,2
(sufficiente)
Il candidato definisce parzialmente o con qualche errore la struttura della base di dati in linguaggio SQL. Commette
errori nel codificare le interrogazioni richieste dal testo in linguaggio SQL e/o codifica solamente quelle più semplici.
2,6
(buono)
Il candidato definisce con qualche imprecisione la struttura della base di dati in linguaggio SQL. Codifica le
interrogazioni richieste in modo complessivamente corretto e/o completo.
3
(ottimo)
Il candidato definisce in modo completo e corretto la struttura della base di dati in linguaggio SQL. Codifica le
interrogazioni richieste in modo corretto e completo.
Descrittore competenza Indicatore
Punteggio max
Descrittore valutazione

Analisi e sviluppo software (punteggio massimo
2/15)
Documentare i requisiti e gli aspetti architetturali necessari allo sviluppo del prodotto;
Organizzare il software e/o il progetto della soluzione web, individuando un disegno conversazionale coerente con l’analisi funzionale e l’implementazione dati proposta, contenente i moduli più significativi.
Codificare un elemento significativo del prodotto proposto in un ambiente e in linguaggio di programmazione a scelta
0,2 Il candidato non risponde
0,8
(scarso)
Il candidato ha gravi difficoltà ad analizzare il software e i requisiti necessari al suo sviluppo. Sbaglia o non produce un
disegno conversazionale e non codifica o lo fa sommariamente e con gravi errori il segmento individuato come
significativo.
1,2
(insufficiente)
Il candidato ha difficoltà ad analizzare il software e i requisiti necessari al suo sviluppo. Non è in grado di produrre in
modo corretto un disegno conversazionale. Non codifica o lo fa sommariamente e con molti errori il segmento
individuato come significativo.
1,47
(sufficiente)
Il candidato analizza parzialmente il software e i requisiti necessari al suo sviluppo commettendo qualche errore di
valutazione. Produce un disegno conversazionale non completo e/o con qualche errore. Codifica con qualche errore il
segmento individuato come significativo.
1,73
(buono)
Il candidato analizza in modo corretto il software e i requisiti necessari al suo sviluppo. Produce un disegno
conversazionale adeguato. Codifica in modo complessivamente corretto il segmento individuato come significativo.
2
(ottimo)
Il candidato analizza in modo corretto e completo il software e i requisiti necessari al suo sviluppo. Produce un disegno
conversazionale adeguato ed originale. Codifica in modo corretto ed ottimizzato il segmento individuato come
significativo.
SECONDA PARTE
Descrittore competenza Indicatore
Punteggio max
Descrittore valutazione
0,2 Il candidato non risponde

Redazione di relazioni tecniche e documentazione
di attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali (punteggio massimo 3/15)
Conoscenza degli argomenti richiesti Trattazione critica Linguaggio adeguato al contesto
(non risponde)
1,2
(scarso)
Il candidato non riesce ad individuare il contesto della problematica richiesta. Dimostra di non conoscere i contenuti
richiesti, né di essere in grado di affiancare elaborazioni critiche e personali a quanto sostiene. Espone i concetti in
maniera molto confusa e/o utilizza un linguaggio non conforme al contesto.
1,8
(insufficiente)
Il candidato ha difficoltà ad individuare il contesto della problematica richiesta. Descrive solo alcuni aspetti della
tematica e/o dimostra di non conoscere i contenuti richiesti, né di essere in grado di affiancare elaborazioni critiche e
personali a quanto sostiene. Espone i concetti in maniera molto confusa e/o utilizza un linguaggio non conforme al
contesto.
2,2
(sufficiente)
Il candidato individua il contesto della problematica richiesta, ma con qualche errore e/o omette alcune aspetti
fondamentali per la trattazione. Le elaborazioni critiche e personali sono assenti o non sempre adeguate a sostenere
gli argomenti descritti. Espone i concetti in maniera non chiara e/o utilizza un linguaggio non sempre conforme al
contesto
2,6
(buono)
Il candidato individua il contesto della problematica richiesta e ne tratta correttamente gli aspetti fondamentali. Le
elaborazioni critiche e personali sono essenziali, ma adeguate a sostenere le situazioni descritte. Espone i concetti in
maniera chiara e utilizza un linguaggio conforme al contesto
3
(ottimo)
Il candidato individua il contesto della problematica richiesta e ne tratta correttamente e approfonditamente tutti gli
aspetti. Le elaborazioni critiche e personali a sostegno delle situazioni descritte sono adeguate ed originali. Espone i
concetti in maniera chiara e analitica e utilizza un linguaggio conforme al contesto.

GRIGLIA:
Studente ______________________________________________________________ classe: ______________
Indicatore
Descrittore competenza
NON
RISPONDE
SCARSO (RANGE valutazione
complessiva
2… 9/15)
INSUFFICIENTE (RANGE valutazione
complessiva
2… 9/15)
SUFFICIENTE (RANGE valutazione
complessiva
10… 11/15)
BUONO (RANGE valutazione
complessiva
12… 13/15)
OTTIMO (RANGE valutazione
complessiva
14… 15/15)
PUNTEGGIO
Prima Parte Punteggio
massimo
Punteggio
massimo
Punteggio
massimo
Punteggio
massimo
Punteggio
massimo
Analisi generale e funzionale del
sistema (Punteggio 0..2)
0,2 0,8 1,2 1,47 1,73 2
Analisi dati
(Punteggio 0..4)
0,2 1,6 2,4 2,9 3,47 4
Modellazione logica (Punteggio
0..1)
0,2 0,4 0,6 0,76 0,87 1
Codifica delle definizioni e
manipolazioni della base di dati
(Punteggio 0..3)
0,2 1,2 1,8 2,2 2,6 3
Analisi e sviluppo software
(Punteggio 0..2)
0,2 0,8 1,2 1,47 1,73 2
Seconda Parte
Redazione di relazioni tecniche
(Punteggio 0..3)
0,2 1,2 1,8 2,2 2,6 3
TOTALI 1 6 9 11 13

ITT "Leonardo Da Vinci" VITERBO A.S. 2014-2015 Simulazione Terza Prova Esame di Stato Classe 5A/Informatica Cognome e Nome ...........................................
78
SIMULAZIONE TERZA PROVA
ESAMI DI STATO
ANNO SCOLASTICO 2014-2015
CLASSE 5A/INFORMATICA
Materie interessate:
Matematica
Storia
Sistemi e Reti
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici
Inglese
Durata della prova: 2 h.
Tipologia B ( quesiti a risposta singola)
Modalità:
Ogni materia propone due quesiti a risposta singola (10
quesiti in tutto)
Criteri di valutazione:
Ad ogni domanda sarà assegnato al massimo 1,5 punto - Quesito senza risposta : 0,1 punti
La griglia di valutazione è la seguente:
A- Conoscenze specifiche e comprensione dei contenuti:
1. Non risponde punti 0,1 2. Non conosce i contenuti punti 0,25 3. Trattazione parziale punti 0,5 4. Aderisce alla traccia nelle linee generali punti 0,75 5. Trattazione completa ed aderente al tema punti 1
B- Uso del linguaggio specifico:
1. Mancanza di struttura logica e inadeguatezza lessicale punti 0,125 2. Errori diffusi che condizionano l’efficacia comunicativa punti 0,250 3. Errori sporadici, lessico limitato, uso accettabile del linguaggio specifico punti 0,375 4. Esposizione chiara, ordinata con uso pertinente del lessico specifico punti 0,5
Il punteggio totale sarà la somma dei punteggi assegnati a ogni risposta e risulterà perciò di 15 punti
al massimo.

ITT "Leonardo Da Vinci" VITERBO A.S. 2014-2015 Simulazione Terza Prova Esame di Stato Classe 5A/Informatica Cognome e Nome ...........................................
79
MATEMATICA
1) Calcolare il seguente integrale definito e indicare il significato geometrico del risultato ottenuto (max 15 righe)

ITT "Leonardo Da Vinci" VITERBO A.S. 2014-2015 Simulazione Terza Prova Esame di Stato Classe 5A/Informatica Cognome e Nome ...........................................
80

ITT "Leonardo Da Vinci" VITERBO A.S. 2014-2015 Simulazione Terza Prova Esame di Stato Classe 5A/Informatica Cognome e Nome ...........................................
81
STORIA
1. Esamina il Delitto Matteotti e l’instaurazione del Regime Fascista (max. 15 righe)

ITT "Leonardo Da Vinci" VITERBO A.S. 2014-2015 Simulazione Terza Prova Esame di Stato Classe 5A/Informatica Cognome e Nome ...........................................
82
2. Presenta la Repubblica di Weimar in Germania (max. 15 righe)

ITT "Leonardo Da Vinci" VITERBO A.S. 2014-2015 Simulazione Terza Prova Esame di Stato Classe 5A/Informatica Cognome e Nome ...........................................
83
SISTEMI E RETI
1) Descrivere le funzioni del livello di trasporto dell’architettura di rete TCP/IP e illustrare le
caratteristiche dei protocolli più noti, specificati per questo livello (max 10 righe)
2) In riferimento al traffico generato dalle applicazioni, illustrare le tecniche che possono essere
impiegate per ottenere livelli di servizio differenti, rispetto al trattamento “best effort” tipico delle reti IP (max 10 righe)

ITT "Leonardo Da Vinci" VITERBO A.S. 2014-2015 Simulazione Terza Prova Esame di Stato Classe 5A/Informatica Cognome e Nome ...........................................
84
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI
1. Illustrare (anche con esempi) gli elementi che compongono un diagramma dei casi d’uso ed evidenziare
in che modo è possibile trarre vantaggio dalla rappresentazione grafica, nella fase di specifica dei
requisiti del software. (max 10 righe)
2. Spiegare cosa si intende per usabilità di un’interfaccia utente e in riferimento al Web, illustrare (anche
con esempi) i principi di usabilità applicabili in fase di progettazione (max 10 righe)

ITT "Leonardo Da Vinci" VITERBO A.S. 2014-2015 Simulazione Terza Prova Esame di Stato Classe 5A/Informatica Cognome e Nome ...........................................
85
INGLESE
1. What is a database and what can it do? (max.10 lines)
2. Can you write a report of the Cold War? (max.10 lines)

86