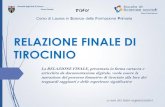Relazione finale IFOM
-
Upload
luca-de-cristofaro -
Category
Documents
-
view
509 -
download
5
Transcript of Relazione finale IFOM

IFOM Fondazione Istituto FIRC di Oncologia Molecolare
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dall’Autonomia Scolastica – Ex IRRE Lombardia
“LO STUDENTE RICERCATORE – Anno 2010”Progetto di integrazione tra ricerca e scuola
Due settimane in laboratorioRELAZIONE FINALE SCIENTIFICA DELLO STUDENTE
(rapporto di ricerca)A cura degli studenti ricercatori
Nome e cognome dello studente: Luca De Cristofaro
Periodo trascorso presso il Campus IFOM-IEO: 14–25/06/2010
Gruppo di lavoro: DNA sequencing Unit
Nome tutor: Dr Sara Volorio
USR – IFOM – ANSAS“LO STUDENTE RICERCATORE - Anno 2010 – Relazione finale scientifica dello studente
1

Relazione finale scientifica
1. Titolo dell’attività svolta:
Ricerca di mutazioni germinali nei geni BRCA1 e BRCA2 in pazienti affetti da tumore ereditario alla mammella e all’ovaia:
studio del flusso di lavoro
2. Sommario dell’attività svolta (Abstract):Il laboratorio di DNA sequencing del campus IFOM-IEO offre sia servizio di diagnostica
predittiva di tumori ereditari in alcuni organi (tra cui la mammella e l’ovaia) sia servizio di sequenziamento di campioni di DNA a scopi di ricerca. Il flusso di lavoro è differente a seconda che un campione faccia parte del primo o del secondo tipo di servizio, anche se le tecniche base di amplificazione del DNA (PCR), del sequenziamento (metodo di Sanger) e la maggior parte degli strumenti sono in comune. Il mio lavoro si è concentrato principalmente sul flusso di lavoro che porta alla ricerca di mutazioni in soggetti affetti da tumore ereditario.
I geni di interesse sono, nel nostro caso, BRCA1 e BRCA2 (BReast CAncer), due geni oncosopressori coinvolti in molti meccanismi della cellula quali i sistemi di controllo del ciclo cellulare, i sistemi di riparo del DNA, la demolizione delle proteine (tramite marcatura con ubiquitina), l’inattivazione del cromosoma X (nelle donne, per compensare la dose di geni in eccesso rispetto al sesso maschile) e la differenziazione delle cellule staminali dell’epitelio mammario. Si è osservato che mutazioni congenite in questi geni innalzano sensibilmente la probabilità di contrarre tumore alla/e mammella/e e/o all’ovaia rispetto al resto della popolazione. Perciò ottenere una preventiva informazione sulla presenza di queste variazioni nucleotidiche in famiglie a rischio permette un tempestivo intervento, se necessario, o una più accurata sorveglianza dell’individuo nel tempo, limitando il rischio dello svilupo del tumore.
3. Descrizione dettagliata dell’attività svolta
3.1 Premessa:Il gene BRCA1 ha 24 esoni di cui 22 codificanti, mentre il gene BRCA2 ne ha 27, di cui
26 codificanti. In entrambi i geni lo start codon si trova nell’esone 2 e in BRCA1 l’esone 4 non viene normalmente tradotto. Gli mRNA trascritti sono rispettivamente di 7.8 kb e 10.4 kb.
Per i geni BRCA1 e BRCA2 e’ stato sviluppato in questo laboratorio un “kit” costituito da 69 ampliconi di circa 500 paia di basi l’uno, indicando con amplicone il prodotto di un’ amplificazione tramite PCR. Gli esoni più lunghi vengono amplificati in più ampliconi parzialmente sovrapposti alle estremità; quelli più piccoli, se consecutivi, vengono amplificati
USR – IFOM – ANSAS“LO STUDENTE RICERCATORE - Anno 2010 – Relazione finale scientifica dello studente
2

in un unico amplicone; quelli che presentano regioni in cui si ripete consecutivamente un solo nucleotide (omopolimeriche) vengono analizzati su ampliconi ottenuti con un primer che si lega al gDNA (per “gDNA”, in seguito nominato anche “genomico”, si intende il DNA costituente l’intero genoma di un individuo) a valle della sequenza ripetuta. In questo modo si possono evitare errori della Taq polimerasi (fenomeno dello “scivolamento” della Taq) che, durante la PCR, tenderebbe ad inserire nell’amplificato altri nucleotidi dello stesso tipo di quelli ripetuti, causando uno frameshift. Questo “kit” è in grado di aumentare l’efficienza e la tempestività della diagnosi poiché consente di amplificare tutti gli ampliconi alla stessa temperatura e di utilizzare solo due primers per la reazione di sequenza.Le analisi sono leggermente diverse a seconda della tipologia del paziente. Si analizzano tutti gli ampliconi nel caso dei probandi, i pazienti da cui si comincia l’analisi del patrimonio genetico di una famiglia. I familiari dei probandi vengono detti collaterali e dei loro campioni vengono amplificati e sequenziati solamente gli esoni mutati nel campione di DNA del probando di riferimento, seguendo il normale flusso di lavoro del servizio.
In questa relazione parlerò del flusso di lavoro, workflow, che parte dall’estrazione del DNA per arrivare alla diagnosi di una mutazione germinale nei geni sopra citati e alla produzione di un referto da consegnare alla sezione di consulenza genetica dell’ospedale di provenienza della richiesta d’analisi. Prevedendo però il flusso di lavoro della diagnosi l’uso di stazioni automatizzate, a causa dell’elevato numero di ampliconi da trattare in contemporanea, la parte sperimentale sarà da me svolta sul gene TRP53, con solo 10 esoni codificanti, su un campione di DNA di topo.Il mio lavoro con TRP53 ha seguito un procedimento intermedio tra quello di diagnosi e quello di servizio. Infatti il gDNA è stato trattato come quello di un probando, ossia sono stati analizzati tutti gli esoni codificanti, mentre solitamente in un campione di servizio si analizza un determinato esone, richiesto dall’utente. Inoltre e’ stato usato un “kit” specifico per questo gene, disegnato mantenendo le stesse caratteristiche, sopra citate, di quello per i geni BRCA 1 e BRCA2. D’altra parte non può essere considerato nemmeno esclusivamente di diagnosi perché queste analisi non conducono a nessun referto, ma solo alla compilazione di una tabella (Allegato 8) che riassume il risultato del lavoro, e perché i metodi di purificazione dei prodotti di PCR e di sequenziamento seguono il workflow del servizio.
3.2 Risultati e discussione:
Il workflow che porta alla stesura di un referto medico può essere schematizzato come da Allegato 1. Maggiori dettagli a proposito dei passaggi sono riportati nella sessione “Materiali e metodi”.
Le fasi di amplificazione delle regioni di interesse (PCR), la visualizzazione del prodotto su gel e l’allestimento delle reazioni di sequenza sono state da me effettuate in modo manuale, usando come materiale di partenza il genomico di topo e come gene da analizzare TRP53.L’Allegato 2 mostra la struttura del gene TRP53, composto da 11 esoni, di cui solo gli ultimi 10 sono trascritti. Gli esoni 3 e 4 , essedo molto piccoli, sono stati analizzati in un unico amplicone, per un totale di 9 amplificati.
Il genomico era già stato precedentemente estratto da cellule di topo. L’amplificazione dei 10 esoni è avvenuta in “plate” a 96 pozzetti (ovvero piastre di materiale plastico adatte a
USR – IFOM – ANSAS“LO STUDENTE RICERCATORE - Anno 2010 – Relazione finale scientifica dello studente
3

sopportare alte temperature), ponendo nei primi 9 di questi una mix pronta all’uso dei primers Forward e Reverse. Successivamente ho calcolato le quantità degli altri reagenti necessari (elencati nella sezione “Materiali e metodi”), eseguendo delle proporzioni a partire dalle quantità di protocollo. Ho però eseguito i calcoli per 11 pozzetti, due in più, per prevenire deficit di materiale dovuti ad errori di taratura delle pipette. Essendo avanzato un volume preciso corrispondente ai due pozzetti in più, questo è stato utilizzato per allestire due reazioni su due regioni (gli ampliconi 2 e 3-4) da parte degli operatori di laboratorio, come controllo.
L’Allegato 3 mostra come appaiono gli amplificati dopo 40 cicli di PCR.Ho caricato 1/10 del volume di reazione di PCR su un gel di agarosio preparato da me come nei “Materiali e metodi”.Si intuisce la bontà della PCR perché in ogni pozzetto è evidente una sola banda e quindi sono presenti solo ampliconi con lo stesso peso molecolare, cioè presumibilmente dello stesso tipo, corrispondete al peso atteso (dato che si può dedurre da una veloce analisi di confronto con il marcatore di peso molecolare appositamente caricato sullo stesso gel). Inoltre si può notare che le bande dei primi due pozzetti, denominati L2 ed L3-4, si trovano alla stessa altezza delle bande degli ultimi due pozzetti, C2 e C3-4, che sono i pozzetti di controllo.
Ho in seguito allestito le reazioni di sequenziamento col metodo di Sanger manualmente, secondo il procedimento del servizio di sequencing, ossia ho suddiviso gli ampliconi in due “plate”: una servirà a sequenziale il filamento senso e l’altra il filamento antisenso. Poi ho aggiunto alle plate una mix (Exosap) contenente i reagenti necessari alla purificazione tramite enzimi dei frammenti di PCR: è l’alternativa non automatizzata al metodo AMPure utilizzato in diagnostica (vedi sessione “Materiali e metodi”). È usata nel servizio perché ottimale per trattare materiale che non ha caratteristiche costanti, come invece succede per i kit diagnostici. Dopo che gli enzimi hanno lavorato, ho aggiunto alla miscela una mix di sequenziamento contenenti degli elementi elencati nella sezione “Materiali e metodi”. Quindi ho portato le “plate” nei termociclatori per far avvenire la reazione. Infine ho purificato i prodotti con due cicli di filtrazione in Millipore, uno strumento che, utilizzando una pompa a vuoto, trattiene i frammenti di acidi nucleici superiori ad un certo peso all’interno di una membrana filtrante. Dopodiché si ottiene il DNA semplicemente eluendolo in acqua e raccogliendolo in una nuova “plate”. Anche nel caso della purificazione delle reazioni di sequenziamento il metodo usato è alternativo a quello della diagnosi perché si adatta maggiormente alle esigenze del servizio.
Prima di caricare le reazioni nel sequenziatore, ho dovuto richiedere il sequenziamento dei miei ampliconi compilando il formato di request del servizio (“single tube”). Nell’Allegato 4 e nella sezione “Materiali e metodi” sono riportate ulteriori informazioni a riguardo.
Compilata la request, ho caricato le “plate” nel sequenziatore che, una volta terminate le corse elettroforetiche, mostra sul computer ad esso collegato un’immagine (come quella riportata nell’Allegato 5) che serve ad apprezzare la qualità delle corse. Ogni riga nell’Allegato 5 viene in seguito elaborata dal software in un grafico della sequenza detto “elettroferogramma”, come in Allegato 6. Maggiori informazioni sul funzionamento del sequenziatore sono reperibili nella sezione “Materiali e metodi”. Ogni “elettroferogramma” di un paziente viene infine importato nel software di analisi descritto successivamente. Nell’Allegato 7 sono mostrate due schermate del software.
USR – IFOM – ANSAS“LO STUDENTE RICERCATORE - Anno 2010 – Relazione finale scientifica dello studente
4

3.3 Conclusioni:
All’interno del processo di lavoro di diagnosi, l’organizzazione del workflow in vari passaggi eseguiti da persone diverse, l’impiego della robotica e, soprattutto, l’efficienza del kit utilizzato permettono al laboratorio di offrire un servizio di alto livello sia dal punto di vista quantitativo, sia dal punto di vista qualitativo.I referti vengono stilati in un massimo di 6 settimane per i probandi e 15 giorni per i casi urgenti permettendo così cure tempestive o un controllo precoce della salute del paziente.Le vari tipologie di mutazioni riscontrabili in un campione sono elencate nell’Allegato 9.
Per quanto riguarda l’analisi del mio campione di topo, nell’Allegato 8 è riportata la tabella riassuntiva dei risultati. Il campione da me analizzato insieme agli operatori di laboratorio non presenta mutazioni ed è quindi “wild type”. Il fatto di non aver utilizzato un campione di DNA destinato alla diagnosi non mi ha ovviamente impedito di apprezzare i metodi di lavoro del servizio e della diagnosi dal momento che ho avuto l’occasione di eseguire in prima persona, con l’aiuto degli operatori di laboratorio, le reazioni di PCR, di sequenziamento e di purificazione e di analizzare i dati con software specifici.
In seguito a questa esperienza, oltre l’approfondimento e l’ampliamento delle mie conoscenze in questo campo, ho avuto l’opportunità di provare in prima persona la vita di laboratorio in un campus di ricerca. In questo modo ho visto confermate le mie passioni e le mie aspirazioni per il mio futuro universitario e lavorativo e ho vissuto a livello pratico la Scienza finora letta soltanto nei libri. Ho anche avuto la possibilità di comprendere il contributo che la tecnologia apporta alla ricerca scientifica sostenendola e dandole la possibilità di progredire. Inoltre nel mio periodo di permanenza ho intuito sia la grande opportunità che un centro come l’IFOM offre alla ricerca scientifica e ai ricercatori sia quanto un impegno in questo settore sia origine di grande soddisfazione a livello personale e, soprattutto, in vista della finalità filantropica dello stesso.
4 Materiali e metodi
Di seguito vengono descritti in dettaglio i passaggi che sono effettuati nel laboratorio di Sequencing, precedentemente schematizzati nell’Allegato 1.
2) Il DNA viene estratto dal campione di sangue e “catalogato”
Il gDNA è estratto in modo totalmente automatico da 200 µl di sangue del paziente da una stazione robotica (QiaCube) tramite lisi, centrifugazioni e diluizioni. Successivamente gli viene assegnato un codice univoco in modo da poter essere archiviato in una banca biologica. Questa operazione è svolta da Matrix, un lettore di codici a barre collegato ad un database. Viene poi misurata la concentrazione del DNA nel campione per mezzo di uno spettrofotometro, uno strumento in grado di associare alla quantità di luce ultravioletta (λ=260 nm) assorbita la concentrazione del DNA.
3) Le regioni di DNA utili ai nostri fini vengono amplificate tramite la tecnica della PCR
USR – IFOM – ANSAS“LO STUDENTE RICERCATORE - Anno 2010 – Relazione finale scientifica dello studente
5

Le reazioni di PCR sono allestite in piastre (plates) a 96 pozzetti. Ogni piastra conterrà gli ampliconi per i geni BRCA1 e BRCA2 di un singolo paziente. Le plates per la PCR sono preparate da due robot. Il primo, CyBio (una stazione robotica a 96 puntali), viene utilizzato per preparare le piastre contenenti, in ogni pozzetto, una mix di primer Forward e Reverse per ogni amplicone. Queste piastre “figlie” sono create a partire da una plate “madre” allestita manualmente, depositando nei pozzetti le diverse coppie di primers specifici per ogni amplicone. I primers utilizzati sono stati appositamente disegnati con delle percentuali di coppie A-T e C-G simili l’un l’altro in modo da poter avere la stessa temperatura di annealing (per garantire una amplificazione in condizioni isotermiche). Inoltre alla estremità 5’ di ogni primer Forward e’ stato aggiunta un cap iniziale costituito da una sequenza oligonucleotidica uguale per ciascun primer Forward ma diversa da quella aggiunta ai primers Reverse, in modo da poter eseguire le reazioni di sequenziamento utilizzando due soli primer, uno per lo strand forward e l’altro per lo strand reverse.Il secondo, Biomek3000 (una stazione robotica a 8 puntali indipendenti), inserisce invece nei pozzetti tutti gli elementi necessari alla PCR, cioè il gDNA da amplificare, i dNTPs, la Taq polimerasi, una soluzione salina che permette alla Taq di funzionare (buffer), un sale di magnesio (MgCl2 nel nostro caso) e del glicerolo (C3H8O3) che favorisce la denaturazione del DNA. A questo punto la plate è pronta per la reazione di amplificazione nel termociclatore GeneAmp PCR System 9700, seguendo un apposito programma predefinito.
4) Si verifica la qualità della PCR
Prima di procedere con il lavoro bisogna verificare che la PCR sia avvenuta correttamente e lo si fa semplicemente allestendo un’elettroforesi su gel di agarosio (vedi Allegato 3 come esempio di come appare una banda amplificata su gel di agario). L’agarosio viene sciolto a caldo (in un microonde) in presenza di un buffer salino e trattato con bromuro di etidio, una sostanza in grado di intercalarsi tra i due filamenti del DNA e di emettere luce se eccitata da raggi UV. Gli amplificati sono caricati nei pozzetti che si formano mettendo nel gel degli appostiti “pettini” prima che questo si solidifichi. Per far in modo che il DNA cada nel pozzetto, si aggiunge al materiale una sostanza che si lega alla molecola, appesantendola, e che allo stempo permette di valutare come il campione migra nel gel, perche’ e’ colorata.Dopo la corsa elettroforetica, il gel viene esposto ai raggi UV. L’immagine e’ quindi catturata da un apparecchio fotografico e stampata su carta appropriata.
5) La PCR viene purificata
Una volta avvenuta la PCR bisogna purificare il materiale ottenuto per evitare che primers, frammenti di gDNA, dNTPs e sali interferiscano con i processi successivi.Lo si fa mediante dei lavaggi con AMPure, una soluzione che contiene delle biglie (beads) magnetiche che trattengono gli ampliconi. Alla fine dei lavaggi, le plates sono adagiate su una piastra magnetica e la fase liquida viene asportata. Quindi le beads vengono risospese in acqua, dove liberano gli ampliconi. Questo passaggio è svolto dal robot Biomek FX, che ripartisce il contenuto della plate iniziale in due plate distinte (una servirà a sequenziale lo strand forward, l’altra lo strand reverse) che verranno trattate poi in parallelo.
6) Il DNA viene preparato per essere sequenziato
Ora si può eseguire la reazione di sequenza (metodo di Sanger). Nonostante le reazioni siano 138 per ogni paziente (69 per il lato Forward e 69 per quello Reverse) i primers da
USR – IFOM – ANSAS“LO STUDENTE RICERCATORE - Anno 2010 – Relazione finale scientifica dello studente
6

usare sono solo due: PE-21 per il lato Forward e M13REV per quello Reverse. I reagenti sono concettualmente gli stessi della PCR, con alcune differenze: si usa un solo primer per ogni reazione e non due; al posto del gDNA abbiamo gli ampliconi appena purificati; non si usa glicerolo; ai dNTPs si aggiungono i ddNTPs (detti “terminatori”). I ddNTPs utilizzati in questo laboratorio sono di due tipi: i BigDye e i dRhodamine. I primi garantiscono buoni risultati a costi non elevati, i secondi offrono risultati più precisi ma sono più cari e perciò vengono utilizzati per le sequenze difficoltose. Per il workflow di diagnosi sono utilizzati solo i teminatori BigDye. Una volta allestite, le reazioni vengono poste in un termociclatore GeneAmp PCR System 9700 che permette l’alternanza dei cicli di temperatura necessari per la formazione dei frammenti di DNA “terminati”e fluorescenti.
7) La reazione di sequenza viene purificata
Si procede alla purificazione delle reazioni di sequenza con una soluzione simile all’AMPure, chiamata CleanSeq. Il procedimento e’ svolto sempre tramite Biomek FX ed è del tutto basato sull’uso delle beads , come quello di purificazione della PCR.È necessario purificare per consentire che la corsa elettroforetica degli ampliconi terminati non sia compromessa dalla presenza di altro materiale fluorescente avanzato durante la reazione di sequenziamento.
8) Si compila la request
Prima di sequenziare il DNA occorre compilare un modulo di richiesta di sequenziamento tramite Internet (request). In una request si specificano tutti i dati utili: il codice del paziente, i primer da utilizzare, la lunghezza approssimativa del materiale genetico da sequenziare, i terminatori impiegati, il metodo di purificazione ecc. Questo permette l’invio dei dati ad un database interno che gestisce la catalogazione e la spedizione dei risultati. Questo modulo esiste in un formato “single tube” (vedi Allegato 4) ed in un formato “96 wells” ,che e’ quello usato per questo tipo di workflow. Nel formato “single tube”, usato prima di sequenziare i campioni di TRP53, a differenza di quelle per la diagnosi, ho dovuto inserire i dati (come per esempio il nome del primer e del templato o la grandezza dell’amplificato) per ogni singola reazione. Invece nella request form per la diagnosi (formato a 96 pozzetti) i dati si mettono solo una volta per tutte le reazioni.
9) Si inserisce il DNA processato nel sequenziatore
La piastra contenente le reazioni di sequenziamento purificate viene denaturata mediante temperatura e posta dentro un sequenziatore (3730XL DNA Analyzer) dove avverrà un’elettroforesi in 96 capillari distinti. Ogni frammento “terminato” verrà separato in base alla sua specifica lunghezza. Quando i frammenti passano presso un lettore ottico che riconosce la diversa luminescenza emessa dai terminatori sotto lo stimolo di un laser ad Argon, ognuno dei quali è associato ad una specifica base azotata, emetterà un raggio di luce che viene trasformato dal Software di “Data Collection” in uno specifico piccolo colorato. L’insieme dei picchi di una sequenza viene chiamato “elettroferogramma” (vedi Allegato 6).La qualità della sequenza viene in un primo momento valutata osservando la chiarezza della successione dei picchi nell’immagine (Allegato 5) prodotta dal computer connesso al sequenziatore. I dati possono essere dunque spediti a chi di competenza tramite il suo codice associato durante la compilazione della request.
USR – IFOM – ANSAS“LO STUDENTE RICERCATORE - Anno 2010 – Relazione finale scientifica dello studente
7

10) Si cercano nelle sequenze le mutazioni
Le sequenze spedite al gruppo di diagnosi vengono analizzate con l’ausilio di un apposito software, Mutation Surveyor, che riesce ad appaiare i due strand, forward e reverse, del DNA e ad associare gli ampliconi alle relative sequenze wild-type create precedentemente in laboratorio o prese da un database online come Ensembl. Nell’Allegato 9 sono schematizzate le tipologie di mutazioni possibili.A volte si utilizzano altri tool, come Berkeley Drosophila Genome project o SplicePredictor Online, dei siti Internet in grado di associare ad una sequenza nucleotidica la probabilità che venga compromesso in quella regione il corretto funzionamento del meccanismo di splicing. In questo caso si prendono in considerazione anche le mutazioni dette “silenti” ossia quelle sostituzioni che non alterano la traduzione.
11 e 12) Si compila il referto da consegnare per la consulenza genetica
L’operatore quindi confronta la sequenza del campione con quella wild-type cercando le mutazioni conosciute ed elencate in “letteratura”.Infine, eseguito il controllo, si compila il referto da recapitare al paziente riportando solo le mutazioni patogeniche e quelle a significato incerto. Sarà poi il medico della consulenza genetica a consigliare al paziente il giusto trattamento farmacologico, chirurgico o preventivo.
5 Bibliografia
Introduzione alla tesi di laurea specialistica in Genetica medica dal titolo “Caratterizzazione degli spettri mutazionali dei geni BRCA1 e BRCA2 in famiglie italiane con suscettibilità genetica ai carcinomi della mammella e dell’ovaia” della studentessa Dott.ssa Barbera Floriana
6 Elenco degli allegati alle presente relazione:
Allegato 1: Workflow della diagnosticaAllegato 2: Struttura del gene TRP53 scaricata dal database online EnsemblAllegato 3: Fotografia della corsa su gel degli ampliconiAllegato 4: Fac-simile della request single tubeAllegato 5: Array view elaborata dal computer connesso al sequenziatoreAllegato 6: ElettroferogrammaAllegato 7: Software Mutation SurveyorAllegato 8: Tabella di analisi del gene TRP53 di topoAllegato 9: Elenco delle tipologie di mutazioni che vengono prese in esame
Data:
24 -08 - 10
USR – IFOM – ANSAS“LO STUDENTE RICERCATORE - Anno 2010 – Relazione finale scientifica dello studente
8