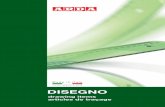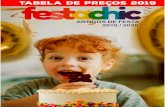ref ita
-
Upload
alexandra-e-alessandro -
Category
Documents
-
view
216 -
download
0
Transcript of ref ita
-
7/24/2019 ref ita
1/14
Alcune aree che non erano sotto il controllo della Chiesa ritornarono alle pi primitive forme dimedicina, no a che i monaci non porteranno il cristianesimo in tutta Europa, assieme allamedicina di stampo e matrice romana.La medicina delle popolazioni germaniche era prevalentemente mistica o casalinga: i demonierano espulsi dal corpo ed i sacrici appagavano gli dei. Sebbene il misticismo rimase, cera picondenza nelle erbe e nella medicina empirica.!resso i "ermani erano gli uomini che controllavano la pratica medica# le donne avevano unafunzione particolare, riportata anche da $acito: %Ad &atres, ad coniuges vulnera ferunt, nec illaenumerare et e'igere plagus parent( )%Essi portano le ferite alle loro madri e mogli, che non
temono di esaminare e trattare le piaghe(*. Alcune donne+guaritrici erano credute avere poterisoprannaturali.La medicina, in seguito alle varie culture barbariche, dovette contemperare le varie culture conuella classica e la religione, la scienza latina e greca e gli insegnamenti della -ibbia, comeappare evidente nellopuscolo di medicina in versi )Commentario &edicinale* dellarcivescovo di&ilano -enedetto Crespo )/0+123*. 4n esso venivano descritti i rimedi della medicina popolare otratti da !linio e 5ioscoride.La cultura celtica si era da tempo di6usa nella popolazione: i "allo+Celti )conosciuti con i nomi digalati, galli e 7eltoi* avevano una medicina sacerdotale, a8data alla casta dei 5ruidi, custodi dellareligione, della medicina, del sapere e della poesia.La medicina dei Celti era fondata su due elementi: il potere di guarigione acuisito dai 5ruidiattraverso tecniche di autoiniziazione, paragonabile a uello degli sciamani in varie culture adassetto tradizionale, e il ricorso alle risorse della natura, a partire dalle piante e dalle acuetermali. 4 Celti a8davano ai 5ruidi rituali e impieghi toterapici, utilizzando principi attivi naturalidi cui avevano una profonda conoscenza.9iconoscevano 5ian Cecht ) dalla lunga presa*, uale 5io della medicina e della guarigione)corrispondente allAsclepio greco* che immergeva i guerrieri feriti nella sua fonte magica,ridonando loro salute e vita.;ccise il glio &iach perch< invidioso della sua abilit= medica )aveva riattaccato la mano a re>uada* con 3 martellate inguaribili.Sua glia Airmed, erborista, rendeva accessibile al genere umano la medicina. 4l padre5ian Cecht,
invidioso, scompigli? le piante e imped@ alluomo di guarire ogni male. Le conoscenze sono ancorasfruttate non solo dalla toterapia, ma anche nella cosidetta medicina allopatica moderna per lapreparazione di vari farmaci. B il caso, per esempio, della belladonna, tuttoggi fonte commercialedi atropina, un alcaloide con propriet= antispastiche e antisecretive.
$ra i rimedi che continuano a essere usati anche oggi in toterapia, con cui i Celti preparavanotisane, infusi, unguenti e cataplasmi, oppure erano impiegati per fumicazioni, si ricordanolassenzio, lartemisia, la salvia, la verbena ed il vischio.Ad esempio: il frassino era molto considerato per suoi poteri magici: per correggere il rachitismodei bambini. Le foglie erano utilizzate come diuretico o lassativo# un letto di foglie di frassinomescolate con felci era molto e8cace contro i reumatismi# i suoi semi in polvere erano utilizzatiper lartrosi e il decotto degli stessi diuretico, lassativo ed antireumatico# linfuso o il decotto di
corteccia era antiemorragico ed un bagno con acua in cui sia stata sbriciolata della corteccia eraindicato per le dissenterie.>umerosissime erano le sorgenti che erano sacre ai Celti in uanto ritenute in grado di risolverevarie problematiche )per esempio la sterilit=, la lattazione, lepilessia, le malattie della pelle, ecc.*.Si pu? parlare di tecniche di guarigione anche a proposito della musica e della danza, a lorovolta oggetto di riscoperta recente in ambito terapeutico, cos@ come a proposito delcombattimento rituale )la lotta bretone ancora oggi praticata*, dal uale sembra che i Celtitraessero beneci a8ni a uelli forniti dalla pratica delle arti marziali in Driente.4n seguito alla loro invasione della penisola, soprattutto i "oti e i Longobardi avevano per?apportato nuove regole e nuove, per uanto primitive, concezioni di cure mediche.Lorigine della medicina germanica, prima della conuista romana del 0 a.C., era
prevalentemente magica e demonistica: %4l medico )lachner* non era pi di un mago che conscongiuri e pratiche simboliche, spesso con alte grida, cacciava i demoni dal corpo. Con riti disacrici cruenti si placavano gli dei: il sacerdote toccava il malato col dito intinto nel sangue dellavittima )7ednger*(. Fotan era adorato uale dio guaritore e la guarigione richiedeva anzitutto unsacricio, spesso di sangue, allo scopo di placare gli dei.4 pricipali rimedi terapeutici erano costituiti da erbe e piante )tra cui vischio, mandragora,piantaggine, verbena, salvia* assieme per? a pietre magiche, a parole magiche ed amuleti.
-
7/24/2019 ref ita
2/14
Luso delle cure termali, uale gi= stimato e sviluppato presso i 9omani, venne di seguitoulteriormente trasmesso e utilizzato. 4nfatti fu un re vandalo )$rasamondo, GH+23 d.C * arestaurare le terme di Agnano. 4n territorio Iegreo, da Cuma a &iseno, a !ozzuoli, orenti citt=come !uteoli svilupparono grandi complessi termali, come uello di -aia, come attesta una letterascritta nel 21 d.C. per conto di Atalarico, re dei "oti, in cui vengono esaltati lincanto della naturaassieme alle virt beneche delle fonti baiane. Le leggi gotiche proibivano severamente laborto,vietavano gli aruspici e le magie# condannavano chi incantava gli uomini ed anche chi si rivolgevaai maghi.
$eodorico ) m. 3JK/K2 * nel suo famoso editto del JJ d.C. )Edictum $heodorici* fu uno dei primi
ad accettare lamministrazione sanitaria e a ristabilire i diritti ed i doveri degli archiatri# eglisosteneva che %tra le arti pi utili e che contribuiscono a sostenere lindigenza della umanafragilit=, nessuna pu? essere anteposta, n< esser considerata pari, alla medicina(, ed anche:%9icordate che peccare nella cura dun uomo crimine domicidio(.4l suo medico, Antimo, scrisse il libro 5ietetica tra il 00 e il 2. 4n esso si spiega la necessit= diun nutrimento razionale e si indicano gli alimenti comuni ed il loro utilizzo: carni, pesci, droghe,latte, ecc. >ella legge dei Misigoti sulla responsabilit= medica era detto che nessun medico potevasalassare una fanciulla senza la presenza di suoi parenti, a meno di un caso urgente. Menivanoanche ssati i compensi per le pi importanti operazioni e per linsegnamento della medicina.4sidoro )1J + 3*, vescovo di Siviglia dal JJ al 3, ebbe il merito di aver convertito alcristianesimo i Misigoti. Nu nominato 5ottore della Chiesa e fu losofo piuttosto che medico nelsenso stretto della parola. Scrisse unopera monumentale in venti libri nei uali cerc? diracchiudere tutto lo scibile umano dellepoca: le EtOmologiae od Drigines.4l libro 4M, dedicato alla medicina, molto interessante poich< vi si trovano espressi alcuni concettifondamentali per lars medica del tempo: %Alcuni si chiedono perch< larte della medicina non siainclusa tra le arti liberali. La ragione consiste nel fatto che mentre ueste ultime trattano di causeparticolari, essa le abbraccia tutte(.Secondo 4sidoro infatti il buon medico doveva essere un buon retorico per poter comprovare almeglio i suoi argomenti# doveva conoscere al meglio la dialettica, utile nello studio dei casi dellemalattie e dei loro trattamenti# la grammatica per poter capire ci? che si leggeva# laritmetica e lageometria erano indispensabili nel calcolo dei giorni di durata di una determinata malattia, cos@
come la conoscenza dellastronomia per capire il rapporto tra lo stato di salute di un individuo egli astri.Egli den@ la medicina %seconda losoa( contribuendo cos@ ad aumentare uel divario tra praticae teoria sul uale gi= Aristotele si era espresso tempo addietro.5al punto di vista etimologico fece risalire il termine stesso di medicina a modus cio alla giustamisura cui doveva essere improntata la vita e la professione di chi la praticava, ribad@ il concettosecondo il uale lassistenza dei malati doveva essere a8data ad una persona pia, ritenendo chegli infermi dovessero essere ubicati in un luogo particolare lontano cio da rumori molesti e brusiifastidiosi che avrebbero potuto turbare lo stato di uiete degli ammalati.>el G il re visigoto 9ecesvindo )33+12* aveva promulgato una legge, la Le' Misigothorum )oLiber iudiciorum*, che andava a creare un diritto uguale e unitario per tutti gli abitanti del regno.
Corona votiva del re visigoto 9ecesvindo. &adrid, &useo Archeologico.$ale legge era per? troppo avanzata e dopo pochi anni, scontti denitivamente i Misigoti, verr=restaurata la civile legge dei feudatari, gestita poi dalle gerarchie ecclesiastiche, e inne dagliimperatori germanici. 5i diritti umani non se ne parler= pi no alla 9ivoluzione Nrancese.4 Longobardi acuisirono la cultura dei 9omani e, imprimendo un segno indelebile alleredit= delpassato, ne determinarono la successiva evoluzione.>ella biblioteca ideale dellM444 secolo, occupavano un posto di primo piano i testi legislativinecessari alla gestione del potere e uelli grammaticali, indispensabile per padroneggiare lalingua latina, ben diversa ormai da uella parlata.>on mancavano poi trattati tecnico+professionali, in particolare di medicina, uali ricettari ederbari. Anche la grande di6usione in et= carolingia degli autori classici si bas? su una tradizione di
studi e testi conservati e riprodotti nella biblioteca longobarda. 4 Longobardi erano ben lungidallessere etnicamente omogenei: mentre i nobili erano certamente individui nordicicromagnonidi appartenenti al gruppo sanguigno A )uello dei veri "ermani*, gli aldiones e ledonne di entrambe le categorie sociali erano probabilmente dei provinciali romanizzati. Let=media era di 3JK 3 anni e la dieta standard era a base di carne )di montone, capra, pollo, muccae maiale*, latte e cereali.
-
7/24/2019 ref ita
3/14
4l re degli dei era Ddhinn+Fodan, il protettore delle stirpe reali )i goti Amali e i dinasti sassonidell4nghilterra*# attorniato da berse7ir feroci come lupi e da val7Orior che trasportano i guerriericaduti in battaglia, Ddino era un nume+mago, invocato per la guarigione. La teriaca )o triaca*:composto medicamentoso, sotto forma di pasta, usato u8cialmente per curare i morsi deglianimali e per i dolori di stomaco, si preparava solo dietro permesso dei medici ed era costituita daun miscuglio di mitridato, alchermes, giacinto, elettuario de gemmis. La scrupolosit= con cui lasua preparazione era condotta, laccurata registrazione di ogni dose preparata su appositi registri,la verica da parte del medico della liceit= nei procedimenti e la presenza del medico nellapolverizzazione degli ingredienti, solitamente eseguita allaperto, ci fa capire limportanza e forse
la pericolosit= del preparato.4n alcune cronache giunte a noi si descrive la preparazione della teriaca nel JJ nei giardini deiconventi o delle ;niversit=: la forma era solenne, con il pubblico che poteva assistere e medici efarmacisti allopera. ;na volta preparata, la preziosa pozione veniva posta in vasi di maiolica.B stata uesta, almeno per sette secoli, la panacea per molte malattie e infermit=. ;n misteroalchemicoPSecondo certi storici, erano stati i $emplari, che praticavano le arti alchimistiche, a detenere laricetta di uesta mistura.G.0 &E54C4>A E CQ49;9"4A. M4S4D>E 54>S4E&E&alattie e saluteChe cosa succedeva uando ci si ammalavaPLa vita nel &edioevo stata denita pericolosa, inumana e breve. AllRepoca la gente sopportavamolto pi dolore e molte pi so6erenze di uanto dobbiamo fare noi oggi.>el &edioevo molti erano i mali che la medicina dellepoca non riusciva a guarire. uasi la met=dei bambini periva a causa di malattie infettive prima di compiere i cinue anni. Le giovanimorivano di parto e gli uomini morivano per incidenti o in guerre.4 medici e la paura%4 dottori non forniscono nessun aiuto concreto soprattutto perch< sono terrorizzati di visitare ilmalato(, scrisse "uO de Chauliac, nel T4M secolo, ma uesto concetto era ben radicato nellapopolazione.&olti medici del tempo pensavano che la malattia fosse il risultato di un miasma veneco# per
neutralizzarlo gettavano sul fuoco polveri aromatiche e accendevano candele.$enevano spesso sul naso unRarancia secca ripiena dRerbe.Altri facevano sostare i loro pazienti nelle cloache, pensando che lRodore nauseabondo degliescrementi facesse fuggire il morbo. Solo i ricchi, per?, potevano permettersi la presenza di undottore....%uesto prezioso amuleto reca sollievo ai so6erenti di inammazione celebrale, ai maniaci, aimalati di angina# salva dai reumatismi e dalle malattie della testa e degli occhi(ueste furono le parole di un medico portoghese: Arnoldo da Millanova che, nel T444 secolo, eraconsiderato una grande celebrit=. >on occorrono altre parole per far capire a che punto sitrovasse la medicina nel &edioevo.4n numerose fonti agiograche + da "regorio di $orso no al basso &edioevo + viene messa in
evidenza lRinutilit= della medicina. >on poche volte lo sforzo del medico per guarire la gente damalattie viene preso come il tentativo audace e addirittura peccaminoso dellRuomo di volerimmischiarsi, per motivo di correzione, negli impenetrabili piani di 5io. uesto era lo scetticismopresente nel &edioevo.Il paziente La visita
La scienza medica era veramente decaduta, dopo aver conosciuto i due grandi studiosi dimedicina dellRantichit=: 4ppocrate )M+4M secolo a.C.* e "aleno )44 secolo d.C.*# la grande stagionedella medicina del mondo antico sub@, infatti, nella tarda antichit=, due potenti attacchi, che levennero portati su fronti diversi: le invasioni dei popoli del >ord e il Cristianesimo.Le culture germaniche, da una parte, avevano teso a limitare ed emarginare la cultura romana, euindi a respingere il bagaglio teorico della medicina# dallaltra il Cristianesimo oltre a guardare
con sospetto, se non a condannare apertamente, i frutti della cultura pagana )e uindi ancoralimpostazione teorica della medicina*, portava di per se stesso un messaggio nuovo eindiscutibilmente forte: la vita cosa e8mera perch< lRuomo solo un pellegrino sulla terra,sottoposto al dolore, alla malattia e alla morte uale pena per il peccato originale.uando i barbari invasero lEuropa, inoltre, molte opere degli antichi vennero da essi distrutte euelle che poterono essere salvate rimasero per anni e anni custodite nelle biblioteche dei
-
7/24/2019 ref ita
4/14
monasteri. Nu cos@ che gli uomini andarono man mano dimenticando molte nozioni importantidegli antichi.!er esempio, la teoria di 4ppocrate secondo la uale le malattie non sono da attribuire a causesoprannaturali fu completamente dimenticata.4n pieno &edioevo )secoli T44 e T444* le malattie pi gravi furono di nuovo considerate opera deldemonio.4n una visione di uesto genere la medicina, di fatto, diventava una cosa superIua se nonaddirittura nociva al doloroso ma necessario processo di puricazione e di espiazione: la curasica, per il cristiano, doveva essere al massimo subordinata a uella spirituale, per cui
lassistenza ai malati veniva considerata come un mero atto di carit= cristiana, un mezzo per ilcredenteKmedico di dimostrare il proprio amore verso il prossimo malato e uindi, in ultima analisi,verso 5io.uesta teoria veniva sostenuta da 4reneo )03+2JJ circa*, padre della Chiesa che bollava di eresiail dualismo tra anima e corpo, e da Clemente Alessandrino )circa 0J+20*, che spesso facevariferimento a teorie siologiche per spiegare fatti spirituali. "regorio di >issa, anchegli padre dellaChiesa, sosteneva che il corpo umano era stato creato per essere sede dellanima.Senza la presenza di una tradizione medica, comunue, non si potrebbero per? giusticare letestimonianze, alcune delle uali risalenti al M44 secolo, di dotti medici che disponevano di ampieraccolte di testi, n< spiegare la rapida ascesa della medicina come scienza a partire dalla secondamet= dellT4 secolo.La medicina occidentale avanz?, comunue, molto lentamente durante il &edioevo. "li studi siappoggiavano sulla sfera religiosa ed i religiosi erano molto pi interessati alla cura dellRanima chea uella del corpo. &olti teologi ritenevano che le cure fossero possibili solo attraverso lapreghiera.La concezione cristiana delle malattie e delle lesioni port? alla fondazione di molti grandi ospedali,costruiti e gestiti dai monaci: sebbene poco era fatto per curare i pazienti, essi eranogeneralmente ben nutriti e confortati dal personale infermieristico religioso.Sebbene la medicina e la chirurgia fossero anche allora strettamente correlate, i medicimedioevali tenevano una netta distinzione fra di esse."eneralmente i medici trattavano i problemi interni al corpo e i chirurghi uelli esterni uali:
ferite, fratture, lussazioni, problemi urinari, amputazioni, malattie della pelle e silide. Essi anchepraticavano i salassi ai pazienti inviati loro dai medici e si occupavano inoltre di estrazionidentarie, osteologia, oculistica ed ostetricia.4noltre, mentre aumentava la popolazione delle citt= medievali, le condizioni igieniche )vediallegato .G* peggioravano, conducendo ad una ampia variet= di problemi sanitari. La conoscenzamedica era limitata e, nonostante gli sforzi degli addetti medici pubblici e delle istituzioni e regolereligiose, lREuropa medievale non aveva un adeguato sistema sanitario pubblico.4l sapone, pressocch< sconosciuto ai 9omani, sembra essere stata una invenzione gallica edivenne di uso di6uso nel corso del secolo 4T. 4nizialmente era liuido e divenne pi simileallRattuale nel corso del T44 secolo. Norse furono gli Arabi che lo svilupparono, formato da olio dioliva )al+ali* e talvolta natron )sodio carbonato*. 4n seguito venne preparato con olio di oliva
profumato alle erbe, assieme a grasso di animale, cenere e soda.4 molti miti e le molte superstizioni riguardanti la salute e lRigiene giocavano un ruolo importante.La gente credeva, per esempio, che le malattie fossero di6use dagli odori cattivi. Era ancheassodato che il corpo fosse il risultato dei difetti dellRanima. &olti cercavano il rimedio dalle loromalattie con la meditazione, la preghiera, i pellegrinaggi ed altri metodi non medici.4l corpo umano era visto uale parte dellRuniverso, un concetto derivato dai "reci e dai 9omani ela teoria dei uattro umori di "aleno )descritta precedentemente, n.d.t.* era sempre di basilareimportanza.5urante uesto periodo la medicina inizi? comunue ad essere riconosciuta uale professione,sulla base di una formale istruzione, un curriculum standardizzato e leggi riconosciute.4n alcune regioni, i medici erano tenuti a superare esami prima di iniziare la pratica. 4 medici non
addestrati erano destinati a sanzioni e multe, cosicch< la licenza di stato divenne proceduracomunemente di6usa.Le donne+medico trattavano comunemente pazienti femminili, ed i medici non istruiti oautodidatti, o UsanguisugheU, sebbene derisi dai medici istruiti, erano lasciati lavorare siasullRuomo, sia sugli animali.LRassistenza medica era molto costosa e solo pochi potevano permettersela. 5i conseguenza lapratica medica formale veniva praticata dalla Chiesa che correlava la malattia con la ricompensa
-
7/24/2019 ref ita
5/14
divina. 4 malati e gli anziani potevano essere curati da medici esperti, monaci, guaritori popolari)spesso donne, specie nelle aree rurali*, in relazione alla classe socio+economica del paziente.!er tale motivo, molti ammalati iniziarono pellegrinaggi nella speranza di guarire,riappacicandosi con 5io. Ci? non ferm? i monaci, che erano i pi acculturati nella popolazionegenerale, dallRapplicare ci? che avevano imparato copiando i testi antichi. Dgni monastero avevauna infermeria dove i rimedi esistenti si basavano sulle erbe, secondo gli insegnamentiippocratici, coltivate nei loro giardini.Le cure a uei tempi erano principalmente basate su preparati di erboristeria, in associazione condiete che specicavano il tipo ed il uantitativo di cibo )possibilmente in unisono con i principi
degli umori* e con lResercizio sico. Solitamente nei casi pi gravi o pi avanzati, poteva averluogo un trattamento chirurgico. $ale includeva, ma non solo, pratiche di salasso, amputazioni omanipolazione ossea.A causa della insicurezza della medicina accademica, molte volte il paziente medioevale potevavolgersi a certi incantamenti, specialmente preghiere, o specici rituali Cristiani. >on erainfreuente il credere a guarigioni miracolose.!oich< la maggior parte della popolazione dellREuropa medievale non viveva nelle citt= doveavrebbero potuto giovarsi di medici colti e non superstiziosi, pi spesso che non, essi sirivolgevano ai guaritori locali che erano solitamente infermiere, casalinghe, o semplici esperti dirimedi erboristici."L4 DS!E5AL44 primi ospedali si formarono fornendo assistenza e rifugio ai vecchi, agli invalidi e ai pellegriniitineranti: i primi ospedali sorsero come ospizi per persone non abbienti, pi che come luoghi dicura.4nvece di invocare gli dei pagani, veniva chiesto il supporto dei santi patroni.4l termine hospitalitas era s@ noto agli antichi, ma solo come attitudine individuale o come obbligonei confronti dellospite: solo con lavvento del cristianesimo inizia a venire considerato come unservizio reso al bisognoso.>on doveva per? mai mancare limmagine del Signore, in uanto gli ospedali erano considerati deiluoghi dove ci doveva essere la presenza guaritrice dello Spirito Santo."li ospedali divennero sempre pi di6usi: lamore di 5ioU, la piet= per umanit= e la
preoccupazione per il proprio benessere consigliarono e favorirono tali costruzioni. Analogamentei pi facoltosi utilizzavano i servizi dei monasteri o dei pochi ospedali nelle aree urbane.Dgni monastero aveva una infermeria con trattamenti prevalentemente erboristici.4 primi ospedali vennero stabiliti dai monasteri ed erano principalmente un rifugio per i vecchi, gliinfermi ed i pellegrini. 4nvece di invocare gli dei pagani, si invocavano il 5io cristiano o i Santi!atroni.Col tempo )prevalentemente nel e dal T44 secolo*, le case adiacenti ad alcuni monasteri si sonoevolute dai ripari per i poveri )'enodochia*, specie nei luoghi ove fossero disponibili mediciesperti.
$ali ospedali pi sviluppati comprendevano un albergo per viaggiatori e studenti indigenti,dispensari per i poveri, cliniche ed ambulatori per i feriti, sedi per i ciechi, gli anziani, orfani,
malati mentali, e lebbrosari per la gente di tutte le et= e di tutte le classi sociali.uasi una met= degli ospedali costruiti era direttamente a8liata con monasteri, priorati e chiese.&olti ospedali, ad imitazione delle Comunit= religiose, avevano formulato precise regole dicomportamento, uniformato il vestire ed integrato i servizi nella loro procedura uotidiana.
$uttavia, il contesto spirituale dellospedale era aumentato, ma non aveva oscurato i loro verisuccessi terapeutici.Adottare un modello religioso era non soltanto la tradizione dei tempi, era esso stesso undispositivo terapeutico eminentemente riuscito. Con la preghiera, i pazienti erano invogliati adaiutarsi e ad aiutare i loro parenti ed amici e la gente in generale.La farmacia&olti ospedali ebbero e6ettivamente un ruolo formativo ed una responsabilit= per lRalimentazione
ed anche per collegamento, grazie a ere commerciali e a tante attivit= patrocinate dallRospedalestesso. $utto uesto era frutto di una buona teologia ed una buona psicologia.
$uttavia, poich< mancavano le pi elementari nozioni di igiene, uegli ospedali erano spesso incondizioni di favorire piuttosto che prevenire il di6ondersi delle malattie: non venivano maicambiate le lenzuolaVSolo negli ospedali femminili si potevano tenere animali.G.2 LA &E54C4>A >ELLAL$D &E54DEMD
-
7/24/2019 ref ita
6/14
La pi comune base per la medicina medievale erano i trattati di "aleno, ma sfortunatamente,nonostante la grande attenzione allanatomia esterna dellRuomo, non contribuivano molto aiprocessi che hanno luogo allRinterno del corpo.Ad esempio la loro grande carenza riguardava la circolazione sanguigna. 5Raltra parte alcunefunzioni basilari, uale la respirazione, erano descritte meglio che nelle teorie ampiamente di6usedi !latone."aleno prese in considerazione, distinguendole, le funzioni volontarie e le involontarie, e indic? lamancanza di sincronismo fra il battito del polso e la respirazione, ma non tanto pi di uesto>el &edioevo lo sviluppo della medicina sub@ lRinIuenza di almeno tre fattori, che modicarono le
cure, la gura del medico ed i suoi compiti, le metodologie di cura e diagnosi.Le condizioni igieniche ed alimentari costituirono il primo fondamentale fattore dRazione: lamorbilit= alta di uei secoli era dovuta ai regimi alimentari poveri, basati uasi unicamente sulconsumo di cereali e legumi e alle condizioni igieniche pessime# non esistevano, infatti, sistemi difognatura e8ciente, e lRigiene personale non era per nulla curata. $utte ueste cause ebberocome e6etto lo svilupparsi di infezioni, di epidemie, come le pestilenze che decimarono lapopolazione, e lo stabilizzarsi in forma cronica di forme morbose.4l secondo fattore fu la religione: il cristianesimo aveva inculcato agli uomini dei valori, delleideologie che ne avevano determinato la formazione sociale, il modo di pensare ed intendere larealt=.4nfatti, in unRera in cui il genere umano stava attraversando un periodo critico, per le continuepestilenze e gli sconvolgimenti bellici, la Chiesa e la religione davano allRuomo una speranza a cuiaggrapparsi, e uesto determin? lRespansione del campo dRazione dellRambiente ecclesiasticoanche in materie profane come la scienza medica. 4l fatto che il malato e le malattie fosseroallRordine del giorno, port? lRuomo medievale a considerare il morbo come una peculiarit=dellRumanit=, erede del peccato originale di Adamo ed Eva.Le epidemie perci? diventano il Iagello con cui 5io punisce i suoi gli, e proprio per uestovengono viste come un valore positivo# ecco che si prola uindi la pedagogia della so6erenzache inIuenzer= le riIessioni religiose sulla malattia e le stesse pratiche assistenziali, soprattuttonelle popolazioni cristiane.>asce cos@ anche il concetto di hospitalitas, terzo fattore, che prevedeva lRaccoglienza,
lRassistenza e lRospitalit= per i malati# di conseguenza monaci e religiosi organizzarono, con ilConcilio di Drl
-
7/24/2019 ref ita
7/14
La tradizione dellRuso delle erbe come medicinali, anche se accolta dai monaci, di originepagana, perch< erano i contadini abitanti del pagus, o distretto rurale, a coltivare negli orti e neicampi uelle piante dalle prodigiose ualit=# tutto uesto costituiva la medicina semplice chemolto spesso niva per completare la medicina dei dotti.>on si limitavano per? solo allResercizio della medicina semplice, ma impomatavano,massaggiavano e, essendo insigniti dei titoli tonsor rasor et minutor, potevano radere, tonsurare,ma era anche abile nel minuere sanguinem, cio salassare nella giusta misura, estraendo con ilsangue anche il presunto peccato del malato, che era naturalmente la reale causa dellRinfermit=.4l togliere sangue era una pratica empirica, ma essendo regolata da procedure precisamente
codicate secondo dottrina, elevava il salasso e la Iebotomia ad arti magistrali. 4nne i monacicrocesegnavano, applicavano toccasana, lenivano i dolori con gesti rituali ed elisir, facevanosorbire acuasanta e baciare le reliuie dei santi, facendo s@ che la restitutio ad integrum dellasalute sica coincidesse con la salvaguardia di uella spirituale.&A>CA>WA 54 &E54C44 medici no al 02JJ erano molto pochi e le terapie scarse e ine8caci. Nino al secolo T44, adeccezione di uella di Salerno di cui parleremo pi avanti, non ci sono scuole speciali ove siinsegnasse la XmedicinaU.Mi era una certa maestria nella cura delle ferite e delle fratture, cosa assai utile viste le continueguerre ma di diagnosi precise e di cure mirate, ancora non se ne parla proprio.Mi erano allRepoca anche numerosi medici poco seri che giravano per le piazze e proponevanorimedi violenti come, per esempio, la cauterizzazione con un ferro rovente delle emorroidi.Dltre a uesti vi erano anche naturalmente medici seri che avevano studiato a Salerno o a-ologna, due rinomate universit=.4 malati si rivolgevano di preferenza ai monaci e ai sacerdoti,che costituivano la classe pi colta dellepoca. >aturalmente uesti ecclesiastici, privi di una seriapreparazione medica, non erano in grado di trovare le cause delle malattie e di curarlescienticamente. 4l loro aiuto era soprattutto spirituale.-isogna per? dire che molti di essi curavano gli ammalati con erbe medicinali, ottenendo spessodegli ottimi risultati.Alcuni poi praticarono con successo anche degli interventi chirurgici.LA $E9A!4ALa pratica della medicina era comunue, e spesso, unRimpresa pericolosa.
!rima della nascita della scienza medica, lRuso delle piante medicinali rappresentava lRunicometodo per curare varie malattie. Le virt attribuite ai rimedi naturali si basavano moltissimo sulleualit= simboliche che erano loro assegnate, oltre che sulle reali propriet=. 4l passaggio dalrimedio medicinale che guarisce alla pianta tossica che avvelena corrisponde molto bene allastrega.Alcune piante molto velenose sono oggi usate per la preparazione di alcuni farmaci.9imedi erboristici>el &edioevo i dottori per curare alcune malattie usavano dei vegetali. !urtroppo alcune volte acausa dellRignoranza dei medici i pazienti morivano avvelenati.Dltre allRignoranza dei medici la medicina erboristica si basava sulle tradizioni popolari e sullesuperstizioni. 4 manuali farmacologici raccomandavano ad esempio di raccogliere le erbe
medicinali in particolari giorni dellRanno considerati magici.&olte erbe usate allRora sono per? utilizzate anche come ingredienti di base nellRattuale medicinaerboristica.4 rimedi erano s@ basati prevalentemente su pozioni e decotti di erbe, ma anche su vermi di terra,urine ed escrementi animali. Alcuni manoscritti medici contemplano centinaia di sostanzeterapeutiche, con la convinzione che ogni sostanza esistente in natura potesse essere utilizzata.5a alcuni scritti possiamo cos@ essere stati edotti su alcune delle principali cause di morteV4 cataplasmi )crusca, acua e senape* davano sollievo alle articolazioni inammate e aiutavano acurare le infezioni.Le purghe erano usate per espellere la malattia dal corpo.4mpasti calmanti di erbe polverizzate e miele servivano a curare ulcere cutanee, mal di gola e mal
di stomaco.Luso di piante curative in molti casi si mescolava con riti e formule magiche.La LACQ>;>"A )secolo T4*: un libro )oltre che una pianta* che contiene rimedi alle malattie e inparticolare preghiere in latino da recitare sugli ingredienti, per difendersi da agenti invisibili espiriti ostili, uali el, demoni e veleni.
-
7/24/2019 ref ita
8/14
;na delle cause pi freuenti di malattie erano infatti le mariolerie degli el, esseri invisibiliindividuati dalla tradizione cristiana come demoni. Erbe, piante, parti di animali e eYuvi di uestisono gli ingredienti classici delle pozioni:Lachnunga ,&andragora,Niori di pioppo&A>59A"D9A: chiamata ancora oggi in "ermania Qe'en7raut, erba delle streghe, lamandragora una radice nera allesterno e candida allinterno, con una vaga forma umanoide cheha portato la fantasia antica e medievale a rappresentarla come una sorta di omuncolo vegetale.Meniva usata per curare infezioni agli occhi, ferite, morso di serpenti, mal dorecchie, gotta ecalvizie.N4D94 54 SAL4CE E !4D!!D: combattono limpotenza.
;E9C4A e ME9-AC4A: venivano utilizzate per numerosissime applicazioni.C9A>4D 54 ;CCELLD: avvolto in pelle di cervo cura le emicranie, cervello mescolato con unguentoed inlato nel naso e8cace contro i dolori di testa.9E>4 e $ES$4CDL4 ESS4CA$4: polverizzati e somministrati col vino curano limpotenza.NEC4 54 "A$$D: e8caci contro le calvizie o la febbre uartanaME9&4 CD> >D54 "4ALL4: triturati e mescolati alla birra servivano a curare litterizia# erano scelticon nodi gialli per combattere il giallo della pelle del malato.4 salassi erano comunemente impiegati per recuperare la salute e lRumore del paziente, edinoltre ogni intervento chirurgico, spesso praticato da un barbiere e senza anestesia, erasicuramente critico.4 medici ritenevano che un eccesso di sangue provocava malattie: di conseguenza le sanguisugheerano usate per succhiare sangue ai pazienti."li unguenti erano molti e gli intrugli da prendere per bocca o da applicare sul corpo erano moltonumerosi. Ad esempio per curare i polmoni si mangiavano ceci cotti nel latte di capra con burro ezucchero, mentre per curare i tumori ghiandolari si facevano impacchi di chi.5i fronte alle malattia gravi in realt= per? non vi erano rimedi e8caci: basti pensare alla lebbra ealla follia. 4n e6etti, in uestRultimo caso, spesso si confondevano i malati di mente con gliindemoniati, soprattutto nel caso degli epilettici, e si cercava di curare i malcapitati con lunghesedute di esorcismo nella speranza di liberarli dai demoni loro persecutori.Le funzioni naturali, uali lo starnuto, erano considerate il modo migliore per conservare la salute.uando cRera un aumento di ualunue umore o liuido organico se ne poteva disporre per il
tramite di sudore, lacrime, feci o urine. Se uesti sistemi naturali si interrompevano o guastavano,la malattia poteva occorrereV 4 medici medioevali favorivano la prevenzione, lResercizio, una buonadieta ed un sano ambiente.;no dei mezzi diagnostici preferiti era lRuroscopia, per cui il coloredelle urine del paziente era esaminato per determinare il trattamento.;n altro aiuto diagnosticoincludeva tastare il polso e prendere campioni di sangue.4l trattamento variava dalla somministrazione di lassativi e diuretici alla fumigazione,cauterizzazione, e assunzione di bagni caldi eKo erbe.Sebbene le procedure mediche nel &edioevosiano generalmente considerata obsolete e basate su erbe, preghiere, formule e incantamenti,esistevano parimenti procedimenti chirurgici e cure simili alle procedure moderne.Driginalmente i medici assistevano i loro pazienti recandosi a casa loro oppure il paziente potevaessere portato dal medico# uesto non favor@ il libero scambio di idee o di esperienze tra i medici e
spesso i consigli sul trattamento di un paziente particolare erano ottenuti per lettera, inviando lalista dei sintomi ad un altro medico.La diagnosi del paziente era solitamente incompleta.Essa consisteva nella ispezione di sangue,feci, urina e nellResame del polso, ma solo in rari casi tutti i precedenti erano inclusi.4l sangue eraesaminato per la viscosit=, temperatura, scivolosit=, sapore, schiumosit=, rapidit= di coagulazione,e le caratteristiche degli strati in cui si separava.Sangue, feci e urine misuravano lReuilibrio degli umori in un individuo.La diagnosi della malattiaera ottenuta dal concetto del diseuilibrio complessivo, uale fosse un meccanismo esplicatoriofondamentale per comprendere le manifestazioni cliniche.LRosservazione, comunue, consisteva principalmente nel considerare visivamente lRapparenzaesterna del paziente, nellRascoltare la descrizione del paziente della malattia, e nellRispezione ed
odore delle sue escrezioni. LRosservazione che includeva tutti i precedenti era cosa rara e pispesso un medico prescriveva un trattamento solamente sulle richieste scritte di un collega o delpaziente stesso.LResame del polso non era per valutare e misurare il Iusso ematico, non essendo i medicimedievali al corrente della circolazione, ma piuttosto per la forza degli spasmi cardiaci.
-
7/24/2019 ref ita
9/14
4 libri di medicina erano consultati per denire uale )e se* fosse necessario un salasso, se ilpaziente dovesse riposare o esercitarsi e se fosse necessario un cambiamento della dieta, o ualemedicamento o erba dovesse essere somministrata.B interessante osservare che sebbene lRartrite ed i reumatismi fossero le malattie pi comuni, ilibri delle erbe e medici prescrivevano soprattutto rimedi per malanni relativi agli occhi.4 rimedi a base di erbe, le misture e la terapia delle gemme erano usati spesso uale trattamentonellRAlto &edioevo. Dvviamente, uesto genere di trattamento aveva le sue limitazioni, postedalla Chiesa cattolica per prevenire il di6ondersi delle eresie.Altri esempi di un trattamentocomune per particolari disturbi consistevano nella preparazione di polveri di giusuiamo e cicuta e
di metterle sulle cosce doloranti# pozioni a base di erbe per la cura dellRittero# indurre il vomito e isalassi per le paralisi e per disturbi addominali# masticare lRalloro# inghiottirne il succo ed apporrele foglie sullRombelico. LRuso delle erbe>el &edioevo la cura delle malattie si basava sullRutilizzo delle piante, dei minerali e sul riposo aletto. Menivano usati molto la menta, il papavero, lRaloe, il nocchio, lRolio, il giusuiamo, lacanfora, lRarsenico, lo zolfo e tante altre sostanze ancora.Come pu? essere osservato nei manoscritti no al T secolo, le erbe erano usate freuentementeper una variet= di scopi nella vita medievale. B importante capire che uesto era un periodo in cuile credenze della gente erano permeate da superstizioni. Essi pensavano che creature uali el egoblins erano esistenti realmente e che lRaria fosse piena di invisibili poteri del male contro le cuicospirazioni dovessero essere trovati rimedi.4noltre gli oggetti della natura avevano intrinsecipoteri che potevano essere usati a tal scopo. 4n particolare scritti dei Sassoni indicavano le erbeda essere impiegate per uesto e per altri motivi, tra cui uello medico, per il trattamento dellemalattie.-evande a base di erbe erano mescolate con birra, latte, o aceto, e molte pozioni fatte con erbeerano mescolate con miele. ;nguenti erano confezionati con erbe e burro. $ali erano prescritti perdisturbi comuni, uali epistassi, calvizie, scottature da sole, perdita dellRappetito e morsi di cani.Essi erano anche utilizzati uali amuleti o sortilegi contro il male e le malattie. !otevano essereappesi alla porta per conservare la vista, curare le pazzie, prevenire dalle fatiche del viaggio oanche per proteggere il proprio bestiame.4n un incantamento contro la febbre troviamo le istruzioni per proteggersene:
%$he sic7 man ... thou shalt place.....thou shalt cover his face Fith cOpress and herbs...... $hat thegreat gods maO remove the evil $hat the evil spirit maO stand aside... &aO a 7indlO spirit a 7indlOgenius be present(.Le piante pi comunemente usate per scopi medicinali erano:Avena, 4perico, Altea rosata e Alteao8cinalis, Aristolochia, &alva, Nilipendula ulmaria, Liuirizia, Maleriana, Consolida e Camomilla.NA&DS4 X&E54C4U 5ELLRAL$D &E54DEMD4sidoro di Siviglia )1J + 3*5ottore della Chiesa, 4sidoro fu vescovo di Siviglia dal JJ al 3, ebbe il merito di aver convertitoal cristianesimo i Misigoti. Nilosofo, piuttosto che medico nel senso stretto della parola, scrisseunRopera monumentale in venti libri nei uali cerc? di racchiudere tutto lo scibile umanodellRepoca: le EtOmologiae o Drigines.Schema delluniverso secondo 4sidoro di Siviglia, da un
manoscritto del sec. T444, Citt= del Maticano, -iblioteca Apostolica Maticana.4l libro 4M, dedicato alla medicina, risulta essere molto interessante poich< vi si trovano espressialcuni concetti fondamentali per lRars medica del tempo: %Alcuni si chiedono perch< lRarte dellamedicina non sia inclusa tra le arti liberali. La ragione consiste nel fatto che mentre ueste ultimetrattano di cause particolari, essa le abbraccia tutte(. Secondo 4sidoro infatti il buon medicodoveva essere un buon retorico per poter comprovare al meglio i suoi argomenti# dovevaconoscere al meglio la dialettica, utile nello studio dei casi delle malattie e dei loro trattamenti# lagrammatica per poter capire ci? che si leggeva# lRaritmetica e la geometria erano indispensabilinel calcolo dei giorni di durata di una determinata malattia, cos@ come la conoscenzadellRastronomia per capire il rapporto tra lo stato di salute di un individuo e gli astri.Egli den@ la medicina seconda losoa contribuendo cos@ ad aumentare uel divario tra pratica
e teoria sul uale gi= Aristotele si era espresso tempo addietro. 5al punto di vista etimologico fecerisalire il termine stesso di medicina a modus cio alla giusta misura cui doveva essereimprontata la vita e la professione di chi la praticava, ribad@ il concetto secondo il ualelRassistenza dei malati doveva essere a8data ad una persona pia, ritenendo che gli infermidovessero essere ubicati in un luogo particolare lontano cio da rumori molesti e brusii fastidiosiche avrebbero potuto turbare lo stato di uiete degli ammalati. Accessibili agli audaci, i piccoliEden dellimmaginario medievale sono celati sulla sommit= di montagne protette da tte nuvole
-
7/24/2019 ref ita
10/14
o pi usualmente collocati su isole, luoghi di eccellenza del meraviglioso, di tutto ci? che fuoridal comune# %producono ogni sorta di bene, godono di una pressoch< totale felicit= e di una beataabondanza( )4sidoro di Siviglia, EtOmologiae*.Qildegard of -ingen era una donna speciale, XprimaU sotto molti punti di vista. 4n un tempo in cuipoche donne sapevano scrivere, Qildegard, conosciuta come XSibilla del 9enoU, produsse lavori diteologia e descrisse le sue visioni fantastiche.uando a poche donne era portato rispetto, ella era consultata e forniva consigli a vescovi, papi ere. Scrisse trattati di storia naturale e dellRuso medicinale di piante, animali, alberi e pietre. Nond?un convento e, sebbene non ancora canonizzata, venne beaticata tanto da essere spesso
ritenuta Santa Qildegard.Qildegard era la decima glia in una famiglia nobile e fu dedicata alla Chiesa n dalla nascita.Ebbe visioni di oggetti luminosi dai tre anni ma nascose tale XdonoU per molti anni. 5agli otto anniinizi? lReducazione religiosa presso una donna eremita )Zutta von Sponheim*, nel monastero di5isibodenberg.4mpar? il latino e compose musica ma ebbe una vita durissima, di stenti eprivazioni. >el 00G0 ebbe una visione determinante: 5io le dava la comprensione dei testi religiosie la esortava a scrivere. Scrisse molti testi religiosi e di medicina, tra cui !hOsica e Causae etCurae )00J*, entrambi relativi alla storia naturale e al potere curativo di vari oggetti naturali,descritti anche in Liber subtilatum. La sua losoa religiosa, per cui essendo lRuomo alla sommit=della creazione, tutto esiste in natura per lui. $ale visione scientica, dedotta dalla cosmologiagreca, unitamente alla teoria degli umori, suggeriva la descrizione ualitativa della natura ed ilsuo impiego medicinale."li scritti di Qildegard sono anche unici per la visione generalmente positiva dei rapporti sessualie per le sue descrizioni del piacere dal punto di vista delle donne. Essi possono anche essereconsiderati la prima descrizione dellRorgasmo femminile.Essa scrisse anche che la potenza dello sperma determina il sesso del nascituro, mentre lauantit= di amore e passione determina il carattere del glio. 4l caso peggiore, uando lo sperma debole e i genitori non provano amore, conduce ad una glia cattiva.B ora noto che Qildegardso6risse di emicrania, e che le sue visioni fossero il risultato di tale stato sico.4l modo con cuidescrive le visioni, i prodromi, lo stato di disabilit= successivo, indicano i classici sintomi diunRammalata di emicrania. Allucinazioni visive, scotomi scintillanti, fosfeni precedevano un
periodo di recupero, benessere ed euforia. $utto ci? fu da lei descritto.Nu a $oledo tra 003G e 001/, dove tradusse 1J opere scientiche dallarabo al latino. $ra uesteopere si segnalano le traduzioni di opere di sica e di astronomia di Aristotele, ma anche di operedi logica, come gli Analitica !osteriora, con il commento di $emistio, e dello pseudo aristotelico 5ecausis.Sia con uestopera sia con il commento di $emistio dette un importante apporto nello sviluppo diaspetti platonizzanti allinterno della tradizione aristotelica )tratto decisivo del carattere di alcunecorrenti della losoa degli ultimi secoli del &edioevo e della prima et= moderna*.LR4>SE">A&E>$D 5ELLA &E54C4>A>ellRAlto &edioevo la scarsit= di letteratura scritta e la gran mescolanza di tradizioni orali, dirimedi XmagiciU, la devozione religiosa e la scarsit= di ducia peraltro comprovata dalla scarsit=
dei risultati* relativamente a teoria, semeiotica ed anatomia non permetteva una erudizionescolastica vera e propria.Le nozioni erano passate dal padre medico al glio o comunue attraverso un rapporto diretto trainsegnante e discepolo. Mi furono i primi accenni di un insegnamento accurato, prevalentementenellRarea bizantina e non molto in uella italiana di dominazione germanica e nel resto dellEuropadove comunue si continuarono a copiare e a studiare i testi utili per la pratica medica che eranopresenti nelle biblioteche monastiche od anche private, come ci informa la Qistoria inventionis actranslationis et miracula sanctae $rophimenae, testo agiograco del T secolo.Attorno allanno /1J, a Salerno un grande archiatra di nome "erolamo, famoso per la sua scienza,disponeva di %librorum immensa volumina( con notizie di innumerevoli sintomi di malattie erelativa terapia# ma una vera e propria scuola apparve solo dal T44 secolo.
G.3 LA CQ49;9"4A >ELLAL$D &E54DEMD!raticata uale e'trema ratio, la chirurgia poteva essere solutoria in casi di cancro mammario,stole, emorroidi, gangrena e cataratta, come per la tubercolosi e la scrofola, ghiandole linfaticheal collo.La forma pi comune di chirurgia era il prelievo del sangue# era considerato uale rimedio perristabilire lReuilibrio tra i Iuidi del corpo.AllRepoca si era in grado di arrestare unRemorragia con ilegacci, operare e contenere in bende unRernia, ricucire le estremit= dei nervi recisi e operare
-
7/24/2019 ref ita
11/14
lRidrocefalo infantile, praticando una piccola apertura nel cranio.Alcune pozioni utilizzate perridurre il dolore o indurre il sonno durante gli interventi chirurgici erano essi stessi potenzialmenteletali.;no di essi consisteva in lattuga, cistifellea da un cinghiale castrato, brionia, oppio,giusuiamo, succo di cicuta )che di per s< poteva essere mortale*.Nino al 021J non veniva usato il bisturi ma il ferro rovente introdotto dagli arabi.Subito disprezzati per uel contatto eccessivamente intimo con il corpo umano# manipolatori dicarne e sangue, posti sullo stesso piano dei macellai e dei carneci# tacciati di essere degli omicidiingannatori, i chirurghi furono a lungo considerati medici inferiori, guardati con sospetto sia dauna Chiesa che considerava la chirurgia una pratica abominevole in contrasto con il credo
cristiano, sia dai loro stessi colleghi medici.Alcuni interventi chirurgici venivano poi delegati ad un subalterno, il barbiere ad esempio, il ualenon si limitava ad operare in un ambito prettamente estetico, ma si dedicava a vere e proprieoperazioni come ad esempio lestrazione dei denti, i salassi, la cura degli ascessi. QenrO de&ondeville, il grande chirurgo francese medico di Nilippo il -ello, riteneva i barbieri: %chirurghiorgogliosi e illetterati, stupidi e completamente ignoranti(, insomma dei veri e propri concorrentidei medici capaci di condividere con uesti ultimi s@ la pratica, ma non certamente il sapereteorico.La gura del barbiere, cos@ come uella del chirurgo, era poi accomunata a uella del fabbro deluale condivideva determinate conoscenze speciche del settore artigianale: una testimonianzarisalente al TM secolo riferisce che ad un candidato barbiere era stato chiesto di forgiare dellepunte di lancia utili in caso di salasso.Le operazioni delegate ai barbieri erano sicuramente uelle pi umili e a pi diretto contatto con ilsangue che, se da una parte poteva essere considerato oggetto di culto rappresentando il sanguedi Cristo, dallaltra era disprezzato e anzi ritenuto pericoloso e velenoso, tanto che la leggeimponeva di gettarlo via immediatamente dopo gli interventi.
$rapano per interventi chirurgici!ochi i riferimenti allRepoca: conosciuti erano alcuni Leech+boo7s o libri omnicomprensivi dimedicina e chirurgia e di tali pochi ne rimangono.-alds Leechboo7, tra di essi, propone unacuriosa struttura per lRanalisi del corpo umano.4l Libro 4 di tale opera descrive le cure controa6ezioni della testa e di seguito gli occhi, le orecchie, la gola no ai polpacci, le gambe ed i piedi.
Contiene le procedure per un gran numero di malattie, uali %tumori o ascessi, a6ezioni cutanee,paralisi, febbri, morsi di serpenti, ferite, vermi intestinali, ecc.(.4l secondo libro tratta del %riconoscimento dei segni della malattia e dei tentativi di diagnosi(.Consistevano in manoscritti ed incunaboli, originati in centri, uali Qereford, Finchester, e D'ford,che coprivano lRintero spettro della medicina medievale. Leechcraft )dallRanglo+sassone laece medico* corrispondeva alla primitiva arte della guarigione, comprendendo ricette,prevalentemente a base di erbe, conosciute in tempi pre+moderni come materia medica.uesti testi erano una specie di ponte tra gli scritti medici anglo+sassoni dei secoli 4T e T e uellierboristici del 9inascimento. !hOsic7 corrisponde allArte ragionata, basata sulla conoscenzadella >atura )phOsica* e ra8gura una gran variet= di trattati ben focalizzati e strutturati, scritti inmiddle english e in latino. $esti vernacolari, uali la versione in inglese del $reasuri of Qelth di
!ietro di Spagna, riIettono una popolarit= delle diagnosi emesse con lRuroscopia, pronosticiastrologici, prevenzione con la dieta e trattamento con salassi. Le traduzioni dal latino, assiemecon gli scritti in latino, composti o copiati in 4nghilterra, attestano le costanti comunicazioni con ilcontinente, lRinIuenza dalla Scuola Salernitana o araba e lRincremento della cultura libresca.CQ49;9"4A E 54SSEW4D>E4l chirurgoEsistono pochi riferimenti alle operazioni chirurgiche, ad eccezione dei salassi. Ci? probabilmente dovuto al fatto che non si sono conosciute procedure anestetiche e8caci no alT4T secolo. Ci? non signica che lRanestesia non sia stata tentata nel &edioevo. &olte pozionierano conosciute dai chirurghi medievali ed erano utilizzate durante la chirurgia.Alcune di esse,usate per lenire il dolore o per indurre il sonno, erano di per se stesse potenzialmente letali.!er
esempio: una consisteva in lattuga, bile di un cinghiale castrato, brionia, oppio, giusuiamo, esucco di cicuta: tale ultimo ingrediente avrebbe potuto facilmente causare la morte.La dissezioneanatomica su cadaveri era rara nel &edio Evo, soprattutto a causa di scrupoli religiosi edintellettuali.Conviene menzionare che la parola utilizzata per descrivere la pozione da assumereper lRanestesia UbelladonnaU, che nellRaccezione della &edia 4nghilterra )ad esempio* potevasignicare inganno, delusione, male# o una condizione inebetita o inconscia# o una pazzia, o unapianta specica: Atropa belladonna, o una bevanda narcotica.
-
7/24/2019 ref ita
12/14
Come si pu? capire: il margine di sicurezza era pericolosamente ristretto tra una anestesiae8cace e la morte per depressione respiratoria.5i conseguenza la chirurgia non era tentata tranne che per i casi di danni da pericolo di vita. Lagrande attivit= dei chirurghi medievali aumentava durante le guerre e le epidemie di peste.LReplorazione del corpo umano a6ascinava i chirurghi medievali. La necessit= di scoprire cosa cRallRinterno di un corpo umano spinse pochi coraggiosi, con forte stomaco, a dissezionare icadaveri.;nimmagine proveniente da un Leech boo7, libro medievale di medicina e chirurgia, che illustraXlRuomo feritoU: le possibili ferite che un chirurgo avrebbe potuto trattare durante la sua carriera.
Sfortunatamente tale pratica era fortemente osteggiata dalla Chiesa cattolica. La Chiesa eracontraria infatti ad ogni forma di manipolazione dei morti. 5urante le Crociate era, comunue,pratica comune cuocere ossa umane, per facilitare il il ritorno dei resti alla terra di origine, peradeguata tumulazione.&olti papi non solo condannarono la dissezione dei corpi, ma talvolta addirittura si impegnaronopersonalmente per fermarla. 4 papi che pi agirono contro la dissezione furono 4nnocenzo 444,"regorio 4T, Sisto M4 e -onifacio M444.Alcuni di loro minacciarono di scomunica chiunue avesse dissezionato un corpo umano o cotto leossa umane. 4noltre, una speciale inuisizione stabil@ che chiunue fosse stato colpevole dimolestare i morti, sarebbe stato arso al palo o comunue punito severamente.Sebbene guardassero sdegnosamente alla dissezione, i papi non si curavano della ispezione delleferite fatali, operata da medici di rinomata esperienza. %Sebbene la necroscopia non fossenecessariamente implicata in uesti casi, una certa indagine anatomica doveva essere fatta(. $aliispezioni erano solitamente e6ettuate )e concesse* in casi di circostanze particolari, per la mortedi preti altolocati, papi o nobili.;n fatto importante da menzionare che la Chiesa non solo permetteva ma e6ettivamenteordinava i parti cesarei in donne morte, nel tentativo di salvare lRanima degli infanti non nati.La medicina, durante il &edioevo, si basava sulle capacit= di diverse classi di operatori: gli anzianierano trattati da medici con istruzione universitaria, da monaci, o guaritori popolari, a secondadella classe socio+economica.Sebbene la pratica e le procedure mediche medievali possano oggi generalmente essere ritenute
obsolete e basate su rimedi tribali, preghiere, formule magiche, ed incantamenti, esistevanoanche interventi chirurgici e cure adeguate che sono simili alle procedure moderne.4 medici credevano anche in uella che divenne nota come la 5ottrina delle Segnature per cui ilcolore dei ori ed altre propriet= delle piante potevano risultare utili per il trattamento diparticolari malattie.4 pochi medici esistenti, risiedevano principalmente nelle citt=, dove potevano ottenere salari eprivilegi consistenti.Solo i pi benestanti potevano, peraltro, avere le cure adeguate, per cui la Chiesa si fece carico dici? che era remunerato dalla ricompensa divina. 4 pellegrinaggi avevano appunto lo scopo diriappacicarsi con 5io.4 monaci, i pi acculturati della popolazione in generale, applicarono le conoscenze tratte dagli
antichi testi medici, di cui avevano fatto le copie.Zohn Arderne era conosciuto specialmente per lachirurgia correttiva delle stole anali, un disturbo abbastanza freuente presso gli 4nglesi.
$utti i XmediciU utilizzavano grosso modo gli stessi rimedi erboristici, ma operavano in gruppisocio+economici nettamente distinti e con grande sducia eKo disprezzo lRun per lRaltro.La situazione si ampli? nei secoli, risultando nelle persecuzioni religiose e caccia alle streghe, che,alla ne, portarono alla esecuzione di migliaia di guaritori popolari, cos@ abili da essere ritenutiavere un patto col diavolo.S$9;&E>$4 CQ49;9"4C4 E "4>ECDLD"4C4Le bacheche allineate e i grandi armadi alle pareti debordavano di una miriade di oggetti:strumenti chirurgici ordinati nelle loro cassette di legno, ferri per la trapanazione del cranio,lancette per salassi, seghe per amputazioni, strumenti di ortopedia, traumatologia e ginecologia
come forcipi e dilatatori.>on mancavano veri prototipi come microscopi da tavolo eportatili.Nornitissima era la bacheca n dai tempi di !ompei ed Ercolano: cucchiai dRavorio,strumenti chirurgici, ampolle, una serie di e' voto di terracotta romani, con riproduzione di varieparti anatomiche del corpo, con prevalenza degli organi interni: fegato, reni e intestini.
4n una tomba di $aruinia stato ritrovato anche un cinto ernario etrusco in bronzo del M44 secolo.$9E ESE&!4 54 CQ49;9"4A &E54EMALE
-
7/24/2019 ref ita
13/14
Come indicato nel testo allegato, probabilmente vorr= trapanare, poi ripulire la ferita e medicarla.;n unguento chiamato Xapostolicon chirurgicumU era usato in uesti casi.4l testo sopra la guraindica: %9iguardo alla frattura ha la forma di una fessura. $alvolta succede che il cranio fratturato da una fessura ed diviso cosicch< nessun lato pi elevato dellRaltro e non certo sela frattura si estenda anche allRinterno del cranio. !er scoprirlo il paziente deve tenere chiuse labocca e le narici e poi so8are con vigore# se il ato esce dalla fessura si sa che il cranio fratturato anche allRinterno del cervello. $rattarlo come segue: se la ferita stretta, si allarga e ameno di essere impedito dal sanguinamento, si trapana immediatamente con strumento di ferro,molto attentamente, da entrambi i lati della fessura. Nare tanti fori che sembri opportuno, e poi
tagliare il cranio da entrambe le parti con un bisturi )spathumina*, cosicch< lRincisione si estendano ai limiti della fessura. Attentamente rimuovere il pus che ne esce con della seta di un sottiletessuto introdotto lateralmente tra il cervello ed il cranio, con lRaiuto di una piuma[poimedicare\(.>ei tempi antichi e medievali, i calcoli della vescica erano rimossi con un metodo detto Xdi CelsoUin ricordo della dettagliata descrizione di Celso nel suo 5e &edicina )M44, 2*.Secondo lui esecondo 9ogerius )Chirurgia, 444, G0+G3*, dopo che il paziente ha digiunato parecchi giorni, ilcalcolo scende nel tratto urinario. 4 manoscritti di Zohn Arderne )il padre della chirurgia inglese, T4Msecolo* contengono schemi di come il calcolo fuoriesce nel pene dopo che stato escisso.>el procedimento tradizionale, comunue, il medico inseriva un dito nellRano, per manovrare ilcalcolo nella discesa nella vescica, mentre premeva dallResterno per coadiuvare e controllare ilmovimento.5opo che il calcolo sospinto allRuscita della vescica, viene rimosso chirurgicamente.LRoperazione )cos@ come oggi* si svolgeva dal retro. uesto viene mostrato nella miniatura, con ilpaziente nella posizione tradizionale, le gambe Iesse a forbice, tenute ferme dagli assistenti)discipuli*, mentre il chirurgo estrae il calcolo attraverso una incisione sanguinante.Mengono anche descritti i trattamenti precedente e successivo, come segue:%Se cR un calcolo nella vescica, assicurarsene come segue: porre a sedere su una panca unapersona forte, con i piedi su uno sgabello# il paziente si siede sulle sue ginocchia, le gambe legateal suo collo con una benda, o euilibrate sulle spalle dellRassistente.4l medico sta in piedi di frontea lui e inserisce due dita della sua mano destra nellRano, premendo con il pugno sinistro sul pube
del paziente.$rattenendo la vescica dallRalto con le sue dita, vi manovra per identicare se il solidorigongiamento sia il calcolo della vescica che so8ce e carnosa# cos@ si identica ci? cheimpedisce la minzione.Se si vuole estrarre il calcolo, si fa precedere una dieta leggera o il digiuno per due giorni.4l terzo giorno si rintraccia il calcolo, lo si porta al collo vescicale e allRingresso e con due ditasollevate nellRano, si incide longitudinalmente con apposito strumento, e si estrae ilcalcolo.9iduzione vertebrale, per scuotimento su una scala. >elle riduzioni spinali, la meritoriareputazione dei "reci per metodiche mediche progressive, trova unReccezione: il brutale metodoper ridurre la dislocazione spinale, appendendo il paziente )o la vittima* ad una scala che vienecalata a terra verticalmente, cos@ da scuotere le vertebre dislocate nellRopportuno posizionamento.uesto procedimento viene descritto nel M secolo nel trattato ippocratico Sulle Articolazioni )!er@
Arthron*, capitolo GG, copiato ed illustrato uattro secoli dopo da Apollonius nel lbro Slogature,capitolo 2.4n accordo con la tradizione ippocratica, una gobba o gibbosit=, considerata per lo piincurabile, pu? essere trattata scuotendo il paziente legato ad una scala.
$ale procedura e seguita in dettaglio nel testo che lRaccompagna.%4 casi ove la curvatura sia bassanella spina vertebrale sono trattati al meglio con la testa allRingi.4mbottire la scala!orvi soprail paziente, sul retro, usando usando bende so8ci ma forti, stringere le sue caviglie alla scala,legando assieme le gambe, sopra e sotto le ginocchia, e legarlo lassamente ai anchi ed al torace,stringere le braccia e le mani, stese lungo il corpo, ma non alla scala.Allora sollevare la scalacontro una alta torre o una casa. 4l terreno deve essere solido e gli assistenti ben esercitati,cosicch< lascino cadere lentamente la scala ed in positione verticale B meglio calarla da un palocon una carrucola scuotendo con tale apparato, ma sconveniente discutere i dettagli.
4 casi in cui la curvatura sia alta sulla spina vertebrale sono trattati al meglio con i piedi in basso.Legare saldamente il paziente alla scala al petto, ma lassamente al collo, solo per tenerlodiritto.!ortare la testa alla sommit= della scala. Legare il resto del corpo lassamente ui e l=, soloper tenerlo verticale.Legare strettamente le gambe fra di loro, ma non alla scala, cosicch< siano inlinea con la schiena(.4n tempi pi recenti, no al T4T secolo, tali procedure venivano ancorautilizzate in medicina, ed anche nelle punizioni corporali.
-
7/24/2019 ref ita
14/14