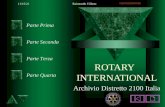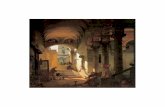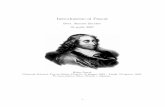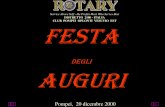Raimondo Villano - Indici di ricerca archivio Distretto 2100-ITALIA del Rotary International
Raimondo villano - La conoscenza di Dio nel pensiero di Pascal
Click here to load reader
-
Upload
raimondovillano -
Category
Documents
-
view
143 -
download
3
description
Transcript of Raimondo villano - La conoscenza di Dio nel pensiero di Pascal

Raimondo Villano - Conoscenza di Dio nel pensiero di Pascal
1/4
Raimondo Villano
Conoscenza di Dio nel pensiero di Pascal(1)
Cosa pensa il grande scienziato (matematico, logico, psicologo) della possibilità da parte dell’intelletto di conoscere Dio?
In Pensées (Fr. 543) afferma che “le prove metafisiche di Dio sono così lontane dal modo di ragionare ordinario degli uomini e così intricate che colpiscono poco e, quand’anche fossero utili ad alcuni, non servirebbero loro che nell’attimo in cui vedono la dimostrazione, ma un’ora dopo essi temerebbero di essersi ingannati”.
Di per sé, dunque, sarebbe possibile dedurre dalla realtà del mondo l’esistenza di Dio ma ciò è faticoso, pochi sono in grado di comprendere i processi di pensiero necessari alle dimostrazioni che, comunque, non producono convinzioni autentiche e, soprattutto, durature.
Chi esamina il mondo in modo sperimentale senza fede o disposizione ad essa bensì con la ragione, trova solo ‘oscurità e tenebre’; Pascal, quindi, non nega la possibilità astrattamente teoretica di conoscere dalla creazione il Creatore: ma se si pone dinanzi alla natura un uomo non credente in Dio né disposto a credervi, questi non vedrà altro che la semplice ‘natura’.
C’è, dunque, una via logica dal mondo a Dio ma, perché sia rettamente intesa e porti al senso esatto, occorre un occhio conveniente.
Il non credente in Dio crede nel concetto di natura.
La semplice osservazione della natura scopre, nel migliore dei casi, un Essere metafisico assoluto; se si deve giungere oltre, a vedere il Dio vivente cui si rivolge l’interiorità umana che aspira alla salvezza, deve nascere un nuovo evento, al di sopra della natura: Dio deve rivelarsi, dischiudendo una nuova ‘vue’, un nuovo spazio in cui sta. È lo spazio della parola, dell’annuncio, del messaggio: in una parola la ‘Chiesa’, una nuova situazione in cui le testimonianze di Dio presenti nella natura diventano efficaci e dispiegano il loro vero significato.
Per Pascal come per Agostino(2) l’esistenza è costituita da piani: il senso e le possibilità del piano inferiore si dischiudono soltanto sul piano superiore. La vita non può venir compresa dal basso verso all’alto bens^ viceversa, gerarchicamente.
Pascal, inoltre, parla del ‘velo della natura’ che avvolge Dio. C’è una forza che oscura lo sguardo; per Pascal l’uomo non costituisce un’unità autarchica ma si rapporta a qualcosa. L’uomo è un essere attratto verso l’alto, che giunge a realizzare il suo vero significato quando incontra l’Essere vero che dall’alto gli viene incontro, Dio, e quando entra con Lui in un vivente rapporto. Solo in una tale relazione con Dio l’uomo è uomo nel senso della rivelazione; solo da qualcosa che è ‘sopra’ in modo assoluto, non metafisico ma del Dio vivo, l’uomo attingere il suo essere vero e autentico.
Ciò vale anche per la conoscenza. Nell’atto conoscitivo c’è tutto l’uomo. Solo quando la tensione conoscitiva va a Dio e da Dio ritorna, come un arco di fuoco, la conoscenza è pienamente se stessa; ma il peccato ha distrutto questo rapporto, spezzando l’arco di fuoco che non afferra più l’esistenza nel suo pieno significato. Il peccato non vuole che si attui la conoscenza del Dio vivo.
L’essenza del peccato è l’egoismo: la volontà di non essere rapportati a Dio, ma di rimanere in se stessi; l’amore dell’uomo per se stesso, che rende sé e il suo mondo il centro di quanto esiste. Inoltre, va considerato il fatto che, come Dio, anche il vero io dell’uomo è nascosto: lo stesso limite che si oppone alla

Raimondo Villano - Conoscenza di Dio nel pensiero di Pascal
2/4
conoscenza di Dio ostacola anche la conoscenza di Dio, lo stesso velo che cade su Dio cade anche sull’uomo, il cui vertice naturale è nella relazione con Dio.
È opportuno precisare, a tal proposito, che il concetto del Dio nascosto o sconosciuto non ha nulla a che fare con quello sviluppato nella teologia dialettica ed è del tutto errato interpretare Pascal sulla falsariga di Kierkegaard: Pascal, infatti, non sa nulla dell’incommensurabilità assoluta che Kierkegaard pone fra il Dio, che è santità, e l’uomo, che non solo è peccatore ma anche peccato. Pascal, in pratica, afferma (Fr. 557): “non è vero che tutto riveli Dio e non è vero che tutto nasconda Dio. Ma è vero che Egli si nasconde a quelli che lo tentano e si rivela a quelli che lo cercano; perché gli uomini sono a un tempo indegni di Dio e capaci di Dio ‘capables de Dieu’, l’agostiniano ‘capax Dei’. Indegni a causa della loro corruzione, capaci in virtù della loro primigenia natura”. È, dunque, qualcosa di diverso dall’incommensurabilità radicale: la chiarezza dello sguardo prima del peccato, consistente nel rapporto originario con Dio, è distrutta a tal punto che l’uomo non comprende più il suo primo stato: “non comprendiamo né lo stato glorioso di Adamo né la natura del suo peccato né la trasmissione di questo in noi. Sono cose accadute nello stato di una natura del tutto diversa dalla nostra e che trascendono il grado della nostra capacità attuale(3)”.
Tuttavia, ciò che è andato perduto continua ad agire, non è semplicemente perduto, è sconvolto ma non estinto. L’uomo è oggi peccatore ma essere uomo non vuol dire essere peccato, ciò è un’esagerazione del pensiero biblico non giustificabili né in Paolo né altrove. Nel Nuovo testamento l’uomo è peccatore ma l’intenzione a Dio è ancora presente in lui e l’incommensurabilità con Dio non è assoluta ma relativa e occultezza significa essere velato; Pascal afferma: “se nulla fosse mai apparso di Dio, questa privazione eterna sarebbe equivoca (…) ma il fatto che Egli è apparso qualche volta e non sempre toglie ogni equivoco(4)”.
Pascal, poi, afferma che non conoscono nella sua occultezza Dio i pagani né nel suo nascondimento sacramentale i protestanti, mentre ben Lo conoscono i cattolici e, infine, là dove ‘gli altri’ non Lo conoscono Egli è “manifesto a noi in tutte le cose”. Pascal, attingendo alla tradizione agostiniana, dà affermazioni gravi sulla condizione dell’uomo affermando, ad esempio, che ‘non è affatto il paese della verità (…) sconosciuta fra gli uomini(5)” e da Dio coperta da un velo(6)” mentre altrove(7) dice che “gli uomini sono nelle tenebre e lontani da Dio (…) nascosto alla loro conoscenza” e che l’attributo che Egli si dà nella Sacra Scrittura è ‘Deus absconditus(8)’. Un Dio che, nonostante l’accecamento dello spirito e l’impurità del cuore fosse senz’altro conoscibile non sarebbe il Dio santo; il suo nascondimento a causa del peccato è segno della Sua verità e santità.
Appena l’uomo pecca, dunque, l’occultezza diviene il naturale luogo di Dio e, per il medesimo motivo, anche l’uomo è nascosto a se stesso e, quindi, “sa così poco chi è Dio, che non sa neppure cosa sia lui stesso(9)’: in effetti, non è “soltanto Deus, ma anche homo absconditus”.
Pascal, conseguentemente, si pone il quesito sulla possibilità di penetrare al di là del velo giungendo alla conclusione che la sola possibilità sia insita nel ripercorrere la via opposta al peccato, ovvero il superamento della centralità esistenziale di se stessi, umiltà e abbandono in Dio e purificazione interiore: tutto impossibile con le proprie umane forze giacché, trascendendo il semplice esame di coscienza e il ravvedimento, prende Dio a misura e fondamento e, pertanto, l’orientamento da assumere è determinato da Dio. In altri termini, si tratta di una nuova arcatura dell’arco, di un nuovo configurarsi della tensione verso Dio, non raggiungibile dalla natura peccatrice.
Altrove, poi, Pascal afferma che: “tutti i corpi insieme e tutti gli intelletti insieme e le loro realizzazioni non valgono il più piccolo moto di carità. Questo (…) è di un altro ordine, di un ordine soprannaturale(10)”. La carità ha una propria natura, un suo piano di valore, una sua propria “grandeur”, fra quelli e questa vi è una ‘différence de genre” che deriva dal superamento di se stessi per amore di Dio: è la grazia che solo Dio può dare.
In un altro passo Pascal afferma che Dio non è semplice autore di verità geometriche (matematiche e logiche) e dell’ordine degli elementi o solo provvidenza su vita e beni umani accordando “prospera successione di anni a coloro che l’adorano” o comprensibile “dal semplice contenuto dell’esistenza umana e

Raimondo Villano - Conoscenza di Dio nel pensiero di Pascal
3/4
della storia” ma è un “Dio di amore e di conforto, che riempie anima e cuore di chi Egli possiede” pur facendo sentire essi interiormente la loro miseria ma anche la Sua misericordia infinita, “che si unisce al fondo della loro anima; che la riempie d’umiltà, di gioia, di fiducia d’amore; che li rende incapaci d’altro fine che non sia Lui stesso(11)”.
Il donarsi di Dio è storico, legato ad una determinata figura in cui Egli si rivela venendo all’uomo: nella rivelazione si fonda il nuovo ordine della carità e della grazia.
In effetti “noi non conosciamo Dio che per mezzo di Gesù Cristo. Senza questo Mediatore è tolta ogni comunicazione con Dio(12)” e “ma neppure noi stessi conosciamo se non per mezzo di Gesù Cristo. (…) Così, senza la Scrittura, che ha per unico oggetto Gesù Cristo, non conosciamo nulla e non vediamo che oscurità e confusione nella natura di Dio e nella nostra stessa natura(13)”. Pascal, poi, esprime il concetto fondamentale che “noi conosciamo, al tempo stesso, la nostra miseria perché quel Dio altro non è che il riparatore della nostra miseria. Così come noi non possiamo conoscere Dio che conoscendo le nostre iniquità(14)”.
Il rivelarsi di Dio nelle cose e negli eventi del mondo era un Suo ‘darsi generale’: la trasparenza delle creature per il Creatore; in Cristo vi è un ‘darsi particolare’: una forma precisa, quella storica; la Sacra Scrittura di Antico e Nuovo testamento prepara al Cristo, lo immette e spiega la storia. Il Donarsi di Dio è storico, legato a figure storiche.
Mentre nelle religioni i miti non sono legati ad alcun evento storico, il Cristianesimo è una serie di eventi biblici, ovvero la storia della salvezza.
D’altro canto, Dio non ha bisogno della proclamazione di santi ma siamo noi uomini ad averne bisogno. “Il santo è colui che ha attorno a sé persone che gli si rivolgono per essere orientate: è uno strumento con il suo corpo che, come un violino in un’orchestra, crea una sinfonia(15)”.
Pascal, infine, considera la Chiesa in stretta connessione con Cristo e vi riserva un’ardente professione di fede e l’espressione lapidaria che “la storia della Chiesa deve essere propriamente chiamata storia della verità(16)” e che “è impossibile che coloro i quali amano Dio con tutto il loro cuore non riconoscano la Chiesa(17)”. La stessa Sacra Scrittura, dunque, non è un fenomeno qualsiasi proiettato da Dio nello spazio universale della storia, bensì legata ad un piano particolare, affidata a una realtà insita nella storia: la Chiesa, sola interprete della Sacra Scrittura e nel cui esclusivo ambito la Sacra Scrittura può essere rettamente ascoltata.
___________
Note
(1) Romano Guardini, Pascal, Morcelliana, Brescia, 1972(1^ ed.: Christliches Bewußtsein, Versuche über Pascal, Bautzen 1934). Romano Guardini (1885-1968), teologo tedesco-italiano, docente a Monaco di Baviera di Filosofia della Religione.
(2) Si trovò a giudicare dal piano più alto conoscitivo la possibilità del piano inferiore.
(3) Blaise Pascal, Pensées (Fr. 560).
(4) Ibid. (Fr. 559).
(5) Ibid. (Fr. 843).
(6) Ibid. (Fr. 718).
(7) Ibid. (Fr. 194).
(8) Ibid. (Fr. 415).
(9) Ibid. (Fr. 430).
(10) Ibid. (Fr. 793).

Raimondo Villano - Conoscenza di Dio nel pensiero di Pascal
4/4
(11) Ibid. (Fr. 556).
(12) Ibid. (Fr. 547).
(13) Ibid. (Fr. 548).
(14) Ibid. (Fr. 547).
(15) Achim Buckenmaier, Lezione del 17 aprile 2013, Città del Vaticano, Pontificia Università Lateranense, Cattedra di Teologia del Popolo di Dio.
(16) Ibid. (Fr. 858).
(17) Ibid. (Fr. 850).