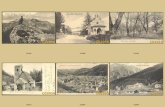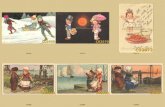PROGETTI E CONCORSI 29 MAR. - 10 APR. 2010 L’INCHIESTA ... · Realizzata con materiale di risulta...
Transcript of PROGETTI E CONCORSI 29 MAR. - 10 APR. 2010 L’INCHIESTA ... · Realizzata con materiale di risulta...

Una «scatola» come sala hobby
Polo culturale nel tennis club
La dépandance di SpeedStudio a Gubbio con lamiere usate
Lapo Ruffi recupera un vecchio edificio degli anni Cinquanta
Luogo: Gubbio(Perugia)Progetto:SpedstudioCommittente:PrivatoRealizzazione:Leonardo Miti &figli (Gubbio)Anno: 2008
■ Realizzata con materiale di risulta e vecchie lamiere usate, la Dépendance di Spedstudio aGubbio richiama lo stereotipo del “capanno degli attrezzi”. Il rivestimento continuo in zincoavvolge interamente il volume. La simmetria della doppia falda è spezzata lungo la linea dicolmo per lasciare spazio a una lunga lama di luce che garantisce un’ottima qualità visiva alproprietario per i lavori di hobbistica. Una “scatola” rivestita in legno si aggiunge comesuperfetazione e permette un collegamento visivo diretto con l’abitazione poco distante.
Luogo: Monguzzo (Como)Progetto: Marco CastellettiCommittente: PrivatoRealizzazione: Losa(Costa Masnaga)Anno: 2009
Luogo:SerravallePistoiese(Pistoia)Progetto:Lapo Ruffi - LraCommittente:Tennis Club RioRealizzazione:Unofà (Firenze)Anno: 2009
La parola “micro-architettura”ricorre sempre più spesso nel-la cultura progettuale contem-poranea: in realtà essa ha leproprie radici in altri tempi.
Correvano gli anni Cinquanta quando LeCorbusier concepì il famoso “cabanon”sulla Costa Azzurra: realizzato in legnodi pino non piallato, accoglieva il soggior-no, un armadio a muro, un tavolo, duesgabelli, una libreria e un angolo nottecon lavabo in circa 15 mq. Negli anniSessanta, qualcosa di molto simile co-struì Norman Foster in Cornovaglia:
Cockpit, nato come punto panoramicoprotetto, introdusse successivamente unnuovo concetto di organizzazione spazia-le e di relazione con la natura. «La mi-cro-architettura può essere considerata co-me un parto degli anni Sessanta», dichia-ra Jay Shafer, creatore della XS House,una casa su ruote di quattro metri per duecon veranda e pensilina ripiegabili. «Al-l’epoca la chiamavano architettura noma-dica, si ispirava alle yurte mongole, aicarri tzigani e ai tepee dei nativi america-ni». Oggi, e questo vale anche per l’Ita-lia, l’aspetto è completamente diverso,così come le attese di chi è destinato adabitare queste micro-architetture. Non èpiù solo una questione di ricerca estetica,piuttosto diventa anche una scelta di tipo
commerciale, dovuta alla carenza di spa-zi urbani edificabili, ai costi di questiultimi e dei materiali. La micro-architettu-ra oggi continua a misurarsi con le picco-le dimensioni, ma è anche attenta a unuso intelligente delle risorse e a una rin-novata relazione con la natura.
L’obiettivo è ridurre la quantità di mate-riale, e quindi anche l’energia necessariaper produrlo e per trasportarlo, ma anchedi creare una rarefazione della presenzaumana nella natura. La scala della micro-architettura, infatti, consente alla natura diessere predominante sull’architettura.
In Italia l’approccio alla micro-architet-tura è ancora timido. Siamo lontani, peresempio, dal prendere in prestito riferi-menti dell’astronautica per ridurre pesi evolumi. Si comincia tuttavia a intravede-re una certa sensibilità per questi temi,che si traduce nello studio di nuove orga-nizzazioni dello spazio per renderlo piùcompatto, nell’uso di materiali in armo-nia con la natura, nel tentativo di renderequesti ambienti più efficienti dal punto divista energetico. Interventi come il picco-lo agriturismo a Cermes (2009), di GerdBergmeister e Michaela Wolf, il Centrovisitatori del lago di Carezza (2008) diWalter Angonese, la chiesa di San Fran-cesco sull’Alpe di Siusi (2009) di WalterKarl Dietl, gli eco-spazi per la didattica aToro (2009) di MODIStudio, lo stabili-mento balneare a Varazze (2008) di Lo-renzo Piazza: sono testimonianze di unavvicinamento al tema della piccola di-mensione, ma anche a quello della naturacome protagonista di una scena nella qua-le l’architettura è una presenza minuta,non disturbante, realizzata con materialisostenibili e riciclabili, e comunque sem-pre di qualità. Illuminanti, in tal senso, leparole di Jan Kaplicki di Future Systemsil quale sosteneva che «tutto è architettu-ra, dalle capanne ai grandi progetti urba-nistici. È importante la qualità, la funzio-ne e la relazione con gli uomini chevivono sulla terra, non la dimensione delprogetto». Colpisce positivamente, poi,che questa nuova sensibilità viene perlo-più dai giovani progettisti, che sarannochiamati a trasformare il rapporto fra uo-mo, architettura e ambiente. Curioso esingolare il lavoro del team di Roma, Lacasa sull’albero: tre architetti e un avvo-cato (esperto degli aspetti giuridici relati-vi al rapporto fra ambiente e architettura)realizzano case appollaiate sui rami deglialberi: piccole, ecocompatibili, realizzatein legno e materiali vegetali, sono un’al-ternativa ecologica e compatta rispettoall’abitazione tradizionale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
I giovani progettisti riscoprono l’architettura«compatta» facendone uno strumento peresplorare il rapporto tra uomo e ambiente
L’INCHIESTA Micro-architettura
La ricerca lavora su materiali e risparmio energetico
Formato ridotto,stessa qualità:il design è «mini»
Progetto in tre volumi con Marco Castelletti
Amaca architetti con Alice Pesce
Nella casa essenzialec’è anche il garage
Biblioteca tascabilea Maserada sul Piave■ Volumi semplici, aggregazioni chiare ma articolate,pochi materiali: è il linguaggio essenziale eminimalista della nuova biblioteca e centro culturalerealizzati dallo studio Amaca a Maserada sul Piave.L’edificio si sviluppa su un unico piano con una salalettura unitaria ma articolata a partire dall’idea che labiblioteca di un piccolo paese deve essere una sortadi laboratorio culturale per attività di vario tipo edeve quindi avere spazi flessibili e noneccessivamente suddivisi.
■ Centrale elettrica, Villetta (Val Pusteria),monovolume, 2009
FOTO
:SI
MO
NCO
NST
AN
TIN
IFO
TO:A
DRI
AN
OBA
CCH
ELLA
■ La casa con padiglione, realizzata da Marco Castelletti, somma di tre differenti volumi confunzioni diverse. L’autorimessa è un parallelepipedo rivestito con lastre di rheinzink. La casa,con tetto a doppia falda, è definita in pianta da un rettangolo che si distende inallineamento all’autorimessa e accoglie in successione gli ambienti della vita domestica. Èrivestita da un intonaco protettivo con inerti di marmo e porfido con effetto marmorizzato. Ilpadiglione immerso nel verde, area di pausa, è rivestito con pannelli di legno di colore scuro.
■ Casa Camelot, Monti della Luna (Val di Susa),Giugiaro Design e Con3studio, 2009.
■ Il volume di un vecchio edificio degli anni ’50 viene ristrutturato per essere di nuovoconsacrato alla sua originaria vocazione: il tennis. La movimentata topografia locale haispirato un’architettura longitudinale, che si sfrangia alle estremità per essere, verso nord,parzialmente inghiottita dalla pendenza del terreno.Verso il pendio collinare, il volume parallelepipedo si immerge nell’orografia del territorio,creando la copertura-terrazza in legno di pino che sfuma con un prato saldandosi aiterrazzamenti.
DI FRANCESCA ODDO
6 PROGETTI E CONCORSI 29 MAR. - 10 APR. 2010

In montagnala chiesaminimalista
Deposito in tre metri quadrati
Il progetto di MODIStudio a Toro (Campobasso)
Stabilimento balneare Un osservatoriocontemporaneo
Di Walter Angonese la struttura a Nova Levante
Walter Karl Dietl in Val Passiria
■ La chiesa diSan Michele,realizzata daWalter Karl Dietlper la Parrocchiadi Saltusio, ècostituita da unambiente a salaa piantaquadrata dall’impianto nitido, essenziale, minimalista. «L’atmosferadi silenzio e di pace che conviene a una chiesa è frutto di unariduzione rigorosa dei colori e dei materiali», spiega il progettista.Diversi gli elementi in legno, fra i quali spicca la torre campanaria inlegno di larice massiccio.
A Torino lo studio Ape firma un contenitore apribile in legno di abete
■ Mini-deposito Donatellodi studio Ape nascedall’esigenza dellaComunità dell’AiuolaDonatello di disporre di undeposito per potercollocare il materialenecessario allarealizzazione delle proprieattività estemporanee.Il mini-deposito è unpiccolo contenitore, unoggetto flessibile cheoccupa 3 mq quando è chiuso e 17 mq quando èaperto. La struttura portante è realizzata inlistellare di legno di abete e le pareti che si apronoa 270˚, grazie a un sistema di cerniereappositamente disegnate, sono rivestite in laminatoad alta pressione traforato a controllo numerico.
L’eco-scuola d’infanziaper le lezioni in giardino
■ I Bagni Pinuccia sono un intervento di micro-architettura balneare,porta di accesso al litorale, mediazione tra la città e il mare. Tre i volumi:piccoli, puri, semplici parallelepipedi addossati come scogli e caratterizzatiognuno da un differente trattamento di superficie. Il progetto risponde altentativo di ottenere il massimo dello spazio funzionale con la minimasuperficie in prospetto, attraverso una gerarchia precisa degli spazi.
Luogo: Varazze(Savona)Progetto: LorenzoPiazzain collaborazionecon Piero Veneziae conMpsettantaaa/DedaloIngegneriaCommittente:Bagni Pinucciadi Piazza Lino sasRealizzazione:Sca Genova,Baglietto (Varazze),Tecnoristorazione(Varazze),allestimenti nautici(Arenzano)Anno: 2009Fotografia:Andrea Bosio
■ Lap sorge a Lambrate, periferiaest di Milano, un quartierevivacemente animato daoperazioni di riqualificazione. Ilprogetto parte dalla ricerca di ungesto vitale, che vuole faremergere il complesso dal tessuto.Viene recuperato il preesistentecapannone con copertura a shed.Su questo, nell’area dell’ingressosi innesta il volume dellatorretta/periscopio, un elementoche con i suoi quattro piani fuoriterra si stacca dal volumeorizzontale.
Team di progettisti per i Bagni Pinuccia di Varazze (Sa) RuattiStudio con Pichler a Lambrate
Luogo: Nova Levante(Bolzano)Progetto: WalterAngoneseCommittente:Provincia autonomadi Bolzano e ForesteDemanioRealizzazione:Pfeifer Bau(Nova Ponente),Holzbau Vieider(Cornedo all’Isarco)Anno: 2009
Luogo: Milano LambrateProgetto: Ruattistudio Architetti conMariano PichlerCommittente: Imperatore srlRealizzazione: Pizzetti (Romano DiLombardia)Anno: 2009Fotografia: Andrea Martiradonna
Centro visite sul lago
Luogo: TorinoProgetto: Studio ApeCommittente: Associazione AiuolaDonatelloRealizzazione: Spazio Artigiani (Torino)Anno: 2008
Luogo: Maseradasul Piave (Treviso)Progetto: AmacaArchitetti Associaticon Alice PesceCommittente:Comune di Maseradadel PiaveRealizzazione:Pellizzari(San Zenone degliEzzelini)Anno: 2009Foto: FrancescoCastagna
Luogo: Saltusio,Val Passiria (Bolzano)Progetto: WalterKarl DietlCommittente:Parrocchiadi SaltusioRealizzazione:Profil Bau(San Leonardoin Passiria)Anno: 2008Fotografia:Renè Riller
■ Il progetto di MODIStudio realizza un eco-nidodove i bambini possono apprendere, osservare,stare a contatto con la natura. L’utilizzo di varimateriali naturali è stimolo visivo e sensorialeper i bambini. I “gusci” sono ambienti coperti inlegno a pianta curvilinea e sinuosa. Poggiati suuna terrazza in legno rialzata rispetto al terreno,i gusci sono degli ambienti permeabili,semichiusi, sicuri. All’interno, arredi in legnoforniscono nuove occasioni per lezioni all’aperto.
■ Il Centro visitatori presso il lago diCarezza, di Walter Angonese, intendeproporsi come “edificio a chilometrozero”, racconta il progettista. Si tratta,cioè, di un’architettura realizzata conle risorse del luogo. La maggior partedel materiale costruttivo (il legno)proviene dalla vicina segheria dellacommittenza. Adottando i materialidel luogo, il progetto riduce leemissioni di anidride carbonicacausate dai mezzi di trasporto estabilisce un dialogo in armonia con lanatura.
Luogo: Toro(Campobasso)Progetto:Modistudio_AssociatiCommittente:Comune di ToroRealizzazione:Holzbau Sud spa(Calitri)Anno: 2009
29 MAR. - 10 APR. 2010 PROGETTI E CONCORSI 7