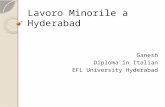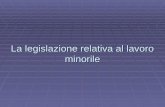principi del processo minorile - legislazione minorile
-
Upload
come2discuss -
Category
Documents
-
view
3.242 -
download
5
Transcript of principi del processo minorile - legislazione minorile

PRINCIPI DEL PROCESSO MINORILE ALLA LUCE DEI DOCUMENTI INTERNAZIONALI IN MATERIA
- Giovanni Cuccato -
Il processo penale minorile, e più in generale, il sistema giudiziario dei minori, comincia la sua evoluzione negli anni ’70. tale evoluzione parte “dall’alto”: dal sistema internazionale. A portare un contributo fondamentale, sono state le “Regole di Pechino” del 1985. queste “raccomandazioni” hanno preceduto di 4 anni la futura “Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia”. L’obbiettivo delle “Regole di Pechino”, era quello di predisporre gli ordinamenti dei singoli stati alla futura convenzione dell’89. le “regole” sortirono il loro effetto: dopo 3 anni tutti gli stati europei erano in grado di recepire nei loro ordinamenti la “convenzione”. In questo periodo c’è stato un uniformarsi quasi totale dei sistemi penali minorili di quasi tutti gli stati europei (Inghilterra esclusa a causa del sistema di common law) fino quasi a poterli interscambiare. Quasi tutti gli stati d’Europa, partendo dalle “regole di Pechino” e dalla “Convenzione ONU”, hanno adottato una legge minorile organica; non è stato così per l’Italia, il cui ordinamento minorile si basa ancora sul Regio Decreto del 1934. Si è preferito intervenire sulle norme disciplinanti il processo a carico dell’autore di reato minorenne, senza modificare in modo sostanziale l’ordinamento. Un altro neo del sistema italiano, è quello di non prevedere, per i minori, pene ad hoc, infatti, per il soggetto minorenne, le pene previste, sono le stesse che si infliggono agli adulti, tranne che per un’obbligatoria diminuzione della pena di 1/3 e il divieto di infliggere l’ergastolo. Le “regole di Pechino” e la “Convenzione ONU”, operano su di fondo quali: il diritto del minore a rimanere minore e come tale ad essere trattato da minore (la “Convenzione” fissa la maggior’età a 18 anni, ai singoli Stati è lasciata la soglia di imputabilità) anche quando egli è autore di reato. Si pone come obbiettivo il “supremo interesse” del minore. Con la “Convenzione” si esclude che il sistema penale minorile possa essere solo punitivo e retributivo (mentre per gli adulti l’art 27 della costituzione dice che la rieducazione deve essere tendenziale, la rieducazione del minore deve essere obbligatoria). Si stabilisce che il minore ha diritto di essere giudicato e assistito da un giudice a da personale (avvocato, servizi sociali, polizia) specializzati, si impone al sistema penale una fuoriuscita del minore in tempi brevi, anche attraverso strumenti, ispirati a una logica responsabilizzante ed educativa, diversi dal sistema penale inteso come mero carcere, cercando, allo stesso tempo, di allontanare la logica del mero perdono e della clemenza gratuita. Si deve prestare attenzione alla libertà personale del minore, si deve cercare di evitare la galera, tutt’al più essa deve essere un provvedimento temporaneo, optando per comunità familiari e dando la possibilità al minore, di eseguire “lavori di pubblica utilità”. Le disposizioni generali sul processo a carico del minore, si trovano nel DPR 448/88 e sono situate negli articoli da 1 a 15. L’art 1, ha al suo interno 2 principi fondamentali: al primo comma si afferma che essendo quella del processo minorile, una disciplina sussidiaria, per quanto non previsto dal DPR448/88, si deve riprendere il processo penale in generale nelle sue disposizioni speciali (adattandole alla personalità del minore); al secondo comma si dice che il giudice deve illustrare all’imputato minorenne il perché si trovi in un’aula di tribunale, adducendo ragioni etiche oltre che giuridiche. L’art 2 afferma che nel procedimento a carico di minori, devono figurare attori specializzati (dai giudici ai servizi sociali) e che anche il PM deve essere specializzato nel ramo minorile (si deve spogliare della mentalità accusatoria). Avviamoci ora ad analizzare il procedimento minorile, distinguendo subito tra procedimento (fase iniziale) e processo (fase avanzata). Il procedimento prende l’avvio con una denuncia di reato alla polizia giudiziaria (carabinieri, polizia municipale e non, guardia di finanza, ecc) che successivamente viene presentata al PM minorile. La denuncia, può anche essere presentata da un privato cittadino. Il PM, ricevuta la denuncia, la valuta e, se fondata, iscrive il denunciato nel registro degli indagati (il minore diventa indagato). Viene emesso l’avviso di garanzia, in modo che il minore possa difendersi da subito. Iniziano le indagini preliminari svolte dal PM e dalla polizia giudiziaria, per verificare l’effettiva responsabilità del minore. Chi valuta le indagini preliminari è il GIP (giudice per le indagini preliminari), questo è un giudice monocratico e togato (di carriera), che già in questa fase delle indagini, su richiesta del PM, il giudizio di non luogo a procedere. Inoltre, sempre su richiesta del PM, ha la possibilità di applicare delle misure cautelari. Il GIP può concedere anche l’incidente probatorio, cioè può permettere di assumere prove prima che si arrivi al processo (ad esempio una perizia psichiatrica o aucsologica, la raccolta di una particolare

testimonianza –raccolta dal giudice che può farsi assistere da un esperto- che viene registrata). Se il PM chiede il rinvio a giudizio, e il GIO valuta positivamente la richiesta, si ha l’inizio del processo penale, se al contrario valuta negativamente la richiesta, si ha l’istanza di archiviazione. Altra soluzione può essere il non luogo a procedere, disciplinato dall’ art 26 (in ogni fase del procedimento, quando il minore ha meno di 14 anni, si può chiedere il non luogo a procedere) e 27 (il PM chiede il non luogo a procedere per irrilevanza del fatto) del DPR 448/88. chiesto il rinvio a giudizio, si ha l’udienza preliminare, di fronte al GUP (giudice per l’udienza preliminare) che è un giudice collegiale, composto da un giudice togato e due giudici onorari. Chi svolge il ruolo di GIP, non può fare anche il GUP (il GUP non deve avere pregiudizi nei confronti dell’imputato). Il compito del GUP è quello di valutare se sussistono o meno le condizioni per procedere. Mentre per gli adulti questa è una semplice “udienza filtro”, per il processo minorile l’udienza preliminare è di centrale importanza: il 90% dei casi di processo minorile si chiude conclude con questa udienza, questo in virtù delle “Regole di Pechino” per una rapida fuoriuscita del minore. Se si arriva al dibattimento, il tribunale per i minori ha composizione piena: 2 giudici togati e 2 giudici onorari. Oltre alle classiche fasi del processo, si hanno anche procedimenti speciali, atti a deflazionare al processo penale. I più comuni sono: il giudizio per direttissima, il rito abbreviato (applicabile anche al minore, questo comporta un’immediata riduzione di pena di 1/3. Con esso si rinuncia alla fase del dibattimento e si chiede che sia il GUP ad esprimersi, si viene così giudicati sulla base degli atti, senza ulteriori prove o testimonianze) e il patteggiamento, che non è possibile applicare al processo minorile (perché contrario all’educazione del minore). In caso, l’art 12 del DPR 448/88, afferma che in ogni stato e grado del procedimento, il minore può essere assistito da un genitore, da una persona di fiducia o dai servizi sociali. A questo punto si ha la sentenza. Questa, può essere impugnata anche dal PM, presso la corte d’appello per minorenni; se anche la sentenza emessa dalla corte d’appello viene impugnata da una delle parti, si ricorre alla corte di cassazione (questa è un giudice di legittimità, un tribunale non specializzato). La sentenza della cassazione non può essere impugnata. In ogni stato e grado del processo, l’imputato minorenne è protetto dall’art 13 del DPR 448/88 che vieta la divulgazione di materiale idoneo al riconoscimento del minorenne coinvolto nel processo (questa però è una norma imperfetta perché non prevede una sanzione) e dall’ art 734 bis del codice penale che prevede l’arresto da 3 a 6 mesi per chi divulghi le generalità o l’immagine della persona offesa (la presunzione d’innocenza è tale finché non vi è una sentenza di colpevolezza). Il processo si può svolgere con 2 modalità: con udienza pubblica o in camera di consiglio. In questo ultimo modo, il processo si svolge nell’ufficio del giudice, alla presenza delle parti in causa, questo per evitare l’udienza pubblica. L’udienza penale, di solito è pubblica per controllare l’operato del giudice. L’udienza penale minorile è sempre a “porte chiuse” per tutelare il minore. Se questi, però, ha già compiuto 16 anni, può chiedere al giudice di avere un’udienza a “porte aperte” (la richiesta è vagliata dal giudice che può decidere di rifiutarla). La camera di consiglio è usata dai giudici anche per decidere le sentenze (questo avviene senza le parti). Dopo alcuni giorni dall’emissione della sentenza, ne viene depositata la motivazione, da questo momento la sentenza può essere impugnata. La funzione della corte di cassazione è quella di cancellare le sentenze immotivate, o di rinviare la sentenza a un’altra sezione d’appello. L’art 27 del DPR448/88 afferma che quando il reato è tenue e occasionale, il procedimento non è nell’interesse del giudice. Il PM, in questo caso, può chiedere il non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. In questo caso il GIP chiama il minore, il suo tutore e il PM in un’udienza camerale, nella quale decide se accettare o rifiutare la richiesta del PM (in ogni caso il PM non si può opporre alla decisione del giudice). La richiesta di non luogo a procedere può avvenire solo se il minore non è imputabile, o se il fatto non è rilevante. Il GIP può rifiutare la richiesta nel momento in cui ci siano gli estremi perché il caso non venga archiviato. Il non logo a procedere per irrilevanza del fatto è una sentenza di favore, che però lascia una traccia indelebile (se si commette un altro reato, in un’altra occasione, non si potrà più avere la richiesta di archiviazione). Se il processo continua, il minore verrà a trovarsi davanti al GUP che a sua volta può dichiarare d’ufficio il non luogo a procedere. Una volta emessa la sentenza, il minore è sottoposto alla sorveglianza del magistrato di sorveglianza (per i minori, questi sono gli stessi magistrati minorili). Questi è un giudice che segue direttamente il minore nell’esecuzione della pena. Egli può decidere di revocare le sanzioni e di concedere la libertà condizionale. La competenza del magistrato di sorveglianza, continua fino a quando il minore non raggiunge il 25° anno d’età, quando cioè esce dalla categoria dei giovani adulti (ex art 3 DPR 448/88). Secondo l’art 4 del DPR 448/88, nel caso

di un minore che ha commesso reato e proveniente da una zona diversa da quella di sua competenza, il PM minorile deve comunicare con il tribunale minorile della zona di residenza del soggetto, affinché questo possa prendere i necessari provvedimenti. Se il tribunale contattato non si attiva, il GUP può attivare dei provvedimenti civili urgenti, a favore del minore, che cessano dopo 30 giorni (circolarità dei provvedimenti). L’art 6 del DPR 448/88, stabilisce che in stato e grado del procedimento, il giudice si può avvalere dei servizi sociali minorili. Questi sono lo strumento più valido perché i provvedimenti siano coerenti con la tutela del minore. I servizi sociali si devono specializzare, perché si possono trovare di fronte a casi di minori particolarmente devianti. Personalmente, trovo che il processo penale minorile possa essere ulteriormente migliorato, magari, prestando ascolto alle molte voci, anche provenienti dall’estero, che suggeriscono la mediazione e la conciliazione, come le più eque ed educative delle sanzioni applicabili, così facendo, almeno per il ramo minorile, il sistema penale perderebbe parte della sua veste retributiva.