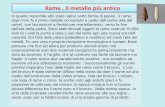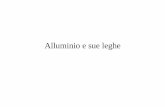Prefazione - Home - Demotech - Technology, Materials &...
Transcript of Prefazione - Home - Demotech - Technology, Materials &...



1
Prefazione
Il progetto “Dolomiticert 2”, realizzato con la collaborazione della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Belluno, è
stato cofinanziato dalla Regione Veneto attraverso le risorse previste
dalla Legge Regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina delle aggregazioni
di filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e
produttivo locale”, del bando 2006.
Il progetto ha sviluppato azioni di interconnessione tra il Distretto
dell’occhialeria e specifici settori dell’industria, tra i quali quello
dell’orafo, favorendo l’implementazione del laboratorio di ricerca e
certificazione “Dolomiticert”.
La Camera di Commercio di Vicenza si è resa disponibile a canalizzare
la ricerca verso le aziende del settore orafo, consentendo di attuare la
sperimentazione su metalli preziosi, quali le leghe dell’oro, che trovano
impiego anche nella produzione di occhiali, nella ricerca di un design e
di un utilizzo dei materiali, sempre più innovativo.
La presente guida consente di riassumere i risultati della ricerca
scientifica svolta in collaborazione con il Laboratorio Saggio Metalli
Preziosi della Camera di Commercio I.A.A. di Vicenza e costituisce una
parte fondamentale delle attività di promozione dei risultati coordinate
con la Fondazione Giacomo Rumor - Centro Produttività Veneto (CPV).
Il progetto lancia una sinergia tra Certottica ed il settore orafo e getta le
basi per collaborazioni ed attività propulsive per l’economia veneta, tra
ricerca e innovazione.
2

3
Indice degli argomenti
Parte generale
Scopo del lavoro pag 09
Introduzione pag 09
Che cos’è il colore pag 11
La Codifica del Colore delle leghe d’oro pag 13
La Misura del Colore pag 17
Come Misurare il Colore pag 22
Lo Strumento pag 24
Parte sperimentale
Misurazioni pag 31
Conclusioni pag 36
Bibliografia pag 37
Appendice pag 39
4

5
Di che colore è il tuo gioiello?
Una guida per i produttori
6

7
Parte generale
8

9
Scopo del lavoro
Lo scopo del presente lavoro è quello di fornire una guida che dia
indicazioni e/o informazioni agli utenti per poter cominciare a muoversi
all’interno del mondo della colorimetria applicata alle leghe d’oro,
mentre non è quello di fornire uno strumento, un mezzo tecnico, per
risolvere tutte le problematiche connesse alla misura del colore delle
leghe d’oro. In altre parole, questo documento non è, e non vuole essere,
una pubblicazione scientifica dato che ne precluderebbe la ricettività e
digeribilità.
All’inizio di questo lavoro la cosa che più ci ha sorpreso è stata l’assenza
di quadri normativi e la carenza di pubblicazioni scientifiche. In tali
termini non è facile affrontare l’argomento in modo semplice ed
intuitivo, ma rafforza la necessità di una guida quale vuole essere questa
pubblicazione.
Introduzione
L’oro, fin dall’antichità, ha assunto un’importanza predominante per le
sue proprietà chimico fisiche, ma anche e soprattutto, per il suo colore. Il
suo colore giallo intenso e la possibilità di trovare il metallo in natura ha
attratto da subito l’uomo tanto da essere stato utilizzato indistintamente
in tutte le parti del mondo a partire dal lontano 3000 a.C.
D'altronde, tra le varie peculiarità dell’oro, vi è il fatto che esso, assieme
al rame, è il solo metallo colorato, che presenta un colore ben
riconoscibile dall’occhio umano. Un’altra caratteristica dell’oro è che le
sue leghe possono assumere colori diversi in funzione della quantità e
della tipologia degli alliganti.
Oggi sono disponibili differenti leghe d’oro colorate e vengono fatti
grossi investimenti per aumentare la disponibilità di variazioni
cromatiche, quali il rosso, il rosa (o rosé), le diverse sfumature di giallo e
il verde, fino ad arrivare a quei colori inusuali, quali il viola, il nero, il
marrone e il blu. Si vengono così a creare delle nuove leghe d’oro, che
10
consentono la creazione di oggetti di gioielleria originali e innovativi.
Fino ad ora, la caratterizzazione del colore delle leghe utilizzate in
oreficeria è sempre stata demandata al puro riconoscimento visivo, dove
variabile influente è sempre stata ovviamente l’esperienza dell’operatore.
Al giorno d’oggi, vi può essere la necessità di fornire prodotti con
caratteristiche ottiche riproducibili in un contesto di rintracciabilità e
standardizzazione (sinonimo di riproducibilità). In tale contesto, la
semplice caratterizzazione visiva può non bastare, rendendo necessaria
una caratterizzazione oggettiva che sia unanimemente riconosciuta tra i
contraenti.
Il mercato richiede oramai al fornitore una costanza di qualità e una
caratterizzazione oggettiva degli attributi fisici, del materiale utilizzato
nella produzione, anche artigianale. Tra questi attributi senza dubbio il
colore è uno di quelli che più caratterizza l'aspetto del prodotto orafo e
una sua specificazione che non sia ridotta alla sola sensazione visiva è
sempre più richiesta in ambito internazionale.
Come già anticipato, attualmente non vi sono normative e/o regolamenti
internazionali comunemente accettati per il settore orafo che agevolino
l’operatore, caratterizzando, o meglio codificando con un linguaggio
comune, il colore delle leghe d’oro utilizzabili.
In questa guida si cercherà di spiegare come attualmente viene affrontato
il problema della codificazione del colore delle leghe d’oro e quelli che
sono i principali strumenti analitici per la loro definizione. Non si entrerà
comunque nel dettaglio delle procedure analitiche, data la complessità
della materia, ma si daranno tutti gli strumenti necessari per poter
affrontare e/o approfondire la materia a chi lo desideri.

11
Che cos’è il colore
L'occhio umano consente di riconoscere una varietà di colori grazie alla
presenza di cellule nervose fotorecettrici; i coni, concentrati sulla retina
dell’occhio umano, sono di tre tipi ognuno dei quali è sensibile ad uno
dei tre colori primari: rosso (R, “red”), verde (G, “green”) e blu (B,
“blue”).
I segnali nervosi che ne derivano sono, tramite una serie intermedia di
trasduzioni ed elaborazioni da parte del sistema nervoso oculare e del
cervello, tradotti in segnali elettrici in modulazione di ampiezza, che
vengono trasmessi al cervello lungo il nervo ottico e “percepiti” dallo
stesso come colori.
I fotoni e le frequenze associate che giungono all'occhio costituiscono lo
stimolo di colore. Ogni singolo fotone raggiunge uno dei fotorecettori
della retina (un bastoncello, oppure un cono) dal quale può essere o non
essere assorbito. La risposta di ogni tipo di cono è proporzionale
all'intensità della luce che lo colpisce solo entro certi limiti: c’è un limite
inferiore, al di sotto del quale il cono non è più sensibile (soglia di
sensibilità) che non è la stessa per i tre tipi di coni (il blu ha la soglia più
bassa) e c'è un limite superiore (soglia di saturazione), al di sopra della
quale la risposta è sempre la stessa. La probabilità che un tipo di
fotorecettore assorba un fotone dipende dal tipo di fotorecettore e dalla
frequenza del fotone.
Come risultato dell'assorbimento, ogni fotoricettore genera un segnale
elettrico, proporzionale al numeri di fotoni assorbiti. Gli esperimenti
mostrano che i segnali generati dai tre coni L, M e S sono direttamente
collegati con la sensazione di colore, e sono detti segnali di tristimolo.
La capacità di distinguere i vari colori e di vederli uguali a come li vede
la maggior parte dei soggetti umani deriva dalla costanza delle
proporzioni numeriche tra i tre tipi di coni della retina tra soggetto e
soggetto.
La luce, vale a dire la radiazione elettromagnetica visibile che incide
sulla retina, è composta da varie componenti monocromatiche.
Il fatto che percepiamo un oggetto come di colore rosso piuttosto che
giallo, oppure verde, dipende dalla frazione di ciascuno dei tre tipi di
coni che viene attivata dalla radiazione elettromagnetica che incide sulla
12
retina.
Ciascuna di queste componenti, quando visibile, produce una sensazione
pura di colore. La combinazione di queste componenti, pure presenti in
una radiazione luminosa policromatica, produce una sensazione di colore
specifica ma in generale non pura. Ad ogni radiazione policromatica
corrisponde un colore percepito.
A un colore può corrispondere in generale più di una radiazione
policromatica, ossia possiamo percepire il medesimo colore anche se le
sorgenti luminose hanno una distribuzione policromatica differente
(metamerismo). In generale un cambio di sorgente luminosa comporta un
cambio di percezione del colore dell'oggetto illuminato.
I colori possono essere classificati sulla base della tinta (rosso, verde,
giallo, ecc.) e sulla base della loro saturazione (rosso, rosa).
I cosiddetti colori neutri, ossia il bianco, il nero e il grigio, corrispondono
a condizioni estreme di percezione del colore. Un oggetto è percepito di
colore nero per il motivo che, rispetto al resto dell'ambiente, riflette una
quantità di luce non percepibile a livello sensoriale dal nostro occhio. Un
oggetto appare di colore bianco perché riflette quella particolare luce
ambientale stimolando sensorialmente in maniera identica i tre tipi di
coni nella retina. Il grigio rappresenta una classe di colori neutri che
forniscono ciascuno una sensazione per certi versi intermedia tra quella
del bianco e quella del nero.
Il colore di un oggetto è dovuto principalmente alla radiazione che esso
ci fa pervenire tramite la riflessione e alla distribuzione cromatica della
sorgente che lo illumina.
La sensazione psicofisica del colore può essere influenzata infatti, oltre
che dal colore dell'oggetto, anche dalla sua estensione e dal colore degli
oggetti immediatamente circostanti l'oggetto medesimo (contrasto).
Le vernici e le pitture sono sostanze chimiche che vengono utilizzate per
cambiare il colore degli oggetti. Tali sostanze presentano delle spiccate
reazioni fisico-chimiche di assorbimento o riflessione delle varie
componenti cromatiche della luce. Combinazioni di vernici possono
fornire praticamente un numero illimitato di colori. I metalli
generalmente non presentano colori spiccati, hanno in effetti una scarsa
saturazione in quanto tendono a riflettere pressoché tutta la radiazione
visibile in maniera indifferente rispetto alle varie componenti cromatiche.

13
La Codifica del Colore delle leghe d’oro
Fin dal passato si è cercato di definire e codificare i colori delle leghe
d’oro.
Il problema è stato affrontato in diversi modi ma principalmente ci si è
affidati al confronto visivo con campioni di riferimento standard.
Quando si fanno valutazioni visive di un colore bisogna ricordarsi che:
- la percezione del colore è soggettiva, cioè è strettamente legata a
chi esegue la valutazione;
- la percezione del colore è correlata alla sorgente che illumina il
campione: variando la sorgente luminosa si può avere una
percezione diversa del colore;
- la percezione del colore è influenzata dalla posizione di
osservazione: cambiando l’angolo di osservazione di un oggetto,
specialmente quando l’oggetto è traslucido, come i metalli, si può
avere una percezione diversa del colore;
- la percezione del colore è influenzata dallo sfondo, facendo
percepire un colore più o meno intenso in funzione del contrasto
con lo sfondo (contrasto).
La luce diurna è la sorgente luminosa preferibile per l’analisi visiva e può
essere considerata neutrale. In particolare è preferibile, per condizioni
standard, osservare un oggetto con la luce diurna (a mezzogiorno) riflessa
da nord (l’osservatore si direziona verso il nord). L’angolo di
osservazione raccomandato è di 45 e lo sfondo deve essere grigio, nero o
bianco.
Uno dei primi esempi di codifica del colore delle leghe d’oro è quanto
fatto, nei primi decenni del secolo scorso, nei laboratori della Degussa a
Pforzheim. In tali laboratori furono preparate 1089 diverse leghe d’oro,
che coprivano tutto l’intervallo di composizione del sistema ternario oro-
argento-rame, per ognuna di queste 1089 leghe fu prodotta una lamina a
forma di triangolo equilatero successivamente assemblati in un grande
triangolo con un metro di lato. Sfortunatamente questa tavola di colori
del sistema ternario delle leghe oro-argento-rame andò distrutta durante
la seconda guerra mondiale. Questo e altri lavori permisero comunque di
codificare le prime descrizioni dei colori delle leghe d’oro e di
sensibilizzare gli operatori in proposito. La limitazione di questi lavori
era che la colorimetria (la scienza della misura dei colori) era ancora agli
14
albori e non permetteva una discriminazione oggettiva di tali leghe
limitando quindi gli operatori alla sola valutazione visiva.
Lo sforzo di arrivare comunque a codificare i colori delle leghe d’oro
portò allo sviluppo di standard che si basavano sulla tecnica del semplice
confronto dei campioni.
Una delle norme più note, applicata in modo estensivo, fu la norma
tedesca DIN 8238 del 1966, che era un’estensione di una vecchia norma
applicata dell’industria svizzera degli orologi.
Questa norma si basa su una serie di leghe d’oro standard a 14 e 18 carati
che garantiscono un intervallo di colori dal rosso al bianco fino al verde e
giallo (esempio in tabella 1). La conformità dei campioni a questi colori
standard avviene attraverso il confronto con campioni di prova. Questo
metodo di valutazione del colore delle leghe d’oro fu molto comune in
Germania, Francia e Svizzera, tanto che, sebbene lo standard sia stato
ritirato, si trovano ancora suoi riferimenti in letteratura.
Il confronto visivo con campioni standard ha il vantaggio della semplicità
e convenienza, ma resta un metodo qualitativo, impreciso, altamente
soggettivo e non fornisce basi per giudicare colori al di fuori i campioni
standard arbitrari.
Codice colore Descrizione colore
1N-14 Giallo pallido – 14 carati
2N Giallo pallido – 18 carati
3N Giallo
4N Rosa
5N Rosso
0N Giallo-Verde
8N Bianco
Tab. 1 colori standard adottati per le casse d’orologio
Successivamente è stata implementata la norma ISO 8654 “Colours of
gold alloys – Definition, range of colours and designation” (attualmente è
l’unica norma tecnica internazionale di applicazione volontaria esistente)
la cui pubblicazione risale al 1987 e da allora non ha avuto revisioni.
Tale norma definisce (classifica) un numero limitato di sei colori,
codificati da 0 N a 5 N (vedere tabella 2). Nello scopo della norma ISO,
l’intervallo di colori era stato implementato per permettere al fabbricante

15
di limitare lo stock di differenti colori che è obbligato a tenere e di
permettere all’acquirente di definire i suoi requisiti con precisione
facendo riferimento ai codici colore riportati senza accompagnare
l’ordine con un campione colore. A differenza della norma DIN, la
norma ISO definisce i codici colori fissando degli intervalli di coordinate
di cromaticità in modo tale che ognuno possa eventualmente verificare,
attraverso una valutazione quantitativa, i propri campioni di riferimento o
prodursi una gamma corrispondente di campioni colorimetri. La norma
ISO 8654 è stata recepita dal CEN che ne ha pubblicato la versione
europea EN 28654. In Italia esiste la versione in lingua italiana rilasciata
dall’UNI (UNI EN 28654) dal titolo “Colori delle leghe d'oro.
Definizione, gamma dei colori e designazione.” pubblicata nel 1994.
Designazione colore Descrizione colore
0 N Giallo-Verde
1 N Giallo pallido
2 N Giallo leggero
3 N Giallo
4 N Rosa
5 N Rosso Tab. 2 codici colore norma ISO 8654:1987
Attualmente vi sono diverse iniziative per meglio codificare il colore
delle leghe d’oro. Una delle iniziative più interessanti è stata attivata nel
2003 dalla MJSA e dalla World Gold Council per definire l’oro bianco.
Tale iniziativa aveva lo scopo di definire come misurare il colore delle
leghe d’oro bianco e riportarne il valore in un singolo parametro
numerico facile da capire con lo scopo ultimo di pubblicare una serie di
norme di applicazione volontaria che permettano la categorizzazione di
tali leghe in relazione alla loro “bianchezza” e alla loro necessità di
essere rivestite dal rodio. Tale sistema deve permettere di fornire un
singolo valore per permettere una facile comunicazione del colore anche
quando il campione non viene fornito.
I lavori hanno concluso che l’indice di giallo (norma ASTM D1925 “Test
Method for Yellowness Index of Plastics” (ritirata nel 1995) definito
dalle coordinate di colore X, Y e Z (tristimoli), permette di definire dei
gradi numerici per identificare le leghe d’oro bianche. Ciò ha portato alla
pubblicazione di una guida per l’industria della bianchezza dell’oro
bianco. Secondo quanto riportato, per essere chiamato oro bianco, una
16
lega deve avere un valore di indice di giallo di 32.0 o inferiore. Inoltre
sono stati definiti tre gradi di oro bianco, come:
- Grado 1 – un buon colore bianco che non necessita di
rivestimento galvanico di rodio;
- Grado 2 – un ragionevole bianco dove il rivestimento galvanico
di rodio è opzionale;
- Grado 3 – un non buon bianco dove il rivestimento galvanico di
rodio è richiesto.
Il comitato per il riferimenti per il colore della MJSA (Manufacturing
Jewellers & Silversmiths of America) ha diffuso una serie di campioni di
riferimento per il colore dell’oro basata sul sistema CIELAB. Questo
sistema offre il vantaggio di descrivere il colore con dati matematici,
senza l’intervento dell’occhio umano e fa parte degli standard sul colore
e sull’aspetto del ASTM (American Society for Testing and Materials).
Quanto sopra è solo un esempio degli sforzi compiuti per razionalizzare e
codificare il colore delle leghe d’oro. D'altronde come si può vedere, allo
stato attuale non vi è un sistema univocamente accettato di facile
applicazione che permetta di differenziare e distinguere i diversi colori
delle leghe d’oro conosciute e di codificare i colori che avranno le nuove
leghe d’oro.

17
La Misura del Colore
Come visto in precedenza, il colore può essere valutato in termini
soggettivi ma se l'accuratezza richiesta nella valutazione va oltre la
capacità di discriminazione visiva umana allora è necessario mettere in
campo degli strumenti analitici appropriati.
L’unico sistema ad oggi che permetta di differenziare in modo univoco
ed oggettivo il colore delle leghe d’oro sono le misure colorimetriche.
Purtroppo, come meglio descritto sotto, tale tipo di misure non sono di
semplice implementazione, dato che richiedono l’acquisizione di
strumentazione professionale e la conoscenza delle funzioni matematiche
alla base del principio. Le misure colorimentriche sono inoltre limitate
dal fatto che necessitano di una discreta superficie di misura impedendo
così di fatto il loro utilizzo ai prodotti finiti di piccole dimensioni o forme
complesse, ma più semplicemente alle leghe non lavorate o semilavorate
opportunamente lucidate e pulite.
Per poter misurare una cosa, questa deve essere prima definita. Tale
concetto vale a maggior ragione per il colore, date che esso è una
caratteristica soggettiva. Non essendo una caratteristica propria di un
oggetto, si è sentita la necessità di trovare una o più grandezze che
potessero renderlo misurabile in modo standardizzato, per poterlo
classificare e riprodurre. Infatti il colore che percepisce l’uomo, è diverso
da quello che percepiscono gli animali, dato che vedono in modo
differente e hanno occhi sensibili a lunghezze d'onda diverse da quelle
che percepisce l’uomo (ad esempio alcuni insetti sono sensibili agli
ultravioletti).
Il colore può essere codificato in vari modi e le modalità sono
testimoniate dall'evoluzione storica dei documenti pubblicati da
organizzazioni internazionali e non volte allo studio dei vari aspetti
metodologici e applicativi del colore.
Il sistema Munsell (sviluppato dall’artista americano Albert Henry
Munsell) è stato il primo sistema per comunicare dati sul colore che
fossero facilmente comprensibili. Il sistema Munsell, che fu sviluppato
nel 1898 con la creazione della sua sfera di colore, o albero, prese la sua
forma definitiva con la pubblicazione nel 1905 del libro “A Color
Notation”. Questo lavoro fu poi ristampato diverse volte fino a diventare
uno standard per la colorimetria. Con tale sistema il colore è descritto con
18
un codice alfanumerico, in particolare da: “colore”, “croma” e “valore”.
Munsell definì il colore come "la qualità con cui noi distinguiamo un
colore da un’altro." Munsel selezionò cinque colori principali: rosso,
giallo, verde, blu, and viola; e cinque colori intermedi: giallo-rosso,
verde-giallo, blu-verde, viola-blu e rosso-viola. Il “croma” indica
l’intensità del colore, come distanza da un asse bianco-grigio-nero ed il
“valore” indica la posizione sulla scala bianco-grigio-nero. Il sistema
Munsell si affida ancora all’occhio umano ed i colori sono descritti
confrontandoli visivamente con dei campioni di colore standard, in modo
da trovare quello più somigliante.
Gli sforzi maggiori per definire in modo univoco la misura del colore,
sono stati compiuti da organismi internazionali come la CIE
(Commissione Internazionale sull'Illuminazione) e la OSA (Optical
Society of America). La CIE ha compiuto lavori di rilievo verso la
creazione di scale e spazi colorimetrici entro i quali sia possibile eseguire
misurazioni che prescindano dalla soggettività e che permettano di
eseguire dei calcoli su delle grandezze definite. Gli spazi colorimetrici
creati non sono lineari, come prevedibile, poiché dipendono da variabili
particolari come la curva di risposta spettrale dei fotorecettori sensibili al
colore posti sulla retina dell'occhio e dall'interpretazione del cervello. La
OSA ha eseguito importanti ricerche sulla non linearità di questi spazi e
sulla costruzione di campioni indeformabili di colore definito.
Il sistema di misura, riconosciuto internazionalmente è stato sviluppato
dalla CIE. Tale sistema ha subito delle modifiche nel tempo e
attualmente ve ne sono di diverse versioni. Le diverse versioni sono
correlate al campo di applicazione per cui sono state sviluppate.
Le più comuni varianti di valutazione colorimetrica CIE sono quelle
denominate “CIE Color Space” e “CIElab”. Tali sistemi di misura sono
ormai considerati il riferimento internazionale e quindi è necessario
riferirsi ad esse quando si parla di colore in termini assoluti o vi è la
necessità dello scambi di informazioni sul colore di un oggetto che siano
correttamente (accuratamente) interpretabili tra due o più parti.
In definitiva, il lavoro fatto dalla CIE, è stato quello di sviluppare un
sistema che correlasse le interazioni tra una sorgente luminosa, l’oggetto
di cui si vuole definire il colore e l’osservatore.
Per fare ciò si è cercato di standardizzare i seguenti parametri:
- Illuminamento;

19
- condizioni dell’osservatore;
- calcolo dei valori di tristimolo X, Y e Z. (I valori di tristimolo
descrivono (simulano) la risposta da parte del sistema visivo
umano ad uno specifico colore);
- conversione dei valori di tristimolo in valori di coordinate di
cromaticità x, y e Y più facilmente comprensibili. Tali coordinate
cromatiche vengono generalmente rappresentate su un grafico
riferite come “spazio colore” (color space).
I valori di tristimolo vengono convertiti nelle coordinate di cromaticità
perché non sono un mezzo pratico per descrivere il colore di un oggetto,
ma piuttosto un mezzo per determinare se, confrontando due colori, essi
hanno gli stessi valori di tristimolo.
Sostanzialmente si somma le risposte di stimolo di colore e le si
normalizza alle curve spettrali di risposta dei fotorecettori sensibili al
colore. Come riferimento vengono utilizzate le curve spettrali codificate
dalla CIE chiamate funzioni colorimetriche. Le aree sottese dalle tre
curve che si ottengono alla fine del procedimento danno origine a tre
valori che sono appunto le coordinate di tristimolo X, Y e Z legate alle
coordinate di cromaticità x ed y da relazioni lineari. I passaggi da uno
spazio di colore ad un altro sono dati da determinate relazioni di
trasformazione di coordinate.
Le coordinate di cromaticità x e y vengono riferite a tonalità e croma. La
terza coordinata Y è la luminosità (vivacità) del colore.
Il diagramma di cromaticità rappresenta i colori meno saturi, che si
approssimano alla neutralità (bianco, nero e grigio), al centro, mentre
verso i bordi vi sono i livelli di saturazione più elevati.
Una raffinazione di questo lavoro, portò nel 1976 al CEI Uniform Color
Space. Questo metodo convertì i valori di tristimolo in un set di
coordinate di cromaticità alternative definite come uI e v
I. Il vantaggio di
questo sistema stava nel fatto che la forma dello “spazio di colore”
risultava equamente distribuito per i diversi colori.
Un alternativo e ormai molto diffuso metodo per definire i colori è il
sistema CIElab Color System. Questo sistema è basato sulla premessa
arbitraria che ci sono tre differenti tipi di ricettori negli occhi (rosso, blu
e verde). Quando questi ricettori vengono eccitati, il cervello interpreta
questi tre segnali come segue; chiaro o scuro, rosso o verde e giallo o blu.
20
Le coordinate definite per rappresentare questi segnali sono:
L*
= luminosità (nero se il valore è 0 e bianco se il valore è 100);
a* = intensità delle componenti verdi e rossa (colorazione rossa se il
valore è positivo, colorazione verde se il valore è negativo);
b*
= intensità delle componenti blu e gialla (colorazione gialla se il valore
è positivo, colorazione blu se il valore è negativo).
La grandezza dei singoli valori ne descrive la “forza” (predominanza)
relativa di quei colori. In questo modo, quando le coordinate a* e b
* si
avvicinano allo zero, il colore diventa neutro (bianco, nero e grigio),
mentre quando i valori di a* e di b
* aumentano la saturazione del colore
aumenta. (Fig. 1)
Il CIElab e lo “spazio di colore” più completo definito dal CIE. Esso
descrive tutti i colori che l’occhio umano può vedere e è stato creato per
essere utilizzato come modello di riferimento da utilizzare.
La relazione non lineare fra L*, a
* e b
* è stata intesa per mimare la
risposta non lineare dell’occhio. Tant’è che, variazioni uniformi nelle
componenti di L*, a
* e b
* nello “spazio di colore” corrispondono a
uniformi variazioni nella percezione del colore.

21
Fig. 1
Come già accennato, quando si vuole misurare un colore bisogna adottare
delle condizioni standard così da assicurare accuratezza e precisione. Ciò
significa utilizzare la stessa condizione di illuminazione, posizione di
osservazione e strumentazione.
Il CIE ha definito diverse tipologie di illuminanti standard che non sono
altro che sorgenti di luce che emettono una determinata intensità
luminosa per ogni specifica lunghezza d’onda.
Per quanto riguarda l’osservazione, si è cercato di fissare le dimensioni
della finestra di osservazione attraverso cui si osserva l’oggetto; questo si
traduce in un angolo di osservazione.
22
Come Misurare il Colore
La misurazione del colore ossia la misurazione degli indici cromatici
(coordinate cromatiche) richiede l'impiego di strumenti analitici accurati.
La soggettività dell'osservazione umana basata sul confronto tra
campione incognito e campione di riferimento è sostituita dalla
misurazione di grandezze fisiche dalle quali si ricavano gli indici
cromatici adeguati al contesto di valutazione colorimetrica in essere.
Gli strumenti di tipo colorimetrico si differenziano per la configurazione
geometrica di misurazione adottata. La guida CIE 15 “Colorimetry”
contempla varie configurazioni strumentali e la preferenza di una rispetto
all'altra è legata al criterio di valutazione del colore adottato. Nel caso dei
campioni di metallo con superficie lucida va sempre tenuto presente
l'elevata riflettività speculare e quindi la bassa saturazione cromatica, per
cui le configurazioni preferite saranno quelle nelle quali la luce riflessa
dal campione è fuori dall'angolo di rilevazione.
Il colore di un oggetto è visto come conseguenza del fatto che l'oggetto
riflette parte della luce ambientale quindi il fattore di riflessione
(spettrale), brevemente riflettanza (spettrale), è la grandezza da misurare
(misurabile) per poter ricavare le informazioni sul colore. La misurazione
della riflettanza è eseguita mediante spettrometri o spettrofotometri
corredati spesso con sfere integratrici per riprodurre le condizioni di
misurazione previste dalle norme.
Gli strumenti possono essere estesi e complessi da gestire oppure
compatti e di impiego relativamente facile. Esistono infatti strumenti da
un lato come gli spettrofotometri a doppio monocromatore ed ad elevato
intervallo di risposta fotometrica oppure gli ellissometri. D'altro canto
commercialmente sono disponibili strumenti portatili che consentono di
ricavare informazioni sui principali indici colorimetrici con misurazioni
della durata di solo alcuni secondi.
La differenza tra i due tipi di strumenti ovviamente è la versatilità di
impiego dei primi associata ad una maggiore accuratezza e la praticità
d'uso dei secondi a scapito di una scarsa versatilità.
Costruttivamente le componenti ottiche essenziali sono le medesime. Una
o più sorgenti radianti o luminose costituite generalmente da lampade ad
incandescenza oppure ad arco con emissioni spettrali rilevanti nel visibile
e/o nell'ultravioletto. Un dispositivo di dispersione della radiazione

23
costituito generalmente da uno o due monocromatori e rappresentati, nel
caso più semplice, negli strumenti portatili da un singolo reticolo
diffrattivo. Un sistema di collimazione della radiazione oppure di
illuminazione del campione a seconda che la misurazione sia effettuata
mediante un fascio collimato di direzione definita oppure mediante
radiazione diffusa da una sfera integratrice. Uno o più sensori sensibili
alla luce, quale un singolo sensore fotoconduttivo o fotovoltaico oppure
un sensore a multielementi sensibili (array, CCD). Infine, ma non meno
importante, un sistema di acquisizione ed elaborazione dei valori di
misura spettrali che fornisca come risultato finale i valori di misura degli
indici colorimetrici.
Gli spettrofotometri a doppio monocromatore hanno una risoluzione in
lunghezza d'onda che può arrivare a qualche centesimo di nanometro. Gli
spettrometri ad array generalmente hanno una risoluzione in lunghezza
d'onda dell'ordine del nanometro. Dal punto di vista colorimetrico è più
che sufficiente, per scopi pratici di confronto tra campioni, la risoluzione
del nanometro. Tuttavia si tenga presente che i calcoli colorimetrici si
basano su valori tabulati ad intervalli di 1 nanometro e che viene
raccomandato dalla CIE che l'ampiezza della banda passante (ossia
l'ampiezza dell'intervallo spettrale della radiazione che incide sul
campione durante la misurazione spettrale) non superi 1 nanometro in
tutto l'intervallo spettrale rilevante per i calcoli delle grandezze
colorimetriche. Queste condizioni nel caso di misurazioni in cui è
richiesta un elevata accuratezza possono rendere non sufficiente
l'impiego di uno strumento portatile e richiedere necessariamente
l'utilizzo di uno strumento più sofisticato.
Le condizioni geometriche di misurazione illuminazione/rilevazione
previste dalla CIE possono essere raggruppate in quattro tipi:
− (0/45): il campione è illuminato in direzione perpendicolare alla
superficie e la rilevazione della radiazione riflessa è effettuata in
direzione inclinata di 45 gradi rispetto alla perpendicolare.
− (45/0): il campione è illuminato lungo una direzione inclinata di 45
gradi rispetto alla perpendicolare alla superficie e la rilevazione è
eseguita perpendicolarmente.
− (d/0): il campione è illuminato da tutte le direzioni e la rilevazione è
eseguita lungo la perpendicolare.
− (0/d): il campione è illuminato dalla direzione perpendicolare alla
24
superficie e tutta la radiazione riflessa dal campione in qualsiasi
direzione è raccolta, sommata e misurata.
In pratica questi quattro tipi di configurazioni possono subire delle
leggere modifiche che possono riguardare la direzione dell'angolo di
incidenza e/o rilevazione e la totalità della radiazione impiegata
nell'illuminamento del campione o la totalità della radiazione riflessa
raccolta e misurata. La CIE tuttavia impone dei limiti sulle modifiche
apportabili agli angoli rispetto alle configurazioni ideali. Altre
imposizioni sulle condizioni di misurazione possono riguardare la
collocazione delle sorgenti e/o dei sensori rispetto alle loro reciproche
posizioni e rispetto alla posizione del campione.
Lo Strumento
La misurazione delle caratteristiche colorimetriche delle leghe preziose
può essere eseguita mediante la misurazione del fattore di riflessione.
Dal fattore di riflessione è possibile ottenere informazioni quantitative su
varie grandezze colorimetriche tra le quali:
L* - luminanza
a* - intensità della componente cromatiche verde/rossa
b* - intensità della componente cromatiche blu/gialla
C - croma
Queste informazioni dipendono strettamente dalla configurazione
adottata per la misurazione del fattore di riflessione. I parametri importati
per eseguire una misurazione comparabile con altri strumenti sono vari,
ma i più significativi sono gli angoli di illuminazione e di ricezione della
luce.
Infatti è ben noto che l'aspetto visivo in termini di brillantezza e di colore
dipendono dall'angolo sotto il quale il campione viene osservato e
dall'angolo di incidenza della luce che lo illumina.

25
Come detto nella precedente sessione, esistono varie configurazioni
strumentali di illuminazione/rilevazione1 che possono essere impiegate
per eseguire la misurazione della riflettanza. La scelta dipende
essenzialmente dalle proprietà riflettenti che si vogliono misurare, ad
esempio le proprietà di riflessione speculare oppure quella diffusa.
Uno strumento che soddisfi le raccomandazioni del documento CIE
15:2004 relative alle misurazioni a scopo colorimetrico richiede le
seguenti configurazioni geometriche di misurazione:
geometria di:8°
cioè con illuminazione diffusa del campione e misurazione della luce da
esso riflessa nella direzione a 8 gradi di inclinazione rispetto alla normale
alla superficie del campione e con componente riflessa speculare inclusa
nella misurazione.
geometria de:8°
simile alla precedente con la variante che la componente riflessa
speculare è esclusa dalla misurazione.
Lo strumento è composto dalle seguenti parti:
- sorgenti;
- sfera integratrice;
- spettrografo;
- sensori;
- ottica di collimazione;
- registratore dati.
La sorgente o le sorgenti in generale hanno lo scopo di illuminare il
campione con luce avente una sufficiente intensità a tutte le componenti
spettrali necessarie per le misurazioni colorimetriche. Le sorgenti
possono essere continue, come la classica lampada alogena, oppure
pulsate come le lampade allo Xeno. La scelta dipende da vari fattori quali
la stabilità di segnale oppure la possibilità di effettuare misurazioni anche
1 La norma CIE 15:2004 ritiene deprecabile l'uso del termine 'osservazione' (viewing)
inteso come atto di vedere la luce riflessa da un oggetto in un contesto di
misurazione. Il termine 'osservazione' è preferibile solamente per indicare l'atto
umano di osservare un oggetto illuminato nella medesima configurazione
geometrica di quella di misurazione.
26
in presenza di un fondo luminoso ambientale confrontabile o addirittura
superiore all'intensità della luce riflessa dal campione.
La sfera integratrice è spesso la componente essenziale dello strumento e
determina la geometria di misurazione. Come suggerisce il termine, essa
è costituita da una sfera rigida che ha lo scopo primario di raccogliere la
radiazione, in questo caso, riflessa dal campione. Il termine 'integrazione'
è sinonimo di “tutto” ovvero la sfera è considerata integrante quando
riesce a raccogliere “tutta” la radiazione riflessa. Ovviamente questa
condizione è una idealizzazione a cui tanto più ci si avvicina quanto
maggiore è il diametro della sfera integratrice. Una sfera però quanto più
è grande, tanto più tende ad assorbire la radiazione al suo interno in
quanto maggiore è la sua superficie e il numero di riflessioni. Diventa
allora importante avere una superficie interna altamente riflettente che
mantenga però nel contempo caratteristiche di diffusione della radiazione
le quali sono essenziali per una corretta integrazione. Ecco quindi che
generalmente le sfere integratrici presentano delle superfici interne
bianche e polverulente con coefficiente di riflessione prossimo all'unità.
Lo spettrografo è quella componente dello strumento dove la radiazione
viene scomposta nelle sue componenti cromatiche. Esso è costituito
generalmente negli strumenti portatili, oltre che da alcune componenti
ottiche ausiliarie, da un reticolo di diffrazione sul quale la luce incidendo
viene riflessa oppure trasmessa in più direzioni in funzione della sua
lunghezza d'onda proprio come accade quando la luce incide su un
prisma ottico.
La radiazione separata nelle sue componenti cromatiche viene rilevata da
un sensore il quale ha il compito di tradurre l'intensità della radiazione in
un segnale elettrico generalmente e auspicabilmente proporzionale. I
sensori possono essere a grandi linee classificati come fotoconduttori
oppure fotovoltaici. Quelli fotoconduttori hanno trovato recentemente
ampia applicazione soprattutto negli strumenti portatili dove compaiono
sotto forma di array di sensori al Silicio oppure CCD. Nel caso degli
array il vantaggio decisivo è la possibilità di evitare l'impiego di
monocromatori motorizzati per la selezione della lunghezza della
radiazione proveniente dal reticolo. In tal modo lo strumento diventa
oltre che estremamente compatto anche molto meno sensibile dal punto
di vista meccanico. L'uso degli array limita la risoluzione spettrale ma
per le misurazioni di tipo colorimetrico questo non costituisce una
limitazione a priori.

27
Le varie componenti descritte ovviamente non operano da sole dal punto
di vista ottico. Infatti quando il campione viene appoggiato alla parete
esterna della sfera per eseguire la misurazione del fattore di riflessione, la
luce della sorgente è collimata sulla sua superficie mediante delle
componenti ottiche quali lenti e specchi. Analogamente la radiazione
riflessa dal campione e raccolta dalla sfera viene “vista” dal reticolo
mediante un'altra ottica di collimazione. Infine la radiazione dispersa dal
reticolo viene convogliata sul sensore tramite altre componenti ottiche.
Le informazioni relative alle varie grandezze colorimetriche misurate
possono essere ottenute a partire dai valori di misura del fattore di
riflessione alle singole lunghezze d'onda. Questi singoli valori di misura
sono ottenuti dalla lettura del segnale corrispondente a ciascun singolo
elemento del sensore ad array. Ovviamente tutto questo è fattibile grazie
alla possibilità di memorizzare i singoli valori di misura del fattore di
riflessione spettrale. Da questi dati memorizzati si possono calcolare
quindi i valori di misura delle grandezze colorimetriche. Generalmente il
processo di memorizzazione e di calcolo viene gestito negli strumenti
portatili da hardware e software appositi e fornito come risultato su
display integrati nello strumento.
28

29
Parte sperimentale
30

31
Misurazioni
Lo scopo delle misurazioni colorimetriche è quello di mostrare come al
variare del titolo della lega la variazione del suo colore può essere
quantificata mediante l'impiego di opportune grandezze colorimetriche.
Le misurazioni sono state eseguite su campioni di metalli preziosi
costituiti da dischi di leghe d'oro e di leghe d'argento di differente
composizione nominale.
Lo strumento utilizzato è dotato di una sfera integratrice da 52 mm con la
possibilità di effettuare misurazioni nelle due configurazioni di:8° e
de:8°. L'intervallo di misurazione del fattore di riflessione relativo
spettrale è da 360 a 740 nm, con una regione di indagine del campione di
forma circolare di diametro 8 mm. Il sistema di misurazione si basa su un
reticolo diffrattivo e un sensore ad array a 40 elementi.
La fase sperimentale del progetto è stata realizzata con la collaborazione
del Laboratorio Saggio Metalli Preziosi della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza.
La sessione di misurazioni prevede una calibrazione iniziale rispetto ad
un campione di riferimento “nero” ed una rispetto ad un campione
“bianco” in modo da fissare due punti sulla scala del fattore di riflessione
relativo.Le misurazioni sono state eseguite con la configurazione di:8°.
Data l'elevata riflettività dei campioni, le prove eseguite con la
configurazione de:8° non hanno dati risultati significativi.
Le coordinate colorimetriche utilizzate sono le CIE L* a* b* e le CIE x y.
La Tabella 1 riportata i risultati ottenuti per le coordinate L* a* b* per
l'illuminante D65 nel caso di campioni di tre leghe d'oro giallo di titolo
differente. La tabella riporta anche la composizione nominale nei cinque
elementi oro, argento, rame, zinco e nichel.
Campione L*(D65) a*(D65) b*(D65) Au Ag Cu Zn Ni
11 Au 375Y 86.8 4.41 22.5 375.0 93.8 437.3 93.8 0.0
20 Au 585Y 88.3 3.79 23.1 585.0 83.0 269.4 62.3 0.0
29 Au 750Y 87.4 4.64 29.3 750.0 141.3 99.9 8.8 0.0
Tabella 1
32
La Tabella 2 riporta risultati analoghi per delle leghe di oro bianco
mentre la Tabella 3 per delle leghe d'oro rosso.
Campione L*(D65) a*(D65) b*(D65) Au Ag Cu Zn Ni
08 Au 375W 83.7 2.19 11.1 375.0 0.0 423.4 75.0 125.0
17 Au 585W 84.1 2.91 13.3 585.0 0.0 281.2 49.8 83.0
26 Au 750W 82.4 5.38 20.8 750.0 0.0 169.4 30.0 50.0
Tabella 2
Campione L*(D65) a*(D65) b*(D65) Au Ag Cu Zn Ni
14 Au 375R 81.2 11.6 18.9 375.0 25.0 578.1 18.8 0.0
23 Au 585R 74.5 13.2 16.9 585.0 16.6 383.9 12.5 0.0
32 Au 750R 83.6 10.8 21.7 750.0 10.0 231.3 7.5 0.0
Tabella 3
Come si può vedere le due coordinate cromatiche CIE a* e b*
consentono di distinguere i vari tipi di lega sia relativamente al colore, sia
relativamente al titolo nell'ambito di un medesimo colore.
La Tabella 4 riporta invece i risultati ottenuti per una coppia di leghe
d'argento di titolo differente e anche in questo caso è possibile la loro
discriminazione sulla base delle coordinate CIE a* e b*. Si osservi
l'effetto lineare della maggiore concentrazione di rame sulla coordinata
a* (giallo-blu) mentre la b* (rosso-verde) manifesta una saturazione
cromatica.
Campione L*(D65) a*(D65) b*(D65) Au Ag Cu Zn Ni
02 Ag 800 89.2 1.10 11.4 0.0 800.0 128.0 71.4 0.0
05 Ag 925 90.8 0.51 10.2 0.0 925.0 48.0 26.8 0.0
Tabella 4

33
Le misure per le coordinate CIE x y, sempre relative all'illuminate D65,
sono riportate tutte in Tabella 5. Come si può osservare la distinzione
delle varie leghe sia tra colori nominali che tra titoli è generalmente
ancora fattibile anche se con qualche eccezione notevole (cfr. ad esempio
i dati della terza e quarta riga relativi ad oro giallo di differente titolo).
Campione x(D65) y(D65)
02 Ag 800 0.337 0.352
05 Ag 925 0.333 0.350
11 Au 375Y 0.363 0.372
20 Au 585Y 0.363 0.373
29 Au 750Y 0.376 0.384
08 Au 375W 0.339 0.352
17 Au 585W 0.344 0.356
26 Au 750W 0.363 0.369
14 Au 375R 0.370 0.360
23 Au 585R 0.373 0.356
32 Au 750R 0.373 0.365
Tabella 5
Ricordiamo che la norma ISO 8654:1987 (E) – Colours of gold alloys –
Definition, range of colours and designation - specifica un intervallo di
colori per striscioline d'oro da utilizzarsi come campioni di confronto
nelle transazioni tra produtori ed acquirenti.
La norma utilizza come illuminate di riferimento il D65 e come
coordinate cromatiche le CIE x y tuttavia riconosce l'uso delle coordinate
CIE L* a* b* per scopi speciali o nel campo della standardizzazione
internazionale.
La Figura 1 mostra le coordinate cromatiche CIE L*a*b* delle tre leghe
d'oro con titolo nominale 750.
34
Figura 1
La Figura 2 confronta invece le medesime coordinate ma per le due
leghe d'argento.
Figura 2

35
La Figura 3 mostra le curve del fattore di riflessione relativo spettrale per
le due leghe d'argento assieme alle tre d'oro con titolo 750 mentre la
Figura 4 mostra invece il corrispondente grafico CIE xy.
Figura 3
Figura 4
36
Conclusioni
In conclusione i campioni, esaminati che costituiscono una campionatura
minima ma significativa in termini di titolo e colore di leghe preziose in
oro e argento, possono essere caratterizzati con elevata capacità
discriminante mediante misurazioni di tipo colorimetrico. In particolare
le misurazioni sui campioni hanno evidenziato la bontà delle grandezze
colorimetriche CIE L* a* b* come indici discriminanti sia di colore a
parità di titolo, sia di titolo a parità di colore nominale del metallo
prezioso.

37
Bibliografia
Riferimenti
K.E. Saeger and J. Rodies, The Color of Gold and its Alloys – The
Mechanism of Variation in Optical Property;
E. Roberts and K. Clarke, The Colour Characteristics of Gold Alloys,
Gold Bulletin 1979 12(1);
R. German, The Colour of Gold-Silver-Copper Alloys, Gold Bulletin
1980 13(3);
T. Shiraishi, K. Hisatsune, Y. Tanaka, E. Miura and Y. Takuma, Optical
Properties of Au-Pt and Au-Pt-In Alloys, Gold Bulletin 2001 34(4)
C.V. Corti, White Gold Colour Defined, Gold Bulletin 2005 38/1;
S. Henderson and D Manchandra, White Gold Alloys: Colour
measurement and Grading, Gold Bulletin 2005 38/2;
C. W. Corti, Blue, Black and Purple! the Special Colours of Gold,
International Jewellery Symposium, St Petersburg, 2006;
C. Cretu and Elma Van Der Lingen, Coloured Gold Alloys, Gold Bulletin
1999 32(4);
G. Wyszecki and W.S. Stiles, Color Science: Concepts and Methods,
Quantitative Data and Formulae, Wiley, New York 1982;
38

39
Appendice
40
Il ruolo dei soggetti coinvolti
La Camera di Commercio I.A.A. di Belluno ha aderito all’iniziativa
Dolomiticert 2 promuovendo il progetto alla Regione Veneto.
Certottica S.c.a.r.l. Istituto Italiano per la certificazione dei prodotti
ottici, ha realizzato la presente ricerca del settore orafo e prevista nel
progetto denominato “Dolomiticert 2”.
Il Laboratorio Saggio Metalli Preziosi della Camera di Commercio
I.A.A. di Vicenza ha fornito le materie prime per la parte sperimentale
della ricerca e collaborato direttamente nel coordinamento delle attività
previste.
La Fondazione Giacomo Rumor - Centro Produttività Veneto (CPV)
ha contribuito alla gestione delle attività di promozione e divulgazione
dei risultati del progetto denominato “Dolomiticert 2” per la parte
dedicata al settore dell’orafo.
Attraverso www.orotech.it, portale tecnologico per il settore orafo gestito
dal CPV, vengono evidenziati e diffusi i risultati del presente progetto.

41
Certottica S.c.a.r.l.
Certottica S.c.a.r.l. è l'Istituto Italiano di Certificazione dei prodotti
ottici autorizzato al rilascio di attestati di conformità per la certificazione
CE di prodotti ai sensi degli articoli 10 e 11 parte A della direttiva
89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale per gli occhi
e dei dispositivi di protezione totali e parziali del viso.
Nato in armonia con il territorio e la sua storia, che racconta l’origine e lo
sviluppo degli occhiali, l’Istituto è cresciuto nel tempo offrendo un ampio
e qualificato ventaglio di servizi. L’elevata professionalità fa di
Certottica un importante supporto alle aziende, sia nazionali sia
internazionali, nell’analisi di prodotti e processi produttivi come previsto
dalle direttive europee e dagli standard internazionali, rilasciando
rapporti di prova idonei a certificarne la conformità.
Certottica è notificato a Bruxelles con numero identificativo 0530 quale
Istituto di Certificazione riconosciuto autorizzato dal Ministero dello
Sviluppo Economico e dal Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale al rilascio di attestati di conformità per la certificazione CE di
dispositivi di protezione per gli occhi e di protezione totale e parziale del
viso iscritto all’Albo dei laboratori di ricerca altamente qualificati con
riconoscimento del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica accreditata dalla Regione Veneto come ente di formazione
continua e formazione superiore e certificata UNI EN ISO 9001:2000 per
la progettazione, gestione e rendicontazione di corsi formativi
Certottica ha, inoltre, firmato una convenzione con la Direzione Generale
per l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori del
Ministero dello Sviluppo Economico, l’Agenzia delle Dogane e ANFAO,
per tutelare salute e sicurezza dei consumatori, salvaguardare le imprese
che operano correttamente sul mercato e svolgere un’attività di vigilanza
del mercato nell’ambito del settore ottico.
Aree di intervento: certificazione – formazione – normazione - ricerca
& innovazione
Ulteriori informazioni sul sito www.certottica.it .
42
Il Laboratorio Saggio Metalli Preziosi
Il Laboratorio di Saggio dei Metalli Preziosi è stato istituito nel 1966 su
richiesta delle Associazioni di Categoria del settore orafo.
In ottemperanza alla recente Normativa sulla disciplina dei titoli e dei
marchi di identificazione dei metalli preziosi - Decreto legislativo n° 251
del 22 maggio 1999 - è abilitato alla certificazione di conformità del
titolo dei metalli preziosi e di controllo sia sul mercato interno che per
l’esportazione.
Il Laboratorio rilascia Rapporti di Prova e Certificati di Conformità che
hanno validità giuridica, riconosciuti dagli Organi di Stato, dalle Dogane,
da Istituzioni pubbliche e private.
Nel settore dei metalli preziosi fornisce alle aziende, agli operatori del
settore e al privato cittadino un servizio d’analisi e di verifica del titolo di
Oro, Argento, Platino e Palladio sottoforma di materia prima,
semilavorati, prodotto finito e dei residui della lavorazione.
In conformità alle prescrizioni della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 : 2005 e
ai criteri applicabili delle Norme UNI EN ISO serie 9000 , il Laboratorio è
Accreditato SINAL.
A livello tecnico scientifico, il Laboratorio collabora con il competente
Ministero delle Attività Produttive, con le Associazioni di Categoria del
Settore, con Istituti di normazione e di ricerca (UNI e C.N.R.), con
l’ASSICOR e con il Comitato Tecnico Europeo di Normazione.
Ulteriori informazioni sul sito www.vi.camcom.it .

43
Il Centro Produttività Veneto
La Fondazione Giacomo Rumor - Centro Produttività Veneto (CPV) è
attiva da oltre 50 anni svolgendo attività di formazione, informazione e
assistenza all’innovazione tecnologica ed alla creazione di nuove
imprese. Come braccio operativo per l’Innovazione del sistema camerale,
realizza concretamente il Progetto Innovazione che la Camera di
Commercio IAA di Vicenza promuove nel territorio vicentino. L’Area
Innovazione del CPV, propone e fornisce alle PMI un modello di risposte
ai loro specifici fabbisogni ed una concreta proposta di servizi sviluppati
ad hoc sui temi della proprietà intellettuale, dei materiali innovativi e
del trasferimento tecnologico.
Tra i servizi proposti alle aziende: • Servizi PatLib (informazioni e consulenze sulla Proprietà Intellettuale).
• Servizio Brevetti Info Express (BIEX).
• Irene Access Point - Irc Network: servizio finalizzato all’incontro tra domande e le
offerte di tecnologia.
• MaTech® Point Vicenza: servizio sui materiali e le tecnologie innovative.
• Servizio di formazione sul Design Industriale.
• Servizio di formazione e training per l’industria.
• I portali di informazione tecnologica: www.vicenzalabnet.it, www.orotech.it,
www.demotech.it.
• Informazioni sui bandi regionali, nazionali e comunitari in tema di innovazione.
Il portale tecnologico del settore orafo
Nello specifico per il settore orafo, si evidenzia l’importante azione
svolta attraverso il portale www.orotech.it.
Nato come uno degli obiettivi programmatici del progetto
“Valorizzazione di prodotti e processi nel settore dei metalli preziosi”,
oggi Orotech è il portale sull’innovazione tecnologica, punto di
riferimento dove le aziende possono reperire informazioni ad alto
contenuto tecnologico su Bibliografia, Brevetti, Normativa e
Seminari tecnico-scientifici. Suggerisce percorsi di miglioramento dell’organizzazione aziendale e
della progettazione, per sviluppare conoscenze, diffonde informazioni
relativamente a leghe e materiali e ad alcuni fra i processi produttivi più
diffusi nel settore.
Ulteriori informazioni sul sito www.cpv.org e www.orotech.it
44