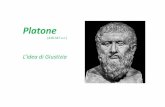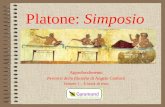Platone
description
Transcript of Platone
5/17/2018 Platone - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/platone-55b079df44eb6 1/13
PLATONE
Riassunto di
Alessia Mocci
5/17/2018 Platone - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/platone-55b079df44eb6 2/13
Alessia Mocci – III F Liceo Scientifico “G. Brotzu” – a.s. 2011-2012
Platone Pagina 1
Indice
1. I rapporti con Socrate e i sofisti
1.1 Contesto storico
1.2 La vita
1.3 Le opere e le “dottrine non scritte”
1.4 I caratteri della filosofia platonica
2. La dottrina delle idee e la teoria dello Stato
2.1 La dottrina delle idee
2.2 La dottrina dell’amore e dell’anima
2.3 Lo Stato e il compito del filosofo
3. Approfondimenti e nuove prospettive
3.1 I problemi dell’”ultimo Platone”
3.2 La dialettica
3.3 Il bene per l’uomo: il Filebo
3.4 Il Timeo e la dottrina delle idee-numeri
5/17/2018 Platone - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/platone-55b079df44eb6 3/13
Alessia Mocci – III F Liceo Scientifico “G. Brotzu” – a.s. 2011-2012
Platone Pagina 2
I rapporti con Socrate e i sofisti
1.1 Contesto storico
Platone conobbe il declino della società ateniese in seguito alla decadenza del periodo aureo del
dominio di Pericle, dovuto sia alla sconfitta della guerra del Peloponneso, sia al governo dei Trenta
Tiranni e successivamente alla democrazia conservatrice che condannò a morte Socrate.
Nell’ambito culturale, anche la sofistica inizia la sua decadenza.
Platone è insieme un aristocratico e un filosofo, perciò brama di trovare stabilità politiche e vive
questa situazione di degrado non solo come crisi della politica, ma dell’uomo.
Idealizza la figura di Socrate, disegnandolo come l’uomo più giusto di tutti che è riuscito ad andare
oltre al relativismo dei sofisti e lo rende perciò protagonista di numerosi suoi dialoghi.
Platone crede che la crisi di Atene sia dovuta ad una crisi intellettuale, abbandona la politica attiva
e pensa che sia necessario riformare globalmente l’esistenza umana tramite un rinnovamento
della filosofia. Decide di rifondare la politica alla luce del sapere.
1.2 La vita
Platone nasce in una famiglia aristocratica, studia presso Cratilo (seguace di Eraclito) e a vent’anni
inizia a frequentare Socrate coltivando molta stima nei suoi confronti fino alla sua condanna a
morte che convincerà Platone a non intraprendere una vita politica attiva. Si accorge che la sola
strada che può guidare l’uomo e la comunità verso la giustizia è la filosofia, perciò pensa che il
potere sarebbe dovuto essere nelle mani dei filosofi. Platone intraprende numerosi viaggi, ma ha
scritto documenti che riportano solo ciò che gli accade nell’Italia del sud: è stato venduto come
schiavo e con i soldi del riscatto – che non furono necessari quando scoprirono la sua identità-
fondò l’Accademia e viene chiamato a Siracusa per riformare lo Stato, ma non gli è possibile a
causa della presunzione del tiranno.
1.3 Le opere e le “dottrine non scritte” Tutte le opere scritte da Platone sono arrivate sino ai giorni nostri, non tutte sono state
riconosciute come autentiche: diverse sono spurie, cioè non sono state scritte da Platone. La sua
attività letteraria può essere suddivisa in tre periodi:
Primo periodo (scritti giovanili o socratici);
Secondo periodo (scritti della maturità);
Terzo periodo (scritti della vecchiaia).
Platone sostiene dei corsi chiamati Intorno al Bene che fanno parte delle sue “dottrine non scritte”
in cui parla di metafisica.
5/17/2018 Platone - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/platone-55b079df44eb6 4/13
Alessia Mocci – III F Liceo Scientifico “G. Brotzu” – a.s. 2011-2012
Platone Pagina 3
1.4 I caratteri della filosofia platonica
Platone aveva grande stima di Socrate, per questo gran parte del suo pensiero può essere
accostato a quello del maestro, anche se la maggior parte delle dottrine di Platone non hanno
nulla in comune con quelle di Socrate. Quindi Platone cerca di interpretare le dottrine filosofichedel maestro. Platone usa come forma di scrittura i dialoghi, infatti Socrate era contrario alla forma
scritta delle dottrine e utilizzava il dialogo perché consentiva di avere una concezione della
filosofia come sapere “aperto”: il dialogo è l’unico mezzo con cui si può comunicare l’indagine
filosofica in compartecipazione con gli altri. Per tutta la vita Platone cercò certezze di pensiero e di
vita su realtà eterne e immutabili, la sua fu una ricerca insaziabile e mai conclusa: la ricerca di una
verità che l’uomo non possiede mai totalmente.
Platone utilizza oltre al dialogo anche i miti per spiegare i concetti e le dottrine filosofiche. Questo
perché con il mito si possono comunicare le dottrine in modo più semplice e diretto, ma ancheperché con il mito si può parlare di realtà che vanno oltre la nostra razionalità. Il mito non è né una
favola né un’argomentazione dimostrabile, semplicemente è un racconto che si può
ragionevolmente ritenere vero.
5/17/2018 Platone - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/platone-55b079df44eb6 5/13
Alessia Mocci – III F Liceo Scientifico “G. Brotzu” – a.s. 2011-2012
Platone Pagina 4
La dottrina delle idee e la teoria dello Stato
2.1 La dottrina delle idee
Nel primo periodo Platone ha difeso e spiegato le dottrine di Socrate, facendo ciò le filtra e
aggiunge suoi pensieri e interpretazioni. Dà molto spazio alle definizioni di Socrate perché pensa
che sia il primo passo per superare il relativismo sofistico e arrivare ad un sapere assoluto.
Quindi Platone formula la “teoria delle idee” con cui inizia la seconda fase in cui va oltre le
dottrine di Socrate, sviluppando un suo pensiero. Probabilmente era spiegata nelle “dottrine non
scritte” quindi non abbiamo numerosi documenti che la spiegano, ma costituisce il centro del
platonismo maturo e Platone afferma di aver risolto i massimi problemi filosofici con essa.
Platone pensa che la scienza sia stabile, immutabile e quindi perfetta. Dal momento che ilpensiero riflette l’essere, si chiede quale sia l’oggetto proprio della scienza. Ciò non può essere
costituito dalle cose del mondo sensibile dal momento che i sensi sono mutevoli corrispondenti
all’opinione e di conseguenza imperfetti. Secondo Platone l’oggetto proprio della scienza sono le
idee, cioè entità immutabili e perfette che esistono in un mondo perfetto (“iperuranio”).
Il filosofo pensa che le cose siano copie imperfette delle idee. L’idea in conclusione è il modello
unico e perfetto delle cose molteplici e imperfette del nostro mondo sensibile.
Nella filosofia di Platone esistono due tipi di dualismo: quello gnoseologico che scinde due tipi di
conoscenza (l’opinione e la scienza) e quello ontologico che divide due tipi d’essere (le cose e le
idee).
Platone ha preso spunto dal pensiero di Eraclito (il nostro mondo è mutevole) e da Parmenide
(l’essere è autentico e immutabile), quindi l’idea di Platone è immutabile e perfetta, ma l’essere è
multiplo. Platone prende da Parmenide anche il dualismo ontologico e gnoseologico.
5/17/2018 Platone - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/platone-55b079df44eb6 6/13
Alessia Mocci – III F Liceo Scientifico “G. Brotzu” – a.s. 2011-2012
Platone Pagina 5
Nel periodo della maturità del pensiero platonico le idee si dividono in due tipi:
Le idee-valori, cioè i principi etici, estetici o politici;
Le idee-matematiche, cioè le entità aritmetiche e geometriche.
Platone parla anche di “idee di cose naturali” e “idee di cose artificiali”. Le idee hanno un ordine
gerarchico in cui troviamo per prima l’idea del Bene, poi le idee dei valori, le idee matematiche e
infine le idee delle cose naturali e artificiali.
Il Bene di cui parla Platone può essere identificato come una presenza divina, ma non crea le idee:
semplicemente si limita a comunicarne la perfezione.
Platone sostiene che le idee siano:
Criteri di giudizio delle cose, le idee sono la condizione della pensabilità delle cose;
Causa delle cose, le idee sono la condizione dell’esistenza degli oggetti.
Il filosofo parla di mimesi1, di metessi
2 e di parusìa3 per cercare di capire a fondo il rapporto tra e
idee e le cose, senza però arrivare ad una conclusione definitiva.
Gli studiosi si sono domandati a lungo se le idee esistano in un mondo come l’aldilà o il paradiso
cristiano o se siano schemi presenti nella nostra mente. Ma si è arrivati alla conclusione che
Platone le intendesse come enti reali che costituiscono un ordine eterno ideale che non esistono
in alcun luogo e costituiscono una zona d’essere diversa dalle cose.
In che modo l’uomo può conoscere le idee? Platone diceva che esse non possono scaturire dai
sensi, ma da una visione intellettuale. Per capire da dove proviene questa “visione”, Platone
racconta il mito della “reminescenza”4: la nostra anima prima di incarnarsi, viveva nel mondo delle
idee e ha conosciuto le idee delle cose. Di conseguenza, quando arriva sulla terra ricorda in modo
innato le idee, seppur in modo sfocato. Questo innatismo ritiene che la conoscenza delle idee non
deriva dall’esperienza sensibile, ma fossero capacità preesistenti. La prova di ciò, secondo Platone,
sta nel fatto che anche un ignorante può arrivare, tramite la logica, a elaborare persino teoremi
geometrici. In conclusione, per Platone possediamo un’innata verità dovuta alla precedente
conoscenza del mondo delle idee.
Platone dice che conoscere, imparare, significa ricordare ciò che si è appreso prima che la nostra
anima si incarnasse. L’uomo non conosce tutta la verità, quindi la cerca, ma non la ignora del
tutto, altrimenti non la cercherebbe, ma la “ricorda” a priori, cioè a prescindere dai sensi.
La dottrina della reminescenza presuppone l’immortalità dell’anima. Platone scrive un dialogo (il
Fedone) in cui elabora tre prove dell’immortalità dell’anima: “dei contrari”, ogni cosa si genera dal
1
Le cose imitano le idee2Le cose partecipano delle idee
3Le idee sono presenti nelle cose
4 Ricordo
5/17/2018 Platone - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/platone-55b079df44eb6 7/13
Alessia Mocci – III F Liceo Scientifico “G. Brotzu” – a.s. 2011-2012
Platone Pagina 6
suo contrario, quindi dopo la morte del corpo l’anima continua a esistere; “della somiglianza”,
essendo l’anima simile alle idee deve essere eterna; “della vitalità”, essendo vita non può
includere in sé la morte.
Platone ritiene che il “filosofare” sia una preparazione alla morte, infatti i filosofi si annullano per
capire meglio le idee: al momento della morte l’anima si libera del corpo e raggiunge il mondo
delle idee.
Nel dialogo la Repubblica, il filosofo parla del destino e del modo in cui la nostra anima conosce le
idee tramite il mito di Er: le anime scelgono il corpo in cui incarnarsi e Er5 racconta loro ciò che
succederà dopo la morte, è l’uomo che sceglie il proprio destino.
Platone si oppone spesso al relativismo sofistico, in particolar modo nella teoria delle idee, egli
pensa che il relativismo appartenga ad una filosofia negatrice di ogni certezza e indistinta. Ritiene
che si debba cercare una certezza assoluta, con la dottrina delle idee trova strutture ideali euniversali. I sofisti e Socrate dicevano che l’uomo doveva misurare e giudicare le cose, Platone
afferma che sono le idee a misurare l’uomo. La conoscenza arriva ad avere un valore assoluto a
differenza del pensiero sofistico, il quale implicava che anche il linguaggio non riuscisse a
esprimere la verità, per Platone dal momento che rispecch ia e rivela le idee, ha anch’esso un
valore assoluto.
Platone pensa che il relativismo sofistico porti al caos, quindi il filosofo con la dottrina delle idee
offre uno strumento per uscire dal caos. Conoscendo le idee si arriva ad una scienza politica
universale che porta infine alla pace e alla giustizia tra gli uomini. Ciò può avvenire solo se il potereè detenuto dai filosofi.
2.2 La dottrina dell’amore e dell’anima
Platone definisce con il termine èros6 il rapporto tra le idee e l’uomo e il rapporto tra gli uomini
impegnati nella ricerca. Scrive due dialoghi sulla teoria dell’amore: il Simposio7 e il Fedro
8.
Nel Simposio viene distinto l’èros volgare (quello corporeo, della carne) e l’èros celeste (quello
dell’anima). L’amore è una forza cosmica che determina l’armonia delle cose. Racconta il mito
degli androgini, il cui messaggio di fondo è il fatto che l’amore sottolinea l’insufficienza del singolo
individuo. L’amore è anche mancanza perché vuole qualcosa di cui ha bisogno ma che non ha.
Secondo il mito Èros è figlio di Penìa9 e Pòros10, non è né divino né umano e brama di possedere la
sapienza e la cerca, perciò è filosofo. L’amore desidera la bellezza perché rende felici, quindi
quest’ultima è il fine dell’amore. La gerarchia della bellezza parte dalla bellezza del corpo, poi c’è
5Guerriero della Panfilia, morto in battaglia e risorto dopo dodici giorni
6 Amore7
Parla della bellezza e dei suoi gradi gerarchici8 Parla dell’amore come aspirazione verso la bellezza e elevazione dell’anima al mondo delle idee
9Povertà
10 Abbondanza, ingegno
5/17/2018 Platone - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/platone-55b079df44eb6 8/13
Alessia Mocci – III F Liceo Scientifico “G. Brotzu” – a.s. 2011-2012
Platone Pagina 7
la bellezza di tutti i corpi, la bellezza dell’anima, la bellezza delle leggi e delle istituzioni, la bellezza
delle scienze fino ad arrivare alla bellezza in sé.
Nel Fedro racconta il mito della biga alata, l’anima si può paragonare ad una biga guidata da due
cavalli: uno bianco (che indica la parte giusta) e uno nero (che indica la parte carnale e
peccaminosa). Dal momento che il cavallo bianco cerca di andare verso l’alto (verso l’iperuranio, in
cui si trovano le idee) e quello nero va verso il basso, l’anima sarà più o meno buona a seconda del
fatto se ha ammirato più o meno a lungo l’iperuranio. La bellezza risveglia nell’uomo la voglia di
cercare la sapienza e la verità, è mediatrice tra l’uomo e il mondo delle idee. L’éros diventa
procedimento razionale, dialettica, cioè la ricerca dell’essere in sé e legame amoroso delle anime
al fine di conoscere. Quindi si sfocia nella retorica: scienza dell’idea e dell’anima.
2.3 Lo Stato e il compito del filosofo
Platone cerca una forma di Stato perfetta, ciò può esistere solo se il potere è nelle mani dei
filosofi.
Lo scopo di una comunità governata dai filosofi è la giustizia: condizione fondamentale della vita di
uno Stato. Quest’ultimo deve essere diviso in tre classi: i governanti, la cui caratteristica è la
saggezza; i guerrieri, la cui virtù è il coraggio; i cittadini, che devono essere temperanti. La giustizia
include queste tre qualità. Ognuno deve svolgere il proprio compito al meglio e nelle migliori
condizioni possibili affinché uno Stato sia giusto.
Platone differenzia nell’anima di ogni individuo tre parti: parte razionale, con cui domina gli
impulsi; concupiscibile, da cui partono gli impulsi carnali e irascibile, che sostiene la parte
razionale.
Bellezza in sé
Bellezza delle scienze
Bellezza delle leggi e delle istituzioni
Bellezza di tutti i corpi
Bellezza del corpo
I gradi della bellezza
5/17/2018 Platone - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/platone-55b079df44eb6 9/13
Alessia Mocci – III F Liceo Scientifico “G. Brotzu” – a.s. 2011-2012
Platone Pagina 8
Secondo Platone, ogni individuo deve svolgere un proprio compito che gli è congeniale. Questo
compito non deve essere considerato ereditario, ma ogni uomo deve considerare di che tipo è la
propria anima, le proprie attitudini naturali. Il mito delle stirpi racconta che ci sono tre tipi di
anima: aurea, argentea o bronzea. Quindi non si formano caste rigide, si ammette la mobilità
sociale: il figlio di un guerriero può diventare governante.
Platone propone l’abolizione della proprietà privata e la comunanza dei beni nelle classi più alte,
affinché i governanti pensino soltanto al bene pubblico e non ai propri interessi. Non ci saranno
coppie fisse e le donne avranno gli stessi diritti degli uomini, i matrimoni avranno una scadenza e i
figli non conosceranno i genitori ma saranno allevati tutti insieme.
I guardiani
11
sono felici perché svolgono il loro compito in nome della giustizia per la pace delloStato, inoltre i filosofi sono felici perché possiedono la conoscenza.
Platone è conscio del fatto che questo Stato non può aver luogo. Stila una classifica delle
alterazioni e degenerazioni che uno Stato può subire:
Timocrazia, governo fondato sull’onore;
Oligarchia, governo di pochi basato sulla ricchezza;
Democrazia, in cui i cittadini sono troppo liberi di fare ciò che vogliono senza misura;
Tirannide, nasce dalla troppa libertà democratica, il tiranno deve circondarsi dei peggiori
individui della città per mantenere il potere.
Platone era aristocratico, si accanì contro la democrazia. Gli aristocratici pensano che il governo
debba essere detenuto “dai migliori”, i democratici ritengono che debba essere detenuto da tutti i
cittadini. Per Platone uno stato è giusto se ci sono marcate differenze e subordinazioni tra le classi
sociali, affinché si mantenga l’ordine pubblico. Ritiene che l’arte della politica sia destinata solo
alle anime auree della città. Platone organizza tutta la società sino ai minimi particolari
(statalismo12) decidendo persino la dieta dei cittadini.
11I filosofi che governano lo Stato
12 Intervento dello stato nella vita privata dei cittadini
5/17/2018 Platone - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/platone-55b079df44eb6 10/13
Alessia Mocci – III F Liceo Scientifico “G. Brotzu” – a.s. 2011-2012
Platone Pagina 9
Platone presuppone che i custodi siano in grado di controllare se stessi e quindi che siano giusti, di
conseguenza riusciranno a controllare anche lo Stato. Gli individui vengono addestrati a pensare al
bene comune sin dalla nascita. Questa società assomiglia ad una grande Accademia con il fine di
formare nuovi governanti. Solo le due classi superiori avranno il diritto di apprendere.
L’essere corrisponde alla scienza (al sapere), il non essere all’ignoranza. Il divenire (una via di
mezzo tra scienza e ignoranza) corrisponde l’opinione.
Platone ritiene che la filosofia sia più importante delle discipline scientifico-matematiche, poiché
quest’ultime ricorrono a numerosi enti sensibili (punto, linea) e alle ipotesi dimostrative. La
filosofia invece si occupa dei problemi dell’uomo e della città. Ciò nonostante anche le scienze
matematiche sono molto importanti perché aiutano a misurare e a trovare conoscenze stabili e
oggettive, costituiscono la propedeutica alla filosofia e preparano il filosofo alla dialettica e alla
scienza delle idee.
La teoria della conoscenza e dell’educazione viene spiegata nel racconto della caverna. Ci sono
degli schiavi incatenati in una caverna e per tutta la vita vedono delle ombre di statuine davanti a
sé, credono di conseguenza che quella sia la realtà. Uno di essi riesce a liberarsi, a vedere le
statuine e ad uscire dalla caverna, abbagliato dalla luce non riuscirà a distinguere il mondo
circostante ma poi lo ammirerà. Quando tornerà dai compagni per renderli partecipi, essi lo
prenderanno per pazzo e lo uccideranno.
Lo schiavo liberato indica il filosofo che scopre le idee e cerca di spiegarle agli uomini.
La finalità politica della filosofia platonica è la fondazione di una comunità giusta e felice.
Soltanto tornando nella caverna, il filosofo sarà veramente tale e avrà completato il suo compito.
Platone condanna l’arte perché ritiene che sia “imitazione dell’imitazione”, cioè imitazioni delle
cose del mondo sensibile che sono imitazioni delle idee. L’arte può esistere solo se adattata alla
filosofia.
5/17/2018 Platone - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/platone-55b079df44eb6 11/13
Alessia Mocci – III F Liceo Scientifico “G. Brotzu” – a.s. 2011-2012
Platone Pagina 10
Approfondimenti e nuove prospettive
3.1 I problemi dell’”ultimo Platone”
Nella terza fase dell’attività filosofica di Platone, quest’ultimo si mette in discussione: modera ildualismo tra modo delle idee e mondo sensibile. Da ciò si interroga su come deve essere pensato il
mondo delle idee e quale sia il rapporto tra realtà naturali e idee.
In questa fase sviluppa una notevole autocritica sulla teoria delle idee, il primo ostacolo è il fatto
che “l’uno” è l’idea e “molti” sono gli oggetti di cui l’idea costituisce l’unità, senza che essa sia
moltiplicata. Quindi si può intendere l’idea nella sua individualità o come una varietà di cose più
l’idea che hanno in comune: questa teoria viene chiamata da Platone “terzo uomo”.
Parmenide diceva che solo l’essere è, mentre in non essere non è. A causa di questa affermazione
non è possibile la molteplicità delle idee, infatti se un’idea non è un’altra implica che “non è”
qualcosa e quindi non esiste. Platone decide di mettere in pratica un “parmenicidio” pur di non
rinunciare alla teoria delle idee.
Platone elabora la teoria dei “generi sommi” per spiegare come più idee possano esistere e come
interagiscono tra loro. Gli attributi fondamentali delle idee sono cinque:
L’essere, ogni idea esiste e quindi è;
L’identico, ogni idea è identica a se stessa;
Il diverso, ogni idea è diversa dalle altre idee; La quiete, quando si considera un’idea da sola;
Il movimento, quando si considera la combinazione di diverse idee.
Parmenide considerava il verbo essere con valore assoluto, Platone lo considera con un valore
copulativo: quindi se una cosa non è un’altra, non vuol dire che non esiste, ma che è diversa da
essa.
Gli eristi affermavano che non poteva esistere l’errore perché implicherebbe il dire qualcosa che
non è e di conseguenza qualcosa che non esiste, Platone dice invece che esiste l’errore perché
consiste nel dire qualcosa diverso dalla realtà.
Platone si interroga su cosa sia l’essere. I materialisti dicono che è ciò che è materia, gli idealisti
dicono che è ciò che è spirito. Platone afferma che l’essere è possibilità: se una cosa può entrare
in relazione con un’altre, se può agire o subire una qualsiasi azione, esiste.
3.2 La dialettica
La dialettica consiste nel conoscere quali idee si combinano tra loro e quali no, è costituita da due
passaggi: prima si definisce una certa idea, poi si divide l’idea nelle sue articolazioni interne.
5/17/2018 Platone - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/platone-55b079df44eb6 12/13
Alessia Mocci – III F Liceo Scientifico “G. Brotzu” – a.s. 2011-2012
Platone Pagina 11
La dialettica presuppone che le idee possono essere in contatto tra loro, ma non con tutte
altrimenti tutti i discorsi sarebbero veri. Per definire un’idea si parte da un concetto generale che
avanza con un processo dicotomico: dividendo per due ogni idea sino ad arrivare ad un’idea
indivisibile che fornisce una definizione specifica. È una ricerca inesauribile.
3.3 Il bene per l’uomo: il Filebo
Platone si chiede cosa sia il bene per l’uomo. Il bene per l’uomo è una forma di vita. La vitaumana ha una forma mista, a metà tra l’animale e il divino, perciò è tra la ricerca del piacere e
l’esercizio dell’intelligenza. Si arriva al bene quando si riesce a misurarli entrambi in modo
giusto: il piacere è illimitato, è compito della ragione dargli un limite. L’uomo deve conoscere
tutte le forme di conoscenza, anche le più basse, perciò deve servirsi anche dell’opinione. Deve
anche conoscere i piaceri, ma solo quelli puri, cioè quelli che non sono dovuti all’appagamento
di un bisogno, ma alla contemplazione del bello.
Platone parla quindi di virtù come scienza della misura.
Ordine e misura
Proporzione e bello
Intelligenza
Scienza e opinione
Piaceri puri
Gerarchia dei valori
5/17/2018 Platone - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/platone-55b079df44eb6 13/13
Alessia Mocci – III F Liceo Scientifico “G. Brotzu” – a.s. 2011-2012
Platone Pagina 12
3.4 Il Timeo e la dottrina delle idee-numeri
Nel Timeo, Platone si domanda quale sia l’origine dell’universo. Per dare una risposta, il filosofo
scrive il mito del demiurgo. Il demiurgo è un divino artigiano che si trova tra il mondo delle idee e
il mondo sensibile. Quest’ultimo era costituito dal caos, perciò il demiurgo plasmò con la materia(imperfetta) le cose del mondo copiando le idee. Il demiurgo crea il tempo, che riproduce nella
forma del cambiamento l’ordine immutabile dell’eternità. Tutto ciò che è armonico e bello è
dovuto alle idee, all’intelligenza e al demiurgo, ciò che è disarmonico è causato dalla materia e
dalla necessità.
Con il Timeo, Platone interpreta i numeri come schemi strutturali delle cose, cioè il codice di
interpretazione di ciò che esiste. Il filosofo, poco prima di morire, interpretò il mondo delle idee
come un mondo matematico, costituito da numeri.