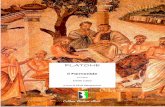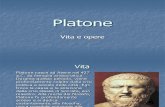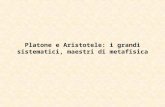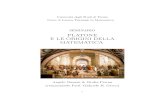PLATONE
-
Upload
claudiastocchino -
Category
Documents
-
view
584 -
download
0
description
Transcript of PLATONE
5/17/2018 PLATONE - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/platone-55b079c6d4b87 1/17
Nicole Maria Zanon III F 30-04-2012
1
5/17/2018 PLATONE - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/platone-55b079c6d4b87 2/17
Nicole Maria Zanon III F 30-04-2012
2
Indice:
1. I rapporti con Socrate e con i sofisti:
Il platonismo come risposta filosofica a una società e a una cultura
in crisi
La vita
I caratteri della filosofia platonica:
Socrate e Platone
Mito e filosofia
2. La dottrina delle idee e la teoria dello Stato:
La dottrina delle idee:
La teoria delle idee e la sua importanza
La genesi della teoria e delle idee
Quali sono le idee
Il rapporto tra le idee e le cose
Come e dove esistono le idee
La conoscenza delle idee Reminiscenza, verità ed eristica
L’immortalità dell’anima e il mito di Er
La dottrina delle idee come “salvezza” o al relativismo sofistico
La finalità politica della teoria delle idee
La dottrina dell’amore e dell’anima:
Il Simposio
Il Fedro
Lo stato e il compito del filosofo:
Lo stato ideale e la giustizia
Caratteri e motivazioni delle classi sociali
Il comunismo Platonico
I guardiano sono felici?
Le degenerazioni dello Stato Platone e la democrazia
5/17/2018 PLATONE - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/platone-55b079c6d4b87 3/17
Nicole Maria Zanon III F 30-04-2012
3
Chi custodirà i custodi? L’importanza dell’educazione nella città
platonica
I gradi della conoscenza e l’educazione
Il mito della caverna La condanna dell’arte imitativa
3. Approfondimenti e nuove prospettive:
I problemi dell’ultimo Platone:
Il confronto con Parmenide
I generi dell’essere e il problema del nulla
La nozione generale di “essere”
La dialettica
Il bene per l’uomo: il Filebo
Il Timeo e la dottrina delle idee-numeri:
Il mito del demiurgo
5/17/2018 PLATONE - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/platone-55b079c6d4b87 4/17
Nicole Maria Zanon III F 30-04-2012
4
I rapporti con Socrate e con i sofisti
Il platonismo come risposta filosofica a una società e a una
cultura in crisiIl platonismo può essere compreso solo in riferimento alla crisi politico-culturale. Dal punto di vista
politico il tempo di Platone è caratterizzato dalla decadenza della Grecia. Tra gli avvenimenti che
concorrono alla decadenza della Grecia abbiamo: la sconfitta di Atene, il fallimentare dominio dei
Trenta tiranni e il ritorno della democrazia. Platone, essendo un aristocratico, è portato a
desiderare una stabilità politica; essendo un filosofo vive questa crisi problematica come una crisi
dell’uomo. Per questo, la figura di Socrate viene vista da lui un simbolo della crisi e una speranza
del suo superamento.
Se si è giunti a uccidere Socrate, Platone pensa che il malessere della società è giunto al limite.Socrate ha sentito la necessità di rinnovare dal punto di vista etico l’uomo e andare oltre il
relativismo dei sofisti, ricercando definizioni comuni a tutti.
Platone ritiene infatti necessaria una riforma globale dell’uomo e questa può essere ottenuta
tramite una rivoluzione culturale.
In sintesi Platone ritiene che nuove certezze di pensiero possano offrire solide basi per una
rifondazione filosofica della politica.
La vitaPlatone nacque ad Atene, da famiglia aristocratica, nel 427 a.C.; a vent’anni
cominciò a frequentare Socrate e fu tra i suoi discepoli sino alla morte del
maestro, Platone avrebbe voluto dedicarsi alla vita politica, ma la morte di Socrate
lo colpì come un’ingiustizia imperdonabile e come una condanna generale della
politica del tempo; da allora la filosofia gli apparve come la sola via che potesse
condurre l’uomo singolo e la comunità verso la giustizia.
I caratteri della filosofia platonicaSocrate e Platone
Possiamo affermare che la ricerca platonica sia un interpretazione della personalità filosofica di
Socrate. La stessa forma dell’attività letteraria di Platone, il dialogo, è un atto di fedeltà al silenzio
letterario di Socrate che ha una concezione della filosofia come sapere aperto. Il dialogo è il solo
mezzo per comunicare l’indagine filosofica. Questa concezione della filosofia, vista come dialogo,
testimonia come Platone si sia portato dietro per tutta la vita il Demone di Socrate e questo ha
fatto si che egli abbia vissuto la filosofia come una ricerca incessante e mai conclusa cioè come un
infinito sforzo verso una verità che l’uomo non possiede mai totalmente ma è un continuoincessante interrogarsi.
5/17/2018 PLATONE - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/platone-55b079c6d4b87 5/17
Nicole Maria Zanon III F 30-04-2012
5
Mito e filosofiaNell’opera platonica vi è l’uso dei “miti”, racconti fantastici attraverso cui vengono narrati concetti
e dottrine filosofiche, il mito in Platone ha due importanti significati: il primo vede il mito come
uno strumento di cui il filosofo si serve per comunicare in maniera più semplice le proprie dottrine
all’interlocutore; il secondo vede il mito come un mezzo di cui si serve il filosofo per poter parlare
di realtà che vanno al di là dei limiti cui l’indagine rigorosamente razionale può spingersi.
Da questo punto di vista il mito è qualcosa che si inserisce nelle lacune della ricerca filosofica
permettendole in alcuni casi di formulare una teoria verosimile cioè qualcosa che si può ritenere
vero ragionando. Inoltre l’uso dei miti da un lato rende più difficile l’interpretazione della filosofia
platonica, dall’altro conferisce al platonismo un aspetto suggestivo, contribuendo nel tempo alla
sua fortuna verso un pubblico più vasto.
La dottrina delle idee e la teoria dello Stato
La dottrina delle idee
La teoria delle idee e la sua importanzaPlatone da molta importanza al metodo di Socrate nelle sue definizioni interpretandolo come il più
importante passo verso un sapere assoluto capace di superare il relativismo sofistico, dunque
Platone giunge a formulare la cosiddetta “teoria delle idee” che segna l’avvio della fase in cui il
filosofo va al di la delle dottrine che Socrate aveva insegnato, elaborando un proprio pensiero.La teoria delle idee, nei dialoghi, forse costituiva l’oggetto delle “dottrine non scritte” e questo
portò qualche studioso a metterla in secondo piano. In realtà la dottrina delle idee rappresentava
il cuore stesso del platonismo maturo; infatti per Platone pretendere di pensare senza “idee”
sarebbe un po’ come pretendere di pensare i pitagorici senza i numeri o il Parmenide senza
“l’essere”.
La genesi della teoria e delle ideeLa genesi della teoria delle idee è da ricercarsi nel concetto di scienza: Platone ritiene che la
scienza debba avere i caratteri della stabilità e dell’immutabilità, perciò della perfezione, ma
essendo convinto che la mente sia uno specchio o una riproduzione di ciò che esiste, Platone si
chiede quale sia l’oggetto proprio della scienza e proprio secondo lui l’oggetto della scienza sono
le idee. Per noi il termine “idea” sta a indicare un pensiero del nostro intelletto, per Platone,
invece, indica un entità immutabile e perfetta che esiste per proprio conto, cioè di una “realtà
autonoma” che costituisce con altre idee una zona diversa dalla nostra che chiama in modo
poetico e metaforico “iperuranio”(in greco significa al di là del cielo).
Nonostante ciò le idee, secondo Platone, hanno uno stretto rapporto con gli oggetti: le cose, per il
filosofo, infatti sono copie o imitazioni imperfette delle idee. L’idea platonica è quindi il modellounico e perfetto delle cose molteplici e imperfette di questo mondo.
5/17/2018 PLATONE - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/platone-55b079c6d4b87 6/17
Nicole Maria Zanon III F 30-04-2012
6
In Platone, inoltre, esistono due fondamentali di conoscenza: l’opinione e la scienza (dualismo
gnoseologico) e due tipi d’essere distinti: le cose e le idee (dualismo ontologico).
La verità imperfetta dell’opinione dipende dalla configurazione imperfetta del suo oggetto e la
verità perfetta della scienza dipende dalla configurazione perfetta del suo oggetto.
L’opinione quindi è di carattere mutevole e imperfetto mentre la scienza costituisce unaconoscenza stabile e perfetta.
Da Eraclito Platone condivide la teoria secondo cui il nostro mondo è il regno della mutevolezza,
mentre da Parmenide la teoria secondo cui l’essere autentico è immutabile. Ma diversamente da
quest’altro, per Platone l’essere risulta multiplo, in quanto formato da una pluralità di idee. Inoltre
per Parmenide il mondo sensibile non ha legami con quello pensato dalla ragione, per Platone,
invece, esiste un indissolubile rapporto. Per l’eleatismo il nostro mondo è apparenza illusoria e
irrazionale, per Platone possiede una specifica realtà anche se imperfetta.
Quali sono le ideeNel pensiero platonico esistono due tipi di idee:
le idee valori: bene, bellezza, giustizia, che formano appunto gli ideali e i valori;
le idee matematiche: corrispondenti alle entità dell’aritmetica e della geometria, cioè secondo
Platone ci sono idee anche nei principi del pensiero matematico.
Insieme a questi due tipi di idee, Platone parla anche di “idee di cose naturali” (es. l’umanità) e di
“idee di cose artificiali” (es. il letto), su questo però Platone rimane a lungo incerto e solo ne gli
ultimi dialoghi fa corrispondenza a ogni realtà la propria specifica “forma”, perciò la sua idea
corrisponde a una forma unica e perfetta di qualsiasi gruppo o classe o di cose che vengonodescritte con lo stesso nome e che possono essere fatte oggetto di scienza.
Nonostante le idee sono molteplici non formano una pluralità disorganizzata, ma anzi hanno un
ordine gerarchico –piramidale con le idee valori in cima e l’idea del bene al vertice.
L’idea del bene è stata paragonata Dio, ciò nonostante, pur essendo “ al di là dell’essere”, cioè
delle idee, il bene non “crea” le idee, ma si limita a comunicare loro la perfezione. Perciò possiamo
concludere che nell’universo metafisico di Platone non esiste un Dio- persona, ma solamente il
“Divino” Platone, infatti, usa il termine impersonale to thè- ion ( il Divino) solo per indicare una
molteplicità di cose diverse.
Il rapporto tra le idee e le cosePlatone da un lato afferma la distinzione tra le idee e le cose, dall’altro ne sostiene lo stretto
legame.
Le idee sono infatti:
Criteri di giudizio delle cose, in quanto per giudicare gli oggetti, dobbiamo riferirci ad essi. Ad
esempio diciamo che due cose sono uguali sulla base dell’idea dell’uguaglianza oppure che due
azioni sono giuste sulla base dell’idea della giustizia. Le idee, perciò, sono la condizione della
pensabilità degli oggetti. Causa delle cose poiché gli individui sono in quanto imitano e partecipano delle “essenze
archetipe”. Ad esempio le realtà che diciamo belle sono tali in quanto imitano e par tecipano e
5/17/2018 PLATONE - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/platone-55b079c6d4b87 7/17
Nicole Maria Zanon III F 30-04-2012
7
che gli individui sono uomini sulla base dell’idea dell’umanità che è la causa che li rende tali. Le
idee, perciò, sono la condizione dell’esistenza degli oggetti e la loro ragione d’essere.
Platone, circa il rapporto idee- cose, pur parlando di “mimesi” ( le cose imitano le idee), di
“metessi” (le cose partecipano alle idee), di “parusia” ( le idee sono presenti nelle cose) rimane
sulla questione molto incerto. Infatti nella sua vecchiaia Platone continua a parlare di questoproblema, cercando di risolverlo nel migliore dei modi.
Come e dove esistono le ideeLe idee sono “trascendenti” in quanto esistono oltre la mente e oltre le cose.
La tradizione ha considerato il mondo platonico delle idee come qualcosa uguale all’empireo
dantesco o al paradiso cristiano. A questa lettura si contrappongono alcuni studiosi del novecento
che considerano le idee di Platone, non come delle cose, ma come dei criteri mentali attraverso
cui pensiamo gli oggetti. Molti studiosi considerano la prima interpretazione come troppo legata
al mito, di conseguenza affermano che il mondo platonico non deve essere interpretato come un
universo di “super cose”, ma soltanto come un ordine eterno di forme o valori ideali, che, come
tali, non esistono in alcun luogo o “ empireo”.
Stabilire con sicurezza quale di queste interpretazioni sia quella vera non è possibile, poiché
entrambe presentano punti di debolezza.
In conclusione, si può affermare che le idee costituiscono una zona d’essere diversa dalle cose.
La conoscenza delle ideeSecondo Platone le idee non possono derivare dai sensi, ma sono “una visione intellettuale”, cioè il
risultato di uno “sguardo della mente”. Viene allora naturale domandarsi da dove proviene questa
visione intellettuale; per rispondere al problema, Platone ricorre alla dottrina della “reminiscenza”
(cioè del ricordo): afferma, infatti, che l’anima, prima di calarsi nel nostro corpo, è vissuta,
disincarnata, nel mondo delle idee. Una volta poi discesa nel nostro mondo, l’anima conserva un
ricordo che ha veduto. Riguardo a questo Platone dice “conoscere è ricordare” in quanto le idee le
portiamo dentro di noi e basta uno sforzo per tirarle fuori, basta quindi ricordarne una perché
tutte tornino alla mente.La gnoseologia di Platone rappresenta quindi una forma di innatismo, perché ritiene che la
conoscenza derivi da metri di giudizio preesistenti nel nostro intelletto, secondo Platone, infatti,
anche un ignorante se ben interrogato, può rispondere esattamente su cose di cui non aveva mai
parlato.
Reminiscenza, verità ed eristicaLa teoria della reminiscenza, secondo Platone, rappresenta la vittoria sul principio eristico-
sofistico secondo il quale “non è possibile, alla’uomo, indagare né ciò che sa, né ciò che non sa”, inquanto sarebbe inutile indagare ciò che si sa, e impossibile indagare ciò che non si sa.
5/17/2018 PLATONE - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/platone-55b079c6d4b87 8/17
Nicole Maria Zanon III F 30-04-2012
8
Secondo Platone, dunque, l’uomo non possiede tutta la verità e non la ignora completamente, ma
la porta in lui a titolo di “ricordo”, perciò conoscendo noi non partiamo né dalla verità né
dall’ignoranza, ma da una preconoscenza o ignoranza di sapere, da cui dobbiamo tirare fuori la
conoscenza vera e propria.
L’immortalità dell’anima e il mito di ErNell’opera il Fedone Platone elenca altre prove
dell’immortalità del’anima. La prima prova detta “dei
contrari” afferma che, come in natura, ogni cosa si
forma dal suo contrario e la morte si genera dalla vita e
la vita dalla morte, nel senso che l’anima viene anche
dopo la morte del corpo. La seconda prova detta “ della
somiglianza”, sostiene che l’anima è eterna in quanto
simile alle idee che sono eterne.
La terza prova detta “della vitalità” sostiene che l’anima
è vita in quanto partecipa all’idea di vita e non può
accogliere l’opposta idea della morte.
Nel Fedone troviamo anche la dottrina filosofica sulla
“preparazione alla morte”, infatti se filosofare significa morire ai sensi e al corpo per poter cogliere
meglio le idee, la vita di Platone risulta tutta una preparazione alla morte in quanto l’anima libera
dal corpo può unirsi direttamente alle idee.
La teoria dell’immortalità a Platone serve anche per chiarire il problema del destino; egli ritiene,
infatti, che il destino di ogni individuo dipenda da una scelta compiuta precedentemente dalla sua
anima nel mondo delle idee.
La sua tesi illustrata con il mito di Er, con cui si chiude la repubblica; Er muore in battaglia e
risuscita dopo 12 giorni, per questo può raccontare agli uomini il destino che li attende dopo la
morte. La parte più importante del racconto riguarda proprio la scelta del destino alla quale le
anime sono invitate prima della loro reincarnazione, ogni anima quindi sceglie la vita che
rincarnerà, ma la scelta spesso dipende dalle esperienze che l’anima ha raccolto nella vita
precedente. Per Platone, perciò, l’uomo sceglie il proprio destino, anche se condizionato da quello
che in vita ha voluto essere ed è stato.
La dottrina delle idee come “salvezza” o al relativismo sofistico Il cuore della dottrina delle idee è costituita dall’opposizione al relativismo sofistico.
Per Platone il relativismo sofistico si identifica con una filosofia negatrice di ogni stabile punto di
vista sulle cose e tende a far divenire un tutto indistinto; per il filosofo l’unica via di scampo è la
restaurazione di una forma di assolutismo, cioè di certezze assolute. Questo porta al superamento
dell’umanismo sofistico e socratico che viene messo da parte e sostituito dalla concezione.
In Platone, infatti, non è più l’uomo a misurare la verità ma è la verità a misurare l’uomo con
regole del pensare e del vivere.
5/17/2018 PLATONE - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/platone-55b079c6d4b87 9/17
Nicole Maria Zanon III F 30-04-2012
9
La conoscenza torna ad avere un valore assoluto e cessa di essere relati va all’uomo; con questo il
relativismo conoscitivo e morale dei sofisti crolla completamente.
La finalità politica della teoria delle ideePlatone ritiene che il relativismo produca disordine e violenza, di conseguenza con la dottrina delle
idee il filosofo vuole offrire agli uomini uno strumento che consenta loro di uscire dal caos delle
opinioni e dei costumi fuori dalle lotte e dalle violenze.
L’assolutismo della teoria delle idee rappresenta perciò il principale strumento di battaglia contro
il relativismo politico e contro l’anarchia sociale.
La dottrina dell’amore e dell’anima
Il sapere, tra l’uomo e le idee e tra gli uomini associati nella comune ricerca, stabilisce un rapportonon solo intellettuale, perché impegna l’uomo totalmente. Questo rapporto viene definito da
Platone amore; alla teoria dell’amore vengono dedicati due dialoghi: il Simposio e il Fedro.
Il Simposio considera soprattutto l’oggetto dell’amore, cioè la bellezza; il Fedro considera l’amore
nella sua soggettività come elevazione progressiva dell’anima al mondo delle idee, al quale la
bellezza appartiene.
Il SimposioI discorsi in lode di Eros, degli interlocutori del
Simposio metteranno in risalto i caratteri più
importanti dell’amore. Pausania fa una
distinzione tra Eros volgare, cioè che si rivolge
ai corpi, ed Eros celeste che si rivolge alle
anime. Il medico Erissimaco vede nell’amore
una forza cosmica. Aristofane esprime uno dei
caratteri fondamentali che l’amore rivela
nell’uomo: l’insufficienza.
Socrate nel suo discorso parla di amore come
mancanza in quanto l’amore desidera
qualcosa che non ha ma di cui ha bisogno. Riassumendo perciò l’amore è desiderio di speranza e di
bellezza in quanto è il bene che rende felici. La bellezza è perciò il fine, l’oggetto proprio
dell’amore.
Si anno inoltre vari gradi di bellezza a cui corrispondono vari tipi di amore: del corpo, dell’anima,
delle leggi e delle scienze; ma il più alto grado di bellezza è la bellezza in sé a cui corrisponde
l’amore filosofico, in quanto è eterna, perfetta sempre uguale a se stessa e superiore alla morte.
5/17/2018 PLATONE - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/platone-55b079c6d4b87 10/17
Nicole Maria Zanon III F 30-04-2012
10
Il FedroPer capire i gradi che l’anima deve percorrere per giungere alla bellezza suprema il Fedro parte
proprio dalla considerazione dell’anima con il mito della biga alata: la natura dell’anima viene
paragonata a una coppia di cavalli alati guidati da un auriga; il cavallo bianco è eccellente, quello
nero è pessimo, e l’auriga ha il compito di indirizzare verso il cielo i cavalli, cioè verso quella
regione sopraceleste che è la sede dell’essere autentico, qui sta la vera sostanza priva di colore
che può essere contemplata solo dalla ragione. Questa sostanza è la totalità delle idee, ma l’anima
potrà contemplarla solo finché il cavallo nero non tiri verso il basso, appesantendola, perdendo le
ali perciò si incarna e va a vivificare il corpo di un uomo. Nell’anima che è caduta e si è incarnato il
ricordo delle sostanze ideali viene risvegliato proprio dalla bellezza. La bellezza fa quindi da
mediatrice tra l’uomo e le idee e al suo appello
l’uomo risponde con l’amore; l’eros diventa
perciò procedimento razionale, dialettica, cioè
ricerca dell’essere in se e unione amorosa delle
anime nell’apprendere e nell’insegnare.
Lo stato e il compito del filosofo
Lo stato ideale e la giustiziaNella più importante opera di Platone, la repubblica, troviamo tutti i temi e i risultati dei dialoghi
riassunti e, ordinati intorno al motivo centrale di una comunità perfetta, la costituzione quindi di
una comunità politica governata da filosofi. Per Platone lo scopo e il fondamento di questa
comunità è la giustizia, nessuna comunità umana infatti può esistere senza giustizia. La giustizia è
la condizione fondamentale della nascita e della vita dello Stato, questo deve essere costituito da
tre classi: quella dei governanti, dei guerrieri e quella dei cittadini. La saggezza è la virtù della
classe dei governanti. Il coraggio è la virtù dei guerrieri e la temperanza è invece la virtù comune a
tutte le classi. La giustizia garantisce l’unità e la forza dello stato, garantendo così l’unità e la forza
anche dell’individuo. Nell’anima individuale Platone distingue tre parti: la parte razionale , la parte
concupiscibile e la parte irascibile.
Caratteri e motivazioni delle classi socialiSecondo Platone lo stato deve per forza essere diviso in classi, in quanto in uno stato vi sono
compiti diversi che devono essere esercitati da individui diversi.
Per quanto riguarda l’appartenenza ad una classe sociale o ad un'altra, Platone divide gli individui
in base alle loro diversità: individui razionali, individui impulsivi e individui al corpo e ai suoi
desideri. Per Platone la divisione degli individui in classi non dipende da un fattore ereditario, ma
da un fattore antropologico e psicologico. Per Platone gli uomini si distinguono tra loro non per
diritti di nascita, ma per differenti attitudini naturali.
5/17/2018 PLATONE - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/platone-55b079c6d4b87 11/17
Nicole Maria Zanon III F 30-04-2012
11
Il comunismo PlatonicoPer un buon funzionamento dello stato e la realizzazione della giustizia, Platone suggerisce
l’eliminazione della proprietà privata e la comunanza dei beni per le classi superiori. I custodi
dovranno avere case piccole e cibo semplice, vivere come accampati e non avere nessun
compenso. L’oro e l’argento saranno proibiti e lo scopo della città è il bene di tutti e non la felicità
di una classe, non dovrà perciò esistere né la ricchezza né la povertà. Allo stesso modo, la classe al
potere non avrà famiglia. Platone ritiene che i governanti debbano avere in comune anche le
donne, ovvero la donna dovrà partecipare alla vita dello stato su un piano di totale parità e
uguaglianza.
I guardiani sono felici?Per Platone la felicità risiede nella giustizia, cioè nell’adempimento del proprio compito, per
l’armonia e la felicità complessiva dello stato.I filosofi, grazie alla loro conoscenza, sono felici già di per sé e non hanno per questo bisogno di
cercare la felicità nei beni materiali.
Le degenerazioni dello StatoLe degenerazioni dello stato corrispondono alle degenerazioni del singolo.
Tra queste:
o La timocrazia, nasce quando i governatori si appropriano di terre e case; a questo tipo di
governo corrisponde l’uomo timocratico, ambizioso e amante del comando e degli onori,
ma diffidente verso i sapienti.
o L’oligarchia in cui comandano i ricchi, a questo corrisponde l’uomo avido di ricchezze.
o La democrazia in cui i cittadini sono liberi di fare quello che vogliono; a questo corrisponde
l’uomo democratico, che non è parsimonioso come l’oligarchico, ma si abbandona ai
desideri.
o La tirannide è la più bassa forma di governo, perché il tiranno, per guardarsi dal l’odio dei
cittadini, deve circondarsi degli individui peggiori. L’uomo tirannico è schiavo delle proprie
passioni ed è il più infelice tra gli uomini.
Platone e la democraziaPlatone critica i sofisti, ma anche gli uomini politici che avevano attuato riforme della città in senso
democratico. Questo negativo giudizio sulla democrazia ateniese, nasce, per Platone, dal desiderio
di ritrovare un modello aristocratico e da un instabilità politica.
L’epoca di Platone è segreta infatti dallo scontro tra gli àristoi e il démos; da questo scontro nasce
una contrapposizione di interessi. Secondo la concezione aristocratica a reggere il governo devono
essere i migliori (àristoi) , non solo per ricchezza ma per virtù e valore personale.
5/17/2018 PLATONE - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/platone-55b079c6d4b87 12/17
Nicole Maria Zanon III F 30-04-2012
12
Invece secondo la concezione democratica a reggere il governo non sono i pochi, ma il popolo.
Con la divisione di classi, nella repubblica si ha la staticità del modello gerarchico di coesistenza
sociale basato su ruoli fissi e nettamente differenti.
Platone giustifica le sue convinzioni sulla disuguaglianza naturale dei cittadini, con quelle che
definisce nobile menzogna; infatti la giustizia in Platone comporta una situazione nella quale igovernanti sono tenuti a governare e i lavoratori a lavorare, senza che tra loro vi siano
interferenze di alcun genere, questo significa che secondo l’organicismo platonico, uno stato è
sano quando ognuno svolge l’attività che gli è propria per il bene di tutti.
In questo modo Platone abbatte la tesi sulla necessità di una gestione comune della cosa pubblica
e contrariamente a Protagora, ritiene che la politica non sia un arte destinata a tutti, ma solo alla
parte aurea della città.
Con il rifiuto della democrazia lo stato assume una fisionomia statalista con regole specifiche. Pur
non essendo democratico lo stato politico non deve essere confuso con lo stato tradizionale;infatti
lo stato della repubblica è aristocratico in quanto chi governa sono i migliori.
Chi custodirà i custodi? L’importanza dell’educazione nella
città platonicaSecondo Platone i custodi prima di custodire gli altri, dovranno essere in grado di custodire se
stessi, questo per il bene comune della città e non per il loro bene personale. Da questo nasce
l’importanza del sistema educativo, lo stato infatti secondo Platone dovrà configurarsi come una
sorta di grande accademia per la formazione di bravi custodi, che se ben addestrati fin dalla
nascita a pensare il bene collettivo saranno sempre all’altezza di agire per il bene dello stato.
Naturalmente Platone per l’educazione al sapere non si riferisce a tutti gli individui, infatti per
l’educazione della classe lavoratrice il filosofo non fa alcun cenno, è convinto che il sapere sia
riservato alle classi superiori.
I gradi della conoscenza e l’educazione L’educazione al sapere corrisponde all’educazione alla filosofia; filosofo è colui che ama la
conoscenza nella sua totalità, perciò per Platone all’essere (cioè alle idee) corrisponde la scienza
che è la conoscenza vera. Al non essere l’ignoranza l’ ignoranza, e al divenire, c he sta in mezzo tra
l’essere e il non essere corrisponde l’opinione che è a metà strada tra conoscenza e ignoranza.
I gradi della conoscenza di Platone sono quattro a cui corrispondono quattro gradi della realtà.
La conoscenza sensibile rispecchia il nostro mondo mutevole e comprende:
- La congettura o immaginazione che ha per oggetto le ombre o le immagini degli oggetti
- La credenza ha per oggetto le cose sensibili.
La conoscenza razionale o scientifica rispecchia il mondo immutabile delle idee e comprende:
-
La ragione matematica che ha per oggetto le idee matematiche- L’intelligenza filosofica che ha per oggetto le idee valori.
5/17/2018 PLATONE - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/platone-55b079c6d4b87 13/17
Nicole Maria Zanon III F 30-04-2012
13
Platone ritiene che la filosofia sia superiore alla ragione matematica, considerata da lui come
scienza suprema in quanto non affronta solo ipotesi indimostrate, ma si occupa anche di problemi
dell’uomo e della città. Questo non esclude che nel sistema di Platone la matematica rivesta una
grande importanza, infatti secondo il filosofo il passaggio della conoscenza sensibile alla
conoscenza razionale matematica si fa mediante l’uso dei metodi di misura.
Il mito della cavernaUno dei miti più noti della repubblica e del platonismo è il racconto della caverna, qui troviamo
soprattutto il dualismo gnoseologico e ontologico, e tratti religiosi che spingono Platone a
guardare il nostro mondo come un regno delle tenebre, contrapposto al regno della luce
rappresentato dalle idee.
Secondo Platone inoltre il ritorno alla caverna fa parte del percorso educativo del filosofo, significa
permettere ciò che si è visto al servizio della comunità e obbedire al vincolo di giustizia. In
conclusione soltanto con il ritorno nella caverna l’uomo avrà compiuto la propria educazione e
sarà veramente filosofo.
La condanna dell’arte imitativa La repubblica è importante anche per la storia dell’estetica che studia i problemi della bellezza e
dell’arte, anche se in quest’opera Platone la esclude dall’educazione dei filosofi. Dal punto di vista
metafisico e gnoseologico la esclude perché ritiene che l’arte sia imitazione di un’imitazione, in
quanto si limita a riprodurre l’immagine di cose e di eventi naturali che sono a loro volta
riproduzione delle idee.
Dal punto di vista pedagogico- politico Platone ritiene che l’arte in generale, sia psicologicamente
e pedagogicamente negativa per il suo potere corruttore sugli animi; l’arte secondo il filosofo
incatena l’animo alle passioni, inoltre raffigura un mondo dominato dal fato escludendo ogni
iniziativa umana. Questa condanna dell’arte non riguarda i miti e per Platone l’arte può esistere
solo in corrispondenza alla filosofia.
Approfondimenti e nuove prospettiveI problemi dell’ultimo Platone
Abbiamo un ulteriore approfondimento delle teorie del filosofo, nei grandi dialoghi della vecchiaia
che rivedendo le proprie dottrine giunge a esiti in parte nuovi; i problemi fondamentali che si
impongono al cosiddetto “ultimo Platone” sono principalmente due:
1. Come dev’essere pensato il mondo delle idee?
2. Come va concepito il rapporto tra le idee e le realtà naturali?
Alla prima questione risponde soprattutto il Sofista, alla seconda soprattutto il Timeo.
5/17/2018 PLATONE - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/platone-55b079c6d4b87 14/17
Nicole Maria Zanon III F 30-04-2012
14
Il confronto con ParmenideNel Parmenide il filosofo si interroga sulla consistenza della teoria delle
idee, rivelandone per bocca di Parmenide, alcune difficoltà.
In primo luogo, posto che “l’uno” è l’idea, mentre “i molti” sono gli oggetti
di cui l’idea costituisce l’unità, non si capisce come l’idea possa essere
partecipata da più oggetti, o diffusa in essi, senza risultare moltiplicata e
quindi distrutta nella sua unità. Inoltre ogni qual volta si considera nella
sua unità una molteplicità di oggetti, si avrà un’idea anche quando si
considererà la totalità di questi oggetti più la loro idea; questa sarà un'altra
idea che considerata a sua volta con gli oggetti e con l’idea precedente,
darà luogo a un'altra idea, sino a continuare all’infinito e questo argomento viene chiamato: “
terzo uomo”.
Ma il problema principale che emerge nel Parmenide è il confronto- scontro con la logica
parmenidea. Platone con la teoria di Parmenide in cui afferma che “ solo l’essere è, mentre il non
essere non è” si rende conto che questa affermazione decreterebbe la morte della teoria delle
idee. Nonostante tutti questi ostacoli, nel Parmenide Platone manifesta di non voler rinunciare alla
teoria delle forme ideali, in quanto ribadisce che senza le idee non si potrebbe neanche pensare e
filosofare. Nel Teeteto Platone dimostra che per definizione adeguata di scienza bisogna rifarsi alle
idee, di conseguenza non rimane che rinunciare al principio eleatico. Nel sofista avviene un vero e
proprio “parmenicidio”.
I generi dell’essere e il problema del nulla Platone per spiegare come possano esistere più idee e come possano comunicare tra loro elabora
la teoria dei “ generi sommi” ovvero degli attributi fondamentali delle idee, che per il filosofo sono
cinque: l’essere, l’identico, il diverso, la quiete e il movimento. Ogni idea è o esiste, e quindi
rientra nel genere dell’essere; ogni idea è identica a se stessa e quindi rientra nel genere
dell’identico. Se ogni idea è identica a sé, ma distinta dalle altre, rientra nel genere del diverso.
Secondo Platone l’errore di fondo del filosofo di Elea è stato quello di confondere il diverso con il
nulla, infatti l’unico modo in cui può esistere il non essere è quello dell’essere diverso, che però, in
quanto tale, non è il nulla assoluto, poiché partecipa anch’esso dell’essere. Platone aggiunge i due
generi della quiete e del moto. Infatti ogni idea può starsene in sé (quiete) oppure entrare in un
rapporto di comunicazione con le altre (movimento).
La nozione generale di “essere” Che cos’è l’essere? Platone ricerca una definizione ancor più generale e universale, e giunge alla
tesi secondo cui l’essere è possibilità. L’essere è possibilità in quanto è tutto ciò che agisce,
subisce ed esiste tutto ciò che può entrare in relazione con qualcos’altro.
5/17/2018 PLATONE - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/platone-55b079c6d4b87 15/17
Nicole Maria Zanon III F 30-04-2012
15
La dialetticaGrazie alla dialettica Platone determina quali idee si connettono tra loro e quali no.
Nella Repubblica la dialettica viene definita come la scienza delle idee-valori; nel Fedro essa viene
presentata come la tecnica stessa del discorso filosofico, il quale si svolge attraverso due momenti:
1. Determinazione e definizione di una certa idea;
2. Divisione dell’idea nelle sue varie articolazioni interne.
L’arte della dialettica è resa possibile dalla comunicazione tra le idee; se tutte le idee
comunicassero tra loro ogni discorso sarebbe vero e non avrebbe più senso la dialettica. Platone
afferma che alcune idee sono combinabili tra loro e altre non lo sono; la tecnica dialettica consiste
nel definire un’idea mediante successive identificazioni e diversificazioni, attraverso un processo di
tipo “dicotomico”, che avanza dividendo per due un’idea, fino ad arrivare a un’idea indivisibile che
ci fornisce la definizione specifica di ciò che cercavamo.
La dialettica infatti:
Si costituisce su base ipotetica, in quanto sceglie una definizione di partenza e poi la mette alla
prova;
Tende a strutturarsi come una ricerca inesauribile e sempre aperta a nuove acquisizioni.
Il bene per l’uomo: il Filebo Platone, nel Filebo, intende stabilire che cos’è il bene per l’uomo. Evidentemente il bene per
l’uomo è una forma di vita e una vita propriamente umana non è né una vita divina, né una vita
puramente animale. La vita umana sarà dunque una vita mista, tra la ricerca del piacere e
l’esercizio dell’intelligenza.
L’indagine morale di Platone si trasforma in un’indagine metafisica a sfondo matematico, poiché
quello che deve essere risolto è un problema di misura. Platone afferma che il piacere è un
illimitato e che a esso bisogna imporre un ordine, o una misura, e questa è la funzione del limite,
ma chi lo impone è l’intelligenza. Quindi della vita dell’uomo devono far parte l’intelligenza, che
sarà la causa dell’ordine e della misura, ma anche il piacere, il quale dovrà essere con un limite.
Platone ritiene che tutta la vita dell’intelligenza debba entrare a far parte della vita umana e che la
scienza dell’essere in sé non è sufficiente, ma bisogna ricorrere anche all’opinione.
In Platone la gerarchia dei valori: al primo posto c’è l’ordine, la misura, il giusto mezzo; al secondo
posto ciò che è proporzionato, bello e compiuto; al terzo posto l’intelligenza; al quarto posto la
scienza e l’opinione; al quinto i piaceri puri.
Il Timeo e la dottrina delle idee-numeri
Il mito del demiurgoNel Timeo viene approfondito il problema cosmologico dell’origine e della formazione
dell’universo.
Per spiegare meglio il rapporto tra le idee e le cose, Platone introduce un terzo termine mediatore:
il demiurgo, una sorta di divino artefice, dotato di intelligenza e di volontà, che si trova in una
5/17/2018 PLATONE - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/platone-55b079c6d4b87 16/17
Nicole Maria Zanon III F 30-04-2012
16
posizione intermedia tra le idee e le cose. All’inizio il mondo
era solo una materia spaziale priva di vita, che Platone
chiama chòra o necessità; il compito del demiurgo essendo
buono e amante del bene era quello di ordinare le cose del
mondo a immagine e somiglianza delle idee.Per rendere questo mondo ancora più simile al suo modello
ideale, il demiurgo ha creato il tempo, misurato dal
movimento degli astri. Nel Timeo tutto ciò che esiste di
positivo e di armonico è dovuto al demiurgo, all’intelligenza
e alle idee, mentre tutto ciò che esiste di negativo e di
disarmonico è dovuto ala materia e alla necessità.
5/17/2018 PLATONE - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/platone-55b079c6d4b87 17/17
Nicole Maria Zanon III F 30-04-2012
17
Bibliografia:
Il nuovo protagonisti e testi della filosofia
Sitografia:
http://aula.forumfree.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale