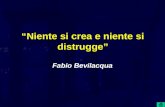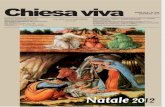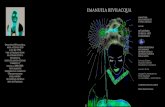Piero Bevilacqua Una scelta di...
Transcript of Piero Bevilacqua Una scelta di...

134
Piero Bevilacqua
Una scelta di campo Dialogo intorno alla Storia del paeSaggio agrario italiano
(a cura Di Stefania Barca)
Autore di testi come Tra natura e storia. Ambiente, economie, risorse in Italia (Donzelli, 1994), La mucca è savia. Ragioni storiche della crisi alimentare europea (Donzelli, 2002), e La terra è finita. Breve storia dell’ambiente (Laterza 2006), Piero Bevilacqua è considerato un punto di riferi-mento imprescindibile della storiografia ambientale italiana. La sua opera affonda le radici nella storia agraria, con il volume Le campagne del Mezzogiorno dal fascismo al dopoguerra (Einaudi, 1980), e con la cura dei tre volumi di Storia dell’agricoltura italiana in età contemporanea (Mar-silio, 1989-91). Con Bevilacqua, studioso tra i primi in Italia ad avvertire la necessità di introdurre una prospettiva ecologica alla storia dell’agricoltura, abbiamo scelto dunque di commentare la ricor-renza dei 50 anni dalla prima pubblicazione della Storia del paesaggio agrario italiano di Emilio Sereni (Laterza, 1961): un libro che esercitò enorme influenza su tutta una generazione di studi rurali e del paesaggio, ma anche sulla nascita della storia dell’ambiente in Italia.
L’interesse della Storia del paesaggio agrario italiano, dal punto di vista storico-ambientale, mi pare evidente fin dalla citazione inizia-le del libro, un passo dell’Elogio degli uccelli di Leopardi, dove si introduce il concetto di natura artefatta: campi lavorati, orti e arboreti, canali e argini, e dunque il paesaggio agrario in quanto prodotto di
lavoro umano mischiato a “natura”. Il libro è poi ricco di richiami al ruolo storico del lavoro umano come fattore di trasformazione della natura, un’idea che è molto presente anche nella tua produzione scientifica di storia dell’ambiente italiano, in particolare nel tuo Tra natura e storia. Altro elemento assai rilevante metodolo-gicamente da un punto di vista storico-ambientale è la percezione del paesaggio agrario come un perenne “in fieri”, prodotto dell’interazione tra modi di produzione, sistemi giuridici, linguaggi, lotte sociali, e non come dato stabile. Il paesaggio «come un fare o come un farsi, piuttosto che come un fatto», scriveva Sereni nell’Introdu-zione. Anche questo concetto è molto presente nella storia ambientale, che nasce come studio delle trasformazioni ecologiche indotte dall’azione umana nel tempo. Per cominciare vorrei quindi chiederti che peso ha avuto il libro di Sereni nella tua formazione e nella scelta di dedicarti alla storia dell’ambiente.
Devo dire che la Storia del paesaggio agrario italiano ha influenzato i miei studi di storia dell’agricoltura più di quanto non abbia direttamente inciso sulle mie ricerche di storia dell’ambiente. È una distinzione di carattere tempora-le, legata alla vicenda del mio percorso di studioso. Anche se poi è difficile – e neppure corretto, nel mio caso – separare nettamente le due sfere di inte-resse. Il fatto è che la lettura dell’opera di Sereni, e soprattutto della Storia del

Vo
Ci
135
paesaggio agrario italiano, è molto precedente (risale agli anni settanta) rispetto ai miei studi degli anni novanta, che hanno messo le trasformazioni ambientali al centro della scena storica. Grazie a Sereni, ad esempio, io ho cercato, nel saggio di apertura della Storia dell’agricoltura italiana, di specificare più analiticamente la nozione di paesag-gio, utilizzando la categoria di “sistema agrario”, più delimitata, ma più pregnante concettualmente per comprendere il nes-so fra modelli produttivi agricoli e forme dell’abitare. I sistemi agrari, per intenderci, sono quelli dell’azienda capitalistica e del-la cascina in pianura padana, la policoltura e il podere delle aree mezzadrili nell’Italia centrale, il latifondo cerealicolo e i borghi d’altura nelle campagne del sud. Tuttavia, come tu giustamente sottolinei nella domanda, nel libro di Sereni è sempre vivo questo nesso – che secondo me risale all’influenza del pen-siero di Marx, conosciuto di prima mano da Sereni – tra il lavoro umano e gli elementi della natura che vengono continuamente plasmati e adattati ai bisogni sociali. Questa capacità di scorgere sempre la presenza dell’opera dell’uomo nella modificazione dei quadri naturali credo che abbia agito in me come antidoto contro una visione superficialmente “naturalistica” della storia ambientale. Mi ha per così dire aiutato ad avere un punto di vista fondativo per tutti i miei studi. Così come credo mi abbia influenzato nel guardare con equilibrio all’azione umana nell’habitat. Non sempre essa è semplicemente distruttiva. Il fatto che, come nel nostro caso, sia stata capace di realizzare le forme del paesaggio agrario italiano ne è una prova di ine-guagliabile esemplarità.
Un elemento metodologico importante, direi centrale, del libro, era la scelta di pri-vilegiare un particolare tipo di fonte, l’opera d’arte, e dunque particolari tipi di lin-guaggio – quello pittorico, quello poetico, quello letterario – quali espressione e fonte legittima di informazioni sull’evoluzione del paesaggio agrario italiano. Il paesaggio agrario di Sereni, e questo mi pare l’elemento più originale e creativo della sua opera, è una unità espressiva in cui le diverse componenti specialistiche della storia agraria – tecniche, sistemi giuridici, sistemi colturali, etc. – tendono a ricomporsi «nell’unità del processo storico», come scriveva l’autore. Direi che questo aspetto metodologico è forse quello meno sondato nella storia ambientale finora, e non solo in quella italia-na – a parte qualche eccezione; per lo meno nulla di comparabile con i risultati che altre discipline, specialmente la geografia culturale e l’eco-criticismo, hanno prodotto

136
in questo senso, sulla scorta di autori come Denis Cosgrove o Raymond Williams. Come vedi l’uso della fonte iconografica e di quella letteraria nella storia ambientale italiana? Avresti suggerimenti da dare a chi volesse intraprendere questo tipo di ricerca?
Nelle sue opere propriamente storiche Sereni, che disponeva di una erudi-zione sterminata, ha spesso voluto privilegiare, in maniera a volte necessa-ria, a volte per scelta mirata, un ambito specifico del suo vasto sapere. Ad esempio, egli ha utilizzato le sue conoscenze linguistiche per indagare Le tecniche e la nomenclatura del cavallo e la circolazione etnica e culturale nella step-pa euroasiatica («Studi storici», n. 3, 1967, pp. 455-533) o Per la storia delle più antiche tecniche e della nomenclatura della vite e del vino in Italia («Atti e memorie dell’accademia toscana di scienze e lettere La Colombaria», 1964, pp. 75-204). Anche se in questo caso il privilegiare le fonti linguistiche è reso necessario da ovvi problemi documentari, viste anche le epoche remote indagate. In altre ricerche storiche, come ad esempio nel saggio I Napoletani da “mangiafo-glia” a “mangiamaccheroni” («Cronache meridionali», n. 4, 1958, pp. 272-295, n. 5, 1958, pp. 351-377 e n. 6, 1958, pp. 398-422), Sereni fa le sue scorribande, in maniera quasi esclusiva, nelle fonti letterarie. Ricostruisce la trasformazione dell’alimentazione dei napoletani tra medioevo ed età moderna utilizzando soprattutto poemi, liriche, opere teatrali, trattati, rinunciando quasi delibe-ratamente a utilizzare altri documenti. La Storia del paesaggio agrario italiano, com’è noto, privilegia le immagini, l’iconografia – anche quella, per la verità, di cabrei e catasti – la pittura, le raffigurazioni della piccola e grande arte pittorica italiana. Naturalmente, il lettore esperto si accorge del vasto fondo culturale che sorregge l’uso delle fonti iconografiche, e di quale non esibita competenza di carattere giuridico, tecnico e agrario è intessuto il racconto delle trasformazioni secolari dei nostri quadri paesaggistici. Tutto questo insieme di saperi, come tu giustamente ricordi, vengono chiamati a rico-struire l’“unità del processo storico”, ma sono come messi a servizio del-la rappresentazione iconografica. Una parzialità che ha tratto in inganno anche qualche grande. Fernand Braudel ha definito, infatti, la Storia del pae-saggio agrario italiano uno “schizzo”. Giudizio riduttivo che nasce anche dal carattere di grande divertissement di questo testo. Mi è capitato di riflettere spesso su tale aspetto. Io credo che Sereni, considerandosi essenzialmente un dirigente politico, ed essendo fuori dall’accademia, abbia deliberatamen-te assunto un atteggiamento esterno rispetto al corso degli studi correnti, da grande “dilettante”, privilegiando di volta in volta parte del suo vasto sapere.Certamente le fonti iconografiche possono essere utilizzate molto proficua-mente per la storia del paesaggio. Penso a come esse potrebbero darci con-to delle trasformazioni radicali che le nostre campagne hanno subito nella seconda metà del Novecento. Tra raffigurazioni pittoriche e rilevazioni con

Vo
Ci
137
fotografie aeree si potrebbero creare cataloghi documentari unici nel loro genere.
La Storia del paesaggio agrario italiano è stata spesso considerata un pilastro fondante della storia ambientale italiana, specialmente quella di matrice agraria, e penso che molte delle cose dette finora chiariscano i motivi di questa associazione. D’altra parte, la storia ambientale rappresenta anche un momento di forte rottura con la tradizione italiana degli studi agrari. Il motivo va ricercato, a mio parere, nella diversa sensibilità che i due filoni di studio esprimono nei confronti del rapporto tra società e ambiente. In Sereni, l’ambiente “naturale” – il paesaggio delle campagne – è espressione dei rapporti sociali di produzione e delle colture ad essi associate, e non – come la storia ambientale propone – soggetto storico con una propria rilevanza, proprie dinamiche, propri equilibri, che risultano di fondamentale importanza per comprendere la stessa evoluzione sociale. Insomma, la storia ambientale pare essere nata dal superamento dell’idea stessa di “paesaggio” verso un più esplicito uso del concetto di “ecologia”. Eppure il paesaggio è parte ineludibile dell’evoluzione storico-ambientale ed infatti ritorna frequentemente nel lavoro di chi fa storia dell’ambiente, non solo in Italia. Insomma, come vedi il rapporto tra questi due termini? Come si è evoluto questo rapporto nella storiografia italiana degli ultimi 50 anni, e che prospet-tive vedi per il futuro in questo campo?
Tutto vero. Nel concetto di paesaggio manca il bios, la vita. Certo, al suo centro c’è sempre l’uomo, ma l’uomo lavoratore, che è soprattutto un essere sociale. Il fatto è che le scienze ecologiche ci hanno messo a disposizione conoscenze che prima nessuno storico, né Marc Bloch né Sereni possedeva-no. Per gli storici del paesaggio, il bosco e la macchia sono elementi del qua-dro agrario, con una propria ragione economica e una origine storica. Oggi sappiamo che il bosco è anche un ecosistema, con una propria complessità di vita. La nozione di biodiversità fa gettare uno sguardo sistemico anche nel mondo della vita. Così i pascoli, il suolo agricolo ci si presentano oggi come ecosistemi, con cui gli animali e gli uomini interagiscono. C’è dietro al paesaggio – come dietro al termine ancora più generico e polisemico di ter-ritorio – un mondo vivente che prima non veniva osservato né registrato.Per rispondere all’ultima parte della domanda direi che le due strade non si sono incontrate. Da una parte c’è la storia del paesaggio – poca, per la verità, almeno da parte degli storici – e dall’altra c’è la storia dell’ambiente. Occorre dire, tuttavia, che non la storia, ma gli studi sul paesaggio si sono moltiplicati in Italia e come sgranati in una molteplicità di discipline, in cui sono impegnati architetti, geografi, agronomi, ecologi, ecc. Si tratta a mio avviso di contributi importanti e innovativi, ma che ancora non trovano una sintesi più generale.

138
Vengo alla parte del libro che più attiene al tema generale di questo volume di «Zapruder», quello sui paesaggi agrari dell’Italia contemporanea (ossia, l’Italia degli anni cinquanta). Sereni sottolineava come l’abolizione del latifondo avesse significato la fine del paesaggio “ad erba e campi”, cioè del maggese nudo improduttivo, il fami-gerato “incolto”, e come per questa via la redditività dell’agricoltura italiana fosse aumentata nel corso degli anni cinquanta grazie all’introduzione di piante foraggere, colture industriali, impianti arborei e dell’allevamento moderno stabulare. Sereni credeva però che vi fosse ora una eccessiva frammentazione della conduzione agraria (il “paesaggio dei campi a pigola”), foriera di “disgregazione” sociale e di “regresso” dall’agricoltura arativa al pascolo, al bosco e di qui allo spopolamento e abbandono rurale. Sereni attribuisce le cause di quest’ultimo fenomeno alle politiche economiche dei governi democristiani e della comunità europea, che comportavano un enorme incremento dei costi e della competizione, a svantaggio della proprietà coltivatrice diretta, e auspicava l’aggregazione dei produttori in entità cooperative di grande dimensione in grado di apportare i cambiamenti tecnici necessari a “modernizzare” l’agricoltura italiana. Sei d’accordo con questa lettura della “grande trasformazione” dell’agricoltura italiana? Quali elementi aggiungeresti a questo quadro delle trasfor-mazioni degli anni cinquanta? Che cosa hanno significato quelle trasformazioni per i diversi agro-ecosistemi italiani?
Sì, sono d’accordo con il quadro di ragioni che ha fornito Sereni. Certo ci sarebbero da aggiungere, oggi, anche le trasformazioni culturali (non col-turali) che hanno investito il nostro paese. A un certo punto i redditi forni-ti dal lavoro industriale, i contratti agrari svantaggiosi nelle campagne, lo standard scadente dei servizi nella società rurale hanno spinto le popola-zioni agricole all’abbandono. A un certo punto la città, il cemento, il mondo dell’industria sono diventati i valori dominanti, quelli che rinviavano ad uno stile di vita superiore e la campagna è apparsa come il luogo dell’arre-tratezza e della miseria. Tutto ciò ha portato all’abbandono di ogni cura del paesaggio anche in luoghi in cui non si è verificata alcuna modernizzazione, o trasformazione in senso industriale dell’agricoltura.Per quanto riguarda la modificazione ambientale, certamente la più colos-sale alterazione è stata operata dal fascismo nelle paludi pontine. Un ecosi-stema di terre ed acque che durava da alcuni millenni è stato trasformato in una piatta pianura agricola. Ma anche dopo la seconda guerra mondiale gli ecosistemi che probabilmente hanno subito le maggiori modificazioni sono quelli sottoposti a bonifica. Penso alle “valli” della pianura padana raccon-tati da Piero Brunello e ad altri “ambienti umidi” consimili.
Un’ultima domanda: il libro di Sereni si concludeva con una celebrazione delle lotte contadine della fase del dopoguerra come principale fattore di trasformazione del paesaggio agrario in senso “democratico e socialista”. Quale bilancio storico è pos-

Vo
Ci
139
sibile secondo te fare di quella fase e dei suoi effetti di lungo termine sull’agricoltura italiana? E soprattutto, sarebbe possibile oggi riscrivere la storia delle lotte sociali nelle campagne in un modo capace di includere la dimensione ecologica? Cosa impli-cherebbe questa riscrittura, in termini metodologici?
Non è facile rispondere a questa domanda. Personalmente sono troppo inter-no alla storia tradizionale di queste vicende. Credo che sia difficile comun-que per chiunque finché non si produce un’accumulazione di informazioni di tipo nuovo su quel mondo. Voglio dire che noi dovremmo prima di tut-to ricostruire i saperi del mondo contadino, una pagina grandiosa ma mai scritta del lavoro umano. Eppure, i contadini che per diecimila anni hanno nutrito l’umanità, lo hanno potuto fare grazie a un insieme di conoscenze tramandate e continuamente arricchite che erano saperi ecologici. Come si comportavano certi semi, in certi terreni, che cosa era possibile coltivare in montagna o in pianura, quanto durava la vita di una coltivazione, ecc.; erano informazioni che riguardavano la natura e quel che da essa si poteva cavare. La storia di questi saperi applicati, che corrisponde allo Stoffwechsel mit der Natur, lo scambio materiale con la natura di cui parla Marx, difficile da farsi, capovolgerebbe molte prospettive del nostro modo di affrontare il passato e potrebbe dar vita a nuove e inesplorate pagine di ricerca e di conoscenza.