Per Petrarca politico: Cola di Rienzo e la questione ... · veda il Saggio critico sul Petrarca, a...
Transcript of Per Petrarca politico: Cola di Rienzo e la questione ... · veda il Saggio critico sul Petrarca, a...
49
Per Petrarca politico:Cola di Rienzo e la questione romana
in Bucolicum Carmen v, Pietas pastoralisdi Enrico Fenzi
1. Le pagine assai suggestive che De Sanctis ha dedicato al confronto tra Dante e Petrarca hanno avuto grande successo. Nonostante alcune avvertenze in contra-rio di Carducci, esse sono infatti all’origine della tenace e scolastica vulgata che, fatta salva l’eccezionale qualità dei risultati poetici, vede Petrarca come l’arche-tipo del letterato italiano asservito al potere, chiuso nell’asfittico mondo del suo egotismo lirico e intimamente alieno, dietro spessi fumi di retorica, sia da ogni dimensione o ideale politico, sia dai faticosi rigori della dimensione speculativa del pensiero. Del resto, ancora Contini ne proiettava l’immagine contro quella di Dante e parlava, nel per altro splendido saggio Preliminari sulla lingua del Petrarca, della sua «fioca potenza speculativa», e della mancanza, in lui, di «ca-pacità riflessiva»1.
Che le cose non stiano proprio così, lo direi ormai evidente: ma è altrettanto evidente che gli sparsi tratti che dovrebbero contribuire alla creazione di una nuova immagine di Petrarca hanno ancora bisogno di tempo per dare corpo a un ritratto alternativo che sostituisca il vecchio e ne erediti l’efficacia. Una delle vie da percorrere sta proprio in una migliore considerazione della sua riflessione politica, spesso di sorprendente acutezza a dispetto del vero e proprio vituperio di De Sanctis, e la cosa emerge oggi tanto più vera dal momento che proprio il “Petrarca politico” ha cominciato a essere oggetto di studi innovativi2.
1. Il saggio, del 1951, è ora in G. Contini, Varianti e altra linguistica. Una raccolta di saggi (1938-1968), Einaudi, Torino 1970, pp. 169-92 (le parole citate, pp. 174 e 191). Di F. De Sanctis si veda il Saggio critico sul Petrarca, a cura di N. Gallo, con introduzione di N. Sapegno, Einaudi, Torino 1964, in particolare pp. 37-45.
2. Uno dei migliori saggi su Petrarca “politico”, dopo quello alquanto trascurato ma a parer mio meritevole di maggior considerazione di R. De Mattei, Il sentimento politico del Petrarca, Sansoni, Firenze 1944, è quello di F. Gaeta, Dal Comune alla corte rinascimentale, cap. iii, Pe-trarca: un apolide disponibile e fortunato, in La Letteratura italiana, dir. da A. Asor Rosa, vol. i, Il letterato e le istituzioni, Einaudi, Torino 1982, pp. 149-255: 197-215, insieme a quelli di M. Feo, Petrarca ovvero l’avanguardia del Trecento, in “Quaderni petrarcheschi”, 1, 1985, pp. 1-22; Id., Il poema epico latino nell’Italia medievale, in I linguaggi della propaganda, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, Milano 1991, pp. 3-72: 66-72; Id., L’epistola come mezzo di propaganda politi-ca in Francesco Petrarca, in Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento, Convegno internazionale organizzato dal Comitato di studi storici di Trieste, dall’École Française de Rome e dal Dipartimento di Storia dell’Università degli Studi di Trieste (Trieste, 2-5 marzo 1993), a cura di P. Cammarosano, École Française de Rome, Roma 1994, pp. 203-26 (si veda qui, pp. 209
50
In tutto questo, la vicenda di Cola di Rienzo e il ruolo in essa di Petrarca occupano un posto importante, non foss’altro perché segnano la definitiva crisi dei rapporti con la famiglia Colonna e, di là da essa, il ridimensionamento di quelli con la Curia papale, e hanno gran peso nel determinare quella scelta filo-viscontea che segnerà tutta la seconda metà della vita del poeta. Ma non è né di “Petrarca politico” in generale né dell’intera complessa vicenda di Cola di Rienzo che ora si vuole parlare. Piuttosto, mirando appunto a un insieme ancora in gran parte da ricomporre, vorrei qui limitarmi all’analisi di un testo esemplare e (questa è la mia opinione) davvero straordinario, quale è l’egloga v del Bucoli-cum Carmen, Pietas pastoralis, diretta a Cola intorno alla metà di agosto del 1347, nel pieno dunque della avventura romana del tribuno che si giocò nell’arco di pochi mesi, dal maggio al dicembre di quell’anno.
Il racconto di quell’avventura è già stato fatto molte volte, ma qui va assai sommariamente richiamato sia per ripetere alcuni essenziali dati di fatto, sia per aggiungere qualche precisazione intorno alla parte che spetta a Petrarca3. Il 20
ss., una analisi delle lettere di Petrarca a Cola); Id., Politicità del Petrarca, in Il Petrarca latino e le origini dell’umanesimo. Atti del Convegno internazionale (Firenze, 19-22 maggio 1991), in “Quaderni petrarcheschi”, 9, 1992, pp. 115-28. Ma si veda pure E. Sestan, L’Italia del Petrarca fra “tante pellegrine spade”, ora in Id., Scritti vari, ii, Italia comunale e signorile, introduzione di M. Berengo, Le Lettere, Firenze 1989, pp. 205-29, mentre dedica un’attenzione specifica alla caratteristiche nuove dell’«eroe intellettuale» impersonato da Petrarca il saggio di G. Bàrberi Squarotti, L’intellettuale e la storia: i versi “politici” del Petrarca (1974), Il Melangolo, Genova 1978, pp. 71-103. Una significativa ed esplicita correzione del ritratto tracciato da De Sanctis, sia pur per linee generali e all’interno di un discorso di tipo celebrativo, è invece in R. Manselli, Pe-trarca nella politica delle signorie padane alla metà del Trecento, in Petrarca, Venezia e il Veneto, a cura di G. Padoan, Olschki, Firenze 1976, pp. 9-22. Ma questi e altri saggi sono stati da ultimo aggiornati attraverso una forte rivendicazione del carattere propriamente e consapevolmente politico di molti dei pronunciamenti petrarcheschi: si vedano in particolare il ricco contributo di D. Bigalli, Petrarca: dal sentimento alla dottrina politica, in Motivi e forme delle «Familiari» di Francesco Petrarca. Atti del Convegno (Gargnano del Garda, 2-5 ottobre 2002), a cura di C. Ber-ra, Cisalpino, Milano 2003, pp. 99-118; G. Baldassari, “Unum in locum”. Strategie macrotestuali nel Petrarca politico, led, Milano 2006; Petrarca politico. Atti del Convegno (Roma-Arezzo, 19-20 marzo 2004), Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Roma 2006 (si veda qui la ricostruzione del dibattito sul Petrarca politico, pp. 13-28 dell’Introduzione), e, particolarmente importante, G. Ferraù, Petrarca, la politica, la storia, Centro Interdipartimentale di Studi Umanistici, Mes-sina 2006. Per quanto mi riguarda, ho sempre avuto speciale interesse per questo tema: tra altre cose, mi permetto di rinviare a un saggio di imminente quanto ritardata pubblicazione negli Atti del Convegno fiorentino del 2004 (il volume di Ferraù è uno sviluppo della relazione tenuta dallo studioso in quella stessa occasione), e alla rapida visione d’insieme che con qual-che ambizione di novità ho cercato di dare nel “profilo” Petrarca, il Mulino, Bologna 2008, in particolare pp. 37-45, mentre all’analisi di un caso concreto quale quello della scelta viscontea di Petrarca ho dedicato il saggio Petrarca a Milano: tempi e modi di una scelta meditata, in Petrarca e la Lombardia. Atti del Convegno di studi (Milano, 22-23 maggio 2003), a cura di G. Velli, M. Vitale, Antenore, Padova 2005, pp. 221-63, seguito dall’altro: Ancora sulla scelta filo-viscontea di Petrarca e su alcune sue strategie testuali nelle «Familiares», in “Studi petrarcheschi”, n.s., xvii, 2004, pp. 61-80.
3. Via via sarà data altra bibliografia, ma è subito obbligato il rinvio a K. Burdach, P. Piur, Briefwechsel des Cola di Rienzo, vol. ii dell’opera di K. Burdach, Vom Mittelalter zur Reforma-tion. Forschungen zur Geschichte der deutschen Bildung, diviso in quattro tomi (il primo dei qua-li diviso in due parti): il terzo (Weidmann, Berlin 1912) contiene l’edizione critica delle lettere
51
maggio, approfittando della lontananza da Roma di Stefano Colonna, Cola di Rienzo convocò il popolo in Campidoglio e in un eloquente discorso attaccò la nobiltà locale, colpevole del degrado della città; propose una nuova costituzione che avrebbe dato ampi poteri al popolo e ottenne la signoria di Roma promoven-do una serie di riforme: il tutto con la formale approvazione del vicario aposto-lico, il vescovo di Orvieto Raimond de Chameyrac. Mentre in Roma Cola impo-stava una lunga serie di misure interne e papa Clemente vi sembrava favorevole alla nuova situazione, Petrarca esprimeva, nel giugno, tutto il suo entusiasmo in una lunga lettera diretta a Cola e al popolo di Roma, la famosa Hortatoria4, che costituisce un testo fondamentale per la piena comprensione della nostra egloga. Del luglio è una seconda lettera a Cola (Disp. 9 = Var. 38), che di nuovo lo esorta a perseverare nel suo programma e gli promette ogni possibile aiuto, ma insieme comincia a dare un quadro realistico della situazione, e consiglia al tribuno la massima vigilanza e autocontrollo, specie nei confronti della Curia. Un ulterio-re affiorare di preoccupazioni è in una lettera successiva, da collocare intorno alla metà di agosto (Disp. 10 = Var. 40). Qui Petrarca dice di essersi ritirato a Valchiusa anche per sfuggire all’ambiente della Curia e all’ostilità crescente che incontrava il suo aperto appoggio alla causa di Cola; manifesta poi i suoi timori e, ricorrendo alla narrazione di un sogno, mette in guardia il tribuno da chi è disposto a tutto pur di rovinarlo5. A queste stesse settimane risale anche la com-posizione dell’egloga, inviata a Cola insieme alla Disp. 11 (= Var. 42), che gliene forniva la spiegazione (configurando così un caso analogo all’altro, che riguarda la prima egloga, Parthenias, mandata al fratello Gherardo insieme alla Fam., x 4, che la illustrava). Anche in questa lettera d’accompagnamento Petrarca ripete d’essersi ritirato a Valchiusa, e aggiunge:
Pertanto ho aggiunto un capitolo al carme bucolico che l’estate scorsa avevo com-posto in questa stessa valle: o meglio, per non usare in faccende poetiche altro che
di Cola di Rienzo e di quelle a lui di Petrarca (alle pp. 87-99 è edita e annotata anche l’egloga v, Pietas pastoralis, insieme alla Disp. 11 che l’aveva accompagnata al tribuno); il quarto Anhang (Weidmann, Berlin 1912) contiene con altre cose un fondamentale repertorio di fonti relative a Cola (Urkundliche Quellen zur Geschichte Rienzos, pp. 1-219), ivi comprese le lettere papali, e di Petrarca le Fam., vii 1; 6; xiii 6; Sine nom. 4. Per la vita di Cola, si veda il volume di P. Piur, Cola di Rienzo (1931), trad. it., Treves, Milano 1934 (la traduzione è di Jeanne Rohr, moglie di Federico Chabod), e il recente che lo affianca e lo aggiorna di T. di Carpegna Falconieri, Cola di Rienzo, Salerno, Roma 2002 (ma un ottimo profilo è anche quello di Jean Claude Maire-Vigueur in Dizionario biografico degli italiani, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 1982, vol. 26, pp. 662-75; dello stesso, si veda ora il recente volume L’autre Rome. Une histoire des Romains à l’époque communale (XIIe-XIVe siècle), Tallandier, Paris 2010, per un ampio e chiaro quadro storico complessivo). Per quanto riguarda Petrarca, assai utile è la documentata rassegna di testi nel volume, The revolution of Cola di Rienzo, ed. by M. E. Cosenza, second edition with new Introduction and Bibliography by R. G. Musto, Italica Press, New York 1986.
4. Disp. 8 (= Var. 48), che cito come le altre della raccolta: Disp., numero e pagina, dall’edi-zione: F. Petrarca, Lettere disperse, a cura di A. Pancheri, Fondazione Pietro Bembo-Ugo Guan-da, Parma 1994.
5. L’analizza bene, anche in relazione alla nostra egloga, Ferraù, Petrarca, la politica, la storia, cit., pp. 27-8.
52
parole poetiche, ho aggiunto un’egloga. E poiché le regole di un genere siffatto mi proibiscono di uscire dalle selve, ho fatto che i due fratelli germani che ne sono gli interlocutori fossero pastori: e quest’egloga appunto mando a quell’uomo coltissimo che tu sei quale sollievo dai tuoi molteplici impegni6.
Intanto Cola aveva proseguito e allargato la sua azione: aveva invitato, nel lu-glio, i rappresentanti di tutte le maggiori città d’Italia nella prospettiva di una loro libera unificazione; aveva abbozzato una politica estera che riproponeva il ruolo centrale di Roma e la sua vocazione imperiale; aveva proclamato il dirit-to del popolo ad eleggere l’imperatore, restituendo ad esso quel potere che il ritrovamento della Lex de imperio divi Vespasiani gli aveva rivelato essere stato anticamente suo; aveva usato la mano pesante contro lo strapotere anarchico e feudale delle grandi famiglie nobili, fatte colpevoli del degrado nel quale Roma era caduta, e ne aveva aggredito i privilegi. Ma era anche entrato in inevitabile collisione, sia a Roma che nel distretto, con la politica e gli interessi papali mi-nacciando in prospettiva l’esistenza stessa di uno “Stato della Chiesa”. Alcuni suoi atteggiamenti si prestavano, del resto, ad essere facilmente criticati e la voce che fosse un pazzo megalomane cominciò a circolare negli ambienti a lui ostili: speciale scandalo suscitò soprattutto la sua investitura di cavaliere accompagna-ta dall’immersione nel fonte nel quale si credeva che l’imperatore Costantino fosse stato battezzato7, e le cerimonie che l’accompagnarono sino alla solenne incoronazione del 15 agosto (nell’occasione, in un fastoso décor di tipo imperiale rifatto sui modelli dell’antica Roma, egli ricevette in successione sei corone, di quercia, d’edera, di mirto, d’alloro, d’olivo e d’argento), che ne consacrava il titolo di tribunus augustus.
Alla fine d’agosto, proprio come Petrarca aveva facilmente previsto, la si-tuazione comincia a volgere rapidamente al peggio. Clemente vi, superata ogni remora, passò all’offensiva e le percosse con le quali venne accolto in Avignone, il 1° di settembre, un ambasciatore di Cola furono il segno inequivocabile che le ostilità erano ormai aperte8. In questa situazione anche a Roma il clima si
6. «Igitur ad Carmen Bucolicum quod estate altera eadem valle cecineram, unum capitu-lum, sive, ut in re poetica non nisi poeticis utar verbis, eglogam unam addidi, et quoniam illius lege carminis silvas exire prohibeor, duos pastores eosdem, germanos fratres, colloquentes feci, quod tibi, Vir studiosissime, multiplicum curarum tuarum solatio transmisi» (Disp. 11, p. 96).
7. Cola sul punto si difende e contrattacca in una lettera del 17 settembre a Rinaldo Orsini e, negli stessi termini, in una lettera a Clemente vi dell’11 ottobre (Burdach, Piur, Briefwechsel, cit., vol. ii, t. 3, pp. 147-8, 163-4).
8. L’episodio è riferito dallo stesso Cola, nella lettera del 17 settembre a Rinaldo Orsini ap-pena sopra citata: «Giorni fa, passata la Durenza, al nostro messaggero che si recava alla Curia furono prese e strappate le nostre lettere; la verga che portava gli fu spezzata in testa; la borsa per documenti che portava al fianco gli fu ugualmente sottratta e rotta, e gli fu detto di riferire che la stessa cosa sarebbe successa a ogni altro nostro messaggero. E così, spogliato di tutto e col capo pieno di sangue, è tornato da noi» («Cursori nostro pridie cum literis nostris ad Curiam venienti ultra Durenciam fuerunt ablate litere et laniate, virga quam ferebat in capite sibi fracta, cassula, quam portabat lateri, ablata pariter et confracta, et dictum sibi mandatum esse, quod singulis nostris cursoribus ita fiat. Et sic vacuus ad nos rediit capite cruentato»; ivi, p. 150). Si veda P. Piur, Petrarcas «Buch ohne Namen» und die päpstliche Kurie, Niemeyer, Halle 1925, pp.
53
fece più avvelenato che mai, sino al famoso episodio del 15 settembre, quando Cola imprigionò per una notte i capi delle famiglie nobili romane accusati di congiurare contro di lui e li condannò a morte, ma al mattino, quando tutto era pronto per l’esecuzione, li perdonò e li rimandò a casa carichi di doni. Questo comportamento fu unanimemente giudicato come una fatale prova di debolez-za (lo farà più tardi anche Petrarca, nella Fam., xiii 6, 11-13, del 1352), né valse a rallentare il fallimento di Cola la vittoria riportata il 20 novembre alla porta di San Lorenzo sulle truppe dei Colonna, che lasciarono sul terreno ben quattro dei loro: Stefano il Giovane e suo figlio Giovanni, Pietro di Agapito e Pietro si-gnore di Belvedere9. è significativo, infatti, che proprio dopo la vittoria un Cola ormai scoraggiato e in grave crisi anche personale accettasse i primi di dicembre le dure condizioni impostegli sin dall’ottobre da Clemente vi e allora rifiutate: dopodiché il 15 del mese, sempre più sfiduciato, abdicò e fuggì, finendo per trovare riparo prima nel Napoletano sotto la protezione di Luigi d’Ungheria10, e poi tra i francescani spirituali della Maiella. I sette anni che seguirono, sino al suo ritorno al potere nell’agosto del 1354 e la sua uccisione, in ottobre, sono ancora ricchi di avvenimenti e di interesse, ma sono anche, ormai, altra cosa, nel senso che non si sollevano oltre la sua personale vicenda né sanno rianimare quel sogno che aveva affascinato Petrarca e che nell’autunno del 1347 s’era in-teramente consumato.
La Dispersa 11 e l’egloga Pietas pastoralis, abbiamo visto, sono state scrit-te nell’agosto, e sono gli ultimi documenti della fase che potremmo chiamare ascendente, quando l’azione del tribuno sembrava travolgere ogni ostacolo e l’adesione di Petrarca era ancora piena e incondizionata. Nelle Sine nomine 2 e
325-6. Con questo passo ha sicura relazione l’inizio della seconda delle Sine nomine: F. Petrarca, Liber sine nomine, traduzione e cura di L. Casarsa, introduzione di U. Dotti, Aragno, Torino 2010, pp. 14-6: «Nuovo tipo di tortura aggredire, come se fosse un nemico, un fanciullo solo, indifeso e innocente; pestare, sino a frantumarle sulla sua testa incolpevole, sia la verga che – se fossero assennati – avrebbero dovuto rispettare e temere, sia la piccola cassetta piena zeppa di lettere importantissime; infine fare a pezzi e sparpagliare quelle lettere che avrebbero potuto ammansire cuori di pietra. Ecco l’ospitalità, ecco l’amore per gli altri! Catturato sulla Durenza, torturato, picchiato, inibitogli l’ingresso in città, il tuo messaggero, che aveva subìto percosse e ferite e anche minacce, è tornato ai tuoi piedi con la testa insanguinata» («Novum genus sevitie, puerum incomitatum, incautum, innocentem hostiliter aggredi; virgam quam, siquid sani esset et vereri et timere debuerant, capsulam quoque gravissimis ac suavissimis literis refertam in caput immeritum donec utrunque frangeretur, allidere; ipsasque literas, que marmoreos ani-mos mollire potuissent, discerptas effundere! En hospitalitas, en caritas! Ad Durentiam captus, tortus, flagellatus et civitatis ingressu prohibitus, nuntius tuus minasque cum verberibus ac vulneribus refertus, ad pedes tuos vertice cruentato rediit»).
9. Si vedano il resoconto che Cola fa al Comune di Firenze, lo stesso 20 novembre, con l’elenco dei Colonna uccisi e degli altri nobili fatti prigionieri (Burdach, Piur, Briefwechsel, cit., vol. ii, t. 3, pp. 175-81), e la particolareggiata narrazione che ne fa l’Anonimo romano, Cronica, a cura di G. Porta, Adelphi, Milano 1981, pp. 144-50. Si veda pure G. Villani, Nuova cronica, a cura di G. Porta, Fondazione Pietro Bembo-Ugo Guanda, Parma 1991, vol. iii, pp. 522-4 (xiii 105).
10. Cfr. ivi, p. 524: «Il tribuno veggendosi così abandonato, sconosciuto uscì di Campido-glio, e vennesene in Castello Sant’Agnolo, e là nascosamente si dimorò fino alla venuta del re d’Ungheria a Napoli, a·ccui si dice andò per mare sconosciuto in su uno legno». Si veda anche Di Carpegna Falconieri, Cola di Rienzo, cit., pp. 139-40.
54
311, del settembre, nulla d’essenziale sembra mutare, ma il voltafaccia della Curia impone toni e considerazioni diverse. Petrarca ribadisce il proprio appoggio e di continuo ripete i propri eloquenti appelli affinché Cola prosegua sulla sua via: «Tu, uomo illustre che hai avuto pietà del nostro stato, rimetti in piedi la patria che già si sta sollevando e mostra agli increduli che cosa ancora possa Roma! […] Gloriosamente hai cominciato: ora, affronta con forza, affronta con costan-za quel che resta!»12, ma deve dar conto che esiste ormai un nemico dichiarato, il papa e la Curia, che portano la responsabilità delle percosse all’ambasciatore, e che si sono esplicitamente pronunciati contro il progetto di unificare Roma e l’Italia, perché dannoso agli interessi della Chiesa (Sine nom. 3). In questo caso, tuttavia, riferendo tale presa di posizione, l’indignazione di Petrarca è tale che per un momento, in questa seconda e ultima delle Sine nomine a Cola, s’espone con un estremo scatto d’orgoglio e di coraggio: «fallo sapere con le mie stesse parole», dice al tribuno, «al popolo romano, affinché capisca cosa hanno deciso circa la nostra salvezza questi nostri capi»13.
Ma questa fase, che obbliga Petrarca a una scelta radicale tra Cola e i suoi sempre più numerosi e forti nemici, non dura, e quasi di colpo, senza che ci resti testimonianza di passaggi intermedi, da settembre a novembre tutto cam-bia. Nella Fam., vii 1, esplicitamente datata all’11 settembre, diretta a Barbato, Petrarca lamenta in forme assai dure che un’avanguardia di “barbari”, e cioè parte delle truppe di Luigi d’Ungheria (il quale sarebbe entrato in Italia solo nel dicembre), avesse posto l’assedio a Sulmona, patria dell’amico, e si prepa-rasse a invadere tutto il Regno e Napoli in particolare, per vendicare l’assassinio del giovane principe Andrea, fratello di Luigi e marito della regina Giovanna, avvenuto nel settembre 134514. Preoccupato per la sorte di Barbato, Petrarca si
11. Piur, Petrarcas «Buch ohne Namen», cit., pp. 167-73 (qui la discussione sulla loro data, pp. 325-8); cfr. anche Petrarca, Sine nomine. Lettere polemiche e politiche, a cura di U. Dotti, Laterza, Roma-Bari 1974, pp. 17-35. Ma si veda ora la recente edizione gà citata, anch’essa con traduzione a fronte, a cura di L. Casarsa, pp. 14-31, dalla quale cito. Sulla collocazione delle due lettere all’interno della raccolta delle Sine nomine, si vedano le preziose indicazioni e ricostru-zioni di G. Baldassari, «Familiarium rerum liber» e «Liber sine nomine», in Motivi e forme delle «Familiari», cit., pp. 723-60: 744 ss., saggio poi rielaborato e ampliato nel volume dello stesso studioso “Unum in locum”, cit., Parte prima, pp. 31 ss.
12. Sine nom. 2, 9-10: «Tu vero res nostras miserate, vir illustris, erige surgentem patriam et gentibus incredulis, quid nunc etiam Roma possit, ostende! […] Ingressus es gloriose. I fortiter, i constanter ad reliqua!».
13. Sine nom. 3, 6: «Quod tu, queso, vir eloquentissime, cum primum, ut soles, in publico perorabis, populo romano meis verbis nuntia, ut intelligat que sunt horum procerum de nostra salute sententie».
14. Sull’assassinio di Andrea (avvenuto con la complicità, pur se mai provata, della mo-glie, la regina Giovanna), si veda la Fam., vi 5, anch’essa a Barbato, forse dell’agosto 1346, nella quale, compiangendo la sorte del giovane principe, Petrarca, non a caso, tace comple-tamente della regina, sua moglie. Per quanto riguarda, invece, la data della lettera in que-stione, ci sono state alcune incertezze. Petrarca scrive infatti come corra voce che Sulmona sia caduta in mano degli Ungheresi (§ 5: «Sic iam in extremum adducta referuntur; iam Sulmonem primo belli impetu calcatum in ditionem hostium pervenisse fama est»), cosa che avvenne, pare, solo in ottobre, se non addirittura in dicembre (ne abbassa dunque la data A. Foresti, Petrarca e la casa in Parma, in Aneddoti della vita di Francesco Petrarca, nuova
55
dichiara pronto a raccomandare l’amico presso Cola onde trovargli una nuova sistemazione a Roma, mostrando così di considerare tuttavia solida la posizione del tribuno. Non in maniera troppo convinta, però, dato che, in rapida alterna-tiva, gli offre ospitalità presso la propria casa in Parma, e vista una certa aria di generale pessimismo che avvolge la lettera.
Poi il silenzio, sino alla Fam., vii 5, a Lelio, del 22 novembre, scritta ex itinere, e cioè dopo la partenza da Avignone e durante il viaggio verso Geno-va. Unica probabile e parziale eccezione è la lettera/documento di Barbato, Romana Res Publica Urbi Rome, che sembra trattenere qualche elemento della Fam., vii 1 a lui diretta15: lettera notabile soprattutto per l’entusiasmo e, occorre pur dire, l’ingenuità con la quale Barbato raccomanda per Roma una sorta di diarchia formata dalla “mente”, Petrarca, e dal “braccio”, Cola (pp. 52-3, rr. 117-8: «quecunque Laureatus consulit Tribunus exsequatur»). Del resto, chiudendo la lettera, lo stesso Barbato sembra lasciar trasparire un’ombra di realismo, preoccupandosi di affidare a Roma la custodia e in-somma l’incolumità di Cola dinanzi all’insorgere di possibili minacce: che era un riconoscere implicitamente che di fronte al suo isolamento politico-diplomatico solo la sua base strettamente cittadina poteva offrirgli qualche garanzia di conservare il potere (pp. 58-9, rr. 210-4). Naturalmente non ab-biamo alcuna risposta di Petrarca a questa che poteva suonare addirittura come una provocazione. Abbiamo invece, nella lettera a Lelio, il completo voltafaccia di Petrarca, che di colpo si chiama fuori. Ora, tutto è mutato e ogni speranza è persa:
edizione a cura di A. Tissoni Benvenuti, con una premessa di G. Billanovich, Antenore, Padova 1977, p. 163, n 12; prima edizione 1928). Ma le voci avranno ingigantito la realtà di un assedio che pare fosse cominciato già nell’agosto, e tutto suggerisce di non correggere la data dell’11 settembre: si vedano in particolare F. Rizzi, Francesco Petrarca e il decennio parmense (1341-1351), Paravia, Torino 1934, p. 271, n 161, e E. H. Wilkins, Studies in the life and works of Petrarch, The Mediaeval Academy of America, Cambridge (ma) 1955, pp. 225-7. Interessa segnalare che nella versione originale della lettera figuravano particolari espressioni d’elogio verso Cola, poi attenuate nella redazione definitiva. Là dove ora si legge (§ 9): «Gratiam, fateor, non mediocrem apud tribunum, stirpe humili sed excelso virum animo propositoque, et apud populum Romanum habeo», abbiamo le varianti: «Gratiam refero non mediocrem apud tribunum stirpe humili sed excelso virum animo potissimoque divinum illum virum et heroicum et apud populum romanum», e «Gratiam fateor non mediocrem apud tribunum divinum illum virum et heroicum et apud populum» (si veda l’apparato dell’edizione critica di V. Rossi, Sansoni, Firenze 1934, vol. ii, pp. 96-7).
15. La lettera di Barbato, conservata unicamente nel ms. Corsiniano 33. E. 27, ff. 64v-70r, è stata illustrata la prima volta da R. Weiss, Barbato da Sulmona, Petrarca e la rivoluzione di Cola di Rienzo, in “Studi petrarcheschi”, iii, 1950, pp. 13-22 (per il ms. si veda Id., Il primo secolo dell’umanesimo. Studi e testi, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1949, p. 62, n 59). è stata pubblicata in Lo scrittoio degli umanisti, a cura di G. Papponetti, vol. i, Barbato da Sulmona fra Petrarca e Boccaccio, Deputazione abruzzese di Storia patria, L’Aquila 1984, pp. 67-74 (le parole citate, p. 70, ll. 130-131). Ma si veda ora l’edizione e le importanti annotazioni di C. M. Monti, La Res publica romana scrive alla città di Roma, in “Studi petrarcheschi”, n.s., xvii, 2004, pp. 38-60 (la convincente corrispondenza di un passo di Barbato con la lettera di Petrarca è segnalata a p. 50, n 38).
56
Ho visto, ho letto e mi ha stupito la copia della lettera del tribuno che mi hai manda-to. Non ho che rispondere. Sono consapevole del destino della patria, e dovunque mi volgo trovo ragioni e materia per soffrire. Distrutta Roma, quale sarà la condizione dell’Italia? Sconvolta l’Italia, come sarà la mia vita futura? In questo lutto pubblico e privato qualcuno rimedierà con le ricchezze, altri con la forza del corpo, altri con il potere, altri ancora con la saggezza. Io non vedo a cosa altro potrei ricorrere se non alle lacrime16.
Ripeto: molti anelli mancano (nelle prime righe della Disp. 9 Petrarca ma-nifesta a Cola l’intenzione di scrivergli ogni giorno) e ciò rende ancora più drammatico il salto. Per esempio, non sappiamo quale lettera di Cola Petrarca abbia visto, ma qualche ragionevole congettura, col senno del poi, è possibile. A Lelio, Petrarca ha scritto durante il viaggio dalla Provenza all’Italia: aveva infatti lasciato Avignone, avendo come meta finale Verona e Parma17. Arriva-to a Genova, il giorno 29 scrive direttamente a Cola la discussa Fam., vii 7, con la quale si congeda da lui. Lo accusa di aver rovinato quel che di buono aveva costruito; di essere cambiato e di essersi messo al servizio dei peggiori (diventando «satellitem reproborum»); gli fa ambiguamente capire che non lo avrebbe raggiunto a Roma, come avrebbe avuto in animo di fare, e insomma lo lascia al suo destino:
Ma perché sto a torturarmi? Le cose andranno come il destino da sempre ha stabilito. Non posso cambiarle, ma posso fuggirle: così, mi hai risparmiato una gran fatica. Con tutto il mio animo mi dirigevo verso di te, e ora cambio strada: certo, non vedrò te cambiato. E addio a te, Roma: se quelle cose sono vere, me ne andrei piuttosto in India, o dai Garamanti18.
è chiaro che Petrarca ha portato a termine la propria operazione di sgan-ciamento da Cola. E l’ha portata a termine pochi giorni dopo le morti dei Colonna a porta San Lorenzo, delle quali in ogni caso egli evita di parlare (una lettera consolatoria, la Fam., vii 13, sarà inviata da Petrarca al cardinale Giovanni Colonna solo nella primavera successiva). Ma a chi egli allude con quei “malvagi” che nella trama della lettera gli forniscono l’alibi più concreto e forte? Ecco, credo stia qui la chiave per tornare alla lettera di pochi giorni prima a Lelio, e, in essa, alla misteriosa lettera di Cola della quale il medesimo Lelio aveva fornito copia al poeta che tanto n’era rimasto turbato. Credo, una
16. Fam., vii 5, 6: «Tribunitie litere copiam, quam michi misisti, vidi legi stupui; quid respon-deam non habeo. Fatum patrie agnosco, et quocumque me verto, dolendi causas materiamque reperio. Roma enim lacerata, qualis Italie status? Italia deformata, qualis mea vita futura est? In hoc publico et privato merore, alii opes, vires alii corporeas, alii potentiam, alii consilium conferent; ego quid conferre possim preter lacrimas non video».
17. Ripeto che mi tengo all’essenziale. Più precisi dettagli su questa fase complessa della vita di Petrarca in U. Dotti, Vita di Petrarca, Laterza, Roma-Bari 1987, pp. 176-90.
18. Fam., vii 7, 9: «Quid autem torquebor? Ibunt res quo sempiterna lex statuit; mutare ista non possum, fugere possum. Itaque non parum michi negotii remisisti: ad te animo propera-bam, flecto iter, certe te alterum non videbor. Tu quoque longum vale, Roma: si hec vera sunt, Indos ego potius aut Garamantes petam».
57
lettera che documentava in maniera irrefutabile l’alleanza del tribuno con Luigi d’Ungheria19.
Nella Fam., vii 1 a Barbato, del settembre, Petrarca aveva continuato a ma-nifestare fiducia in Cola, come abbiamo visto, mentre si scagliava, con striden-te contraddizione, contro l’invasione dei “barbari” ungheresi dai quali proprio Cola s’aspettava aiuto. Ora, da tempo si stavano stringendo rapporti tra Cola e Luigi d’Ungheria, e Petrarca non poteva non esserne al corrente. L’8 luglio Cola riferiva per la prima volta a Clemente vi di aver ricevuto due distinte ambascerie «offerentes eorum potenciam vestro Romano populo»: una dalla regina Gio-vanna e l’altra dal re d’Ungheria («recepi eciam ambaxiatores regine Ihoanne ac vicarii regis Ungarie Aquile permanentis»), e quasi incidentalmente aggiungeva più avanti, verso la fine della lettera, di aver già stretto rapporti più concreti con il vicario regio, che già comportavano un abbozzo di alleanza20. Ed è appunto in questa seconda direzione che le cose andarono avanti, come mostra un poscritto del 5 agosto a una lettera al papa del 27 luglio. Qui, Cola riferisce apertamente d’aver ricevuto il giorno prima da parte del vicario regio l’offerta di cinquecento cavalieri ungheresi da lui stipendiati da inquadrare tra le truppe di Roma e la proposta di ospitarne altri mille: cosa ch’egli dice di non aver accettato: «Ego vero id nolui acceptare, ymmo renuncciavi expresse» (ai cinquecento e ai mille, o solo ai mille, come par di capire?), dichiarando altresì, mentendo spudorata-mente, d’averlo fatto per favorire una “altra parte” non meglio specificata, che non può essere altro che quella della regina Giovanna e, in definitiva, del papa medesimo21. Si arriva, così, alla seconda metà di settembre, quando arriva a Roma un’ambasceria solenne attraverso la quale Luigi d’Ungheria avrebbe chiesto tre cose: la solidarietà fattiva di Cola nella condanna degli assassini di Andrea, l’alle-anza con lui («amiciciam et ligam perpetuam») e infine il libero ingresso in Italia.
19. J. Macek (Pétrarque et Cola di Rienzo, in “Historica”, xi, 1965, pp. 5-51) pensa che questi malvagi siano gli esponenti della nobiltà feudale, prima combattuti, ai quali Cola avrebbe finito per cedere. E questa è l’opinione corrente: si veda U. Dotti, La città dell’uomo. L’umanesimo da Petrarca a Montaigne, Editori Riuniti, Roma 1992, pp. 144 ss. Ma quali esponenti? Si ricordi che Petrarca scrive queste parole pochi giorni dopo la strage dei Colonna a porta San Lorenzo, quando nulla poteva far immaginare ch’egli avesse mutato linea nei confronti della nobiltà ro-mana: ci sono gli Orsini, certo, sin dall’inizio piuttosto vicini a Cola, e ad essi pensa infatti A. Rehberg, Clientele e fazioni nell’azione politica di Cola di Rienzo, Roma nel Rinascimento (coll. RR inedita, 33/i), Union Printing, Roma 2004, pp. 131-2, e con lui Ferraù, Petrarca, la politica, la storia, cit., pp. 23, 36 ss., che accenna appunto ad «ambigui legami con la parte orsina». Ma questa non era certo una notizia dell’ultima ora, tutt’altro, né tale da spiegare – sarebbe stato un ben misero alibi – il voltafaccia di Petrarca. Continuo dunque a credere all’alleanza di Cola con Luigi d’Ungheria, entrato proprio in quei giorni in Italia e dal tribuno atteso con favore. Sui tempi della discesa in Italia di Luigi, si veda Villani, Nuova cronica xiii 107-112, pp. 526-47: partenza dall’Ungheria il 3 novembre; il 26 novembre a Udine; il 10 dicembre a Modena; il 13 a Forlì; il 20 a Foligno; a L’Aquila per il Natale; a Benevento l’11 gennaio; il 17 ad Aversa e il 24 a Napoli, dopo che la regina Giovanna era fuggita per mare alcuni giorni prima. Ne ripartirà alla fine del maggio 1348, allo scoppiare della grande peste.
20. Burdach, Piur, Briefwechsel, cit., vol. ii, t. 3, pp. 47-8, ove appunto Cola parla di amba-sciatori mandati a L’Aquila e di ottimi rapporti con il vicario che assicura loro la possibilità di recarsi a Napoli presso la regina Giovanna con la quale gli ungheresi erano in guerra.
21. Ivi, p. 116.
58
Questa è la versione che Cola stesso ne dà al papa, in una lettera più tarda, dell’11 ottobre, continuando a mentire. Avrebbe infatti risposto:
Alla prima richiesta la risposta mia e di questo vostro popolo romano fu questa, che ad essi e a tutti quelli che reclamano giustizia, noi non l’avremmo negata. Alla seconda, che noi accettiamo l’amicizia di tutti coloro che amano la giustizia, ma che assolutamente non potevamo e neppure volevamo stringere un’alleanza con loro sen-za che la Vostra Santità ne fosse informata e ce ne desse il mandato, e ancora, senza aver consultato le varie città d’Italia confederate e concordi con il popolo di Roma: ad esse questo vostro popolo ed io abbiamo mandato apposite ambascerie. Di tutto ciò sarà quello che la Vostra Santità vorrà sia fatto22.
Tutto questo almeno a me apre la strada al sospetto che Petrarca si sia finto a bell’apposta così naïf da esaltare il tribuno e vituperare il suo prossimo alleato ungherese precisamente per predisporsi una via d’uscita (pur non essendo in discussione la sincerità delle sue preoccupazioni per la sorte dell’amico Barba-to). Come che sia, è anche vero che egli non perse, o riconquistò, la fiducia di Clemente vi, che il 13 novembre conferì a Petrarca la carica di proprio inviato facendolo latore di una lettera a Mastino della Scala, precisamente intesa a otte-nere che costui ostacolasse l’ingresso del re ungherese in Italia23. Sì che, arrivan-
22. Ivi, pp. 167-8: «Ad quorum primum responsum per me et ipsum vestrum Romanum populum ita fuit, quod eis et omnibus iusticiam petentibus non denegabamus eandem; ad alia vero, quod non recusabamus amiciciam alicuius iusticiam diligentis, ligam tamen facere cum eis minime poteramus, nec eciam volebamus absque Sanctitatis vestre consciencia et mandato, et eciam non consultis aliquibus civitatibus Italie confederatis et Romano populo coniunctis, ad quas idem vester populus et ego ambassiatam direximus specialem. De quibus omnibus fiet quod Sanctitas vestra mandabit». Ma il Villani, Nuova cronica, xiii 105, p. 521): «Nel detto anno [1347], all’entrante d’ottobre, ambasciatori del re d’Ungheria vennero a Roma profferendosi al tribuno e popolo di Roma, il quale a grido di popolo il detto re d’Ungheria fu ricevuto a·llega e compagnia del popolo di Roma». Anche Clemente vi, che temeva sopra ogni cosa la calata in Italia di re Luigi e aveva preso decisamente partito per la regina Giovanna, naturalmente non gli credeva, e ripetutamente nelle sue “istruzioni” andava ripetendo che Cola «nelle sue parole non è amico della verità, ma mente senza arrossire, quasi avesse faccia da prostituta» (al legato Bertrand di Deux, il 12 novembre, in Burdach, Piur, Anhang, cit., p. 82: «in verbis suis non habet sociam veritatem, sed, quasi frons meretricis ei facta sit [Ier 3, 3], sine rubore mentitur»). Poco avanti in questa stessa lettera, infatti, egli afferma d’aver appreso per via confidenziale ma sicura («fidedigna quorundam insinuatione percepimus») che quelle ambascerie che Cola, come ab-biamo visto, dice d’aver mandato a vari comuni, avevano lo scopo non confessato di assicurare il libero transito di re Luigi attraverso l’Italia (si veda anche la nota seguente).
23. Su questa missione veronese, che comportava per Petrarca la qualifica di inviato papale, si veda C. Cipolla, Sui motivi del ritorno di Francesco Petrarca in Italia nel 1347, in “Giornale storico della letteratura italiana”, xlvii, 1906, pp. 253-65 (qui, pp. 256-7, il testo della lettera del papa a Mastino, con la menzione di Petrarca quale suo inviato). Si veda anche Wilkins, Studies on the life and works of Petrarch, cit., pp. 17-8. Già in una lettera precedente, del 15 settembre, a Bertrand di Deux il papa dava istruzioni affinché si impedisse in ogni modo il temuto transito delle truppe ungheresi facendo debite pressioni su Mantova, Bologna e sul patriarca d’Aquileia, e in particolare si cercasse ancora di indurre Cola a passare dalla parte della regina Giovanna, facendo insieme mutare posizione a molti nobili romani che avevano offerto il loro aiuto al re d’Ungheria (Burdach, Piur, Anhang, cit., p. 57).
59
do a Genova e dovendo proseguire per Verona con quella missione da compiere, Petrarca, che fino a quel punto era probabilmente riuscito a giocare su due tavoli (poiché scrive a Cola che non l’avrebbe raggiunto a Roma, come avrebbe avuto intenzione di fare, possiamo immaginare ch’egli avesse almeno fatto balenare agli occhi del tribuno questa possibilità), non poteva ormai fare altro, accam-pando questo o quel motivo, che rompere con Cola. E il motivo – ripeto ancora, l’alleanza con Luigi d’Ungheria, che avrebbe trasformato il “Tribuno Augusto” in un semplice “satellite” di un re straniero – era certamente all’altezza della situazione.
Ma, tra tanti e discutibili elementi, ripeto, due sono quelli che vorrei qui trattenere. Uno, particolare: «se tu, Cola, non ti curi di te stesso», scrive Pe-trarca, «preoccupati almeno per me; sai quale tempesta mi minacci e quanti mi saranno addosso con i loro rimproveri, se comincerai a scivolare»24. L’altro, generale: «ma perché tormentarmi? Le cose andranno come una legge eterna ha stabilito: mutarle non posso, ma posso fuggirle»25. Ora, per il primo punto, non sappiamo quali rischi Petrarca abbia corso davvero, ma che egli temesse di correrne sembra sicuro. Con ragione, del resto, vista la profondità della sua spaccatura con i Colonna e la radicale contrapposizione alla politica della Curia alle quali il suo appoggio a Cola l’aveva portato. Al proposito, occorre ri-cordare che egli aveva preso proprio in quei mesi un’iniziativa ch’è ben rivela-trice delle tensioni del momento e dell’articolata strategia delle sue mosse. Il 9 settembre 1347 (si badi alla data!) aveva infatti presentato una supplica a papa Clemente vi, chiedendo di potersi ritirare a vivere presso la certosa di Mon-trieux (ma questa certosa non è esplicitamente nominata), pur senza diventare monaco e conservando le sue rendite. Il documento, presente nell’Archivio Segreto Vaticano, nel Registro delle suppliche, non ha nulla a che spartire con la dimensione letteraria: è in tutto e per tutto un documento di vita che, collocato in quel preciso frangente, non può essere inteso se non come una mossa tattica fatta per tranquillizzare, dopo le pur recenti fiammate, tanto il Colonna che il papa sui limiti del suo impegno in favore di Cola26. E almeno a me sembra più che plausibile che questa mossa (del 9 settembre, ripeto, e cioè due giorni prima della lettera a Barbato) non possa che confermare il sospetto sopra avan-zato, che anche l’attacco virulento contro l’alleato di Cola facesse già parte di una accorta strategia di rientro.
Il secondo punto, per la verità, allude a un discorso più generale che oltre-passa i limiti di questo intervento. Mi basta tuttavia accennare che la frase citata
24. Fam., vii 7, 13: «si – quod opinari nequeo – tuam fortasse negligis, at saltem fame mee consule; scis quanta michi impendeat procella, quanta, si labi ceperis, in caput meum reprehen-sorum turba conspiret».
25. Fam., vii 7, 9: «Quid autem torqueor? Ibunt res quo sempiterna lex statuit: mutare ista non possum, fugere possum».
26. Si veda l’analisi del documento (ma senza alcun cenno all’idea che io me ne sono fatto) di Wilkins, Studies in the life and works of Petrarch, cit., pp. 13-5. Aggiungo che è singolare la corri-spondenza tra il documento e le esortazioni che il personaggio di Monico (il fratello Gherardo) rivolge al poeta in Parthenias, la prima egloga del Bucolicum Carmen.
60
mi sembra illuminante, tanto più se la si accosta ad una analoga già rivolta a Cicerone, nella seconda delle lettere a lui dirette, Fam., xxiv 4, 2 (probabilmente del 1345), rimproverandolo della sua vanità e della sua incostanza:
[…] nella tua vita cerco invano solo la fermezza d’animo, la ricerca della quiete ch’è necessaria a chi vuole far professione di filosofo e la fuga dalle guerre civili, quando la libertà è morta e la repubblica già sepolta e compianta27.
La parola-chiave, qui e là, è «fuga»: la fuga che diventa un obbligo morale quan-do, dinanzi al venir meno delle speranze, il “filosofo” deve tornare a se stesso e riscoprire nell’isolamento dello studio la sua natura di ospite e testimone della storia, non di attore28. Anche nell’egloga viii, Divortium, pur essa scritta allora, nel 1347, partendo da Avignone per l’Italia e lasciando il papa, «protervo pa-store», e sciogliendosi polemicamente dal servizio presso il cardinale Giovanni Colonna, Petrarca chiede al vecchio, intrattabile e aspro padrone di permetter-gli di fuggire: «tollera misericordiosamente la giusta fuga alla quale mi sento obbligato»29. Petrarca, dunque, fugge dai vecchi legami di servitù: «Com’è triste un servo invecchiato! Sia dunque libera la mia vecchiaia: la giovinezza da servo è alle spalle, e una libera morte metta fine a una vita da schiavo»30, e fugge dalla trappola in cui l’impegno in favore di Cola stava per farlo cadere, e risolve così, in un colpo solo, le contraddizioni che si erano andate accumulando e avevano finito per esplodere, esemplarmente, nella crisi di quei mesi. Ancora, nella Sine nom. 11, scritta all’inizio del 1352 a Rinaldo Cavalchini, Petrarca dichiara all’ami-
27. Fam., xxiv 4, 2: «neque tamen in vita tua quicquam preter constantiam requiro, et phi-losophice professioni debitum quietis studium et a civilibus bellis fugam, extincta libertate ac sepulta iam et complorata republica».
28. Non posso trattenermi dal citare un passo dalla Repubblica di Platone, 496c5, che lar-gamente prefigura l’atteggiamento di Petrarca e illustra quanto sto cercando di dire: quando la città è irrimediabilmente in rovina «colui che fa parte di questi pochi [filosofi] e che ha gustato la dolcezza e la felicità di un simile bene, resosi conto della pazzia dei più, del fatto che nulla vi sia di sensato nel comportamento di nessun uomo politico e del fatto che non vi sono alleati con cui intrapprendere la difesa della giustizia, senza esporsi alla morte; quando simile a un uomo caduto in mezzo a belve feroci, al furore delle quali egli rifiuta di associarsi, senza per altro essere in grado di tener testa da solo a quell’orda selvaggia, è quindi sicuro di morire prima di aver servito la sua città o i suoi amici, senza profitto né per l’una né per gli altri; dopo aver riflettuto su tutto ciò, egli si astiene dall’agire e non si occupa che dei propri affari, e come un viaggiatore sorpreso dalla tempesta ripara dietro a un muro dal turbine di polvere e di pioggia sollevata dal vento, allo stesso modo, nel vedere gli altri traboccare di ingiustizia, egli si ritiene fortunato di trascorrere l’esistenza quaggiù puro dall’ingiustizia e dall’empietà e di uscire dalla vita nella speranza, con serenità e pace dell’anima» (ha attirato la mia attenzione su questo passo P. Hadot, Che cos’è la filosofia antica? [1995], Einaudi, Torino 1998, p. 92). Anche Seneca elogia Lucilio per la sua intenzione di ritirarsi a vita privata, a dispetto di quel che parrebbe imporre la morale stoica. Solo a determinate condizioni, infatti, il saggio si impegnerà nella vita politica: «Nec ad omnem rem publicam mittimus nec semper nec sine ullo fine» (Epist., 68, 1 ss.). E gioverà per contro ricordare che Cicerone patisce come un “male minore” l’otium filosofico al quale la situazione lo costringe: si veda De officiis, iii 2-3.
29. Più o meno, renderei così il v. 19: «Quin iustam permitte fugam, et miserere coacti».30. Buc. Carm., viii 27-9: «Triste senex servus! Sit libera nostra senectus. | Serva iuventa retro
est; servilem libera vitam / mors claudat».
61
co che unica soluzione per entrambi è quella di fuggire dalla pestifera Avignone: «Nel mezzo di tante tenebre non vedo cos’altro serva a te e a me oltre la fuga»31, e nella 13, nell’aprile dello stesso anno, di fronte a quella «spelonca di ladroni» che è diventata la Curia, ripete: «Io non ho nient’altro da poter opporre a tante forze contrastanti tranne la compassione dovuta alla madre [la Chiesa] e, come vedi, un’opportuna fuga con la quale liberare i miei occhi da uno spettacolo così triste»32.
Questi passaggi sono decisivi nel mostrare che secondo Petrarca l’intellettua-le può e anzi deve difendersi dagli irrimediabili disastri del mondo e dai pericoli che incombono ritirandosi nello studium, e dunque volgendosi a ciò che davvero ci si aspetta da lui e che intimamente gli appartiene e definisce la natura della sua condizione. Lo ripeterà, del resto, e in forme particolarmente eloquenti, nella famosa lettera a Stefano Colonna prevosto di Saint-Omer, Fam., xv 7, anch’essa scritta nella prima metà dell’aprile 1352 e dunque in prossimità della fuga verso la Milano dei Visconti, nella quale passa in rassegna la situazione politica dell’Italia e dell’Europa e a fronte di un panorama così tragico ripropone quel suo grande motivo della “fuga” del sapiente che certo non esaurisce il discorso sull’impe-gno in senso lato politico, ma ne costituisce un polo importante, in un modo o nell’altro sempre sottinteso:
Fa quello che fanno gli uomini puliti, e non solo gli uomini ma anche alcuni animali di pelo candido che hanno paura della sporcizia e che, uscendo dalla tana, se vedono che il terreno attorno è lordo di fango, ritraggono il piede e tornano a riparare nel loro nascondiglio. Così anche tu, se non trovi da alcuna parte ove avere quiete e riposo, rientra nella tua camera e torna a te stesso: veglia con te, parla e taci con te, passeggia con te, fermati con te, e stai certo che non sei solo se stai con te […]33.
La partita doppia che Petrarca gioca tra l’impegno politico e lo “studio” (o la “fuga” nello studio, se si preferisce) è insomma costitutiva del suo essere, non un espediente della sopravvivenza: sì che, a questo punto, all’appropriata defi-nizione di lui come ospite nelle stanze del potere potremmo sostituire quella, altrettanto provvisoria, di testimone consapevole. Testimone degli avvenimenti
31. Sine nom. 11, 11 (ed. cit., p. 102): «Ego enim tantis in tenebris quid tibi aut etiam quid michi preter fugam expediat non video».
32. Sine nom. 13, 4 (ed. cit., p. 118): «ego enim nichil habeo quod tam multis contraniten-tibus prestare possim, preter commiserationem matri debitam et michi placitam – ut vides – fugam, qua oculos meos tam mesto liberem spectaculo». Accenna a questo tema nelle due Sine nomine Baldassari, Familiarium rerum libri, cit., pp. 750-1 (poi in “Unum in locum”, cit., pp. 66 ss.).
33. Fam., xv 7, 19-20: «Fac quod nitidi quidam homines solent, nec homines tantum sed candida quedam animalia sordesque timentia, que ubi cavernulis egressa loca circum ceno obsita conspexerint, pedem retrahunt et intra latibulum suum se recipiunt. Tu quoque nul-lum quietis ac solatii locum toto orbe reperiens, intra cubiculi tui limen et intra te ipsum redi; tecum vigila tecum loquere tecum sile tecum ambula tecum sta, ne dubita solus esse, si tecum es […]». Per la data della lettera (1352, con aggiunte nel 1356), si veda E. H. Wilkins, The making of the «Canzoniere» and other petrarchan studies, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1951, pp. 326-8.
62
che lo sovrastano ma, entro quegli avvenimenti, anche e necessariamente custo-de di sé e, potremmo addirittura dire, del proprio “io politico”, cioè di quella dimensione esistenziale dell’io con la quale la politica si misura e dalla quale trae i suoi valori (direi, addirittura, che all’interno di un tale “io politico” si debba far rientrare anche il suo tanto studiato “io lirico”). In ciò, credo che Petrarca sia il primo, entro la nostra cultura, che rinnovi nel profondo l’idea stessa della politica spostandone il centro di gravità dai contenuti sovrapersonali, normativi e istituzionali che sino a quel punto ne avevano orientato la percezione, verso un’esigenza strettamente personale di felicità alla quale la politica o corrisponde o non è nulla, ed è insieme pericoloso e inutile occuparsene. E se “di felicità” può parere troppo, si dica almeno “di pace”, perché è senz’altro la pace, per quanto minacciata o relativa essa sia, che Petrarca ha sempre chiesto alla po-litica, di là dagli specifici regimi, dal comunale al tirannico (anche quello dei Visconti), ch’egli non sa e non vuole giudicare se non in quanto garanti o meno delle elementari condizioni di pace, appunto, che permettano agli uomini una vita anche solo minimamente felice.
Ora, è vero che simili considerazioni rinviano a un discorso più ampio, che investa l’insieme dell’esperienza petrarchesca e la sappia leggere in tutta la ric-chezza dei suoi movimenti e dei suoi molti risultati. Ma quanto s’è appena ac-cennato può essere facilmente riportato al momento che ci interessa: dopo tutto, siamo partiti da una citazione dall’egloga Divortium, e cioè dal testo nel quale, lasciando Avignone per l’Italia nel novembre del 1347, e affrontando il medesimo viaggio che lo porterà prima a Genova e poi a Verona e a Parma e che lo vedrà giocare abilmente la partita del divortium da Cola, Petrarca contestualmente di-chiarerà il proprio divortium dai principali nemici di Cola e, fino a ieri, dai suoi principali protettori: i Colonna e il papa e la Curia tutt’intera. La breve intensa stagione della partecipazione all’avventura di Cola non è dunque finita in un binario morto: addirittura, si direbbe che, nel momento in cui ci si immergeva con sincero entusiasmo e correndo consapevolmente qualche rischio, Petrarca riuscisse a tenere ben salde le fila di un gioco diverso, e insomma che si preparas-se a usarne. Come se la puntata altissima e però del tutto virtuale della restaura-zione della Roma imperiale servisse a ottenere la concreta essenziale vincita della propria personale libertà.
2. Molto, naturalmente, sarebbe ancora da dire, ma basti questa sommaria traccia per tornare finalmente all’egloga, che va collocata, ripeto, in una fase nella quale Petrarca ancora sente di dover dare il proprio contributo ideologico-politico alla causa di Cola. La Disp. 11, abbiamo detto, l’accompagnava al tribuno e la spie-gava chiarendo molti punti particolari (la sua parte esegetica sarà dunque via via citata per intero nelle note al testo). Nello stesso tempo, proprio le spiegazioni di Petrarca suscitano qualche perplessità quando si voglia mettere a fuoco il nucleo propriamente politico del suo discorso, sempre interessante e in alcuni casi as-sai penetrante. I due interlocutori, Marzio e Apicio, rappresentano quella casta nobiliare che sino a quel punto era stata l’effettiva padrona di Roma e la causa non secondaria del suo degrado (specificamente, Marzio rappresenta i Colonna,
63
e Apicio gli Orsini): essi discutono sul modo migliore di aiutare la vecchia madre in difficoltà (Roma, appunto), e manifestano opinioni divergenti, sino a che non interviene un terzo personaggio, Festinus, e dunque “Veloce”, o “Impaziente” (un uccello o la Fama stessa che corre veloce, come dice Petrarca), che zittisce i due come inconcludenti chiacchieroni e annuncia che proprio Cola, il loro disprezzato fratello minore, ha già preso in mano la situazione e sta restituendo la madre all’antico splendore. Le parti sono distribuite con grande oculatezza, in modo tale che i tre personaggi (s’intende che il terzo sia Cola, anche se non compare direttamente) rappresentino tre modi profondamente diversi di porsi dinanzi al problema. Ma è appunto questo rapporto che, soprattutto nel caso di Marzio, ma parzialmente anche in quello di Apicio (con Festinus non ci sono problemi), non sembra correttamente rappresentato nella lettera sì da generare, al suo stesso interno, una palese inconguenza.
Restiamo per un momento a Marzio. Caratterizzato nella lettera come bel-licoso e inquieto – il nome stesso lo dice34 –, si distinguerebbe dal fratello per essere devoto alla veneranda madre Roma («erga genitricem pius et sibi compa-tiens») e per volere a tutti i costi ritrovare l’antica unità, convinto com’è che la città può ancora tornare potente e recuperare l’antica sapienza a lungo nascosta per timore dei tiranni. Così, letteralmente, Petrarca, che presenta Marzio come personaggio positivo, antagonista rispetto al “voluttuoso” e inerte Apicio35, e finisce dunque inevitabilmente per indebolire il ruolo di Festinus (e dietro lui di Cola), visto che non è tanto chiaro come costui possa accomunare entro il me-desimo aspro rimprovero entrambi i fratelli. Ma non è solo la coerenza interna della lettera a soffrire di tale interpretazione della figura di Marzio: lo è anche, infatti, il puntuale contenuto dell’egloga. Qui Marzio, è vero, a tutta prima non pare connotato negativamente e addirittura si potrebbe avere l’impressione che
34. François e Bachmann (F. Pétrarque, Bucolicum Carmen, texte latin, traduction et com-mentaire par Marcel François et Paul Bachmann, avec la collaboration de François Roudaut, préface de Jean Meyers, Champion, Paris 2001, p. 315, n 35) ricordano che Petrarca, in Fam., iii 4, 1, qualifica di «bellacissimus vir» Stefano Colonna il giovane, vincitore nel 1333 in uno scontro con gli Orsini a Castel Cesareo, e ucciso il 20 novembre 1347 a porta San Lorenzo (G. Billanovich, Un carme ignoto del Petrarca, in “Studi petrarcheschi”, n.s., v, 1988, pp. 101-25: 104 ss.).
35. Onde coerentemente il Piendibeni a proposito dei vv. 22-3: «mostra che gli Orsini hanno sempre trascurato lo stato, dandosi da fare solo per i loro interessi. I Colonnesi, il contrario» («Bucolicum carmen» e i suoi commenti inediti, a cura di A. Avena, Società Cooperativa Ti-pografica, Padova 1906, p. 268: «ostendit quod Ursini semper statum publicum neglexerunt, privatis eorum commodis insudantes. Columnenses contra»). Una glossa contenuta nel cod. D. ii. 14 della Biblioteca Casanatense scrive allo stesso proposito: «La famiglia Colonna volle a suo tempo fare in modo che Roma avesse come suo solito il papa e l’imperatore, mentre la famiglia Orsini vi si oppose» (ibid.: «Colonensia domus voluit quodam tempore ordinare ut Roma ha-beret papam et imperatorem modo sollito, domus vero Ursinorum contradixit»). Si ricordi che Petrarca aveva scritto nel 1333, contro gli Orsini, oltre al sonetto 103 dei Rvf, Vinse Hanibàl, et non seppe usar poi, una epistola in versi, Ursa peregrinis, rimasta fuori dalla raccolta per le sue particolari caratteristiche metriche (è impiegata la tecnica dei versus caudati e dei versus cum auctoritate): si vedano Billanovich, Un carme ignoto del Petrarca, cit., e C. M. Monti. Un carme di Pietro da Parma, in “Studi petrarcheschi”, n.s., v, 1988, pp. 126-53. Ma per le (improbabili) letture filo-colonnesi dell’egloga, si veda la nota seguente.
64
Petrarca voglia porre i suoi padroni Colonna in una luce favorevole, denigrando per contro gli Orsini (e ciò sembra urtare con il fatto che acerrimi nemici di Cola furono i Colonna, non gli Orsini, che anzi si schierarono dalla sua parte e furono addirittura a capo, con Cola Orsini, delle sue truppe), e favorevolmente è stata in genere interpretata la sua figura36. Ma non è così, e l’egloga non la si intende se così la si interpreta. Rivediamo dunque quale sia la sua effettiva posizione nell’egloga.
è lui che prende la parola, che parla più a lungo di tutti (per 69 versi su 140) e che chiede con forza che si faccia qualcosa in aiuto della veneranda madre per alleviarne le sofferenze e farla tornare grande: nulla gli sta più a cuore, e questo è il primo dovere di un figlio devoto. Concretamente, la proposta che egli fa al fratello consiste nel restaurare la casa comune, nel superare le vecchie e rovinose inimicizie e nel tornare ad abitarla tutti insieme: del resto, la madre in realtà possiede ancora molto di ciò che li fa ricchi (vv. 82-3: «nam pascit oves, pascitque iuvencos / unde istas cumulamus opes»). Ecco dunque che Marzio, di là da tanta retorica esibizione di buoni sentimenti, finisce per ridire a suo modo quanto gli aveva già rinfacciato Apicio con esplicita brutalità, ai vv. 52-3: essere entrambi, insieme a tutti quelli come loro, nient’altro che dei ladroni e dei banditi della peggior specie. Petrarca stesso, del resto, lo va ripetendo in maniera martellante nelle sue lettere, e non sembra proprio che voglia fare un’eccezione per i Colon-na: al contrario37. In altri termini, ciò significa che Marzio propone una rinnovata alleanza feudale e insomma un patto che torni a mettere le grandi famiglie in condizione di appropriarsi di quelle ricchezze che, si badi, sono della madre, e cioè di Roma, non loro, e di riavere così potenza e onore (vv. 76-8: «Hinc iussa nepotes / accipiant, hic una domus, nec scissa potestas, / nec fratrum divisus
36. Così Burdach e Piur (Briefwechsel, cit., vol. ii, t. 3, p. 87), commentando l’egloga: «Mar-tius der Idealist, der die weite Vergangenheit und Zukunft umfasst». Ma i segnali in questo senso sono molti, a partire dagli antichi commenti (si veda la nota precedente), sino a quello recente di François e Bachmann (Pétrarque, Bucolicum Carmen, cit.), i quali non danno rilievo agli elementi negativi a proposito di Marzio, mentre nel “cappello” (p. 110) suggeriscono, come già faceva un “argomento” anonimo del cod. Vat. Lat. 1679 («Bucolicum carmen» e i suoi com-menti inediti, cit., p. 76), che nel personaggio possa celarsi Stefano Colonna il Vecchio, forse celebrato ancora all’altezza di Tr. Fame ii 162-3: «il mio gran Colonnese, / magnanimo, gentil, constante e largo». Per la verità, che qui si tratti di lui non è sicuro: si veda la nota di Pacca ad locum, pp. 429-30 del suo commento ai Triumphi, Mondadori, Milano 1996, ma ciò non muta il fatto che Petrarca, che gli scrisse l’8 settembre 1348 la bella “consolatoria” Fam., viii 1, ne ebbe personale e grande stima e altamente l’abbia sempre esaltato per virtù e amor di patria, parago-nandolo a Giulio Cesare, a Scipione, a Camillo: si vedano le Fam., ii 3, 17-24; v 3, 6-7; vii 13, 17-9; xx 13, 24-5, e, seppur meno diffusamente ma con altrettanta intatta ammirazione, Fam., ii 9, 23; iii 4, 4; iv 12, 6; v 2, 5; xv 1, 9; xv 8, 8; xix 4, 4. Mi resta dunque difficile legare a lui personalmente la figura di Marzio. Ancora, a proposito dei vv. 74-5, essi scrivono: «Nous pensons qu’alors Pétrarque faisait confiance encore aux Colonna, ses protecteurs et amis, et à leur patriotisme» (Pétrarque, Bucolicum Carmen, cit., p. 311). Di nuovo non penso sia così, per la radicalità della diagnosi politica di Petrarca intorno alla situazione di Roma. Piuttosto, è la calcolata ambiguità del testo che può lasciar credere una cosa simile.
37. In proposito l’Hortatoria è esplicita nel denunciare i nobili romani e segnatamente i Co-lonna e gli Orsini come un branco di lupi famelici, rapinatori delle ricchezze altrui, miserabili ladruncoli, rapaci predoni... (si veda Pietas pastoralis, v. 52, n).
65
honos»), e di più, spaccia tale patto come la prima condizione affinché Roma possa risorgere dalla condizione di degrado nella quale giace. Le due cose sono però in profonda, essenziale contraddizione, e per i destini di Roma si tratta della peggior proposta possibile: la peggiore e la più irrealistica insieme. Non sarà dunque inutile ricordare che per Bartolo da Sassoferrato il regime al quale Roma è tornata a sottostare, dopo Cola, è semplicemente mostruoso, e lo è, se-condo lui, per la circostanza del tutto anomala ma storicamente spiegabile per la quale il potere è nelle mani di una molteplicità di tiranni che non sono legati l’uno all’altro sì da formare una vera e propria oligarchia, né tendono a eli-minarsi l’un l’altro sino a che uno finisca per accentrare il potere su di sé, ma convivono indipendentemente tutti insieme e tutti insieme opprimono la città: «La città di Roma, modello di costumi e modello di politica, è arrivata a una tale mostruosità nella sua struttura di potere che davvero si può dire che non si tratta di un regime, né di un regime ha la forma»; «Quanto ho detto sopra, che il potere di molti uomini malvagi non è così cattivo come il potere di un tiranno unico, vale quando quei molti tendono a ridursi a uno, e hanno potere solo quando lo esercitino tutti insieme: diversamente accade se ciascuno di loro esercita per conto suo un potere tirannico, senza che gli uni si occupino degli altri, come ho detto sopra parlando di quel mostruoso regime che vige ora in Roma»38.
Qui tocca ad Apicio di smontare, con estremo disincanto, il discorso di Mar-zio. «Ma come!», esclama: «Noi viviamo di furti e rapine che a stento ci bastano a sopravvivere, e tu vuoi costruire una casa alla madre moribonda? Insomma: visto che in sostanza di rapina continueremo pur a vivere, stiamocene nei nostri castelli e lasciamo che le cose vadano per il loro verso: lei morirà, e anche noi la seguiremo […] e una barchetta basterà, se qualcuno vorrà andare in città, senza che occorra rifare i ponti distrutti». In altre parole: il ceto baronale non è in grado, neppure volendolo, di costruire o ricostruire alcunché, e a parlar pro-priamente è, socialmente e politicamente, già morto. La sua logica anarchica e privatistica e la sua presente situazione economica e militare non gli permettono che la sopravvivenza e la rapina, niente di più. La salvezza di Roma e qualsiasi di-segno politico che si collochi all’altezza di questo progetto sono oggettivamente fuori dalla sua portata. Come si vede, il gioco delle parti tra i due è complesso e intrigante, e straordinaria è la lucidità propriamente politica di Petrarca: quella che gli permette di articolare perfettamente il suo discorso tra ciò che appare (e che definisce l’ambito della falsa-coscienza di Marzio) e ciò che è. La nobile re-
38. «Civitas enim Romana caput morum, caput politiarum, ad tantam monstruositatem circa sui regimen venit, quod verius dici potest quod non est regimen nec regiminis forma habet»; «Hoc autem quod supra dictum est, quod regimen plurium malorum hominum non est ita malum, sicut regimen unius tyranni, intelligendum est si illi plures tendunt ad unum et non possunt nisi simul; secus si quilibet per se tyrannidem exerceret et unus de alio non curaret, ut supra dixi de regimine monstruoso quod nunc est in urbe Romana» (De regimine civitatis i ii 76-9, p. 152; iii ii 467-2, p. 169, in D. Quaglioni, Politica e diritto nel Trecento italiano. Il «De tyranno» di Bartolo da Sassoferrato, 1314-1357. Con l’edizione critica dei trattati «De Guelphis et Gebellinis», «De regimine civitatis» e «De tyranno», Olschki, Firenze 1983).
66
torica di Marzio finisce infatti per rivelarsi come una rinnovata e aggressiva ide-ologia del privilegio e della soppraffazione («quello che è di Roma deve tornare ad essere nostro»), della quale già nell’Hortatoria Petrarca metteva in rilievo la pericolosità: se, contro Cola, i nobili fossero riusciti a ricostituire il loro potere, per i cittadini di Roma sarebbe stato ancor peggio che nel passato: «non crediate che essi ricreino per voi le stesse condizioni di fame che se ne sono andate con loro, ma molto più rabbiose e vieppiù crudeli per il tempo trascorso»39. Mentre il pigro e disincantato Apicio ha almeno il pregio di rendere un quadro esatto di quello che il loro dominio inevitabilmente comporta.
A questo punto interviene Festinus, che tronca quei vani discorsi per dire essenzialmente tre cose che Marzio e Apicio sembrano scioccamente ignorare: la prima, che la madre ha già dato tutto il potere al giovane e sin lì conculcato fratello, cioè Cola, il quale l’esercita amministrando in maniera eccellente i beni che gli sono stati affidati; la seconda, che l’aspetto principale dell’azione di Cola sta precisamente nell’impedire il saccheggio dei beni pubblici e privati da parte delle famiglie nobili che niente altro sanno e vogliono fare (e Marzio, ripeto ancora, non fa certo eccezione!); la terza, che questa politica di tutela di per sé basta a capovolgere le sorti della città riportando insieme sicurezza e ricchezza, e permette che si possa davvero pensare alla sua rifondazione. La difesa e la certezza del diritto sono dunque le chiavi per la rinascita: e infatti il primo passo è stato quello di elevare robusti steccati per tener fuori gli animali da preda e di preparare buone forche per impiccarvi quelli che si sarebbe riusciti a catturare. In chiusura, infine, Festinus, dopo aver assomigliato le grandi famiglie romane a bestie feroci, e tra esse i Colonna al sanguineus aper (v. 125), e dopo aver invitato Marzio e Apicio a tornarsene nei loro castelli e ad accontentarsi di tosare le loro magre pecore, aggiunge un argomento ulteriore, che già aveva avuto particola-re sviluppo nell’Hortatoria: solo Cola può dirsi veramente cittadino romano, e solo lui, infatti, la vecchia madre riconosce come figlio, mentre gli altri due non sono che degli stranieri, di origine tedesca i Colonna e di origine spoletina gli Orsini40.
Sin qui l’egloga, costruita attorno a una robusta impalcatura politica che nella sostanza corrisponde singolarmente alla Cronica dell’Anonimo romano, là dove questa parla di Cola e, attraverso le parole dello stesso Cola, denuncia le respon-sabilità delle famiglie feudali per il degrado della città e del territorio: «e dice ca·lli baroni de Roma so’ derobatori de strade: essi consiento li omicidii, le rob-barie, li adulterii, onne male; essi voco che la loro citate iaccia desolata»; sottoli-nea la natura sociale delle forze che sostengono il tribuno: «Puo’ questo adunao moiti Romani populari, discreti e buoni uomini. Anco fra essi fuoro cavalerotti e de buono lenaio, moiti descreti e ricchi mercatanti», e insomma «bona iente» che vuole provvedere «allo buono stato»; descrive le conseguenze dei suoi prov-
39. Disp. 8, pp. 54-6: «nolite credere eamdem illos quam extulerunt famem recreaturos, sed multo rabidiorem et magis magisque tractu temporis efferatam».
40. Per questo spunto polemico che mira a riservare al solo Cola i diritti inerenti al fatto d’essere “cittadino romano” (lo è anche Petrarca stesso, in virtù dell’incoronazione capitolina che aveva comportato questo privilegio) si vedano vv. 135-40 e note.
67
vedimenti, e i malvagi che fuggono via: «Allora le selve se comenzaro ad alegrare, perché in esse non se trovava latrone. Allora li vuovi comenzaro ad arare. Li pellegrini comenzaro a fare loro cerca per le santuarie. Li mercatanti comenzaro a spessiare li procacci e camini. […] Ora spessiano li forestieri e·lli alberghi so’ repieni per la folla della moita forestaria. Le case abannonate se racconciavano. Nello mercato la moita iente curre. […] Tutta Roma staieva leta, rideva, pareva tornare alli anni meliori passati»41.
Che dire, allora, della lettera? L’egloga, letta a dovere, non lascia dubbi sull’effettiva e radicale condanna della posizione di Marzio. Petrarca maschera abilmente la cosa e però fa che la rumorosa falsa coscienza di Marzio sia de-mistificata dal cinismo disincantato di Apicio, e che il sottile gioco delle parti tra i due finisca per accomunare Orsini e Colonna nella condanna che l’intera oligarchia romana merita (ma no, per Bartolo non è neppure una oligarchia, ma qualcosa di mostruoso). La lettera, e dunque l’interpretazione per così dire ufficiale che lo stesso Petrarca dà dei suoi versi, è invece per questo aspetto francamente depistante. La ragione la possiamo solo immaginare: un residuo di cautela nei confronti dei potenti padroni l’ha spinto a stendere attorno a loro un velo così fragile, e forse il gusto, che diventa del tutto patente nell’eglo-ga, per una scrittura capace di obbedire alla definizione canonica dell’ironia, che «negat quod dicit»42.
Sul punto occorrerà tornare. Intanto è importante valutare l’impalcatura politica del discorso petrarchesco, ancorato alla esatta analisi sociale delle parti in causa: se posso dire, questo è ciò che occorre mettere pienamente in conto, mentre ho talvolta l’impressione che la tradizionale lettura che punta quasi tutto sul mito dell’antica Roma quale contenuto sostanziale dell’egloga e anima dell’atteggiamento di Petrarca (e di Cola) rischi di spostarne l’effet-tivo centro di gravità trasformandola in un testo connotato soprattutto sul piano retorico-letterario. Tale pregnanza propriamente politica è rafforzata da una significativa mancanza. In essa, infatti, è assente qualsiasi esplicito ri-ferimento al papa e al suo eventuale ritorno (ma si veda v. 23 e nota). Si tratta
41. Anonimo romano, Cronica, cit.: i passi, rispettivamente, alle pp. 105, 111, 117, 130-1, per altro già ben commentate nel fondamentale saggio di M. Miglio, Gruppi sociali e azione politica nella Roma di Cola di Rienzo, in “Studi romani”, xxiii, 1975, pp. 442-61: 451 ss. Na-turalmente, molto altro sarebbe da citare: ma si vedano, ancora di Miglio, Gli ideali di pace e di giustizia in Roma a metà del Trecento, in La pace nel pensiero, nella politica, negli ideali del Trecento. Atti del Convegno del Centro di studi sulla spiritualità medievale (Todi, 13-16 ottobre 1974), Accademia Tudertina, Todi 1975, pp. 175-97, ove si dà un giudizio riduttivo dell’impegno di Petrarca nel momento della sfortuna politica e della caduta di Cola; e il più recente saggio di Rehberg, Clientele e fazioni nell’azione politica di Cola di Rienzo, cit. (in particolare il primo dei due volumi di A. Rehberg, A. Modigliani, Cola di Rienzo e il comune di Roma).
42. Si veda al proposito il bel libro di D. Knox, Ironia. Medieval and renaissance ideas on irony, Brill, Leiden, 1989, in particolare pp. 9 ss. Ma va anche detto che il distacco dai Colonna fu più complesso e non senza alcune contraddizioni: si vedano al proposito i cenni di A. Reh-berg, Francesco Petrarca al servizio dei Colonna, in Petrarca e Roma. Atti del Convegno di studi (Roma, 2-4 dicembre 2004), a cura di M. G. Blasio, A. Morisi, F. Niutta, Roma nel Rinascimento (RR inedita, 35), Roma 2006, pp. 75-112: 112, n 185.
68
di un silenzio che non può essere attribuito al caso. Si sa sin troppo bene come la decadenza di Roma sia da Petrarca associata alla “cattività avigno-nese”, e quanto egli abbia combattuto per tutta la vita affinché i papi tor-nassero nella loro città, sino a farne un motivo assolutamente centrale della sua visione della realtà del suo tempo, se non addirittura il più importante. Ora invece, in maniera del tutto eccezionale, egli fa un articolato discorso su Roma e sulla sua possibile rinascita imperiale che prescinde dal fatto che la città debba tornare ad essere la capitale della cristianità. Si tratta, in fondo, della stessa ambiguità entro la quale il tentativo di Cola si svolse e infine affogò, la quale impone anche all’egloga un intrigante silenzio, ché non era possibile conciliare ciò che era affatto inconciliabile. Contro il tentativo di Cola il papato aveva finito per ergersi con tutto il suo potere, e solo una esclusiva e vacua dimensione retorico-letteraria poteva rendere un ipocri-ta omaggio all’uno e all’altro. Ma appunto, questa non è né la dimensione dell’egloga né delle lettere a Cola, tra le quali stanno le prime delle Sine no-mine (2 e 3), cioè della raccolta dedicata a mostrare con la maggiore durezza possibile quanto poco l’Italia, e Roma in particolare, potessero aspettarsi da quei papi e da quella Curia, com’è, del resto, nelle due egloghe che seguono alla Pietas pastoralis, la vi, Pastorum pathos, e la vii, Grex infectus et suffec-tus43 (allora, io credo, nel pieno della disillusione e della rabbia, sono stati scritti anche i tre sonetti anti-avignonesi, Rvf, 136-8).
Quel silenzio, insomma, corrisponde a un giudizio storico-politico che nel momento dello scontro diretto pone discriminanti insormontabili e in-trappola Petrarca in una grave difficoltà. Egli deve scegliere tra l’asse por-tante che caratterizza la sua posizione politica in quanto intellettuale: il ri-torno del papato a Roma e il rischio di gettarsi in un’avventura politica che di fatto aveva finito per dichiarare guerra a quel ritorno e che stava, per di più, rapidamente fallendo. Non sappiamo se ci siano state esitazioni e di che tipo, ma la decisione finale era scontata, così come era scontato l’esito dello scontro. Se qualche aspetto del distacco di Petrarca da Cola è ancora misterioso, insomma, e se è tutt’altro che infondato il sospetto che egli non reggesse alla durezza della situazione così come cominciò a determinarsi tra la fine d’agosto e i primi di settembre, certo non lo sono le sue ragioni profonde, e il ruolo che il poeta ha scelto per sé ne esce riconfermato, di là dai rischi corsi.
43. Concepite in un primo momento, nel 1347, come un’egloga unica, si staccarono poi una dall’altra, e la seconda fu completata dopo che, nel dicembre 1350, ci fu la nomina di dodici nuovi cardinali. Allora, nel 1347, io credo che siano stati scritti anche i tre sonetti anti-avignonesi, Rvf, 136-8: si vedano per ciò l’ed. Santagata del Canzoniere, Mondadori, Milano 1996, pp. 666-7; E. Pasquini, Il mito polemico di Avignone nei poeti italiani del Trecento, in Aspetti culturali della società italiana nel periodo del papato avignonese, Accademia Tu-dertina, Todi 1981, pp. 259-309; F. Suitner, L’invettiva antiavignonese del Petrarca e la poesia infamante medievale, in “Studi petrarcheschi”, n.s., ii, 1985, pp. 201-10; M. Picone, Avignone come tema letterario: Dante e Petrarca, in “L’Alighieri”, xliii, n.s., 20, 2002, pp. 5-22.
69
3Quinte Egloge titulus est: Pietas pastoralis. Collocutores Martius Apitius et Festinus44
Martius Quid genitrix veneranda dolet, germane? Quid illi accidit hoc dignum gemitu? Quorsumve recentes mesta pluet lacrimas, nec lumina nostra madescent?
Apitius Cuncta vorant anni volucres; domat omnia tempus indomitum; cecidit matris fortuna decorque, 5 arentique virens senio dat terga iuventus.
Martius Aspice quot circum stabiles, urgentibus annis, et virides cernuntur anus. Aliunde profecto luctus et offensi veniunt suspiria cordis. Querere nos causas, fatisque obstare repertis 10 suadet amor pietasque iubet, meritumque reposcit altricis, partusque labor, fastidia, cure.
Apitius Vim nescit natura pati. Licet omnia certent pectora ab adverso, cunctas licet advocet artes humanum genus et studio contendat inani, 15 invictum caput illa ferens, contemnet habenas.
Martius Hec prope diis natura pares iubet esse parentes.
Apitius Hec eadem prohibet cursum prevertere vite, et rerum turbare vices. Iuvenescere mater nostra nequit; vana est pietas; de coniuge quisque 20 cogitet et parvis studeat succurrere natis.
Martius De genitrice nichil? Sedenim michi maxima matris cura subest vidue; nil hac michi carius usquam.
44. Il testo, dal «Bucolicum carmen» e i suoi commenti inediti, a cura di A. Avena, cit., pp. 114-8, ricontrollato su quello di D. Di Venuto, Il «Bucolicum carmen» di Francesco Petrarca. Edi-zione diplomatica dell’autografo Vat. Lat. 3358, eTs, Pisa 1990 (quello fornito da Burdach, Piur, Briefwechsel, cit., vol. ii, t. 3, pp. 87-93, pur basato su quello di Avena, riporta la varia lectio dei manoscritti). Ho anche fatto ricorso all’edizione francese diffusamente annotata: Pétrarque, Bucolicum carmen, cit. La traduzione, mia, ha inevitabilmente tenuto conto di quella elegante e scorrevole di Luca Canali, in F. Petrarca, Bucolicum carmen, a cura di L. Canali, collaborazione e note di M. Pellegrini, Manni, Lecce 2005, pp. 81-95. Cito dall’ed. Avena («Bucolicum carmen» e i suoi commenti inediti, cit., pp. 207-15) il testo del commento anonimo (da alcuni attribuito a Donato degli Albanzani) conservato nel codice della Bibl. Laurenziana, 33 Plut. 52, e, pp. 266-71, quello di Francesco Piendibeni da Montepulciano, conservato nel codice Vaticano Pal. 1729. L’egloga è tradotta e annotata anche in Petrarch’s Bucolicum carmen, transl. and ed. T. G. Bergin, Yale University Press, New Haven 1974, pp. 58-73, 225-7; in Petrarch, The revolution of Cola di Rienzo, cit., pp. 83-9, 90-7, e nell’ed. parziale (comprende le egloghe 1-5, 8 e 11) di M. Berghoff-Bührer, Das Bucolicum Carmen des Petrarca. Ein Beitrag zur Wirkungsgeschichte von Vergils Eclogen, Peter Lang, Bern-Berlin 1991, pp. 238-64.
70
Apitius Quis vetat esse pium? Munus leve dulcia verba. Hos humeros, has illa manus, hec brachia nobis 25 sola dedit, donisque suis ea sola fruatur. Non comes esse sibi, quascunque vocarit in oras, abnuo, nec fragili baculum me ferre senecte.
Martius Dii tibi consilium celo tribuere sereno; nunc pietas sua regna tenet, sua possidet arma: 30 filius es, matri vin subveniamus egenti?
Apitius Fare; quid expectas? Omnis mora torquet amantem.
Martius Est domus ampla sibi, nemoroso condita colle, dudum magnanimi longo quam tempore fratres obsequiis coluere piis. Tum cognita late 35 mater erat, saltus nimis invidiosa per omnes. Felix et partu, et silvestribus inclita gazis, ac nemorum regina potens; mors invida natos preripuit misere, perierunt corpora fratrum. Fama viget. Nos ludibrio dilata iuventus 40 spiramus, sed fama iacet tenebrisque sepulta est. Sub nobis mutata domus fortuna; tot annis incolumis, nostros cecidit non passa furores. Hec matri reparanda domus; nil gratius illi, ni quo fata premunt, fractis consurgere bustis 45 aspiceret natos et tempora prisca reverti.
Apitius Milia sunt hominum, curarum milia mille: quisque sibi sapiens. Unde hec tibi somnia, frater? Pellere pauperiem labor est mortalibus ingens, cui nunquam speranda quies; nos sorte maligna 50 vivere per silvas ulla vix possumus arte; et –tecum, germane, loquor- non furta rapinis mixta iuvant, plenis nec prede ab ovilibus acte. Tu nova tecta paras ruiture attollere matri?
Martius Non nova, sed veterum turpes reparare ruinas 55 da, frater, da, care, manus partemque virilem sponte subi; vincat pietas invicta laborem. Siccemus parites lacrimas, et mesta parentis pectora, ne tales doleat genuisse, levemus.
Apitius Cura supervacui pectus quatit! Occidit illa 60 spes sobolis, que cuncta procul compleverat arva, nec muris contenta suis nec cespite parvo. Ad paucos reditum; pascent nos avia baccis arboreis, duplicisque capax testudinis antrum, dum tonat, excipiet ventosque arcebit et imbres, 65 mater ubi alternis convivia festa diebus hic aget atque illic, geminoque fruetur honore.
71
Martius Coniugibus despecta quidem et calcata superbis, ac dominas habitura nurus! Quin flectere tandem et monitus meliora vide: genitricis uterque 70 tecta colat limenque pius venerator adoret quos sacri tetigere pedes. Non aspera mando; dulce est annose iuvenem servire parenti. Non in vestibulo pudeat me mane videri sollicitum quid mandet anus. Quin septa laremque 75 molimur, solitas sedes? Hinc iussa nepotes accipiant, hic una domus nec scissa potestas, nec fratrum divisus honos. Vicinia iunctos horrebit; virtus gladio plus vera timetur. Aggrediamur opus, quedam leviora videntur 80 expertis; genitrix, animos si cernat amicos, ipda aderit: nam pascit oves pascitque iuvencos, unde istas cumulamus opes. Ars fallere matrem prima quidem pueris! Fortune frusta vetuste, preterea et terre salis altum infodit acervum, 85 quem cupido quondam pecori blandita latenter miscuit et sapidas aspergine reddidit herbas; insuper ad veteres ortos umbrosaque Tempe, Saturnique domos, et que possedimus ultra (Lidius at nunc hospes habet) violentus ab alto 90 monte cadit rivus qui, dum sua rura revisit, impedit invalidam transverso gurgite matrem. Pons fuit hic, manibus sanctorum structus avorum, tempus in hoc solidus; tacitos quo tramite fures, qui gregibus pestem, silvis suprema parabant, 95 repperit argutus nocturno tempore pastor collaque sic meritis fregit. Tua dextera pontem hunc – tibi nota loquor – tumidas effudit in undas, dumque nocere michi properas matrique tibique et gregibus silvisque noces. Sed iurgia mitto. 100 Hic nostram modo poscit opem; sine crimine quamvis, non onerum partem tecum tolerare recuso.
Apitius Compulit in facinus tua longa superbia. Verum cimba brevis fluvio est, habilis transire volenti; rus breve trans fluvium superest; fortuna solutos 105 angustat finesque locat quos fratribus olim tam bene pacatis quam nos sumus. Arcta priorum, arcta extremorum confinia; at inter utrumque laxarunt sua rura senes. Audacia letos non stabiles habet eventus: en omnia demum 110 ad primas rediere vias, forsque improba giro lusit in assiduo. Quid quod sine ponte manemus tutius in ripa? Iam, quantum ad cetera, serum est edificare domos sub tempus velle sepulcri.
Festinus Quid vano sermone leves consumitis horas? 115
72
Tertius ille minor, quem vos calcare soletis, silvas frater habet; iam fundamenta domorum sede locat patria; genitrix sibi rura gregemque credidit et nati gremio secura quiescit. Parent cuncta sibi. Curas agit ille seniles 120 ense puer stricto laqueisque sub arbore tensis, quis avium furumque pedes et colla premantur. Pinguibus arentes tenerisque ab ovilibus arcent fortia claustra lupos, tristis non murmurat ursus, sanguineus non sevit aper, non sibilat anguis, 125 non rapidi predas abigunt ex more leones, non aquile curvis circumdant unguibus agnos: excelso predulce canens sedet aggere custos. Pascua tuta silent. Audit iam litus utrunque carmen, et extremus calaber ligurumque recessus, 130 undifragi sectique tenens convexa Pelori. Si vocem extulerit, Mauros turbabit et Indos, arctoasque nives austrique calentis arenas. Imperat is vobis linguam cohibere; capellas ite domum tondere inopes. Negat almaque mater 135 partem uteri vos esse sui, suppostaque iurat pignora falsa sibi: vallis te proxima misit, Apenninigene qua prata virentia silve Spoletina metunt armenta gregesque protervi; te longinqua dedit tellus et pascua Rheni. 140
Martius Nunc memini: audieram veteres narrare bubulcos.
Marzio. Fratello, di che si lamenta la nostra veneranda madre? Cosa le accade che meriti il suo pianto? Sino a quando, nella sua tristezza, rinnoverà queste lacrime, mentre i nostri occhi neppure inumidiscono? Apicio. Gli anni volano e tutto divorano: il tempo doma inarrestabile ogni cosa. La fortuna e la bellezza di nostra madre sono sparite, e la verde giovinezza da tempo ha voltato le spalle alla sua vecchiaia inaridita. [7] Marzio. Guarda-ti attorno, quante vecchie d’anni appaiono ben conservate e forti! Di sicuro, il dolore e i sospiri del suo cuore ferito vengono da qualcosa d’altro. Cerchiamone le ragioni e, se le troviamo, contrastiamo un destino siffatto: l’amore ci convince a farlo, e ce lo impone la pietà. E lo pretendono i meriti della nostra genitrice, e la fatica e gli affanni e le preoccu-pazioni del parto. [13] Apicio. Non si può fare violenza alla natura. Anche se tutti gli animi le muovessero contro; anche se il genere umano ricorresse a tutti i mezzi e si bat-tesse – inutilmente – con ogni impegno, la natura risolleverà invincibile la testa e spezze-rà le nostre redini. Marzio. Ma è proprio la natura che ci impone di considerare i genito-ri come divinità! Apicio. Tuttavia, è ancora lei che ci proibisce di capovolgere il corso della vita e di sovvertire l’ordine delle cose. Nostra madre non può ringiovanire, e la pietà è inutile: ognuno di noi pensi piuttosto alla propria moglie e s’ingegni di provvede-re ai figlioletti. Marzio. E per la madre, niente? La mia preoccupazione maggiore va a lei vedova: non esiste nulla che mi stia più a cuore. [24] Apicio. Chi impedisce di esserle devoti? Le parole di conforto sono un obbligo che non pesa. Lei sola ci ha dato queste spalle, queste mani, queste braccia: ora, lei sola goda dei suoi doni. Non sarò certo io a rifiutare di esserle vicino ovunque mi chiami, né di essere il bastone della sua fragile
73
vecchiaia. Martius. Gli dei ti hanno dato una saggezza di trasparente serenità. La pietà ha riconquistato il suo posto e ha ritrovato le sue armi: tu che ne sei figlio, non vuoi dun-que che aiutiamo una madre che ne ha tanto bisogno? Apicio. Parla, che aspetti? Per chi ama ogni ritardo è un tormento. [33] Marzio. La madre ha una grande dimora posta su un colle boscoso, e per lungo tempo i nostri magnanimi fratelli l’hanno devotamente onorata. Allora, lei era conosciuta in lungo e in largo, oggetto d’invidia per tutta quella regione montana, felice dei suoi parti, famosa per le sue agresti ricchezze, regina potente delle selve. L’invida morte alla sventurata rapì i figli: i nostri fratelli morirono e la loro fama ancora vive. Noi giovani vergognosamente sopravvissuti respiriamo ancora, ma la nostra fama è morta, sepolta nelle tenebre. Sotto di noi, le sorti della casa sono cambiate: intatta per tanti anni, è crollata per non aver sopportato la nostra follia. Questa è la casa che dobbiamo restaurare per nostra madre: niente essa amerebbe di più che vedere i propri figli risorgere, infrante le tombe verso le quali il destino ci incalza, e assistere al ritorno dei tempi antichi. [47] Apicio. Gli uomini sono migliaia, e i loro affanni sono milioni: ognuno è saggio per sé. Da dove ti vengono questi sogni, fratello? Scacciare la povertà è la più grande fatica dei mortali, e rispetto ad essa non c’è mai da sperare riposo. Per sorte maligna, noi a stento riusciamo a sopravvivere in qualche modo per queste selve, e non ci bastano furti e rapine (parlo a te, fratello!), né le prede sottratte alle stalle piene. E tu vorresti procurare una nuova casa per una madre che sta per morire? [55] Marzio. Non voglio una casa nuova, ma voglio riparare le vergognose rovine della vec-chia. Dammi una mano, fratello caro, aiutami, e assumiti di buon grado un compito da uomini: la pietà, vittoriosa, vinca la fatica. Asciughiamo insieme le lacrime della madre e confortiamone il triste cuore, sì che non si dolga d’aver generato dei figli come noi. [60] Apicio. è una preoccupazione inutile quella che ti agita. è finita la speranza in una prole come quella che aveva riempito ogni terra lontana, insoddisfatta com’era delle proprie mura e della propria piccola contrada. Siamo tornati a essere pochi: ci nutriremo per luoghi impervi di bacche d’alberi, e quando tuona ci accoglierà un vasto antro dalla dop-pia volta, riparandoci dal vento e dalla pioggia. E ora qua e ora là, un giorno dopo l’altro, la madre parteciperà a festosi conviti e sarà onorata da entrambi i figli. [68] Marzio. Sarà disprezzata, invece, e calpestata dalle spose arroganti, e si troverà le nuore come padro-ne. Lasciati convincere, infine, e accetta il consiglio di considerare qualcosa di meglio. Andiamo entrambi ad abitare nella casa della madre, e adoriamo con pia venerazione la soglia toccata da sacri piedi. Non ti spingo a niente di difficile: è bello che un giovane si occupi della madre carica d’anni. Io non mi vergognerei affatto d’essere visto la mattina in anticamera pronto a ricevere i suoi ordini. Perché non restauriamo i recinti e il focola-re della sua tradizionale dimora? Qui i nipoti verranno a ricevere gli ordini: qui, per noi fratelli, ci sarà una casa comune, il potere intatto e l’onore indiviso. Se saremo uniti i vi-cini avranno paura di noi: la virtù vera è più temuta della spada. [80] Mettiamoci all’ope-ra e tutto sembrerà più facile una volta intrapreso. Nostra madre, se ci vedrà d’animo concorde, ci aiuterà: è lei che possiede gli agnelli e i giovenchi dai quali ricaviamo la no-stra ricchezza. L’arte di ingannare la madre è la prima che i fanciulli imparano! A lei resta qualcosa dell’antica ricchezza, e inoltre tiene nascosto sotto terra un gran mucchio di sale che un tempo mescolava di nascosto, amorevolmente, e spargeva per rendere più sapori-te le erbe del pascolo al gregge goloso. Più in alto, presso i vecchi orti e l’ombrosa valle che Saturno abitava e noi possedevamo (ora, li possiede uno straniero di Lidia), un fiume scende impetuoso dall’alto del monte e frapponendosi con il suo corso impedisce di tornare alla nostra debole madre ch’è andata a rivedere le sue terre. [92] C’era un ponte, qui, costruito dalle mani dei nostri santi antenati e rimasto intatto sino ad oggi. Su di esso, di notte, un eloquente pastore sorprese i ladri che si preparavano in silenzio a ster-
74
minare le greggi e a mandare in rovina le selve, e giustamente li fece decapitare. Pro-prio tu, con le tue mani (dico cose che ben conosci), hai fatto precipitare nelle onde rigonfie questo ponte, mentre cercavi di far del male a me e in verità stavi danneggian-do tua madre e te stesso e le greggi e le selve. Ma la smetto con le recriminazioni. Quel ponte richiede ora il nostro lavoro: anche se io non ho alcuna colpa, non mi rifiuterò di sobbarcarmi parte della fatica insieme a te. [103] Apicio. A una simile azione mi ha spinto la tua continua superbia. Tuttavia, c’è una barchetta sul fiume, sufficiente a far passare chi lo voglia. Ci resta un piccolo campo, di là. La fortuna ha ridotto i nostri possedimenti un tempo illimitati riducendoli entro i confini ch’erano già degli antichi fratelli, tanto in pace tra loro quanto lo siamo noi: confini stretti quelli degli antichi, dunque, e stretti i nostri che siamo i loro ultimi discendenti. Tra quelli e noi i nostri vecchi hanno allargato i loro, ma l’audacia ottiene successi effimeri e tutto alla fine è tornato come prima, e la sorte malvagia nel suo instancabile giro si è presa gioco di noi. Perché non ce ne stiamo al sicuro su questa riva, senza ponte? Del resto, è tardi per voler costruire case, quand’è tempo di pensare al sepolcro. [115] Festinus. Perché spre-cate tempo prezioso con discorsi sciocchi? Quel terzo fratello – il minore – che voi siete abituati a calpestare possiede già le selve e in terra patria sta gettando le fonda-menta della casa. La madre gli ha già affidato i campi e le greggi, e se ne sta sicura sotto la sua protezione. Tutto gli ubbidisce, e il ragazzo affronta problemi da uomo maturo con la spada in pugno e con tante trappole tese sotto gli alberi per stringere zampe e collo agli uccelli da preda. [123] Robusti steccati tengono lontani i lupi affama-ti dai ricchi e teneri ovili; l’orso triste non ringhia più; il sanguinario cinghiale non imperversa; il serpente ha smesso di sibilare; i rapidi leoni non rapiscono più, secondo natura, le loro prede, e le aquile non ghermiscono gli agnelli con le loro unghie ricurve. Il pastore siede in alto, e canta melodiosamente: tacciono sicuri i pascoli, e ascoltano quel canto i due mari e il golfo estremo di Calabria e il ligure e quello che tiene divise da terra le cavità del Peloro, contro il quale le onde s’infrangono. [132] Se alzerà la voce, turberà Mauri e Indi, e le nevi del Nord e le arene infuocate dell’Austro. è lui che v’impone di tacere: tornatevene a casa a tosare le vostre magre caprette! La veneranda madre afferma che voi non siete frutto del suo ventre, e giura che le siete stati appiop-pati come figli attraverso una fraudolenta sostituzione. Infatti, è la valle vicina che ha mandato te, dove gli armenti e le greggi di Spoleto brucano aggressivamente i verdi prati delle selve appenniniche; tu, invece, vieni dalle terre lontane dei pascoli del Reno. Marzio. Me lo ricordo, l’avevo sentito dire dai vecchi contadini.
1-4. Martius … Apitius: Petrarca spiega: «I due pastori rappresentano due generi di cittadini che abitano la medesima città ma che divergono assai uno dall’altro circa la questione del suo governo. Uno è Marzio, bellicoso e irruente, il quale deriva il suo nome da Marte che gli antichi posero come padre del nostro fondatore, e costui è devoto e compassionevole nei confronti della madre. La genitrice è Roma. L’altro fratello è Apicio, altrimenti conosciuto come maestro di cucina, attraverso il quale si possono intendere tutti coloro che s’abbandonano ai piaceri e alla pigrizia» (Petrarca; così semplicemente d’ora in poi le citazioni dalla Dispersa 11, pp. 98-102 dell’ed. Pan-cheri): «Duo quidem pastores duo sunt civium genera in eadem urbe habitantium, sed de Republica longe discordantium; alter est Martius, hoc est bellicosus et inquietus, scilicet a Marte, quem conditoris nostri parentem finxit antiquitas, nominatus, erga genitricem pius et sibi compatiens. Genetrix autem Roma est. Alter frater eius est Apicius, quem magistrum coquine novimus, per quem voluptatibus et inertie deditos licet intelligere». Il Piendibeni (come l’Anonimo) aggiunge i nomi delle famiglie di
75
riferimento: «Martius Columnensium familia est, a Marte dicta, quia bellicosi homi-nes sunt. Apitius domus Ursina, ab Apitio summo in arte epulandi magistro. Cum et ipsi Ursini in epulis et convivijs diligentissimi sunt» («Bucolicum carmen» e i suoi commenti inediti, cit., p. 267). Marco Gavio Apicio fu un famoso e ricco gourmet vis-suto sotto Tiberio di cui parla Seneca, Ad Helviam, x 8 (si veda anche Giovenale, iv 23 e xi 3; Plinio, Nat., x 133; Marziale, iii 22): sotto il suo nome ci resta un trattato, De re coquinaria, che è però frutto di varie stratificazioni successive, risalenti in linea di massima al IV-V secolo (una comoda edizione tascabile è quella a cura di G. Caraz-zali, Bompiani, Milano 1994). L’immagine di base che guida l’egloga è dunque quella che raffigura Roma come una vecchia vedova in lutto. In Petrarca la ritroviamo già in una serie di testi che presentano fitti riscontri con il nostro testo: le Epist. i 2 e 5, indirizzate a papa Benedetto xii nel 1335 e nel 1336 esortandolo a tornare a Roma; la canzone Spirto gentil, Rvf, 53, di datazione (e destinazione) dubbia, ma certo prece-dente il 1347; la Fam., x 1 scritta nel 1350-51 all’imperatore Carlo iv di Boemia esor-tandolo a scendere in Italia (§ 14: «Immagina ora di vedere il venerabile aspetto della città di Roma: pensa a una matrona grave d’anni, dagli sparsi capelli bianchi, la veste lacerata, miserevolmente pallida […]»; «Finge nunc animo almam te Romane urbis effigiem videre; cogita matronam evo gravem, sparsa canitie, amictu lacero, pallore miserabili […]»). L’immagine è anche in Dante: nell’Epist. vi 1, 3 è l’Italia ad essere rappresentata come una misera vedova abbandonata e oppressa; l’Epist. xi ai cardinali italiani si apre citando quello che può essere considerato l’archetipo dell’immagine, Geremia, Lam. 1, 1: «Quomodo sedet sola civitas plena populo, facta est quasi vi-dua domina gentium», ricordato esplicitamente poco avanti, 2, 3, mentre più avanti, 10, 21 ss., Dante sviluppa il concetto che tocca ai cardinali venerare e soccorrere lei «solam sedentem et viduam», con un’esortazione che Petrarca parrebbe riprendere nelle parole della Familiare appena citata: «occorre che voi poniate dinanzi agli occhi della mente quale essa sia, secondo le capacità della vostra immaginazione» («qualis est, pro modulo vestre ymaginis ante mentales oculos affigatis oportet»); Pg, vi 112-3, all’imperatore: «Vieni a veder la tua Roma che piagne / vedova e sola». Ma Roma come vedova piangente è anche in Lucano, i 186-190, e poi Simmaco, sant’Ambrogio, Prudenzio, Cassiodoro, Claudiano (i rinvii completi nell’ed. Berghoff-Bührer, cit., p. 357, note 19-24); e, per quanto ci interessa più da vicino, così è raffigurata nel famoso affresco fatto dipingere da Cola in Campidoglio nel 1344: «Era pento uno grannissimo mare, le onne orribile, forte turvato. In mieso de questo mare stava una nave poco meno che soffocata, senza tomone, senza vela. In questa nave, la quale per pericolare stava, stava una femina vedova vestuta de nero, centa de cengolo de tristezze, sfessa la gonnella da pietto, sciliati li capelli, como volessi piagnere. Stava inninocchiata, incro-ciava le mano piecate allo pietto per pietate, in forma de precare che sio pericolo non fussi. Lo soprascritto diceva: “Questa ène Roma”» (Anonimo, Cronica, cit., p. 106). Si veda per tutto ciò S. Romano, “Regio dissimilitudinis”: immagine e parola nella Roma di Cola di Rienzo, in Bilan et perspectives des études médiévales en Europe. Actes du premier Congrès Européen d’Études Médiévales (Spoleto, 27-29 mai 1993), édités par J. Hamesse, Féd. Int. des Instituts d’Études Médiévales, Louvain-la-Neuve 1995, pp. 329-56: 342-5; M. G. Blasio, “Certe Romani homines non sunt”. Esperienza antiquaria e progetto politico nelle lettere di Petrarca a Cola di Rienzo, in Petrarca e Roma. Atti del Convegno di studi (Roma, 2-4 dicembre 2004), a cura di M. G. Blasio, A. Morisi, F. Niutta, Roma nel Rinascimento (RR inedita, 35), Roma 2006, pp. 125-44: 129, 133.
3. madescent: Africa, viii 832-833: «genitrix resoluta capillos / mesta iacet tundi-tque genas gemituque madescens».
76
4-6. Cuncta vorant … terga iuventus: in opposizione all’interventismo di Marzio, ecco subito la fatalistica e filosofica inerzia di Apicio, il quale ribadirà nel corso dell’egloga che la decadenza di Roma è tanto naturale quanto irreversibile. anni volucres: così Ovidio, Met., viii 239; xii 21. Ma, di Petrarca, si veda Epist. i 14, 88: «Nonne vides volucri labentia secula cursu?»; Fam., xxiv 10: «volucres dies» ecc. arentique … iuventus: topica l’opposizione tra la giovinezza virens e l’ari-dità della vecchiaia (pseudo Acrone, in Orazio, Epod., 13, 4, ed. Keller, i, p. 423: «iuventus viret et senectus arida ponitur»). Si veda Virgilio, Aen., v 295; Ovidio, Ars, iii 555; Trist., iii 1, 7, e sotto, v. 8. dat terga: “volta le spalle”, e quindi “fugge” (Virgilio, Aen., x 365; xii 463 ss.).
7-8. Aspice quot … anus: cioè, considera quante siano le città stabili e vitali nonostante l’età (la quale non può essere, dunque, la causa principale delle condizioni nelle quali versa Roma). Si tratta di un motivo già sviluppato con ampiezza nella Epist. i 2, 24 ss., ove Roma stessa, rivolgendosi a papa Bene-detto xii, osserva che esistono antiche città tuttavia fiorenti (ricorda Mantova, Padova, Pisa), e dunque conclude, vv. 38-43, che sono le interne discordie e le rapine dei figli degeneri ad averla condotta a tale stato: «non deriva dunque dai malanni dell’età che io sia oppressa da rughe senili e dai capelli bianchi, ma piuttosto dal fatto che, da quando te ne sei andato, mai alcun giorno luminoso è sorto per me, né alcun fraterno amore ha tenuto uniti con la sua dolcezza i miei figli ribelli che non si sono fatti scrupolo di oltraggiare la vecchia madre» («Ergo / non venit etatis vitio, quod ruga senilis / canitiesque premat. Sed enim te nulla remoto / illuxit michi pulchra dies, nullaque rebelles / devin-xit fraternus amor dulcedine natos, / haud satis annosam veritos contemne-re matrem»: cito qui e in seguito da F. Petrarca, Epistulae metricae. Briefe in Versen, Herausgegeben, übersetzt und erläutert von O. und E. Schönberger, Könighausen & Neumann, Würzburg 2004, pp. 36-8). Virgilio, Aen., vi 304: è di Caronte una «viridis senectus».
10-1. Querere nos causas … amor: in verità proprio Marzio è abbastanza sbriga-tivo circa le cause, che ravvisa sì nelle lotte tra le fazioni nobiliari (v. 43), ma che con perversa coerenza finisce (vv. 97-100) per far ricadere sull’avversario. suadet amor: Fam., xx 4, 1: «mei amor suadet». Ausonio, Epist. 1, 7, al padre: «pietas mea suadet amorem».
13. Vim … pati: si veda l’«inexorabilis lex nature», in Fam., xii 7, 2.
15. studio … inani: così Virgilio, Buc., ii 5.
20-1. de coniuge … natis: «Le mogli e i figli dei quali Apicio, trascurando la madre, si preoccupa, sono le proprietà terriere e i suoi vassalli» (Petrarca: «Coniuges et filii quibus neglecta madre studet Apicius, terre et eorum vassal-li sunt»). In altri termini, ad Apicio stanno a cuore solo i personali interessi di famiglia.
77
23. vidue: ha valore generale (“vedova” dell’antica potenza), ma può essere inte-so come un’allusione al trasferimento della sede papale ad Avignone, e dunque alla necessità del ritorno, per restituire a Roma la grandezza che le è dovuta (per il tema della “vedovanza” di Roma, si veda sopra, nota ai vv. 1-4).
24. Quis vetat … dulcia verba: notevole anche se non necessaria l’interpretazione dell’Anonimo, per il quale queste parole sono dette da Apicio a parte, tra sé e sé: «“voglio piamente parlare per mostrarmi pio: niente e nessuno mi impedisce di farlo”. E dopo aver detto ciò tra sé, si rivolge a Marzio» («Bucolicum carmen» e i suoi commenti inediti, cit., p. 209: «pie volo loqui, ut pius videar; nam nichil vel aliquis vetat me hoc ostendere. Et ideo postquam intra se hoc dixerat, ad Martium dirigit sermonem»).
27-8. Non comes … senecte: Epist. i 2, 115-116 : «An cessas prebere manus? lap-samque iuvando / erigere et fidus fragili comes esse senecte»; ibid., 152 : «Tu [il papa] vite spes una michi baculusque cadenti»; Epist. ii 12, 70 : «ac pius annose baculus, precor, esto parenti»; Fam., xxii 7, 7: «baculus imbecilli senio».
32. Omnis mora … amantem: Ovidio, Ars, iii 473-4 : «mora semper amantes / incitat».
33. Est domus … colle: «Tra i due c’è una gran discussione sulla pietà filiale dovu-ta alla vecchia madre, e in particolare sul dovere di restituirle la sua antica dimo-ra: e il Campidoglio è tale dimora» (Petrarca: «Inter hos sibi de pietate vetuste matri debita magna contentio est, super restituenda presertim domo eius antiqua, que domus Capitolium est»). Poco avanti, ancora Petrarca riassume così il senso della contesa tra i due: «Apicio non vuole che si restauri il Campidoglio, ma che Roma sia lacerata e divisa in due parti, e che il potere sia alternativamente ora di questi, ora di quelli. L’altro aspira all’unità e là dove ricorda le ricchezze della madre in relazione alla ricostruzione del Campidoglio vuol dire che Roma sarà ancora potente se avrà figli tra loro uniti: Roma che nutre pecore e giovenchi, cioè l’umile plebe e le classi più benestanti» («Vult autem Apicius non refici Capitolium, sed Romam lacerari et in duas partes discerpi, ut alterne nunc apud hos, nunc apud illos summa rerum sit. Alter ad unitatem nititur, et in eo quod ad refectionem Capitolii maternas etiam divitias commemorat, vult Romam adhuc potentem, si filios habeat unanimes, que scilicet et oves et iuvencos pascit [v. 82], plebem scilicet humilem et populum fortiorem»). Per il Campidoglio quale cuo-re del potere imperiale di Roma si vedano Buc., iii 131-63; Ovidio, Met., xiv 822: «in summo nemorosi colle Palati».
34. fratres: gli antichi romani (i Scipioni, i Deci, i Fabi, i Catoni e gli altri come loro, come spiega l’Anonimo: «Bucolicum carmen» e i suoi commenti inediti, cit., p. 209).
37. silvestribus … gazis: Epist. i 2, 132 ; ii 17, 44; iii 2, 15: «inter gazis aurique nito-rem». Virgilio, Aen., v 40: «gaza laetus agresti».
78
38-9. mors invida … fratrum: ormai sono morti non solo gli antichi fratelli, ma anche i loro figli (a rigore, dunque, la discendenza si è interrotta e i moderni “fratelli” sono eredi abusivi degli antichi: si veda avanti, vv. 60-1 e 135-40).
40. Fama viget: così Ovidio, Met., vii 58.
41-2. Nos ludibrio … sepulta est: quelli sono morti, ma la loro fama «viget»; noi siamo vivi («spiramus» sottolinea la mera sopravvivenza), ma la nostra fama gia-ce, e addirittura s’è trasformata in ludibrio, in vergogna.
42-3. Sub nobis … non passa furores: è questo il punto in cui Marzio fa parziale autocritica. è sotto il nostro potere – egli dice – che i destini di Roma sono preci-pitati, dal momento che la città non è riuscita a sopportare le conseguenze delle guerre tra le nostre famiglie.
52. tecum, germane, loquor: è detto con perfidia (“tu sai bene di cosa parlo […]”, e insomma “anche tu, come me, vivi di rapina”). Il motivo della grande no-biltà romana come un’accolita di rapinatori e saccheggiatori, insieme a quella dell’origine straniera delle famiglie dei Colonna e degli Orsini (si veda avanti, vv. 137-40), percorre tutta l’Hortatoria: «voi [cittadini romani] siete assediati da branchi di lupi famelici»; quelle grandi e superbe famiglie «senza furti e rapine non saprebbero come calmare la loro fame»; «Quelli per cui avete tante volte versato il vostro sangue, che avete nutrito con le vostre fatiche e i vostri patri-moni, che a prezzo della pubblica miseria avete innalzato a private ricchezze, costoro non vi hanno giudicato degni della libertà e hanno ammassato nel fondo delle loro spelonche e negli infami nascondigli delle loro rapine le spoglie della repubblica lacerate e fatte a pezzi»; voi cittadini di Roma avete taciuto «dinanzi a pochi ladruncoli che imperversavano in Roma come in una città conquistata»; fate attenzione «affinché nessuno dei lupi rapaci che avete cacciato dai vostri ovili e che ancora adesso vanno continuamente strepitando attorno ai recinti con finti gemiti e in apparenza più mite, irrompa con l’inganno là donde con la forza ha dovuto uscire»; e ancora ai cittadini di Roma: «Ditemi: voi che non avete sop-portato l’arbitrio dei re e degli imperatori romani, sopporterete ancora la rabbia sanguinosa di questi predoni stranieri e la loro insaziabile avidità? » (Disp. 8, rispettivamente p. 40: «vos famelici luporum greges obsident»; p. 44: «qui sine furtis ac rapinis famem sedare nequeunt»; p. 50: «Pro quibus sanguinem vestrum totiens fudistis, quos vestris laboribus, vestris patrimoniis aluistis, quos publica inopia ad privatas copias extulistis, hii neque vos libertate dignos iudicarunt, et laceratas reipublice reliquias carptim in speluncis et infandis latrocinii sui pe-netralibus congesserunt»; p. 52: «coram paucis latrunculis non aliter quam in capta urbe crassantibus»; p. 54: «ne quis forte luporum rapacium, quos a vestris ovilibus repulistis et qui etiam nunc assidue septa vestra circumstrepunt, ululatu ficto aut specie alia blandiore, unde violenter exivit, fraudolenter irrumpat»; p. 68: «Dicite michi: si Romanorum regum et imperatorum licentiam non tulistis, alienigenarum predonum tamdiu cruentam rabiem et inexplendam avaritiam
79
preferetis?») ecc. Ma già nell’Epist. i 2, 89-92 Roma lamenta sia la guerra civile che la dilania, sia le rapine che subisce da avidi tiranni, assomigliati ai Proci che in assenza del capo della casa (qui, il papa) l’hanno occupata e violata.
60-1. Occidit … sobolis: ribadisce che c’è stato un salto di generazioni (si veda sopra, vv. 38-9), e che i figli di quegli antichi romani non esistono più.
63. paucos: pochi, e in miseria.
64-5. duplicisque … imbres: il senso non è del tutto chiaro. Petrarca spiega: «Le spelonche di cui si parla sono le fortezze dei potenti che da esse resi sicuri in-sultavano le calamità del popolo» («Antra autem que nominantur, arces sunt potentium, quarum fiducia calamitatibus publicis insultabant»). L’Anonimo, fe-dele al contesto bucolico: «cioè una casetta con due tetti […] una casetta ci può accogliere, e sarà sufficiente a ripararci dalle piogge e dal freddo» («Bucolicum carmen» e i suoi commenti inediti, cit., p. 211: «idest aliqua domuncula cum duo-bus testis […] casula nos capit et sufficiens erit ad arcendum imbres et frigus»: restando all’imagery bucolica, si noti Epist. i 4, 55: «ramorum densa testudine»). Ma è ovviamente a Petrarca che dobbiamo attenerci, e intendere che in caso di pericolo sia Marzio che Apicio, cioè i Colonna e gli Orsini avrebbero dovuto semplicemente ritirarsi nei loro ben difesi castelli, al riparo dai ventos e imbres, cioè dagli attacchi nemici (onde la “duplice testudine” potrebbe alludere a un doppio ordine di strutture difensive, corrispondente forse, sul piano simbolico, a un duplice ordine di minacce: quelle derivanti dalle guerre tra famiglie e quelle derivanti dai tentativi di riscossa dei cittadini di Roma). Il che è ciò che regolar-mente avveniva, come proprio Cola, che s’esaurì in inutili assedi, ben sapeva, e sapeva l’Anonimo romano (si veda per esempio Cronica, cit., pp. 141-2: «Fra tan-to [settembre 1347] Colonnesi e·lli signori de Marini, missore Ranallo e missore Iordano, fortificavano le loro fortellezze […] Fortificano Marini e renovano lo fossato intorno. Menano uno forte steccato de doppie lena» ecc.). Ma un’altra spiegazione è possibile, più coerente al testo, intendendo che con «duplicis te-studinis» si alluda ai due quartieri di Roma controllati e ben difesi dalle due famiglie, Castel Sant’Angelo per gli Orsini e San Marcello per i Colonna. Così, seppure con qualche confusione, sembra intendere il Piendibeni («Bucolicum carmen» e i suoi commenti inediti, cit., p. 269).
66-7. mater ubi alternis … honore: per questo festeggiare a giorni alterni, si veda la spiegazione di Petrarca già sopra citata, nota 33: «Apicio non vuole che si restauri il Campidoglio, ma che Roma sia lacerata e divisa in due parti, e che il potere sia alternativamente ora di questi, ora di quelli», mentre l’Anonimo specifica, confermando il generale orientamento filo-colonnese autorizzato da Petrarca medesimo nella lettera: «tra altri motivi di discordia tra i Colonna e gli Orsini questo era il principale: i Colonna volevano che la sede del governo e giu-diziaria fosse in Campidoglio, come s’usava nell’antichità; per contro, gli Orsini dicevano di volere che tale sede fosse a casa loro, nel quartiere di Sant’Angelo,
80
quando sarebbe toccato a loro esercitare il potere, e che in modo analogo fosse a casa dei Colonna, cioè a San Marcello, quando fosse toccato a loro: le due fami-glie, infatti, comandavano a mesi alterni. Così, la repubblica era divisa, perché gli Orsini volevano fare della sede del governo qualcosa di esterno e privato, mentre i Colonna la volevano riportare in seno alla comunità» («Bucolicum carmen» e i suoi commenti inediti, cit., p. 207: «inter alias contentiones hec inter ipsos Collunenses et Ursinos principalis: nam ipsi Collunnenses volebant ipsam curiam romanam et iudicium esse in Capitolio, ubi antiquitus consueverat; et etiam ipsi vero Ursini dicebant se velle eandem curiam esse ad eorum domus, ad castra sancti Angelj, seu ea vice, cum eis dominium contingeret; et similiter esse ad domum Columnen-sium, seu ad sanctum Marcellum, cum illis dominium contigeret; nam per men-sem vicissim quisque dominabatur. Ita res publica divisa erat, ita Ursini volebant detrahere curiam ad peregrina ac privata, Colunnenses vero ad locum comunem»: così introducendo l’egloga, mentre ripete la cosa avanti, p. 211, a proposito degli «alternis diebus» del v. 66). Lo segue il Piendibeni, che applica questa spiegazione all’antro dalla “duplice testuggine” dei versi precedenti (vedi).
68. despecta: anche in Epist. i 5, 1-2, Roma è rappresentata come «despecta […] femina».
75-6. Quin saepta … sedes: i saepta sono i recinti per gli animali, ma anche i muri delle case e in particolare, come ricordano François e Bachmann, i recinti del Campo Marzio nei quali si radunavano per votare i cittadini, divisi per centurie (Cicerone, Mil., 48); il Piendibeni, («Bucolicum carmen» e i suoi commenti ine-diti, cit., p. 269): «septa: sacra loca, vel claustrum Capitolij». Il Lare era il nume protettore del focolare domestico, ma anche della città (Ovidio, Fast., v 135-6: i Lari «stant quoque pro nobis et praesunt moenibus Urbis / et sunt praesentes auxiliumque ferunt»). Marzio consiglia dunque di installarsi stabilmente nel cuo-Marzio consiglia dunque di installarsi stabilmente nel cuo-re politico e religioso di Roma, e insomma nel cuore del potere. Si ricordi, per contro, che nella citata lettera ai quattro cardinali riformatori, nel 1351, Petrarca raccomandava loro di escludere dal governo della città proprio gli interlocutori dell’egloga, i Colonna e gli Orsini: «questi nobili non solo non devono accedere al senato e alle altre dignità, ma ne devono essere completamente allontanati per lungo tempo, perché per lungo tempo essi soli hanno usurpato tali cariche, in forza della loro arroganza e per la passività della plebe» (Fam., xi 16, 11: «hos nobiles non modo senatoriam et reliquas dignitates participare cum aliis, sed diu etiam ab his penitus abstinere, quas diu soli per arrogantiam suam et plebis patientiam usurparunt»).
76-7. Hinc iussa … accipiant: nei versi precedenti Marzio accentuava il carattere di servizio del suo progetto, di pura dedizione ai bisogni della vecchia madre; ma subito, qui, il discorso si ribalta e il vero contenuto dell’operazione si rivela per quello che è: sfruttare il nome di Roma per tornare al potere e per continuare a godere delle sue ricchezze (si vedano soprattutto vv. 82-3). L’essenziale analisi di questo atteggiamento Petrarca torna ad esprimerla nella citata Fam., xi 16, 18:
81
i nobili romani proclamano di voler governare in servizio alla città, ma «crede-temi, hanno in mente il contrario: non già di calmare ma piuttosto di scatenare l’insaziabile fame della loro avidità su ciò che resta di questa disastrata città. Ma probabilmente avranno il coraggio di negarlo, e vorranno nascondere con l’impudenza di poche parole la condotta ben nota al mondo di tutta la loro vita, e vorranno esser chiamati cittadini romani e amanti della loro patria. Non è così […]» («At michi credite, contrarium meditantur, ut scilicet de reliquiis sparse urbis insatiabilem avaritie sue famem non tam mitigent quam accendant. Verum et hoc negare forsitan audebunt et unius verbi impudentia notam mundo totius vite seriem occultare et romani cives et amantes patrie dici volent. Non ita est […]»).
80-1. Aggrediamus … expertis: già nella Hortatoria: «Di più, molte cose che sem-brano dapprincipio difficili a chi le affronta diventano poi facilissime se si perse-vera» (Disp. 8, p. 62: «Adde, quod et multa difficilia primum aggredientibus visa sunt, que longius progressis apparuere facillima»).
82. pascit oves … iuvencos: Marzio si fa forte del fatto che la madre è ancora in condizione di produrre qualche ricchezza, che le viene dai «populares homines qui labore et sudore vivunt», come spiega l’Anonimo («Bucolicum carmen» e i suoi commenti inediti, cit., p. 212), siano essi di condizione plebea oppure più benestanti (Petrarca: «oves et iuvencos pascit [v. 82], plebem scilicet humilem et populum fortiorem»; si veda sopra, nota 33).
83. unde … opes: è la versione che Marzio dà rispetto ai furti e le rapine di cui parlava Apicio (v. 52). Si tratta di un passaggio delicato e rivelatore perché, con allusiva ed efficace torsione logica («pascit […] cumulamus»), Petrarca sottolinea come sia Roma a possedere l’insieme dei beni dai quali la grande aristocrazia ri-cava il cumulo delle proprie ricchezze (si veda sopra, v. 52). Il progetto di tornare uniti per godere del favore della madre si rivela dunque come quello che intende affermare un potere così solido e totale su quella ricchezza da stroncare ogni op-posizione e sospetto di rapina. In altre parole, è proprio la lotta tra le opposte fa-zioni che rende automaticamente evidente ove davvero stia la sorgente prima della ricchezza, ma contemporaneamente svela anche il meccanismo di rapina messo in opera dalle grandi famiglie. Mentre – suggerisce Marzio – la saldatura dei loro comuni interessi nell’esercizio incontrastato e indiviso del potere avrebbe il potere di nasconderla: come si potrebbe, a quel punto, essere ladri del proprio?
83-4. Ars fallere … pueris: hanno ragione François e Bachmann a dire che questo aforisma «surprend et détonne dans le contexte», anche se accettano la spie-gazione corrente che risale all’Anonimo: «si noti ch’è dei fanciulli ingannare la madre, ma non per questo dobbiamo ingannarla noi, che siamo uomini» («Bu-colicum carmen» e i suoi commenti inediti, cit., p. 212: «idest nota esse pueris decipere matrem, ideo non est quod nos decipere debemus, qui sumus viri»). Essa appare ragionevole anche se non perfettamente a fuoco (nel testo, l’accento
82
cade sul fatto che l’arte di ingannare la madre è la prima che i fanciulli imparino, onde la conseguenza che se ne trae non va senza qualche forzatura). Per parte mia, credo che il disagio interpretativo derivi dalla voluta ambiguità del testo, che si presta perfettamente a essere letto più o meno come: “persino i bambini imparano presto come ingannare la madre!”, e dunque come un’esortazione, appunto, a farlo. Se così fosse, la sostanziale doppiezza del discorso di Marzio, apparentemente ingenuo e lineare, avrebbe raggiunto il suo esito ultimo, lungo il filo della straordinaria doppiezza della scrittura di Petrarca.
84. Fortune frusta vetuste: corrisponde alle «reliquie sparse urbis» della Fam., xi 16, 18, citata sopra, nota ai vv. 76-7.
85. terre salis … acervum: «Tra gli altri avanzi dell’antica fortuna ricorda anche il sale nascosto, con il quale possiamo semplicemente intendere gli introiti pub-blici della tassa sul sale, che, come sento dire, sono elevati: tuttavia è meglio intenderlo come la sapienza dei Romani da lungo tempo nascosta per paura dei tiranni» (Petrarca: «Inter ceteras autem fortune prioris reliquias et salis occulti meminit, per quem licet simpliciter publicos ex sale redditus, qui ut audio magni sunt, possimus accipere, melius tamen accipe sapientiam Romanorum diutius metu tyrannidis occultatam»). In omaggio alle regole del “genere”, Petrarca si sente in dovere di fornire una spiegazione allegorica, ma intendere che si tratti letteralmente del sale sembra la spiegazione migliore: le finanze di Roma erano disastrate dalla pessima amministrazione clientelare, ma le entrate dovute alla tassa sul sale erano altissime, tanto che già in luglio Cola poteva dichiarare al papa che il riordino dell’estrazione del sale permetteva una rendita di 30.000 fiorini l’anno, in virtù della quale gli era stato possibile eliminare alcune gabelle (Burdach, Piur, Briefwechsel, cit., vol. ii, t. 3, p. 43: si veda Di Carpegna Falconie-ri, Cola di Rienzo, cit., p. 82 e note). Naturalmente, Marzio non sembra affatto pensare alla buona amministrazione, ma piuttosto vuole convincere Apicio che entrambi avrebbero avuto il loro tornaconto nel fare la pace e nel tornare diret-tamente al governo della città.
87. aspergine: Epist. ii 15, 55-6: «fontesque tepentibus undis / antra rigant roran-tque salubri aspergine campi».
88-9. insuper ad veteres … ultra: elenca una serie di territori a nord di Roma, già facenti parte dei suoi domini: Orte, Sutri, l’Umbria. Così, infatti, Petrarca spie-ga: «La strada per i vecchi orti e per le dimore di Saturno è quella che conduce alla vecchia città di Orte e a Sutri, e all’ombrosa Tempe, cioè all’Umbria, nella quale si trovano Narni e Todi e molte altre città» (Petrarca: «Iter illud ad veteres hortos et ad Saturni domos, hoc est ad Hortanam civitatem veterem ac Sutrium ducit, et ad umbrosa Tempe: hoc est ad Umbriam in qua est Narnia et Tudertum et alie multe»). Tempe era una valle della Tessaglia nota per la sua bellezza, ma in Virgilio, Georg., ii 469, la frigida Tempe vale genericamente per una fresca vallata (si vedano anche Catullo, lxiv 285-6: «viridantia Tempe, / Tempe, quae silvae
83
cingunt super impendentes», e Orazio, Carm., iii 1, 24). Anche nel carme Ursa peregrinis, v. 20, la «nemorosa Tempe» rappresentava l’Umbria (cfr. Billanovich, Un carme ignoto del Petrarca, cit., p. 119; si veda Buc., iv 51).
90. Lidius … habet: quelle regioni sono ora in possesso di un “lidio” e dunque di un etrusco. Secondo gli antichi, infatti, gli etruschi erano originari dell’Asia minore (Virgilio, Aen., viii 479-80; Orazio, Sat., i 6, 1-2), onde Petrarca «[…] e ancora oltre in Toscana, il cui popolo tu sai ch’è disceso dalle genti di Lidia» («[…] et ulterius in Tusciam, cuius populus a Lidorum gente profectos esse non ignoras»). L’ipotesi più probabile è che qui si alluda a Giovanni di Vico, signore di Viterbo e prefetto di Roma, il quale controllava il Lazio settentrionale e aveva rifiutato di giurare fedeltà a Cola, che nel giugno del 1347 gli mosse guerra, co-stringendolo a venire a patti. Nel 1354 Cola partecipò a un’altra guerra contro di lui, al seguito dell’Albornoz. 91-3. rivus … Pons: il Tevere e il ponte Milvio. Petrarca: «e il ponte attraverso il quale [Roma] soleva raggiungere la sua campagna è il ponte Milvio, sopra il fiu-me, cioè il Tevere, che discende dalle elevate vette dell’Appennino» («et ponte, quo rus suum petere solebat, qui pons Milvius est, supra rivum, hoc est Tiberim, ex alto Apennini vertice descendentem»).
92. impedit … transverso gurgite: Livio, xxiii 19, 11: «amnis transverso vertice».
93. Pons fuit hic: il ponte Milvio (si veda sopra, 91-3).
94-7. tacitos quo … meritis fregit: «Il pastore là ricordato, che sul ponte scoprì e uccise i ladri, è Marco Tullio Cicerone, il quale, come sai, sul ponte Milvio scoprì la congiura di Catilina. Opportunamente è detto pastore in quanto console, e ar-guto perché principe dell’eloquenza» (Petrarca: «Pastor autem, de quo illo loco fit mentio, qui fures in ponte reperit et occidit, Marcus Tullius Cicero est, qui ut nosti supra pontem Milvium coniurationem reperit Catiline. Bene pastor, quia consul; bene argutus propter eloquentie principatum»). Nel 63 a.C. alcuni am-basciatori dei Galli rivelarono segretamente alle autorità di avere con sé alcune lettere compromettenti per Catilina e i suoi: nella notte tra il 2 e il 3 dicembre fu organizzato un finto agguato sul ponte Milvio ai danni degli ambasciatori, furo-no loro sottratte le lettere e, con quelle in mano, Cicerone ottenne l’immediata esecuzione dei congiurati che erano in città.
97-9. Tua dextera … michi properas: nel 1335 ci fu una fase acuta nella lotta tra gli Orsini e i Colonna, e in essa si scatenò anche la cosiddetta “guerra dei ponti”, che, meno il ponte Mammolo, erano controllati dai colonnesi. Il 3 settembre gli Orsini conquistarono il ponte Milvio (allora chiamato ponte Molle) e distrussero le due arcate centrali. Il 9 Stefano Colonna lo riconqui-stò, ma il ponte rimase inagibile, e ancora lo era al tempo di Cola, anche se nel 1343 la regina di Ungheria, in visita a Roma, aveva devoluto una grossa somma per ricostruirlo. Una allusione a tutto ciò è probabilmente nell’Hortatoria a
84
Cola, Disp. 8, p. 52, ove Petrarca inveisce contro le grandi famiglie talmente feroci e barbare che «in pontes, in menia atque immeritos lapides desevirent». Si veda Petrarch, The revolution of Cola di Rienzo, cit., pp. 36-7. Per un’antica iscrizione che documenta la rovina del 1335 si veda A. Mercati, Nell’Urbe dal-la fine di settembre 1337 al 21 gennaio 1338, Pontificia Università Gregoriana, Roma 1945, pp. 14-5.
98. tumidas … in undas: Ovidio, Fast., iii 595: «tumidas […] per undas»; Trist., i 5, 77: «tumidis […] in undis» (così Stazio, Theb., ix 315, e si veda Lucano, i 370 ecc.). Virgilio, Aen., xi 393: «tumidum […] Thybrim», e si vedano pure, con ae-quor o mare, Virgilio, Aen., i 142; iii 156; viii 671; Ovidio, Her., 18, 33 e 193.
100. et gregibus silvisque noces: «La selva danneggiata dal crollo del ponte e il gregge sono rispettivamente la patria e il popolo romano» (Petrarca: «Silva qui-dem, cui pontis ruina damnosa est, et grex patria est et populus Romanorum»). La rovina del ponte è dannosa perché isola Roma da quelli che dovrebbero esse-re i suoi territori (si veda sopra, nota 91), che non riesce più a controllare. Ma ciò appunto è un bene per Apicio (sono infatti i suoi Orsini che l’hanno distrutto), il quale vuol farne convinto anche Marzio (vv. 103 ss. e 112-3).
105-11. rus breve … ad primas rediere vias: Petrarca mette in bocca ad Apicio una considerazione che s’avvicina molto a quella tipica della polemica anti-imperiale e anti-romana dei regalisti francesi e angioini del tempo di Filippo il Bello, tra Duecento e Trecento, contrastata da Dante nel secondo libro della Monarchia. Secondo la loro visione, l’impero romano si era formato attraverso una serie continua di guerre e violenze, e non godeva di altra legittimazione al di fuori di quella procurata dalla forza. Perciò, come era cresciuto, così era giusto e inevitabile che fosse decaduto, sì che il suo tornare ai primitivi confini e la frammentazione in vari regni delle regioni occupate non facevano altro che ripristinare la situazione normale, alterata in modo abnorme dallo strapotere militare romano. Né è un caso che Apicio ricorra a questo schema: la nostra situazione di debolezza è tale – egli spiega a Marzio – che ogni potere forte non potrebbe che distruggerci, mentre la debolezza e l’isolamento di Roma sono la migliore garanzia della nostra sopravvivenza: assai precaria, per altro, e minacciata dall’imminente fine.
106-7. fratribus … nos sumus: sarcastica allusione a Romolo e Remo, che si sono amati tra loro quanto, oggi, gli Orsini e i Colonna.
107-8. Arcta … confinia: nella lettera del 18 novembre 1351 ai quattro cardinali, Petrarca traccia lo stesso percorso, dal nulla al nulla: «seguite gli esempi del tempo in cui questa città salì al cielo dal nulla, non di questo in cui da un destino tanto alto è stata quasi ridotta al nulla» (Fam., xi 16, 33: «eius temporis exempla sequimini quo urbs illa de nichilo surrexit ad sidera, non huius quo de tante fastigio fortune pene ad nichilum est redacta»).
85
115. Festinus: «Mentre i due stanno così litigando sopraggiunge un uccello, cioè “la Fama della quale nessun male è più rapido” come dice Virgilio» (Petrarca: «Qua de re sic altercantibus, volucer supervenit, hoc est: Fama malum quo non aliud velocius ullum, ut ait Maro [Aen., iv 174]». In Disp. 8, p. 64, è la Fama che porta a Petrarca notizie di Cola.
115. Quid vano … horas: «Questo uccello inveisce contro le loro vane questioni e gli inutili alterchi» (Petrarca: «Hic volucer curas eorum vanas arguit et iurgia superflua»). Africa, i 459: «Quin [… ] brevem consumimus horam?».
116. Tertius … soletis: «Questo fratello sin qui minore sei tu» (Petrarca: «Frater iste iunior hactenus est tu»), cioè Cola di Rienzo, dal 20 maggio 1347 padrone della città, già minor in quanto di origine umile ma destinato a diventare maior quale vincitore sulla vecchia oligarchia. Disp. 8, p. 50, dei nobili e di Cola: «Illi humilitatem viri huius contemnebant atque calcabant».
117-8. iam fundamenta … patria: probabile allusione alle leggi immediatamente emanate da Cola subito dopo aver preso il potere, che contenevano una serie di disposizioni fondamentali per cominciare a rimettere ordine nella città, sia sul piano politico che su quello amministrativo. Per l’elenco delle prime leggi emanate, si veda Anonimo, Cronica, cit., pp. 113-4. Questa parte dedicata alle migliorate condizioni di Roma cala in una dimensione concreta quanto Petrarca auspicava esortando papa Benedetto xii a tornare a Roma: si vedano Epist. i 2, 183 ss., e 5, 108 ss.
118-20. genitrix … cuncta sibi: gli inizi di Cola erano stati in effetti assai fortunati; sia il popolo di Roma che il papa lo appoggiavano, e l’opposizione baronale sem-brava schiacciata e impotente. Nella Sine nom. 4, 46 ss., del novembre 1352, in difesa di Cola allora imprigionato in Avignone, Petrarca sottolinea quante buone cose Cola fosse riuscito a fare in pochi mesi.
120. Curas … seniles: si veda Ausonio, Epist. iii 11: «curam […] senilem». Questa è una variante del motivo del “giovane canuto”, ossia del giovane che agisce con il senno e la capacità di decisione di un uomo maturo. Sul motivo, si veda G. Cipriani, Scipione “Enfant Prodige”, in Preveggenze umanistiche di Petrarca. Atti delle Giornate petrarchesche di Tor Vergata (Roma-Cortona, 1-2 giugno 1992), eTs, Pisa 1993, pp. 141-70.
121-2. ense puer … colla premantur: alcune esecuzioni esemplari imposero sin da principio l’autorità di Cola, che fece tagliare la testa a un monaco “infama-to” e impiccare come un delinquente comune il nobile Martino Stefaneschi. Virgilio, Aen., xii 175: «stricto ense» («stricto ferro», Aen., iv 579-580 e x 715).
123-4. Pinguibus arentes … lupos: tra le prime disposizioni di Cola vi fu quella di mettere sotto diretto controllo delle autorità cittadine i ponti e le vie di ac-
86
cesso a Roma, tradizionalmente nelle mani dei baroni, che non potevano più avere fortificazioni in città. L’elenco di animali che segue (con i lupi, l’orso, il cinghiale, la serpe, i leoni, le aquile) designa altrettante nobili famiglie, come Petrarca spiega: «sotto il nome di alcune fiere ho nascosto i nomi, l’indole o gli stemmi di altrettanti tiranni» («sub ferarum vocabulo quorumdam ex tyrannis vel nomina vel naturas vel armorum signa recondidi»). Già gli antichi interpreti sono tuttavia in difficoltà nell’identificare le corrispondenze esatte, salvo che per l’orso, che naturalmente sta per gli Orsini (si veda Rvf, 103, 5-8). In genere s’intende che i lupi rimandino ai conti di Tuscolo; la serpe proba-bilmente agli Anguillara; i leoni ai Savelli (che avevano nello stemma un leone circondato da rose) o agli Annibaldi; le aquile al ramo dei conti di Tuscolo da Segni (aquila nello stemma), o ai conti di Vico. Ma il cinghiale (aper)? Nella canzone 53 dei Rvf, Spirto gentil, Petrarca elenca allo stesso modo le famiglie nobili nemiche dei Colonna: «Orsi, lupi, leoni, aquile et serpi / ad una gran marmorea colonna | fanno noia sovente, et a sé danno» (vv. 71-3). Come si vede, manca solo l’aper, che per il Piendibeni («Bucolicum carmen» e i suoi commenti inediti, cit., p. 271) ora rappresenterebbe appunto i Colonna, e con lui oggi sono François e Bachmann (l’aper, infatti, «s’ajoutant à la liste du poème italien, doit – en bonne logique – avoir remplacé la gran marmorea colonna, image de beauté et de majesté»). La cosa è credibile anche per la caratterizzazione dell’animale, definito “sanguinario”, che ben s’adatta alla immagine guerriera, e dunque alla natura, dei Colonna evidente anche nel suo rappresentante nell’egloga, Martius. Nella Sine nom. 2 a Cola, §§ 10 e 12, Cola stesso è un leone, mentre i suoi nemici sono “rane rigonfie”. Importante anche la corrispondenza con l’affresco fatto fare da Cola in Campidoglio (si veda so-pra, nota ai vv. 1-4) nel quale erano rappresentati quattro ordini di animali: «Lo primo ordine erano lioni, lopi e orzi. La lettera [il cartiglio] diceva: “Questi so’ li potienti baroni, riei rettori”. Lo secunno ordine erano cani, puorci e caprioli. La lettera diceva: “Questi soco li mali consiglieri, sequaci delli nuobili”. Lo terzo ordine stavano pecoroni, dragoni e golpi. La lettera diceva: “Questi soco li falzi officiali, iudici e notari”. Lo quarto ordine stavano liepori, gatti e crape e scigne. La lettera diceva: “Questi soco li populari, latroni, micidiari, adulteratori e spo-gliatori”» (Anonimo, Cronica, cit., p. 107).
125. sibilat anguis: la stessa clausola in Lucano, vi 69.
128-9. excelso … silent: Festinus annuncia a Marzio e Apicio che «il fratello mi-nore, con il consenso della madre, già erige dimore e governa le selve, e cantando dolcemente alle mandrie, cioè promulgando leggi giustissime e abrogando quel-le dannose, impone loro il silenzio» (Petrarca: «iuniorem fratrem matris consen-su domos erigere, silvas regere, eisque silentium indicere, gregibus animalium canentem dulciter, hoc est leges iustissimas ferentem et nociva repellentem»). Virgilio, Aen., i 164: «Aequora tuta silent».
129. litus utrumque: il Tirreno e l’Adriatico.
87
131. undifragi … Pelori: Petrarca parla di capo Peloro, in Sicilia, presso Messina, in Africa, viii 321-9. Si veda Virgilio, Aen., iii 410 ss. (François-Bachmann).
133. Arctoas … nives: Arctos è l’Orsa maggiore, e per metonimia la regione del nord (Orazio, Carm., i 26, 3).
134-5. capellas … inopes: ribadisce che le grandi famiglie baronali vivono di rapi-na e che le loro legittime ricchezze si riducono a ben poco (si veda sopra, v. 52).
135-40. Negat … Rheni: il motivo polemico dell’origine straniera dei Colonna (renana) e degli Orsini (spoletina), principali ladroni delle ricchezze di Roma, ne fa anche dei barbari e in quanto tali dei saccheggiatori per definizione. Lo si leggerà ancora nelle due lettere del novembre 1351 ai quattro cardinali incaricati di riformare il governo della città, Fam., xi 16, 9 e 14, e Fam., xi 17, 4, ma è già nell’Hortatoria, qui direttamente ripresa: «Enumerate coloro che vi hanno strap-pato l’onore e le ricchezze, che hanno distrutto la vostra libertà: esaminate l’ori-gine di ognuno di loro. Questo ce l’ha mandato la valle di Spoleto, quell’altro il Reno o il Rodano o qualche altro ignobile angolo della terra. Così, quello che era stato trascinato in trionfo con le mani incatenate dietro la schiena di colpo, da prigioniero che era, è diventato cittadino. Anzi, non cittadino, ma tiranno […]» (Disp. 8, 2, p. 42: «Decoris vestri fortunarumque raptores, libertatis eversores dinumerate, singulorum origines recensete. Hunc vallis Spoletana, illum Rhenus aut Rhodanus aut aliquis ignobilis terrarum angulus misit. Ille vinctis post ter-gum manibus ductus in triumpho repente de captivo factus est civis. Imo vero non civis sed tyrannus […]»). E ancora: «A me tocca stabilire solo questo, che certamente non sono Romani. Di tutti costoro che vedevate così superbamente altezzosi d’un vano titolo di nobiltà, da qualsiasi parte siano arrivati, quale ma-laugurato vento li abbia trasportati, quale barbarie li abbia mandati, per quanto abbiano calpestato il vostro foro e siano saliti al Campidoglio circondati dalla folla dei loro sgherri, per quanto, infine, abbiano oltraggiato con il loro piede superbo le ceneri degli illustri romani, ebbene, non ce n’era alcuno che non fosse straniero e che, come dice il Satirico: “non fosse appena arrivato in questa città con i piedi tinti di bianco”» (ivi, p. 46: «Quod unum diffinire meum est, certe Romani homines non sunt. Horum omnium, quos inani nobilitatis titulo tam superbe fastidiosos videbatis, undecumque venerint, quolibet infelici vento de-lati sint, quecumque illos miserit barbaries, quamvis foro vestro obversarentur, quamvis stipati satellitum turbis in Capitolium ascenderent, quamvis superbo gressu Romanorum illustrium cineribus insultarent, nemo non peregrinus erat, et ut ait Satyricus [Giovenale, i 111]: “Nuper in hanc urbem pedibus qui venerat albis”»). Riferita ai soli Orsini l’accusa di essere arrivati a Roma come schia-vi è già nella metrica Ursa peregrinis, v. 4, del 1333: vi sarebbero infatti arrivati con i piedi tinti di bianco, pedibus albis, come appunto avevano gli schiavi che dovevano essere venduti al mercato (si veda Billanovich, Un carme ignoto del Petrarca, cit., p. 119). L’origine romana, tuttavia, dei Colonna (ma francese del Sud era la moglie di Stefano il vecchio, Gaucerande de l’Isle-Jourdain, donde
88
forse l’accenno di Petrarca al Rodano nel primo dei passi appena citati) e quella tuscolana degli Orsini non sembrano da mettere in discussione. Al proposito, mi limito qui a rimandare agli eccellenti saggi di G. Crevatin, Roma e i barbari, in Petrarca e Roma, cit., pp. 49-60: 57 ss., e di M. G. Blasio, al quale in toto torno a rinviare, “Certe Romani homines non sunt”, cit., pp. 140 ss., e a S. Carocci, Baroni di Roma. Dominazioni signorili e lignaggi aristocratici nel Duecento e nel primo Trecento, École Française de Rome, Roma 1993, che oltre alla bibliografia sull’ar-gomento offre ottime schede sulle grandi famiglie romane con ampio corredo di carte e tavole genealogiche.
141. Nunc memini … bubulcos: gli antichi già lo sapevano, anche se poi è calato il silenzio dinanzi all’evidente interesse di quelle famiglie a farsi passare per ro-mane.









































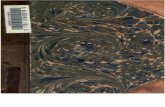



![Francesco Petrarca - Canzoniere [eBook ITA]](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/557211bc497959fc0b8f6cbc/francesco-petrarca-canzoniere-ebook-ita.jpg)




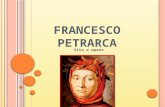





![[Dante Alighieri, A Cura Di Natalino Sapegno] La D(BookZZ.org)](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/5695d0f81a28ab9b02949ee4/dante-alighieri-a-cura-di-natalino-sapegno-la-dbookzzorg.jpg)


