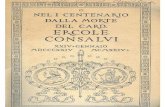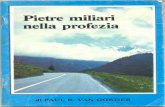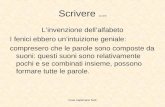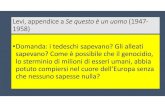Pensieri,parole,numerieomissioni( · sapevano!contare!fino!a!99.999.!Con!un!buon ......
Transcript of Pensieri,parole,numerieomissioni( · sapevano!contare!fino!a!99.999.!Con!un!buon ......
Pensieri, parole, numeri e omissioni
Spesso gli eventi sono riportati dai media in modo scorretto, abbelliti nella forma e non spiegati nella sostanza. Il progetto Numerage di Adriano Attus, da cui è tratta questa immagine, è una provocazione che ci introduce al mondo dei numeri in maniera critica. Qui, attraverso la tecnica del collage viene proposta una semplice serie di numeri (da uno a cento) recuperati dai quotidiani di tutto il mondo. Nell’assemblaggio vengono forzate tante regole di percezione visiva e lo spettatore, per seguire la successione ordinata, ha bisogno di tempo e attenzione. La forma è gradevole a livello estetico ma il messaggio risulta sovraccarico nella presentazione. Cosa significa tutto ciò? Che i numeri, quando manipolati, mentono: il focus è perso, il lettore disorientato, la verità nascosta. I numeri, quindi, sono uno strumento potente, a disposizione di chi li sa adoperare. Ma cosa sono, davvero, i numeri?
Novem figure indorum he sunt 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Cum his itaque novem figuris, et cum hoc signo 0, quod arabice zephirum appellatur, scribitur quilibet numerus, ut inferius demonstratur. Le nove cifre degli indiani sono queste: 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Con queste nove cifre, e con questo simbolo: 0, che in arabo si chiama zephir, si può scrivere qualsiasi numero, come si vedrà più avanti. Leonardo Pisano, figlio di Guglielmo dei Bonacci e quindi in quanto filius Bonacci detto Fibonacci, scrisse il suo Liber Abaci nel 1202 di ritorno da alcuni anni passati prima in Algeria e poi a Costantinopoli dove conobbe il sistema di numerazione utilizzato dagli arabi e di fatto lo importò in occidente. Ma la storia dei numeri comincia ben prima, probabilmente 30.000 anni fa. Alcune incisioni testimoniano la volontà di tenere il conto di qualcosa, forse il numero degli animali o il passare dei giorni. Di certo nelle società preistoriche il numero non aveva assunto ancora il carattere astratto che percepiamo oggi e non esisteva il 5 ma esistevano 5 animali.
Anche oggi, ad esempio, come può un pastore in un remoto villaggio del mondo, ignaro dei numeri e dell’aritmetica, riconoscere intatto il proprio gregge di 40 pecore al ritorno dell’ovile? Allo stesso modo in cui i fedeli contano recitando un rosario o i carcerati nelle segrete del castello contano i giorni: stabilendo una relazione biunivoca tra segni (tacche su un bastone, grani del rosario, segni su un muro) e significato. Contare senza numeri è possibile, quindi, ma l’uso di un solo simbolo rende complicato gestire le grandi quantità. La soluzione al problema, un grande salto dal punto di vista concettuale, è l’uso di due simboli di cui il secondo rappresenta un numero definito di unità.
Nel 4.000 a.c. i sumeri, prima, e i babilonesi, poi, adottarono un sistema di numerazione a base 60 utilizzando appunto due simboli: un chiodo per le unità e una specie di occhio per le decine.
I primi metodi di calcolo, con ogni probabilità facevano uso del corpo umano. Con le dita, ad esempio, si può contare facilmente fino a 28 utilizzando le falangi ma in alcune zone della Cina con una sola mano sapevano contare fino a 99.999. Con un buon allenamento era possibile eseguire rapidamente somme e sottrazioni anche con numeri piuttosto elevati. I sumeri, quindi, furono probabilmente i primi a contare con una certa dimestichezza il che, però non vuol dire automaticamente saper fare di conto. Per questo sempre loro (ma un millennio dopo) utilizzarono dei gettoni (gli antenati delle fiches dei casinò) fatti di argilla essiccata e le cui diversa forme ne determinavano il valore. Con questo stratagemma e l’uso di simboli diversi poterono cominciare a moltiplicare tramite somme ripetute e dividere mediante spicciolature. Certamente, però, fu l’abaco a cambiare le potenzialità del fare di conto. La parola abaco deriva dal semitivo abaq che significa sabbia, polvere ossia la materia di cui erano fatti i primi esemplari. In realtà non si sa bene chi lo inventò. Se ne sono trovati tra i Maya, gli Egizi, i Cinesi, i Romani. I più antichi hanno più di 2000 anni mentre sono rimasti di uso in Europa fino al ’700 o, nella sua forma più evoluta di pallottoliere, fin dopo la II guerra mondiale in Russia, Cina e Giappone. L’abaco è una tavola divisa in colonne che rappresentano potenze del 10 e ogni gettone rappresenta una unità di quella potenza. L’uso dei numeri, infine, si è ulteriormente modificato con l’introduzione del metodo posizionale ossia l’idea che i simboli usati per scrivere le cifre non abbiano un valore fisso ma che questo vari al variare della loro posizione nella scrittura del numero. È il modo che abbiamo noi oggi di intendere i numeri. Questo fatto ha introdotto due novità importanti. La coincidenza tra scrittura e calcolo, innanzitutto, fatto impossibile in precedenza. E la necessità di introdurre un numero, sconosciuto fino ad allora, che simboleggiasse l’assenza:lo 0. In tutto questo, però, non si è ancora accennato allo 0, il nulla. Furono gli indiani a dichiararne apertamente l’esistenza e a utilizzarlo in campo matematico. Non fu un caso in quanto la loro filosofia, al contrario di quelle occidentali, contemplava il ‘non essere’. Dagli indiani agli arabi e poi in occidente grazie al monaco francese Gerbert d’Aurillac che lo conobbe attraverso i mori e lo introdusse anche grazie al fatto di essere nel frattempo diventato papa con il nome di Silvestro II. Le tracce della numerazione posizionale, e di conseguenza del numero 0 furono però scarse fino al Liber Abaci di Fibonacci che tradusse in zefiro l’arabo sifr da cui discendono sia la parola zero (passando attraverso l’intermedio zevero) che cifra. Da sempre, quindi, l’uomo ha cercato risposte nei numeri. Ne è sempre stato affascinato e prima ancora di diventare ‘matematico’ li ha utilizzati come mago, cabalista, compilatore di calendari, misuratore del tempo e creatore di miti e filosofo. I numeri, la matematica, la razionalità percorrono spesso letteratura e arte. Borges, con la sua libreria o nel racconto Il giardino dei sentieri che si biforcano. Le opere di Piero della Francesca, maniaco delle proporzioni e delle sue norme descritte nel De perspectiva pingendi che hanno influenzato fortemente la pittura dell’Ottocento e del Novecento.
Piero della Francesca che, non a caso, trovò il suo principale sponsor in fra Luca Pacioli, inventore della partita doppia e auto del De divina proporzione. I numeri hanno la loro propria storia e i loro propri significati che da questa derivano. Ma i numeri sono fatti di materia flessibile, adattabile al di fuori della matematica. Si pensi alla relazione inesistente tra i numeri 9 e 11 finché per tutti non sono diventati il simbolo di una data tragica. La prima definizione di numero venne data da Talete come ‘collezione di unità’. L’unità, quindi (monade) aveva un ruolo privilegiato al di fuori della serie dei numeri, un’entità autonoma contrapposta alla moltitudine. 1, quindi, diventa sinonimo di perfezione e, di conseguenza 2 il suo contrario. Numero immondo che rappresentava la femminilità, l’accoppiamento e quindi il peccato. Ma al tempo stesso la consolazione e la grazia in quanto Gesù, la seconda persona della trinità, inviò a due a due i suoi discepoli a convertire i giudei. 3 è il ritorno all’unità, la trinità, appunto, passato-‐presente-‐futuro, le grazie, le furie, le parche, i piani dell’arca. 3 (più di due) è stato anche sinonimo di moltitudine e lo ritroviamo ancora in diverse lingue. Troi, in francese ha origine comune con tres, molti. Come dalla stessa radice derivano troppo e truppa, ad esempio. Anche se Luca Pacioli, alla maniera di Brancaleone, scrisse: ’Commo in divinis una medesima substatia sia fra tre persone padre figlio e spirito santo così una medesima proporzione de questa sorte sempre conven se trovi fra tre termini e mai ne in più ne in meno se po retrrovare’ 4 richiama la stabilità, l’equilibrio, la forza, la giustizia e la stabilità. La tetraktys era la figura simbolica in cui i pitagorici prestavano giuramento e condensavano le loro teorie: un triangolo i cui lati sono formati da quattro punti e un altro punto, l’unità, al centro.
Qui ritroviamo i 4 elementi, terra, acqua, aria e fuoco. 4 come i venti principali, i punti cardinali, le fasi della luna, le stagioni. 4 è il numero dell’uomo descritto da Vittruvio dove la larghezza dell’uomo a braccia
spalancate corrisponderà alla sua altezza dando così forma a un quadrato ideale. L’uomo perfetto, anche quando non è perfetto.
Il 5 simboleggia la perfezione mistica, e quella estetica, è un numero circolare che moltiplicato per sé stesso sempre a sé stesso torna. Il 6 il numero del male. La realtà è che con i numeri ci si può fare quello che si vuole, si possono interpretare a piacimento e spesso grazie a loro semplici coincidenze diventano teoremi o, talvolta, complotti. I numeri si piegano alla numerologia (un’invenzione di Sant’Agostino, pare), all’interpretazione forzata, al simbolismo così come si piegano talvolta i bilanci delle società. E così le statistiche, gli indici e le conseguenti previsioni.
fonti: U.S. Office of Management and Budget / Centers for Disease Control & Prevention
I conti si possono sempre quadrare ma questo non vuol dire raggiungere la verità. E noi, soprattutto noi, lo sappiamo bene. Fatti e notizie sono regolati dai numeri, l’economia è anche questione di numeri, la finanza lo è completamente. Comunicare con attenzione il loro reale significato diminuisce l’incertezza, è un dovere etico. I numeri sono alla base della musica e dei suoi canoni ma è l’estro la rende imprevedibile e sorprendente. Lo stesso vale per l’arte e le proporzioni che, nell’estetica classica, identificavano il principio della bellezza nella consonanza delle parti tra loro e nel rapporto con il tutto e che, via via, ha abbandonato la perfezione
formale per approdare sempre più incisivamente all’espressione emozionale della materia e dello spazio senza peraltro perdere valore anche quando rimangono dei semplici numeri.
Jackson Pollock, n°5 (1948), valore $140.000.000
Mark Rothko, n° 6 (1951) $186.000.000 da Yves Bouvier a un magnate russo, cresta compresa. O $49,99 su art.com, spese di trasporto escluse.
Da Attus siamo partiti e con Attus finiamo. We are not numbers. Non siamo numeri, è vero. Ma alla domanda fondamentale sulla vita, l’universo e tutto quanto chi ha letto La guida galattica per autostoppisti conosce la risposta definitiva. Questa:
«"Quarantadue!" urlò Loonquaw (al super computer Pensiero Profondo). "Questo è tutto ciò che sai dire dopo un lavoro di sette milioni e mezzo di anni?" "Ho controllato molto approfonditamente," disse il computer, "e questa è sicuramente la risposta. A essere sinceri, penso che il problema sia che voi non abbiate mai saputo veramente qual è la domanda"» E in realtà il problema è davvero questo. I numeri possono fornire risposte e, talvolta, essere risposte a loro volta. Quello che è fondamentale è sapere cosa si vuole sapere e come lo si vuole sapere. Servono basi per dare senso e stabilità alle altezze. Il rapporto è biunivoco, il collante è la serietà. Non siamo numeri, quindi. Allora siamo parole? Diceva Groucho Marx: gli uomini sono donne come tutte le altre. Possiamo quindi dire che i numeri sono parole come tutte le altre?