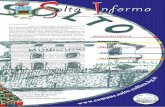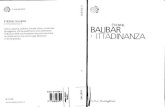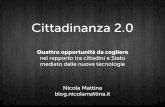Open Data e Trasparenza come punto di contatto fra cittadinanza e politica
Click here to load reader
-
Upload
marco-montanari -
Category
Government & Nonprofit
-
view
104 -
download
2
Transcript of Open Data e Trasparenza come punto di contatto fra cittadinanza e politica

Open Data e Trasparenza come punto di contatto fra cittadinanza e politica Marco Montanari – 12/2014
Nel 2009 il presidente degli Stati Uniti Obama, insieme all’allora CIO Vivek Kundra, annunciava il lancio della piattaforma data.gov1, sottolineando la possibilità, per chiunque, di utilizzare e analizzare i dati della pubblica amministrazione e da lì prendere decisioni per la propria azienda e per la propria vita. Pochi mesi dopo vengono resi pubblici progetti analoghi dal Regno Unito2 e dal nord Europa e in seguito anche in Italia3 e in tutto il mondo, compresi paesi apparentemente meno interessati all’argomento. Con quell’atto del 2009 entra nelle discussioni e nei documenti di politica e istituzioni il concetto di “Open Data”, che rappresenta la semplicità di accesso al dato pubblico sia in termini di procedura, permessi di accesso, sia dal punto di vista del formato dei dati esposti dal fornitore dei dati. La spinta culturale verso la necessità di trasparenza basata sui fatti viene da diverse direzioni. Innanzitutto, la visione tipicamente anglosassone che pervade oramai anche la nostra cultura e che è la base di grandissima parte degli strumenti disponibili sia on-line che off-line, che mette al centro delle decisioni un rapporto causa-effetto e costo-qualità misurabile e molto utilitarista. Seconda forza in gioco è la diffusa sfiducia verso le istituzioni, causata in parte da scelte poco oculate da parte della politica e in parte
1 http://www.data.gov/
2 http://data.gov.uk/
3 http://www.dati.gov.it/

dalla mancanza di capacità di adattamento da parte di grandi istituzioni “classiche” ai cambiamenti della società. Terza forza in gioco è la diffusione sempre più ampia di strumenti tecnologici e connettività, che consentono a chiunque l’accesso fisico e culturale a quantità di dati potenzialmente enormi. Queste forze si sviluppano in maniera analoga in ogni paese e portano ai una serie di effetti, positivi e negativi. Il primo effetto è l’ossessione per i numeri, tipicamente legato al mondo del management, che porta alla pubblicazione di basi di dati immense e di difficile lettura. Un esempio emblematico è il caso di SIOPE4, lo strumento che raccoglie tutti i dati di spesa degli enti pubblici italiani. Lo strumento, che solo da un anno pubblica liberamente dati aggregati, dati aggregati, ma presenta problemi di accessibilità e restituisce dati di difficile analisi. Soprattutto la mancanza di una fase di semplificazione dell’accesso e normalizzazione dei dati esposti trasforma ogni lettura in un'interpretazione. Altro esempio, più accessibile a tutti, è quello dei bilanci comunali aperti. Nei fatti, molti comuni hanno pubblicato i loro bilanci, ma, a parte l’informazione sul valore della singola voce di spesa, resta comunque impossibile ricostruire le scelte e le decisioni puntuali che portano alle singole spese a bilancio. Ulteriore esempio sono gli appalti: spesso si indicano cifra e assegnatario, ma raramente dettagli riguardanti il progetto interessato. Abbiamo poi la smania per la quantità: meglio tanti dati di bassa qualità che pochi dati veramente validi. La differenza è strutturale. La qualità dei dati si misura in modo abbastanza semplice: freschezza (il dato deve essere recente, altrimenti non aiuta a prendere decisioni nuove),
4 https://www.siope.it/siopelocale/siopewelcome.html

frequenza di aggiornamento (se il dato non viene mai aggiornato diventa nulla la freschezza e quindi diventa inutile) e completezza (se la descrizione di un evento o di una spesa è incompleta, il dato è inutile). Questa valutazione qualitativa è fondamentale, perchè con dati di bassa qualità si può fare solo una volta una valutazione (quando i dati sono ancora validi e rispecchiano ancora uno stato di fatto), mentre con dati di alta qualità è possibile costruire dei processi di riuso dei dati e di valutazione in tempo quasi reale di situazioni che cambiano. Questa smania può anche portare alla volontaria atomizzazione dei dati col fine di aumentare artificiosamente i numeri di dati pubblicati. Il terzo effetto è la diffusione, lenta ma costante, di una cultura del Dato, che porta gradualmente a un distacco sempre più forte dal dibattito politico basato su opinioni. Questo anche grazie alla diffusione di un nuovo modo di fare giornalismo, che tiene le radici nel mondo del giornalismo scientifico, ma che punta alla analisi delle scelte sociali, politiche ed istituzionali attraverso la lente dei dati raccolti. Storicamente assistiamo all'avvio, verso il 2011, dei datablog del New York Times5, negli USA, e del Guardian6, in Inghilterra. Il giornalismo orientato ai dati trova poi applicazione anche in Italia e altri paesi, e ogni contesto dà alle sue produzioni una specificità legata al tipo di pubblico e all'economia del sistema editoriale. Il quarto effetto è la nascita di un nuovo senso civico, guidato dal dato. Se sono le tasse a pagare per i servizi e per i progetti dell’amministrazione, allora dovrebbe essere possibile tracciare, punto per punto, a quali progetti siano
5 http://www.nytimes.com/upshot/
6 http://www.theguardian.com/data

arrivati i fondi e quali risultati abbiano portato alla società. Questo vale ancor di più se i fondi vanno e vengono da entità percepite tipicamente lontane, quali Unione Europea e altre istituzioni per le quali non è prevista l’elezione diretta e che comunque si occupano di aspetti tipicamente molto tecnici. Per favorire questo senso civico in Italia, caso unico in Europa e rarissimo a livello mondiale, il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS7) ha creato il portale OpenCoesione8, creato dal che si occupa di raccogliere e monitorare la spesa per i progetti finanziati dall’Europa destinati all’Italia. Partendo da questo progetto sono state avviate due attività grazie al contributo della società civile e all’apertura delle istituzioni a questi contributi. La prima è Monithon9, una piattaforma che raccoglie informazioni e report di monitoraggio sui progetti finanziati raccogliendo informazioni, interviste, documenti direttamente dal territorio e dalle persone coinvolte nei progetti. La seconda, derivante da una collaborazione tra istituzioni e società civile, è il progetto “A Scuola di OpenCoesione”10, nel quale Ministero dell’Istruzione e DPS mettono centinaia di studenti delle scuole superiori nelle condizioni di leggere un progetto europeo, comprendere documenti e procedure burocratiche, analizzare i risultati di un progetto e comunicarli nel modo più accattivante attraverso la collaborazione di giornalisti e professionisti della visualizzazione dei dati. Il quinto effetto è il graduale aumento di interesse, anche da parte di enti privati, verso la pubblicazione di dati.
7 http://www.dps.gov.it/it/index.html
8 http://opencoesione.gov.it/
9 http://www.monithon.it/
10 http://www.ascuoladiopencoesione.it/

Progetti internazionali come opencorporates11, la crescente percezione del ruolo sociale delle imprese, il fascino della visualizzazione complessa dei dati hanno portato molti privati a diffondere informazioni sempre più puntuali sulle loro attività. Tutto sommato la situazione italiana è positiva, anche se spesso si sottovalutano diversi aspetti. La pubblicazione di dati interni all’amministrazione come Open Data ha un complesso significato politico e amministrativo che va molto al di là della visualizzazione di un file scaricabile sulla pagina web di un'istituzione. Anzi, la scelta di pubblicare un particolare dato in una particolare forma è, al netto di leggi su privacy e diritto amministrativo, un atto prettamente politico, in quanto decisione di confine, di contatto fra amministrazione istituzionale e cittadinanza. E proprio su questa frontiera si trova l'aspetto comunicativo che rappresenta e fa da campione ai casi d'uso degli Open Data. Usare correttamente questo strumento permette di dare a tutti i mezzi per valutare nel modo migliore l’operato e per comunicarlo nel modo più efficace: L’istituzione pubblica i suoi dati, partendo da quelli viene creata la comunicazione istituzionale e, per giustificare le scelte che hanno portato a quelle attività e quelle spese, la politica utilizza gli stessi dati e le informazioni derivate dalle elaborazioni fatte per la comunicazione istituzionale per fare la sua comunicazione e dare la sua chiave di lettura più o meno condivisibile ma, una volta tanto, basata su informazioni fondate e verificabili. Fare tutto questo in modo efficace e non macchinoso diventa ancor più importante da quando, attraverso il
11
https://opencorporates.com/

Decreto 33 del 14 marzo 201312, è diventato obbligo di legge pubblicare le informazioni sulla trasparenza all’interno dei siti web delle istituzioni. Enti che avevano avviato discorsi su Open Data prima dell’attivazione dei portali trasparnza o che hanno colto l’occasione per avviarli hanno dimostrato che il portale per la trasparenza ha molta più utilità quando inquadrato in quell’ottica, piuttosto che come strumento avulso dal reale uso dei dati. Evidentemente questa maggiore utilità è sia procedurale (si pubblica un solo file, non diversi ad uso interno, portale, esterno), sia culturale (gli impiegati che si occupano di esporre quei dati in modo efficace hanno già una storia di uso delle informazioni). A tutti questi aspetti numerici e tecnici si aggiunge l’opportunità unica che l’Italia ha grazie alla sua storia e al suo passato. Con 50 luoghi protetti dall’UNESCO come beni dell’umanità13, l’Italia è prima al mondo come storia e cultura così come è prima nella densità con cui questa storia e questa cultura diventano materia nelle opere artistiche e architettoniche nel nostro paese. La valorizzazione di queste è un onore straordinario che porta con se’ anche una responsabilità immane non solo verso noi stessi, ma verso tutta l’Umanità. I casi, negli ultimi anni, di crolli, di perdite di opere nei trasferimenti fra musei, di disastrose concessioni edilizie in zone archeologiche, dimostrano che a volte non siamo in grado, a causa di eccessive sovrastrutture legali retaggio di scelte del passato, carenze tecnologiche e, a volte, carenze culturali, di valorizzare la
12
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. - http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33 13
http://whc.unesco.org/en/statesparties/it

nostra storia nel modo migliore. E’ necessario innanzitutto accettare che la cultura storica e artistica siano in se’ un prodotto, così come lo è già, più facilemente, la cultura eno-gastronomica. Un esempio emblematico di esportazione di cultura è quello del Rijksmuseum14 di Amsterdam, che consente di esplorare le varie collezioni prima di andare fisicamente a vedere le opere, studiandole, approfondendole e – per il marketing – stampando le opere o i dettagli delle opere preferite su poster, cartoline, tazze, senza nemmeno lasciare casa propria. Tutto questo non diminuisce le visite ai musei, ma, anzi, le aumenta, anche grazie alla maggiore visibilità delle singole opere disponibili a potenziali utenti. Questa visibilità aumenta anche grazie alla possibilità di rielaborare le opere, come dimostrano azioni artistiche quali le Public Domain Remix15, che hanno lo scopo di valorizzare opere note e meno note favorendone il riuso e la rielaborazione per nuove creazioni. Gli Open Data culturali, territoriali e gestionali sono il fondamentale punto di contatto fra mondi diversi. Accettarlo è il primo passo verso la comprensione che non esiste un dato “più utile” e uno “meno utile”, perché ciascun dato rappresenta un aspetto della storia che ha portato un gruppo sociale ad effettuare quella specifica scelta e prendere quella specifica decisione. Solo la visione unitaria e coerente dei vari dati consente veramente di comprendere il passato e, in base a quello, prendere le decisioni migliori per un domani nel quale sempre più la complessità diventerà centrale.
14
https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio 15
http://france.publicdomainremix.org/