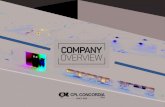Editoriale · o meno, nella divisione della ricchezza mondiale. Il nostro corpo è un segno...
Transcript of Editoriale · o meno, nella divisione della ricchezza mondiale. Il nostro corpo è un segno...
1
APRILE 2006 NUMERO 20
EditorialePer i tribuni grassi compreso lo scriventeNumerose inchieste condotte in diversi paesi confermano che i grassi sono in genere giudicati più simpatici, aperti e disponibili dei magri. Basta pensare alla popolarità goduta da Giovanni XXIII, papa bene in carne, di gran lunga superiore a quella del suo ossuto predecessore. Pare insomma che i grassi riscuotano consensi quasi unanimi...Eppure siamo tutti d’accordo nell’affermare che una delle caratteristi-che della nostra epoca è l’ossessione per la magrezza, il rigetto quasi maniacale dell’obesità.Nella maggior parte dei paesi sviluppati, un’ampia fetta di popolazione sogna la magrezza, ma si scopre grassa, e soffre di tale contraddizione.In Italia, il 47 % delle donne ed il 42% degli uomini sentirebbero, se-condo i sondaggi, la necessità di dimagrire.Come spiegare questa contraddizione tra la simpatia suscitata dai grassi e il rifiuto quasi fobico dell’obesità, questo rapporto di odio-amore? La corpulenza è innanzitutto il segnale esteriore della quantità di cibo di cui possiamo disporre, cioè della parte che ci spetta, legittimamente o meno, nella divisione della ricchezza mondiale. Il nostro corpo è un segno immediatamente percepibile della nostra adesione ai vincoli so-ciali, della nostra lealtà alle regole della distribuzione e della reciprocità economica. L’obeso è descritto in genere come un buontempone, allegro, spiritoso, con il gusto dell’amicizia e dei lieti convivi, dietro questa dimostrazione di simpatia si percepisce anche un giudizio negativo: sull’obeso grava spesso il sospetto di nascondere, sotto la maschera gioviale, tristezza e sofferenza.Il quadro che emerge conferma insomma l’esistenza di un doppio stereotipo del grasso. Da un lato un uomo pienotto, estroverso, abile nelle relazioni sociali, pronto allo scherzo e alla battuta, che racconta barzellette sempre nuove, ma che nell’intimo probabilmente soffre del suo stato fisico.Ne nasce un dilemma: come “riconoscerli” nella realtà. Come si può distinguere un grasso “buono” da un grasso “cattivo”? È evidente però che non abbiamo bisogno di conoscere il peso delle per-sone che frequentiamo per sapere se ci sono più o meno simpatiche. Spesso possono risultare decisivi particolari tratti morfologici, come pancia, doppio mento, struttura della pelle, consistenza “molle” o “soda” del tessuto adiposo, e via dicendo. Ancora una volta però, il criterio non sembra rendere conto di tutte le situazioni reali. Se poi entra in ballo la forza fisica, non si parla più di obesità, ma di persone “robuste”.Il grande problema di ogni dibattito sull’obesità, sia esso scientifico o no, riporta in fin dei conti ad un unico interrogativo: i grassi sono col-pevoli o innocenti? Sono vittime delle loro ghiandole, della loro eredità genetica, oppure sono rei di ingordigia? No, quasi sempre sono grassi perché mangiano troppo, senza controllarsi.La grassezza viene dunque ineluttabilmente associata all’ingordigia, a sua volta percepita come violazione di quelle leggi di condivisione del cibo che in molte società costituiscono l’essenza stessa del legame sociale. Ne deriva che l’ingordo (e di conseguenza il grasso) è implicita-mente accusato di minacciare le fondamenta stesse dell’organizzazione sociale. Non c’è da stupirsi che egli debba restituire in qualche modo ciò di cui si è indebitamente appropriato.Cosa può restituire l’obeso alla collettività? Innanzitutto la forza. Infatti, chi è sottoposto a lavori pesanti non viene giudicato grasso, anche se in realtà lo è.
Il facchino obeso assisterà alla miracolosa metamorfosi del suo grasso in muscolo, la sua voracità si trasformerà in robusto appetito. In certe società, alcuni individui, come i giapponesi lottatori di Sumo, vengono ingrassati istituzionalmente, affinché possano svolgere fun-zioni altamente considerate.. Esistono anche versioni occidentali di sportivi “grassi”: dai sollevatori e lanciatori di pesi, ai lottatori e ai pugili. Anche loro sfuggono alla categoria degli obesi per accedere a quella dei giganti di professione. Molti attori comici hanno sfruttato la loro grassezza per costruire un personaggio tipico e quasi mitico: pensiamo a “Stanlio e Olio”. Altri hanno utilizzato la propria obesità in ruoli cinematografici più sfac-cettati, oscillando tra i due poli, maligno e benigno, a seconda delle occasioni, esempio: Orson Welles e il più recente Burt Spencer. Gli stessi comici giocano a volte su questa ambiguità, caricando il proprio personaggio di un’ombra di sadismo, come quando “Olio” tiranneggia il magro “Stanlio”.La distribuzione sociale della grassezza, nei paesi sviluppati, è cam-biata radicalmente. Qui, un tempo (ma ancora oggi nel Terzo Mondo), il “popolo grasso” occupa gli strati superiori della gerarchia sociale, mentre il “popolo minuto” quelli bassi. La metafora serve ora a rappresentare il rapporto di sfruttamento fra Nord e Sud, fra mondo ricco e mondo povero. Al tempo in cui i ricchi erano grassi, è chiaro che
una ragionevole rotondità godeva di una certa considerazione. La si associava alla salute, al benessere economico, ad una pacifica rispet-tabilità. Dell’uomo grassoccio si diceva “sta bene” (l’è in tè bò) ; chi era magro suggeriva
solo un’idea di malattia, di cattiveria o di sfrenata ambizione.“Vorrei che attorno a me ci fossero uomini
grassi e con la testa ben pettinata, e tali, insomma, che dormano la notte. Quel Cassio laggiù ha un aspetto troppo magro e affamato:
pensa troppo, e uomini del genere sono perico-losi” scrive Shakespeare nel Giulio Cesare.
Il modello che domina oggi è nettamente diverso da quello del XIX secolo e da quelli tuttora dominanti in certe culture, persino in certi strati delle nostre società occidentali. Ciò non significa che i nostri an-tenati apprezzassero l’obesità, o che non sapessero distinguerla dalla corpulenza. Il sospetto di trasgressione che pesa sui grassi è permanente e univer-sale. Occorre dunque distinguere fra le categorie propriamente dette (ma-grezza, grassezza, obesità) e i limiti che una data cultura attribuisce loro. Criteri, misure e linee di demarcazione che variano sensibilmente. Una volta, ci voleva più ciccia per essere ritenuti obesi, e bastava un fisico meno esile per essere considerati magri. Una volta…
Gian Franco Fontana
L’appuntamento della CCIX Tornata è fissato a BERTINORO nella Cà de Bè
per domenica 26 marzo 2006 alle ore 10,00L’On. Stefano Servadei tratterà il tema :
“Le Eccellenze Romagnole” che sarà il filo conduttore delle tornate del 2006.
Successivamente il Tribuno Luigi Rivola parlerà sul tema : “Il ciclismo in Romagna”.
Al termine, ci fermeremo per il pranzo rustico (15 Euro) presso la stessa Cà de Bè.
2 3
PSICOLOGIA DELL’IDENTITÀnella comunità di Bertinoro
Senza identità, siamoun oggetto della storiaJoseph Zerho
Costruzione dell’ identitàPer Aristotele, l’identità é una “unità”della sostanza. Questa conce-zione che ha influenzato per secoli il pensiero occidentale (per esem-pio Rousseau) ha portato a considerare l’identità’ personale come coscienza di un’unità e continuità spazio-temporale, riguardante sia il corpo, sia gli aspetti non-corporei dell’individuo.Nell’Europa medioevale, nel cosiddetto mondo feudale, l’identità di una persona aveva poco a che fare col suo modo di proporsi, ma deri-vava piuttosto dal suo “appartenere” in altre parole era data da un tito-lo che spettava al Signore o al membro del clero. S’inizia a cambiare quando l’individuo comincia a proporsi in modo nuovo: il dominio di un individuo “su di sé” l’immagine di una identità autonoma.Con la modernità abbiamo la cultura dell’innovazione, dell’indivi-dualismo e delle opportunità molteplici, la produzione di differenze, esclusioni, ma anche la liberazione di potenzialità. L’identità é uno degli aspetti centrali e costanti della personalità: non é possibile com-prendere pienamente un individuo se non si conoscono i contenuti e la struttura della sua identità o immagine di sé. L’identità é quindi un aspetto essenziale della persona mentre il Sé è un elemento presente nell’identità. Successivamente - e siamo nel secolo scorso- al termine identità vie ne attribuito un rapporto con il sociale. Pertanto, secondo le moderne teorie sociali, l’individuo trova la sua continuità di sviluppo dell’identità ,la sua collocazione sociale, nel giudizio degli “altri”.Le ricerche di psicologia sociale mentre confermano la dipendenza dell’individuo nello sviluppo e nel “completamento” della sua identità (della sua “unità della sostanza” aristotelica) dal contesto sociale, dimostrano anche l’importanza assunta dall’ambiente fisico nella interazione con l’individuo nonché l’influenza e le pressioni sul com-portamento di questi. Infatti l’identità di un contesto sociale nasce prima attraverso il rapporto che gli individui hanno con 1a natura che li circonda, con il loro territorio.Il rapporto tra l’individuo e la comunità di appartenenza, l’ecosiste-ma locale, viene regolato -sulla base di un lungo processo adattivo - da norme stabilizzate dalla cultura, creando così nel soggetto un modello cosciente dell’ambiente (sociale e fisico) che rappresenta un sistema di atteggiamenti interiorizzati e stabilizzati e quindi coglibili attraverso specifiche ricerche, come è avvenuto per la comunità di Bertinoro.
Percezione dell’ identitáL’identità, nella dimensione socio-culturale, deriva dalla consapevo-lezza di appartenere ad un gruppo, dalla tendenza a considerarsi mem-bri di tale gruppo. Sulla base di questo assunto sono state individuata delle “categorie sociali” (il bertinorese, il romagnolo-bertinorese, il romagnolo) che permettessero ai soggetti (44 abitanti del Centro storico di Bertinoro, scelti attraverso un campione rappresentativo) di esprimere il proprio sentimento anche di appartenenza territoriale. Un test creato per verificare la presenza di identità comuni ed un questio-nario orientato a cogliere i contenuti di questa identità (luogo, dialetto, storia, vita quotidiana, tradizioni, ecc.) sono gli strumenti utilizzati nella ricerca.I dati raccolti (validati attraverso elaborazioni statistiche) evidenziano un alto grado di coesione tra i 44 soggetti ed indici piuttosto marcati in direzione di una solida identità. Infatti, il bertinorese del Centro storico è molto legato alla sua terra che ama al pari del proprio luogo (casa,campagna,eco.) dove vive; è molto legato e ama le proprie radici; è molto legato e ama il suo dialetto. Inoltre è piuttosto legato alla comunità ed alle tradizioni familiari.
Di contro si sente poco legato alle istituzioni pubbliche (Comune e ASL).In particolare, per l’uomo bertinorese assumono grande valore la ter-ra, il luogo dove vive, il dialetto, la tradizione familiare, le origini.Discreto il suo legame con la comunità: la tradizione culturale, il proprio paese, le proprie radici, la propria cultura. Per la donna di Bertinoro assumono grande valore al pari dell’uomo, la terra, il luogo dove vive, il dialetto, il paese, le radici, la tradizione familiare, ma anche l’essere “bertinorese”. Circa l’età, il gruppo dei più giovani della comunità (dai 15 ai 29 anni) evidenzia di amare molto il proprio dialetto e di essere molto legati al proprio paese, ed é abbastanza legato alla propria cultura e alla tradizione familiare mentre ritiene che le generazioni di ieri abbiano trasmesso molti valori alle generazioni di oggi. Il gruppo degli adulti (dai 30 ai 50 anni) è molto legato a origini, dialetto, luogo.Infine il gruppo degli over 50 evidenzia un numero di aspetti ai quali è molto legato: radici, storia, gente, luogo ed è molto appagato dei valori coltivati.
Identità e valoriIl concetto di “valore” si lega a quelle che sono le linee guida di una personalità centrata sulla costruzione prima, e sul mantenimento poi, dell’identità: questa ultima rappresentando il nucleo centrale della per-sonalità, s’impegna proprio sui valori che ne condensano la struttura,
i valori, per così dire, costituiscono gli ‘atomi’ dell’identità ed indivi-duarli significa “poter interpretare la stabilità che si nasconde dietro il fluttuare dei comportamenti”.Le tradizioni nelle quali, in tempi passati, l’abitante della. comunità di Bertinoro si identificava, oggi si dif-ferenziano da zona a zona, come era avvenuto ieri, se pur in parte, alla fine cioè degli anni ‘70 quando ini-ziammo la nostre ricerche. -Questi valori, insiti nelle tradizioni, sono cioè in rapporto più o meno stretto col territorio. Tuttavia le caratte-ristiche e le differenze territoriali, e quindi nel caso presente anche valoriali, non vengono ad intaccare l’identità di queste genti legate alla
centralità de1la loro cultura, della loro storia, dei valori espressi nel tempo.Per esempio, la famiglia si poggia ancora oggi su modelli culturali abbastanza consolidati, anche se non privi di qualche mutamento, in particolare nell’area industriale di pianura (Santa Maria Nuova), mentre nell’area rurale si possono trovare aspetti evolutivi rispetto a ieri, quali “il rientro in famiglia” dei giovani nell’ottica di un riflusso di maggiore entità in collina. La religione, a sua volta, é un valore rimasto immutato nel tempo, anche se spesso concepito in modo “utilitaristico” ovvero nella sua espressione sociale. Ed ancora, il lavoro che vede nella figura dell’operaio-contadino la continuità tra l’identità agricola e i modelli culturali dovuti all’indu-strializzazione. Per concludere, l’abitante del Centro storico ha, riassumendo, una forte identità con la terra, il luogo dove vive, le tradizioni familiari, mentre ama le proprie radici, il dialetto, il proprio paese. Egli si sente bertinorese nel senso pieno e ne dimostra la propria indentità (come è emerso marcatamente dal Test Identità Culturale); al contempo però sente fortemente l’appartenenza alla Romagna, probabilmente per salvaguardare quella storica contrapposizione con l’area emilia, nella quale egli, da sempre, poco si identifica.
Marcello Novaga*
*Il prof. .Marcello Novaga, docente di psicologia applicata nelle Università di Milano e di Padova, conduce da alcuni decenni ricerche sul contesto sociale e organizzativo romagnolo, in particolare sulla comunità di Bertinoro alla quale ha dedicato tre volumi pubblicati da Walberti, Longo, Il Ponte Vecchio.
2 3
LE ACQUE SALUTARI DI BAGNO, TRA FEDE E LEGGENDEPer tradizione si racconta che le acque medicamentose di Bagno di Romagna fossero anticamente ritrovate e scoper-te da S. Agnese, figlia d’un nobile di Sarsina la quale, dopo d’essere stata scacciata dal suo genitore per non avere voluto acconsentire ad un matrimonio combinato, si ritirò in questi luoghi, ricoperti allora di folte ed orride bo-scaglie colla sola compagnia di un suo fedele cagnolino. Questi, arrivato sul posto, cominciando a razzolare con le zampe dove sotto terra stavano nascoste l’Acque Termali, in breve tempo, le fece scaturire. Erano le famose acque termali tanto efficaci e salubri. La Santa, si lavò
con quelle e rimase perfettamente sanata e liberata da “una fiera lebbra, che tutto il suo gentil corpo ricopriva, ed affliggeva”. Era probabilmente una delle numerose malattie della pelle dovute a deficienze nell’alimentazione e alla scarsa igiene.Un’altra leggenda racconta che il padre di Agnese, pagano, la condannò a morte in quanto cristiana e la consegnò a due sgherri perché la conducessero nei boschi e la trucidassero riportando la veste bagnata del suo sangue. Giunti nella selva i due sgherri eb-bero compassione di lei e la lasciarono in vita: uccisero un capret-to e in quel sangue bagnarono la veste che riportarono al padre. Un’altra versione ancora, narra che fu ucciso il cagnolino che se-guiva Agnese; secondo altri invece il cagnolino fedele rimase con Agnese nella selva, vivendo con lei nelle caverne di Valfonda. Un giorno la giovane fu colpita da una malattia della pelle (forse la scabbia) che le procurava un grande fastidio, sicché ella piangeva e pregava il Dio dei cristiani che la facesse morire piuttosto che lasciarla in quel tormento. Allora il cagnolino si mise a raspare in terra con le zampe, subito zampillò un rivolo d’acqua calda con la quale Agnese si lavò, guarendo dal suo malanno.Successivamente il padre di Agnese, andando per i boschi in una
battuta di caccia, incontrò la fanciulla e, non riconoscendo in lei la figlia, se ne innamorò e le chiese di sposarlo. Agnese, che aveva riconosciuto il padre, senza rivelare chi fosse, rispose che avrebbe acconsentito se egli avesse fatto ciò che lei desiderava. Tornata a Sarsina e rivelata la sua identità, ottenne che il padre e tutta la famiglia si convertissero al Cristianesimo. La fanciulla poi tornò nei boschi dove era vissuta e morì santamente. I suoi resti furono sepolti nella chiesa parrocchiale di Pereto Boio (oggi, Buio), dove esse sono ancora conservati in una cassa di marmo, posta sotto l’altare maggiore.Anche il padre camaldolese Parisio Ciampelli, componendo una storia di Bagno di Romagna, ha riferito la leggenda delle origini delle terme, scoperte per l’intervento non di un cagnolino, ma di un agnello, le cui acque risanarono Agnese colpita dalla lebbra. Ancora don Giovanni Babbini, ha riferito le seguenti tradizioni intorno alle ultime vicende terrene di Agnese e al culto delle sue spoglie.Agnese, nei boschi dove viveva in penitenza, scolpì da sola una cassa funebre nel sasso vivo. I colpi risuonavano lontano e chi li sentiva non sapeva rendersene conto.Prima di morire Agnese lasciò detto che la cassa doveva essere trasportata da due vitellini nel luogo da lei prescelto. I contadini cercarono di rimuoverla con l’aiuto di due buoi, senza riuscirvi. Aggiogarono allora due vitellini, come Agnese aveva detto, e la cassa fu portata nel luogo stabilito. La leggenda ricordata da don Babbini narra ancora che Agnese, prima di morire, espresse il de-siderio di mangiare un acino d’uva; ma si era di gennaio e nessuno poteva averne. Ella indicò un luogo che si trovava oltre l’aia: un bambino vi accorse e trovò un grappolo d’uva fresco e rigoglioso che portò ad Agnese.Gli abitanti di Bagno, desiderando di avere nella loro chiesa i resti di Agnese, si recarono in processione a Pereto portando in dono, in cambio delle sacre reliquie, un quadro della Madonna. Era una bella giornata d’estate ma, quando uscirono dalla chiesa per portare a Bagno le reliquie, scoppiò un temporale così furioso che dovettero abbandonare l’impresa. Si accontentarono di portare
San Pietro in Bagno, tempera del Mazzuoli, 1788
S. Agnese, sec. IV
4 5
delle fonti, delle grotte e degli alberi secolari.La stessa repulsa del matrimonio, che è causa dell’allontanamento della fanciulla, corrisponde ad un comportamento che era proprio delle ninfe. Secondo i miti più arcaici questi esseri soprannatura-li di sesso femminile non andavano esenti da passioni e legami amorosi con dei ed uomini, ma le unioni che ne seguivano erano burrascose e non durature. Un’eco di tale comportamento è nelle fiabe e leggende che raccontano di unioni, sfortunate e interrotte improvvisamente, tra giovani uomini e personaggi femminili mi-steriosamente legati a un corso d’acqua o a una grotta. In epoca romana si credeva che Diana esigesse dalle ninfe del suo seguito un rigorosa castità.Se, come riteniamo, il personaggio di Agnese della leggenda del-l’alto Savio è derivato da quello di una ninfa (sotto il cui patronato erano poste le fonti termali di Bagno), è comprensibile che il rac-conto prenda inizio dal rifiuto, da parte della fanciulla, del matri-monio che il padre vuole imporle. Dal prospettato accostamento alle ninfe consegue inevitabilmente la domanda se la leggenda di Agnese fosse la trasposizione cristiana del culto alla ninfa sarsinate invocata da Marziale nell’epigramma 58 (libro IX):
Nynpha sacri regina lacus, cui grata SabinusEt mansura pio munere templa dedit,Sic montana tuos semper colat Umbria fontesNec tua Baianas Sassina malit aquas
O Ninfa, regina del sacro lago, dove Sabino per ringraziamentoHa offerto in pio dono un tempio, Così l’Umbria montana possa sempre venerare le tue fontiNé la tua Sarsina mai preferire le acque di Baja Secondo la religione pagana le ninfe, contrariamente agli dèi onni-presenti, erano esseri soprannaturali i cui poteri erano circoscritti a un luogo particolare: fonte, grotta, bosco. La ninfa in onore della quale Cesio Sabino, ragguardevole personaggio sarsinate dell’età flavio-traianea, aveva eretto dei templi, non avrebbe potuto essere la stessa alla quale erano dedicate le terme di Bagno, site a diverse ore di cammino da Sarsina. Tuttavia Marziale, seguendo le tendenze sincretiche prevalenti nel tardo paganesimo, sembra unificare, nella ninfa cantata nell’epi-gramma, le diverse divinità sotto la cui tutela erano poste le molte fonti (tuos fontes; aquas) dell’antica Sassina (... Sarsina).Mentre riteniamo che i templa eretti da Sabino debbano essere cer-cati tra i ritrovamenti archeologici dell’area di Sarsina ed escludia-mo che possano identificarsi nel modesto complesso votivo portato alla luce presso le fonti termali di Bagno, pensiamo nondimeno che, secondo la concezione religiosa espressa da Marziale, la ninfa sarsinate estendesse il patronato fino alle terme di Bagno: ipotesi che spiegherebbe l’attribuzione a Sarsina della nascita di Agnese, essendo peraltro la leggendaria fanciulla destinata a scoprire le fon-ti di Bagno di Romagna.
***
nella loro chiesa le ossa di un braccio e lasciarono riposare gli altri resti a Pereto, dove ancora si trovano, ritenendo che quello fosse il volere di Agnese. Don Babbini afferma che a Pereto mancano le ossa di un braccio di Agnese, come egli avrebbe constatato nel cor-so dell’ultima ricognizione dei resti, fatta molti decenni fa insieme al Vescovo.Quanti hanno raccontano la leggenda delle origini delle terme di Bagno chiamano « santa » la fanciulla che era stata risanata dalle acque miracolosamente sgorgate dal suolo.Monsignor Angelo Peruzzi, vescovo di Sarsina dal 1581 al 1600, nel verbale della visita pastorale svolta a Pereto nel giugno 1594, fece riferimento all’altare sub quo dicuntur esse ossa S. Beatae Agnetis , attenuando l’attribuzione di «santa» con quello di «bea-ta».Don Testi, nell’ opera dedicata a Sarsina (Cenni storici tradizionali, Faenza ,1910) ha affermato di aver visto nell’Archivio vescovile i processi di santificazione di Agnese, iniziati ma rimasti incom-piuti.Le suddette espressioni di «santa» e di «beata» vanno peraltro intese secondo la voce e la venerazione popolari, prescindendo dalla canonizzazione della Chiesa. Nè al clero sarsinate più colto poté sfuggire che la leggendaria Agnese, nata a Sarsina e sepolta a Pereto, non era identificabile, come era avvenuto, con la santa, nata e sepolta a Roma. Una soluzione di compromesso, dettata dalla necessità di contenere la venerazione locale entro le date fissate dal calendario canonico, si avverte a Pereto dove la festa in onore della solitaria scopritrice delle terme di Bagno viene celebrata il 28 gennaio, ultimo giorno dell’«ottava» di Sant’Agnese, che la Chiesa venera il 21 gennaio.Esclusa l’identità tra Agnese di Sarsina e Agnese di Roma, ci si chiede se l’agiografia intorno alla santa romana può aver determi-nato o influito sulla formazione della leggenda nell’alto Savio.Secondo Sant’Agostino e San Damaso, Agnese fu una fanciulla dodicenne martirizzata al tempo di Diocleziano. Secondo la tra-dizione greca Agnese era invece una vergine adulta che, avendo rifiutato di tributare sacrifici agli dèi pagani, venne condotta in un postribolo prima di subire il martirio. Un giovane, che aveva tenta-to di farle violenza, cadde fulminato e risorse per intercessione di Agnese. L’episodio della violenza carnale miracolosamente respin-ta giustificava il nome attribuito alla santa, derivando Agnese dal greco agné, «pura», «casta». I Romani vollero risalire a un etimo ugualmente significativo fa-cendo derivare Agnese da agnus, «agnello» (di Dio). Sant’Agostino dice: Agnes latine agnam significat graece castam.Nella Legenda Aurea (XIII secolo) le vicende della santa s’arric-chirono di nuovi particolari. Il figlio del prefetto Sinfronio si inva-ghisce di Agnese, ma è ripetutamente respinto da costei. Il prefetto le ordina di votarsi a Vesta se vuol restar nubile, altrimenti sarà condannata al postribolo. Agnese è trascinata nuda per le strade di Roma ma i capelli, miracolosamente cresciuti, l’avvolgono e un an-gelo le pone sulle spalle un candido mantello. Un giovane tenta di violentarla, ma cade a terra accecato. Condotta sul rogo, le fiamme si scostano dal corpo della santa che poi viene sgozzata. Costantina (santa Costanza), figlia dell’imperatore Costantino, ottiene la gua-rigione dalla lebbra dopo aver pregato sulla tomba di Agnese, in onore della quale farà erigere la basilica sulla via Nomentana.Nelle versioni medioevali della leggenda di Santa Agnese si rile-vano due temi comuni alla leggenda di Agnese di Sarsina: il rifiuto delle nozze e la guarigione dalla lebbra. Questi temi sono peraltro così diffusi che, in assenza di altre concordanze, non possono vale-re a proporre una comunanza o una connessione tra le due leggende messe a confronto. Il rifiuto delle nozze, sia nei racconti che nelle agiografie, era una tipica causa di contrasto della famiglia con la fanciulla, determinando il ritiro di questa in un convento o eremo e l’inizio di una vita dedita alla religione. La guarigione dalla leb-bra affligge l’Agnese di Sarsina mentre, nella leggenda romana, colpisce Costantina la quale sarà risanata pregando sulla tomba di Agnese (come suo padre, Costantino, sarà guarito dallo stesso male per intercessione di papa Silvestro). Era un miracolo di risanamen-to assai comune nella narrativa edificante e profana del Medioevo.L’allontanamento di Agnese dalla famiglia e dalla città, la ininter-rotta permanenza nelle selve, l’attribuzione di una fonte di acque curative, sono elementi che avvicinano Agnese alle ninfe, signore
Una rosa recisaFu solo attorno agli anni 1950 che i proprietari iniziarono a tinteg-giare gli esterni delle abitazioni molto spesso rovinate dagli eventi bellici e comunque da un decennio di abbandono. Abitavo in un palazzo di due piani costruito alla fine degli anni venti che oltre alle pareti con muro a vista, aveva alcune parti tin-teggiate di un bel colore ocra. La proprietà decise di rinfrescare la tinteggiatura e stuccare le ferite delle schegge di granate e , come allora avveniva, diede l’incarico ad un artigiano imbianchino, che lavorava da solo con l’unica attrezzatura di una scala e di qualche secchio di vernice con adeguati pennelli. Per queste ragioni “tec-niche” la tinteggiatura procedeva molto a rilento e in quell’estate del 1950 mi svegliavo alle prime ore del mattino, col rumore della scala dell’imbianchino e del pennello che spandeva la vernice. Il tutto era accompagnato da un ritornello canticchiato dall’artigiano: «..è una rosa profumataa..» e via due colpi di pennello. Il ritornello non completò mai la frase ….Un brutto mattino non udii i soliti rumori e il canto dell’imbianchi-no, meravigliato mi affacciai alla finestra, vidi la scala e i secchi di vernice, ma lui non c’era. Appresi poi che quell’uomo, che sembrava così tranquillo e spensierato si era suicidato. La “rosa profumata” non ebbe per me un seguito!
4 5
Gente semplice, i Morri professavano a Rimini l’arte dell’ore-ficeria da lunghi anni ed erano fra i sei orefici con laboratorio e bottega lungo la strada Maestra. I fratelli Agostino e Nicola aveva-no appresa l’arte in famiglia e la proseguirono con estro e abilità; ma l’arrivo delle Armate napoleoniche sconvolse il quieto vivere di questi artigiani.Le nuove idee infiammarono i giovani della famiglia: Luigi fin dalla prima coscrizione del 1803, Giuseppe fu fra i Veliti, morto a Monaco nel 1806 e Lorenzo, nel battaglione zappatori. Dopo il 1815, le generazioni erano già provate dalle guerre na-poleoniche e ai moti del 1821 e del 1831 non parteciparono i Morri.Ebbero invece parte attiva nell’amministrazione della cosa pub-blica e Agostino senior fece parte della Magistratura quale Con-sigliere comunale dal 1839 al 1845. Nel 1845 è ancora membro della Magistratura quando, nel moto guidato da Pietro Renzi, i due figli maggiori, Alessandro e Luigi Morri sono parte attiva e componenti della squadra che, sorpresa la sentinella al corpo di guardia della caserma di S. Francesco, la occupa; mentre le altre due squadre raggiungeranno lo sferisterio e la Rocca Malatestiana, per liberare i detenuti politici . I quattro giorni della rivoluzione riminese misero in moto le Cancellerie d’Europa e i rivoltosi, alla notizia di un corpo di spedizione inviato contro la città, emigrarono a San Marino, in Toscana e in Francia. Nel 1847 i tre figli dell’orefice sono fra gli organizzatori, gli istrut-tori e i comandanti della Guardia Civica, con la quale combatte-ranno sui campi lombardo-veneti.Alessandro (1820-1875), dopo aver militato e dimostrato facile vena poetica in versi d’occasione, sarà nel ‘49 vice segretario del comitato per eleggere la nuova Magistratura, e uno degli eletti dal popolo per formare il Municipio a norma del decreto 29 dicembre 1848. Sarà quindi segretario del Comune di Sogliano al Rubicone e spo-serà Luisa Vincenzi, sorella della madre di Giovanni Pascoli.
I MORRI E I PASCOLItra guerre risorgimentali e un amore sfortunato
Assalto a una caserma di Rimini, 1845
Per questa parentela, infatti, il 31 dicembre 1855 Alessandro por-tò al fonte battesimale il futuro poeta, al quale impose i nomi di Giovanni, Placido, Agostino. Nel 1865 i coniugi Andrea e Luisa Morri portavano al fonte battesimale Maria, Santa, Adele, Annetta, colei che il mondo, specialmente delle lettere, conoscerà poi unicamente come Mariù Pascoli.Ormai la vita delle famiglie Morri e Pascoli scorrerà parallela e serena fino a quel fatale giorno di San Lorenzo del 1867 quando, come scrisse il Poeta : « ritornava una rondine al tetto: / l’uccisero, cadde tra spini». Il fattore dei Torlonia, padre del poeta, era stato assassinato.Nell’autunno, riunito il consiglio delle famiglie Morri Pascoli, che Alessandro Morri presiederà, si stabilì il da farsi sul futuro degli orfani. È allora che lo zio Morri suggerisce a Giacomo il trasferimento della famiglia a Rimini, che egli stesso seguirà poi nel 1871, ed è in quella sede che ogni cosa fu vagliata, studiata ed attuata.Dopo di allora il poeta, che già amava gli zii di Rimini, chiamerà Alessandro «mio forte amico» e Mariù riconoscerà «che era sem-pre stato un serio ed avveduto consigliere». Rispetto ed affetto, che per Giovanni Pascoli si tradurranno nel 1875, alla morte dello zio, in versi commoventi. I versi ebbero una curiosa sorte, come ci racconta Mariù. La vedova, «la zia Luisa, religiosissima, fu messa in sospetto da alcune persone sulla fede cristiana del poeta e quindi della poesia, e per averne un parere sicuro, pensò di farla leggere a Giovanna Grilli», ritenuta dai riminesi in odore di santità. Appena lettala, la Grèlla esclamò: «brusèla, brusèla, l’è contra Crèst! »: il giudizio era autorevole e tutte le copie dell’edizione riminese della poesia furono bruciate, meno due, la copia della zia Rita che donò poi a Mariù quando uscì dal collegio e quella di Andrea, conservata dagli eredi.
6 7
Alessandro nel marzo del 1863 fu prescelto dalla Giunta muni-cipale, «in apprezzamento delle doti e cognizioni teorico pratiche che lo distinguevano sulla con-dotta dei pubblici uffici», quale segretario dello Stato Civile del Comune. Il suo nome e la sua operosità sono testimoniati da tre annuari statistici pubblicati dal Comune di Rimini sul mo-vimento dello Stato Civile negli anni 1868-1869-1870, ricchi di tabelle e di dati, redatti con un rigore scientifico che sorprende. L’altro fratello di Alessandro Morri, Luigi (1823-1898), poco più che ventenne nel 1845 par-tecipò al moto risorgimentale riminese e nel ‘48 raggiunse i campi di battaglia veneti dopo
avere militato, in qualità di sottufficiale, nella Guardia Nazionale. Nel 1849 partì con la colonna Pianciani alla volta di Roma re-pubblicana, ma costretto a fermarsi ad Urbino per malattia, fu qui dichiarato prigioniero, né poté riavere la libertà se non dopo tristi e dolorosi trasferimenti da una città all’altra, sotto la costante mi-naccia della fucilazione. Liberato, ritornò a Rimini. Nel 1859 fu a capo della spedizione dei 67 volontari riminesi costretti ad accettare l’esilio dagli Stati della Chiesa per accorrere a combattere nella campagna di guerra sui campi lombardi.Nel 1860 fu il primo ad entrare nelle Marche, capitano di una com-pagnia di romagnoli; nel ‘62 fu aiutante maggiore di battaglione della Guardia Nazionale. Nel 1864 fondò in patria l’Associazione Liberale Riminese, quindi fu azionista e ispettore dell’Istituto di educazione gratuita per i figli del povero, e dal ‘71 vice presidente della Società veterani, poi del Comitato elettorale per la candi-datura di Luigi Ferrari. Spese dunque la vita giovanile nei moti rivoluzionali, la maturità nelle opere sociali più meritorie.Questo il clima della famiglia Morri ove crebbe e si formò Andrea (1830-1886), il minore dei fratelli. Componente della 3° Legione Romana dalla sua fondazione, fece parte della Divisione Civica Volontari nel corpo di operazione pon-tificio nel Veneto, fino al 20 settembre 1848, quando la Legione si sciolse a Rimini. Il 3 dicembre dello stesso anno si arruolò in Ancona nel reggimento Unione con il quale nel maggio del 1849 si recò alla difesa di Roma e fu sulle barricate di Porta S. Pancrazio. Nel luglio, caduta Roma, fu prigioniero delle armi francesi e per venti giorni ricoverato all’ospedale di Bastia in Corsica.Tornato a Rimini, collaborò al consolidamento dell’Istituto di educazione gratuita per i figli del povero e si adoperò coscien-ziosamente nell’organizzazione e nell’istruzione della Guardia Nazionale fino al 1859 ricoprendo i gradi da sergente a capitano.Nell’aprile del 1860 con altri 13, raggiunse 827 volontari garibal-dini a Genova dove il 4 maggio partì per la Sicilia raggiungendo Marsala il giorno 11. Colla vittoria di Caserta Vecchia si chiuse il glorioso periodo delle battaglie nella campagna risorgimentale del 1860 e l’impresa dei “Mille”,Capitolata Capua il 2 novembre, Andrea Morri, rientrato a Napoli, venne imbarcato, con un migliaio di camicie rosse, diretto a Genova, poi a Bologna, quindi a Rimini. La sintesi della sua vita gloriosa ed avventurosa, è arrivata fino a noi racchiusa nelle “noterelle” del suo Taccuino. Nel frattempo Giovannino Pascoli s’era invaghito di Imelde, la minore delle figlie di Alessandro, sua cugina, con la quale nel-l’aprile (1896) aveva già in corso i “preparativi matrimoniali”, e fatta richiesta, tramite l’amico Pirozz (Pietro Guidi), a San Mauro, dei documenti personali. Il poeta nel 1884 insegnava in un liceo di Matera e scriveva a casa chiedendo notizie delle cugine Annetta e Imelde.
L’Annetta e l’Imelde, spiegherà poi Mariù nelle sue memorie, «erano due buone e care ragazze, quasi della mia stessa età , ma assai diverse da noi per fortuna, perché esse erano ricche e vesti-vano con molto lusso, e noi eravamo povere e vestivamo molto dimessamente. Ricordo che il nostro amor proprio si contorceva dalla mortificazione quando dovevamo uscire insieme». Già in queste parole c’è una prima avvisaglia di un disagio che si trasformerà in una apprensione ed un disappunto “singolare” di Mariù: « … cominciai presto a sentire delle voci che mi sconvol-sero tutta. Si diceva che Giovannino era in procinto di prendere moglie. Tutti si congratulavano con me, mentre io confusa e stor-dita non trovavo altro da dire se non che non sapevo niente, ma mi si assicurava che era vero, che sposava una romagnola, una cugina di Rimini».Mariù era forte ed oculata, ma era diventata precocemente orfana ed aveva passato otto anni seppellita in un collegio fino a che non era arrivato il fratello buono che le aveva porto una mano trasfor-mandola in una giovane donna libera, valorizzata ed amata fino al-l’idolatria. E quando l’altra sorella Ida se ne era andata per seguire un suo destino matrimoniale, i due fratelli si strinsero ancora di più in una coppia indissolubile, chiusa in un loro piccolo mondo che nessuno poteva intaccare.Mariù riuscì ad allontanare la Imelde Morri dal fratello con l’im-pulso della sua fraterna gelosia, ma nel paese raccontarono come la Imelde si fosse lamentata dell’abbandono con la cugina e altri insinuarono anche che il poeta avesse pianto per il distacco. Mentre avvenivano questi fatti era intanto nato un altro amore e Imelde Morri diventò la contessa Baldini.
gff
Andrea Morri
Il RubiconeMussolini, che aveva dappertutto, e specialmente in Romagna, i suoi informatori, non poteva ignorare la teoria e le ricerche di Gigino di Bernardino quando, circa a metà degli anni Trenta e per contentare il podestà di Savignano che tanto gli si era racco-mandato, aveva stabilito che il fiume detto fino a quel momento Fiumicino, prendesse il nome di Rubicone e che la stessa citta-dina di Savignano si fregiasse di un’aggiunta quasi nobiliare: Savignano sul Rubicone. La popolazione del luogo si era rallegrata, il podestà aveva visto avverarsi il suo lungo sogno storico e squadristico insieme, e per noi romagnoli si era chiusa, provvisoriamente, l’era delle polemi-che che chiameremo fluviali.Da queste parti ci sono tre fiumiciattoli scorrenti verso l’Adriatico che sempre hanno preteso di essere il Rubicone. C’è il Pisciatello, a Cesenatico; c’è il Luso (oppure Uso), che lambisce Sant’Arcangelo, e infine c’è il Fiumicino, savignane-se. Si figuri che il primo favore che chiedemmo noi romagnoli a Napoleone, quando venne a saccheggiarci, fu di aiutarci a sbro-gliare la matassa dei fiumi. Che facesse lui, che decidesse lui che aveva sempre ragione. Per la verità, il favore, a Napoleone, glielo chiesero i forlivesi, essendo Sant’Arcangelo abbastanza soddisfatto di spacciare per Rubicone il suo Uso, anche in base a una sentenza della Sacra Rota del 1756. Ma Napoleone, lo sanno tutti, non aveva nella manica quelli della parte di Ravenna (e fu poco una canagliata il trasferimento della capitale da Ravenna a Forti?) e, inoltre, il condottiero di Waterloo aveva preso una specie di cotta per alcune autorevoli cittadine di Cesena che poi si sarebbero trasferite a Forlì capitale.Anche Napoleone era uno che ne aveva poche delle spicce. Era una specie di Grundèra vestito da maresciallo. Napoleone pertanto decretò in favore del Pisciatello (successivamente le lapidi che in Cesenatico celebravano il battesimo in Rubicone del rivolet-to locale furono rimosse e trasferite nella sede della Biblioteca Malatestiana) e ancora una volta il conflitto di competenze si placò. Forse se a Mussolini non si fosse offerta l’occasione di fare un dispetto al suo rivale Corso, tutto sarebbe rimasto come prima. Ma può anche darsi che Muslé, facendo propria la teoria di Gigì d’Barnardé, non abbia voluto perdere l’occasione di aver ragione, almeno una volta.
m.d.
6 7
L’intolleranza religiosa e vere e proprie guerre di religione, im-perversano sul mondo. Non siamo tanto ingenui dal pensare che le ragioni di tanti misfatti siano solo di carattere religioso, e in particolare da addebitare ad una religione, perché riteniamo che altri e ben più importanti elementi di carattere politico, economi-co e anche razziale ne siano la base preminente tuttavia le cose allo stato attuale sono queste e ricordare quanto avvenne da noi cinque secoli fa è utile e propedeutico. Un Papa, alcuni anni fa, ha chiesto perdono per quanto è successo.
La redazione
Sulla Rocca Comunale di Lugo è collocata una targa marmorea, dettata da Olindo Guerrini, che cosi recita: PIÙ CHE QUESTA PIETRA / DURI IL RICORDO DI / ANDREA RELENCINI /STRANGOLATO E BRU-CIATO QUI PRESSO / NEL MDLXXXI I PER SENTEN-ZA DELLA S.R. INQUISI-ZIONE / ED AMMONISCA CHE LA CHIESA NON TOLLERA / OMBRA DI LI-BERTA’.La strada laterale destra della Rocca, quella che immette a piazza Baracca è intitolata ad Andrea Relencini, figlio acquisito di terra romagno-la il cui martirio non potrà essere dimenticato. Ma chi era Relencini? Aiutandomi con uno scritto di Ambrogio Bongiovanni (1848-1916) già direttore della Biblioteca Trisi di Lugo, storico, amante degli eventi di Romagna, inizio dalla fine della vita di questo grande modenese trapiantato e naturalizzato lughese.
Una mattina d’estate dell’an-no 1581 sotto un cielo limpido e sereno, già dalle prime ore, le strade polverose della Terra di Lugo si animano di persone giunte da ogni parte del con-tado, con ogni mezzo, fino a divenire una moltitudine che la si vedeva solamente nelle feste delle grandi città. Quale era la novità? Era corsa voce di un fatto eccezionale, mai ac-caduto a Lugo e cioè il supplizio di un empio, eretico, seguace di Lutero, condannato dalla Santa Inquisizione. Nelle parole e dai volti della gente si intuisce sdegno, odio e ribrezzo per il condannato e tutti, salvo pochi, sono ansiosi di veder applicata la sentenza. Nella piazza interna della rocca, é stata preparata una catasta di legna, necessaria per un rogo “purificatore” e la gente é ammassata all’esterno in attesa che sia calato il ponte levatoio per potervi accedere. Con un rumore di catene il ponte viene abbassato e la gente prende posto ai lati della piazza in attesa di assistere a quell’evento. Di li a poco un libero pensatore sarà messo a morte da altri uomini che nascondono, dietro una
ANDREA RELENCINIlibero pensatore romagnolo
maschera cristiana, una loro crudeltà al limite del sadismo, solo perché il condannato la pensa diversamente da loro e non vuole sottoporsi a una volontà dogmatica, a una ingiustizia ambiziosa di potere. Descriviamo gli avvenimenti come ce li tramanda la cronaca del tempo. Entrano nella piazza cento cavalieri in armi, i trombettieri, che con i loro suoni fanno rabbrividire, uno stuolo di preti e frati con un gonfalone su cui è disegnata una croce irta di chiodi. Segue il potere rappresentato dai membri dell’ufficio dell’Inquisizione, dai dignitari del Sacro Ordine domenicano, dal rappresentante del vescovo di Imola, dal commissario estense e cosi via, con giudici, notai, anziani della comunità, valletti, cavalieri, sgherri ed altra gente armata.Uno scabino (giudice) sale sul palco dove già è stato portato il condannato a lato della forca e dà lettura dell’atto d’accusa. Indi un frate, con una croce in mano, si avvicina al condannato
esortandolo all’abiura ed al pentimento. Al rifiuto, con la “fiera ostinatezza del dover obbedire alla intimazione del tribunale inquisitorio”, un notaro del seguito legge le sentenza di morte. “Ei non tiene china ne tentenna la testa, e rifìuta di baciare un Cristo di legno.”Ad un gesto del giudice, la vittima viene presa in conse-gna dal carnefice per l’ese-cuzione. Viene impiccato, ma non emette un gemito o un lamento ed appena dati gli ultimi tratti di vita, viene tagliata la corda e gettato nel-la catasta di legna a cui è già appiccato il fuoco. Eseguita la sentenza le sue ceneri vengo-no disperse perché di lui non resti niente.
Lugo conosce così il martirio di un uomo il cui solo peccato era stato quello di non essersi sottomesso alla Sacra Roma-na chiesa. E questo era avve-nuto senza potersi difendere, senza conoscere il nome degli accusatori, senza sapere di quale delitto venisse accusato se non quello di professare principi non contrari alla fede
di Cristo, ma a una “chiesa” di uomini che la interpretava e usava per i suoi fini terreni.Della vita di Relencini si conosce poco, se non che era un uomo comune, uguale per condizione e dignità ad altri del suo tempo. Nato a Modena, da povera famiglia, con pochi studi, era un fer-mo assertore della dottrina di Lutero e un buon conoscitore dei “libri proibiti” sia di Lutero che di Didimo da Faenza.Era amante delle letture filosofiche e morali e divenne così un ribelle nei confronti della Chiesa. Aderì a Modena all’Accade-mia Letteraria dove con Paolo Ricci iniziò a propagare le idee
Rocca di Lugo, sec. XVI
8 9
riformatrici del nuovo credo luterano. Il Duca d’Este, spinto dal-la Sacra Inquisizione, iniziò una vera e propria repressione nei confronti degli aderenti all’Accademia, incarcerandone alcuni fra i quali il Ricci. Gli altri affiliati furono costretti a fuggire da Modena e fra questi il Relencini che si stabilì a Lugo, continuan-do a professare le proprie idee. Fu un uomo molto laborioso che praticava l’arte del falegname e per questo fu chiamato maestro. Era considerato un uomo intelligente e colto, conoscitore delle scienze matematiche, infatti si prodigò per risolvere i problemi idraulici del territorio fra i quali la serrata della rotta del Senio fra Lugo e Fusignano. Ma il suo “fare” ed il suo “conoscere” erano avversati da chi, per invidia, ne temeva la popolarità. Fu quindi “chiacchierato” e additato come seminatore di zizzanie, propagatore di scienze occulte, eretico perverso e per questo fu denunciato e incarcerato.Fu aperto nei suoi confronti un processo per aver rinnegato la Santa Fede romana facendosi luterano, oltre ad altri capi d’ac-cusa per “fanatiche arti diaboliche” ed altre nefandezze non ben precisate come era allora d’uso presso la Sacra Inquisizione. Questa sostenne che dovevano esserci “altri soci che con esso dovessero avere comunanza”, e pretese dallo stesso il nome di altre persone di fede luterana.Infatti i delatori del Relencini l’accusarono che “altri seco lui aveano visto a confabulare e a convivere”. In nessuno dei casi addebitati fu mai portata prova e Relencini mai farà dei nomi, ne-gando ogni rapporto con chichessia, non volendo gravare la sua nobile e ferrea coscienza di alcun minino rimorso. Il commis-sario ducale, in data 19 ottobre 1580 informava Alfonso d’Este che “Quel M° Andrea non ha per anco accusato alcuno, se bene ha questo inquisitore certi sospetti”. Il Tribunale sostenne la sua colpevolezza e l’invitò più volte a fare nomi, per la sua salvezza altrimenti doveva applicare “giuste e severe leggi”.Relencini non parlò e continuò imperterrito a sostenere le sue convinzioni.Allora l’inquisitore lo fece torturare, con la prova del fuoco, nella speranza di carpirgli una confessione, ma Andrea Relencini non accusò nessuno.Scriverà così il commissario ducale in data 3 novembre 1580: “si trova hormai come ispedito dall’inquisizione, et tormentato con fuogo non ha accusato alcuno et se ne sta ostinato nella sua perversa opinione, si che si disputa se dee essere abbrugiato, o pure condannato a carcere perpetua et aspettasi credo risolutio-ne da Roma”.Riscriverà nuovamente il commissario al Duca d’Este, in data 9 novembre 1580: “L’inquisitore a questo M° Andrea Relencini ha assignato 40 giorni di tempo a pentirsi e ritornare alla SS. Ma-dre Chiesa et per quello che mi ha detto ha havuto commissione da Roma di ispidirlo onde dubito che sia per farlo abbruciare, perchè esso inquisitore fra questo viene costi per parlare a V.A.S. desideroso di fargli anche condurre il prigioniero “.L’inquisitore, frate Angelo da Faenza, si reca a Lugo per redigere la confessione del Relencini, ma per l’ennesima volta mastro An-drea non parla. Il commissario ducale avvisa il Duca dell’esito avuto da frate Angelo chiedendo il da farsi per ottemperare alla sentenza pronunciata dall’Inquisizione. Il Duca prende tempo e non risponde, ma l’11luglio 1581 il commissario invia al Duca il seguente messaggio: “L’inquisitore ha deliberato domenica prossima dare la sentenza di M° Andrea Relencino in S.to Dome-nico con l’intervento del Vicario del vescovo di Imola et altri, di che non ho mostrato curarmi”.L’intransigenza fanatica esautorava così la tolleranza politica del Duca d’Este.
Ugo Cortesi
P.G.R.Lungo la carreggiabile che da Giugnola conduce a Piancaldoli e che anticamente portava a Imola, esiste tuttora un pilastrino in sasso che tanti anni fa proteggeva un’ immagine della Madonna di Bocca di Rio e che ora farà sicuramente parte di una collezione di qualche ladro di ceramiche.Quella Madonna ricordava un fatto avvenuto nell’anteguerra che ha qualcosa di commovente e di tragicomico nello stesso tempo.Tonio e Maria abitavano al Casetto, facevano i mezzadri in quel poderetto, ancora esistente, che risaltava alla curiosità dei ragazzi del paese perché, non essendoci nei pressi alcuna sorgente, i due avevano escogitato un sistema di approvvigionamento idrico per mezzo di una “teleferica”.Infatti essendo il Casetto posizionato sull’orlo di un dirupo sulla riva sinistra del fiume Sillaro, da qui partiva, ancorato al tronco di una robusta quercia, un filo di ferro sul quale era appeso e scorre-va un secchio che scendeva per inerzia fino a una sorgente posta in basso sulla riva opposta del fiume.Senza fretta il secchio si riempiva quindi veniva fatto risalire trainato da una funicella azionata da un verricello a mano, e non impiegava poco!A quei tempi l’acqua si risparmiava per forza, oggi si spreca in-consideratamente.Un giorno Tonio considerato che la vaccherella che allevava mo-strava il desiderio di accoppiarsi, decise, col permesso del padrone di portare la bestia a conoscere il toro, detto Romano, che offriva le sue prestazioni in una casa colonica detta Le Rose vicino a Giugnola.Di buon mattino, trattenendo la vacca con una fune legata alla cavezza, il nostro Tonio si incamminò di buon passo sulla car-reggiabile che conduceva alla monta costeggiante la riva destra del fiume. Ad un certo punto, proprio nelle vicinanze dell’antico Ospedale di S. Antonio, la vacca cominciò a scalpitare, come può capitare quando queste sono in calore. Il nostro Antonio, che fra l’altro non era troppo robusto, non riuscì a trattenere la bestia la quale lo scaraventò giù nello scosceso diru-po fino ad annegare nelle fredde acque del Sillaro.Del fatto se ne parlò molto e fu l’avvenimento dell’anno per quei piccolissimi paesi.Tonio lo conoscevano tutti ed era considerato una brava persona, ma soprattutto: “un galantòm”, razza oggi in estinzione.Maria rimase sola e per tirare avanti, andò a convivere con la figlia maritata verso Visignano. Prima però di abbandonare il Casetto si recò, di lunedì, al mercato di Firenzuola dove acquistò una ceramica con la Madonna di Boc-ca di Rio, alla quale era tanto affezionata, e la pose in un pilastrino, costruito a sue spese, proprio sul luogo della disgrazia capitata al marito, a memoria imperitura!Ma, non sapendo leggere, non aveva fatto caso, la poveretta, a quelle tre, solo tre, letterine in un cartiglio alla base dell’immagi-ne: P.G.R. (per grazia ricevuta)!
Emilio Prantoni
8 9
Enrico Rizzi, figlio di Luigi è ricordato nel cimitero della Certosa a Bologna come: “artefice valente che utensili e ornamenti vari in pregiati metalli maestrevolmente elaborava”. Era un calderaio, bat-ram , artigiano del rame, che aveva bottega
UNA BATTERIA DA CUCINA IN MINIATURA
Cucina Monumentale, quadro del sec. XVII-XVIII, Bologna, Museo Davia Bargellini.
alla fine dell’Ottocento nella Rocchetta bentivolesca alla base del-la Torre degli Asinelli. Fu sfrattato dal comune di Bologna attorno agli anni Venti e si trasferì in via Gargiolari portando con se un ricordo dell’attività della sua famiglia .Voglio alludere alla riproduzione in miniatura di tutti gli utensili di rame necessari a una grande cucina, quale poteva essere quella del duca di Montpensier.Questo campionario di 340 pezzi riprodotti in miniatura si trova attualmente nella collezione storica e artistica della Cassa di Ri-sparmio di Bologna assieme al diploma dell’infante Don Antonio di Orléans. che concedeva nel l893 a Enrico Rizzi il titolo di proveedor con l’uso reale nelle «facturas y etiquetas dello stabi-limento di caldereria in Bologna».La vetrina fu esposta nel 1892 alla I Mostra d’arte applicata al-l’industria e fu premiata con medaglia d’argento. La riproduzione, rende abbastanza bene, oltre la singolarità dell’oggetto, la perfetta finitezza di ogni più piccolo utensile di rame cavo, modellato a colpi di martello su minuscoli pali, che lo Zingarelli nel suo voca-bolario bolognese cosi definisce «arnesi quasi ad uso d’incudine consistenti in una asta di ferro infissa in un ceppo verticalmente,
oppure in varia maniera inclinati, sui quali il calderaio batte alcuni suoi lavori».Fa da centro alla vetrina il camino con il suo focolare munito di forni e di cassette. Nel piano è il girarrosto con il meccanismo che farà girare lo spiedo: gli alari sono decorati da due statuette. Il tubo verticale è pronto a versare acqua calda: appese ad un ferro sono ramenne o schiumarole, mescoli e forchette. Nella cappa sono ben disposti stampi e stampini da dolci e padelle. A destra una vasca da bagno con fornello posta su ruote onde po-
10 11
tersi trasportare di camera in camera; a sinistra la pompa dell’ac-qua e una grande catinella per rigovernare.Sulle pareti grattugie, coltelli, pistadure o taglieri, candelieri, brocche, calzider o secchi muniti inferiormente di perno per muo-vere il meno possibile il fondo del pozzo, scaldaletti, padelle da arrostire le castagne.Nel fondo della vetrina sono appesi altri svariati utensili della bat-teria da cucina (battrì da cusena): cuccume, molte tejje o tegami, role o teglie, padelle e casseruole con coperchi, scaldaletti o scal-dapiedi, scolabrodi e scolapasta, altri stampi e stampini da budini e da pastine, zamponiere con graticola, terine o zuppiere, dariol o stampi da verdura, brusen o tostatori da caffè, salvavina o pevere con relativa grasparola o graticola atta ad impedire l’entrata nelle botti o nelle damigiane di graspe e vinaccioli, padelle da letto e vasi d’uso igienico o da nòt. Nel mezzo e in alto è un ingegnoso distillatore di liquori.E superfluo ricordare come durante l’ultima guerra un’infinità dei tradizionali utensili da cucina fu requisita e adoperata in usi bellici e come oggi altri materiali meno costosi abbiano sostituito il vecchio e nobile metallo forgiato con tanta abilità dai battirame. Queste considerazioni contribuiscono a dare maggiore valore al campionario in miniatura qui illustrato.
g.f.f.
Fascismo di sinistrain RomagnaNon s’è mai placata la disputa intorno all’effettiva natura, oltre che al peso, del cosiddetto “fascismo di sinistra”. Negarne l’esi-stenza, ridurlo a mera trovata ingannevole non è storiograficamen-te produttivo. Se si trattasse di un fenomeno privo di qualunque consistenza, non sarebbe probabilmente mai nato, alla metà degli anni Trenta, l’appello dei dirigenti comunisti «ai fratelli in camicia nera». Né d’altra parte riconoscerne l’esistenza e le aspirazioni costituisce una postuma apertura di credito. Dopo una incubazione nella fase discendente del ventennio, il “fascismo di sinistra” giunse al ci-mento con la realtà e giocò, effettivamente, le sue carte a Salò, e lì se ne misurò l’equivoca matrice, che mescolava questione sociale e ‘razza’, e, soprattutto, se ne palesò l’esito criminale.Nonostante le incerte sortite delle prime settimane, tra le quali spiccano il fondo del «Corriere della Sera » del 30 ottobre ‘43 inti-tolato Socialismo e, in una tribuna provinciale, l’ipotesi “lanciata” dal Popolo di Romagna, organo del fascio repubblicano di Forlì, di una alleanza con Stalin divenuto ormai patriota (6 ottobre ‘43). Il “fascismo di sinistra”, impostosi come ideologia ufficiale a Salò, svolse, sempre più apertamente, il ruolo di ramo italiano del nazionalsocialismo tedesco. Di esso condivise l’aberrante identificazione “razziale” tra capitalismo ed ebraismo e l’identifi-cazione, altrettanto “razzialmente” motivata, tra «nazioni giovani» o «ariane» e rivoluzione intesa come « Nuovo ordine europeo». È significativo che il primo avvio in tal senso (quando ancora Salò era di là da venire) fosse concomitante e coincidente, con lo scatenamento della campagna razziale, e con la proclamazione, ossessiva in quella campagna, del carattere originario (dal 1919) e fondante del razzismo per il fascismo. Non è un caso dunque che, nella torrenziale pubblicistica di Salò, Mussolini faccia di conti-nuo proclamare la propria personale fedeltà, da sempre, a quel fascismo, la propria pretesa di essere rimasto pur sempre (al di là delle scelte imposte dalla Realpolitik) il leader di quel fascismo, e di avere dunque, a Salò, finalmente realizzato il suo progetto. Mai forse propaganda fu meno vera, mai, più istruttiva.
gifra
Nicola Bombacci, socialista coetaneo di Mussolini, fondatore del P.C.I. a Livorno, aderì alla R.S.I. e fu fucilato a Dongo.
10 11
Una delle leggi più impopolari approvate dal nuovo Governo sabaudo ( gennaio 1869), fu quella sul macinato, uno dei cardini principali su cui contava il Ministro delle Finanze per giungere al pareggio dei conti dello Stato giunto allla fine delle guerre risor-gimentali e coloniali con un grave deficit. Consisteva in un con-tatore applicato alle macine del grano per misurare la quantità lavorata. Colpiva più pesantemente le famiglie meno abbienti che sul pane e le farine basavano la loro alimentazione
A livello governativo e parlamentare i moti del macinato chiari-rono a molti l’esistenza di una «questione sociale» i cui termini andavano al di là di una semplice parificazione delle spese di bilancio o di una mera composizione degli antagonismi sociali attuata a termini di legge. Infatti, alla Camera, il deputato riminese Luigi Ferrari, assieme ai colleghi Torrigiani e Quintino Sella accu-sò il ministro delle finanze, Cambray-Digny, «di aver determinato i moti dell’Emilia con la sua imprevidenza»; Francesco Crispi, che pure aveva favorito la legge sul macinato, giunse a «riconoscere nel popolo il diritto di resistenza, quando il Governo esce dalla legge»; gli onorevoli Rattazzi, Miceli, Oliva e Ferraris stigma-tizzarono con parole violente la repressione governativa, mentre l’opposizione cattolica, tramite il giornale bolognese «L’Ancora» (30 gennaio 1869), si sfogò individuando nei tumulti il risultato dei “latrocini” compiuti dai liberali durante il processo di unificazione nazionale, ai danni del potere temporale e dei beni ecclesiastici.Dopo il sanguinoso episodio della Comune di Parigi del marzo-maggio 1871, la situazione politico-sociale italiana subì una svolta decisiva anche all’interno del movimento operaio e contadino. La scossa ricevuta dai partiti politici in seguito a quell’avvenimento impose atteggiamenti nuovi, rispetto a quelli del passato, nei con-fronti del mondo del lavoro. Da una maggiore e più attenta considerazione di quest’ultimo da parte dei liberali, fino alla crisi del movimento mazziniano; dalla
LA TASSA SUL MACINATO
adesione alla rivoluzione parigina di molti giovani repubblicani, fino all’irrigidimento su posizioni retrive dei mazziniani ortodossi; dalle nuove sollecitazioni pervenute al movimento internazionali-sta, fino agli entusiasmi di Garibaldi e a una maggiore consistenza del movimento operaio e contadino, quasi ogni gruppo politico ricevette dall’episodio della Comune una spinta concreta e reale, un’indicazione di termini di lotta per una soluzione dei problemi che travagliavano la società italiana. I gruppi che si muovevano in nome del socialismo, i quali dalla fondazione della prima Internazionale dei lavoratori del 1864 avevano agito in Italia secondo moduli organizzativi non troppo efficienti, da quel mo-mento riuscirono a impostare una azione la quale, se pure caotica e ancora contraddittoria, acquistò un peso notevole soprattutto nelle campagne.Infatti la propaganda svolta da Andrea Costa e Michele Bakunin non aveva tardato a concepire la rivoluzione del proletariato agri-colo come il proprio « cavallo di battaglia » «In relazione alla rivoluzione sociale» aveva scritto l’agitatore russo fin dall’8 settembre 1870, «si può dire che le campagne italiane sono anche più avanzate delle città. Rimaste di fuori di tutti i moti e di tutti gli sviluppi storici, di cui sinora hanno sol-tanto pagato le spese, le campagne italiane non hanno né tendenze politiche né patriottismo... Ma [voi] destate appena l’istinto pro-fondamente socialista che sonnecchia nel cuore d’ogni contadino italiano; rinnovate in tutta Italia, ma con un fine rivoluzionario, la propaganda che il cardinale Ruffo aveva fatto in Calabria, alla fine del secolo scorso; gettate soltanto questo grido: La terra a chi la lavora con le proprie braccia! e vedrete se tutti i contadini italiani non si muoveranno per fare la rivoluzione sociale...Il movimento del tutto spontaneo dei contadini italiani nello scorso anno [1869], movimento provocato dalla legge che ha colpito con un’imposta la macinatura del grano, ha dato la misura del naturale
Vignetta satirica, 1869
12 13
socialismo rivoluzionario dei contadini italiani».Durante il primo congresso regionale dell’Associazione Internazio-nale dei lavoratori, tenutosi a Bologna il 17-19 marzo 1872, vennero stabilite la «necessità ed urgenza di avere fra le schiere Internazionali il lavoratore delle campagne, siccome quello che costituisce la maggioranza popolare e che ha in generale maggior bisogno di migliorare la sua condizione fisica e sociale». A tale scopo venne deliberato «d’istituire in ogni Sezione un Comitato con l’incarico ufficiale di diffondere alla campagna l’idea emancipatrice Internazionale...». Al secondo Congresso «federale», tenuto ancora a Bologna il 15 marzo 1873, si affermò che «a terra, gli strumenti di lavoro, il capitale in genere non possono rimanere a disposizione di una mi-noranza privilegiata e sfruttatrice» e che «dovere principalissimo degli operai della città si è di promuovere alla campagna una viva propaganda imperocché 14 milioni di contadini.., agonizzano per febbri e fame ed aspettano ansiosi l’ora della emancipazione». Qualche mese dopo, a S. Pietro in Vincoli (Ravenna), durante il 1° Congresso romagnolo si fecero voti «perché la unione dei lavora-tori dei campi fosse presto costituita».E ancora, in un foglio murale, affisso clandestinamente per conto della Federazione anarchica delle Romagne (agosto 1878), ven-nero indicati i termini che avrebbero permesso l’attuazione della «rivoluzione sociale», fra i quali si diceva che «il contadino si ri-fiuti di portare, come oggi fa, i frutti della terra da lui lavorata, al-l’odiato padrone che sciupa la vita nell’ozio e nella dissolutezza».Ma a parte l’azione politica e propagandistica degli internaziona-listi anarchici, sempre propensi a idealizzare il significato delle rivendicazioni contadine, ciò che ebbe un certo peso nell’insieme della situazione oggettiva di quegli anni fu l’esplodere di una nuo-va manifestazione di grave e profonda crisi che coinvolse l’intero paese e, in particolare, l’Emilia. Le discordie fra Mazzini e Garibaldi negli ultimi anni di vita del-l’agitatore genovese, fra repubblicani e anarchici, fra governo e opposizioni non contano gran che, se non vengono comprese e inquadrate nelle difficoltà economico-sociali di quegli anni, di cui i tumulti del 1874 furono la manifestazione più violenta.Si trattò di un anno, il 1874, veramente difficile per le colture agricole i cui raccolti si presentarono con una scarsezza estrema, al punto che le popolazioni affamate si abbandonarono in molte zone della regione emiliana a violente manifestazioni di prote-sta e ad atti vandalici, saccheggiando forni, depositi di grano e botteghe di generi alimentari. I pesanti provvedimenti presi dalle autorità governative per sedare i tumulti, le opere di assistenza organizzate dalle autorità di vari municipi mediante cucine pub-bliche e distribuzione di sussidi, l’intervento dei repubblicani della Consociazione romagnola invocante una politica capace di soddisfare le esigenze popolari, le critiche degli internazionalisti che colsero il fenomeno in termini escatologici, il riacutizzarsi del brigantaggio, il grosso processo di Ravenna contro la banda dei cosiddetti « accoltellatori » la quale, come una cosca mafiosa, re-golava ad io i prezzi delle granaglie sui mercati romagnoli ci fanno intendere da vicino quanto fosse difficile il momento attraversato dalle popolazioni emiliane.
Alfeo Bertondini
Vignetta satirica sulla tassa del macinato pubblicata nel faentino “Lunari de Smembar 1869”
Epidemie e pestilenzein RomagnaGrandi epidemie hanno storicamente percorso l’Europa e l’Italia, lasciando dietro di sé un manto di lutti e sconvolgimenti sociali tali da alterare e modificare, usi e costumi e modi di vita che non sempre ci sono stati tramandati nella loro giusta valenza, essendo l’attenzione degli storici prevalentemente concentrata su guerre, governi, re ed avvenimenti politici di facile individuazione e da-tazione.Ovvio che le pestilenze (ricordiamo soprattutto la “peste nera” di metà Trecento e quella seicentesca manzoniana) sono state favo-rite dalla precaria igiene in cui ha sempre vissuto il popolo minuto (i ricchi potevano fuggire o isolarsi dal contagio) e dall’ignoranza di cure, tardivamente giunte una volta che, declinate le teorie le-gate agli “umori” dell’ aria e dei corpi) e fatalismi di fede, per cui la malattia derivava dalla giusta punizione divina, si è cercato di individuare con obiettività (e poi scienza) la causa del morbo.Naturalmente anche le condizioni ambientali e geografiche hanno da sempre avuto responsabilità nel determinare una pato-logia; così, per la Romagna della “bassa”, nella lunga epoca del paludismo, troviamo endemicamente la “mal aria”, così come dai porti di Ravenna e Rimini ci sono giunte varie malattie esotiche d’importazione.Le zone del Faentino e della valle del Lamone hanno, dal punto di vista della topografia medica, scienza ormai desueta, un riscontro epidemiologico migliore rispetto ad altre zone. Fatto attribuito in parte a posizione geografica, venti orientali, mitezza del clima, tradizione sanitaria forse più organizzata che altrove. Per altri ancora in grazia della particolare protezione dall’Alto, favorita da una tradizione guelfa protratta per secoli. Ciò non ha impedi-to l’accesso, esclusione fatta per la peste del Manzoni, di ferali epidemie; fra queste, a metà dell’Ottocento, il “cholera morbus”, nonché la tristemente nota influenza “spagnola”, verso gli anni Venti del ‘900.Accanto a queste se pur meno tragiche per decessi, altre patologie destinate a declinare man mano che s’approfondivano diagnosi e terapia, quali la tisi (debellata solo dall’avvento della streptomi-cina) rabbia, difterite e tifo.La rabbia è dovuta ad un virus che si concentra nel cervello dando origine a forma di pazzia e idrofobia (cioè l’odio per l’acqua e il cibo dovuti alla paralisi dei muscoli della deglutizione). In Romagna per buona parte dell’Ottocento, pur con limitato numero di casi umani, s’assisterà ad una vera ossessione di ster-minio di cani randagi, indipendentemente dalla loro pericolosità e affrontati dai municipali con sciabola e fucili. Ripetuti a iosa allarmati bandi e inutili provvedimenti, in attesa di una tardiva identificazione del virus (1903).La difterite, dovuta ad un bacillo che può provocare una laringite strangolante, sarà senza dubbio più frequente, anche se a Faenza, al contrario di quanto succede nell’imolese e nel forlivese, è se-gnalata solo nel 1876. La sieroterapia, dovuta al Behring, farà crollare nel giro di un decennio la drammatica pericolosità della malattia.Sempre nell’Ottocento declina il tifo esantematico petecchiale (a Faenza duecento casi dalla metà del secolo), affrontato nella sua forma addominale con norme igieniche, isolamento e sterilizza-zione d’ acqua.Ma è sopratutto il colera, giunto da Francia e Piemonte dopo una meno cruenta comparsa vent’ anni prima, che nel 1855 chiederà un severo tributo di morte all’Italia ed a noi.Con una percentuale di decessi che supera il 60% dei contagiati, vi saranno coinvolti come sempre i gruppi sociali più modesti in ambienti meno salubri, in particolare quindi anziani e bambini,
segue a pag. 14
12 13La grande frattura nella vita di Dante Alighieri fu la condanna all’esilio che coincise con il crollo della Parte Bianca. Le vicende sono notissime e culminano con quella venuta a Firenze di Carlo di Valois, il fratello di Filippo il Bello, capitano generale della Chiesa - che, presentatosi in veste di paciere, affidò il governo ai Neri, dando via libera alle vendette di parte.Fu allora che Dante, «non per prova alcuna, ma per pubblica fama», venne dichiarato colpevole di baratteria, ossia di broglio politico, e condannato per decreto podestarile a 5.000 fiorini d’ammenda, a due anni di confino e alla perdita dei diritti civili. Siccome non si presentò in giudizio, la condanna fu aggravata con la confisca dei beni e il bando dalla città; se fosse caduto nelle mani della Signoria, l’avrebbero bruciato vivo. Dante non doveva rivedere mai più la sua Firenze.Eppure, in un certo senso, dobbiamo essere grati a quel Podestà, Cante de’ Gabrielli da Gubbio, che sanzionò la sua condanna.Lo aveva ben compreso Giosuè Carducci, che in un sonetto fa-moso proponeva addirittura di innalzargli un monumento. Senza di lui, senza la sua servile acquiescenza ai voleri della Parte Nera, non avremmo avuto la Divina Commedia. Sembra che il poema fosse già iniziato all’atto della condanna; ma in ogni caso non po-teva essere giunto al di là del canto V dell’Inferno, poiché nel VI si trovano già degli accenni agli avvenimenti politici del 1302. Ed é fuori dubbio che, senza il dramma dell’esilio, che strappò Dante a ogni cosa diletta e lo spinse, povero e solo, sulle vie d’Italia, il racconto della peregrinazione attraverso il regno dei morti avrebbe avuto ben diversi accenti: non così urgente l’ansia di giustizia, non così appassionato l’anelito a Dio, non così viva e sofferta la parte-cipazione alle vicende umane.Forse il pellegrinaggio non sarebbe nemmeno giunto al suo ter-mine.È difficile per un uomo sazio, sicuro e prospero, entrare in Paradiso, sia pure con la sola fantasia . Così, per diciannove anni dopo quell’autunno nero, alle tappe di Dante sulle vie dell’esilio s’accompagna l’altro viaggio, quello nei tre regni ultraterreni, e sovente il mondo visibile suggerisce delle immagini per il mondo invisibile. La maremma toscana, desolata e selvaggia, si trasforma nella selva dei suicidi, dove ogni arbusto, ogni sterpo velenoso e con-torto imprigiona un’anima, colpevole d’aver rigettato un giorno il fardello della carne: non la verde linfa circola in quei tronchi, ma scuro, denso sangue umano.
L’ESILIO DI DANTE ALIGHIERI
L’arsenale di Venezia, fervente di lavoro, con i carpentieri e i ca-lafati all’opera intorno alle carene delle navi, diventa la bolgia dei barattieri, proprio la colpa a di cui era stato accusato Dante! e la pece ribollente ricopre corpi contorti di dannati. Le arche disseminate intorno a Pola, nella conca detta Pratogran-de, specie d’immenso sepolcreto, in cui la pietra delle vicine cave di Vitriano veniva utilizzata per le tombe, s’illuminano agli occhi del poeta di sinistri bagliori infernali: sono le sepolture infuocate, sulle mura della città di Dite: da una di esse sta per drizzarsi l’om-bra maestosa di Farinata degli Uberti. Così i dirupi delle coste liguri diventano gli aspri scoscendimenti della montagna del Purgatorio; la foce del Tevere è il luogo di raduno delle anime spirate in grazia di Dio, che attendono l’an-gelo nocchiero; la pineta di Ravenna offre una similitudine per la divina foresta spessa e viva del Paradiso Terrestre, a sommo del monte dell’espiazione. Quanto più il viaggio procede, più Dante è solo. Dalla compagnia malvagia e scempia degli altri esuli bianchi si distacca ben presto, deluso dalle loro meschine discordie, dalle loro velleità di rivin-cita, dai colpi di mano sempre destinati al fallimento. Gli amici della sua giovinezza sono lontani, molti sono morti: Forese Donati se n’è andato giovane, nel 1296, « bruciato verde», nel pieno delle baldorie. Dante ne ritrova l’ombra nel Purgatorio, già prossima alla liberazione per le preghiere della buona moglie, Nella. Guido Cavalcanti si è spento quattr’anni dopo, consumato dal-la malaria, dopo alcuni mesi di confino politico nell’insalubre Sarzana; gli altri sono stati inghiottiti dalla distanza, dal tempo, dall’oblio. Intorno a quest’uomo sdegnoso e difficile, che i suoi stessi com-pagni di partito evitano, il cerchio della solitudine si dilata. Ma è una solitudine popolata di ombre amiche: Virgilio, il poeta diletto, venerato negli anni della gioventù con quello specialissimo ardore che i letterati in erba conoscono per i grandi modelli del passato, e Beatrice, la donna del suo primo amore, non morta, ma più viva e più bella ora, perché più necessaria.Sono loro i compagni dell’esilio, più assai degli occasionali pro-tettori e patroni feudali, siano poi i Malaspina di Lunigiana o gli Scaligeri così ospitali in Verona. Le dimore di Dante presso que-ste corti danno luogo sovente a curiose ed errate interpretazioni, quasi che il suo soggiorno fosse un’anticipazione di quel costume così frequente poi nel Rinascimento, quando la presenza d’uno
14 15
che vanno incontro ad una rapida disidratazione, che conduce al decesso in pochi giorni per insufficienza renale.La confusione sanitaria ai primi casi è massiva. A Ravenna, chissà perché, è vietata la vendita di meloni e cocomeri, guardati con estremo sospetto. A Imola si raccomanda di evitare “la collera, la paura, i piaceri troppo vivi…, la tranquillità dell’animo essendo il massimo preservativo”. A Faenza, più praticamente s’allarga il cimitero e si provvede a uno scalcinato lazzaretto presso la chie-sa di S. Ippolito. In città, nell’estate, il numero dei casi aumenta rapidamente, fino a contare a metà luglio 166 decessi su 317 contagiati.Vario l’impegno dei medici cui è dato di “appena toccare il polso del malato una volta che abbiano bagnato le dita nell’aceto” e che in parte si danno uccel di bosco, in parte soccombono al contagio o si dedicano con osservanza al loro dovere, pur disponendo di presidi terapeutici limitati al cloruro di calce, laudano e acido nitrico.Il lazzaretto è incontinente e viene per altro evitato per la diffi-denza popolare e il dubbio che vi si somministrino veleni, onde abbreviare la vita dei miseri” e, chi può scappa in campagna come si farà nella Seconda Guerra di Indipendenza, perché qui ovvia-mente il contagio è meno diffuso.Il primario dell’ospedale, Jacopo Sacchi, riserva le cure alla guar-nigione austriaca, più gratificante e remunerante (150 ricoverati e guariti, nessuno col colera).Fortunatamente con l’autunno il morbo declina e ad ottobre si possono tirare le somme dell’epidemia. Il bollettino sanitario municipale parla così di 1146 contagiati (un ventesimo della po-polazione) con 821 morti.Passano i decenni e si cambia secolo.Una caratteristica che riguarda l’epidemia influenzale, ribattez-zata “spagnola” e che in tutto il globo provocherà più morti della guerra mondiale in corso, sarà il silenzio e la censura imposti al fine di non intaccare ulteriormente il morale di popolazioni già a terra per i lutti e le restrizioni inerenti la guerra. L’ordine del gior-no in Romagna, come ovunque, è “sottovalutare”; col contorno di ordinanze e consigli spesso inutili, se non addirittura sconfinanti nel ridicolo (...”si impedisca ad ogni italiano la sudicia abitudine di stringere la mano, e la pandemia scomparirà nel corso di una notte”, B. Mussolini).In provincia di Ravenna l’influenza compare nella primavera del 1918, di breve durata e scarsa mortalità, non in attenuazione però nei mesi estivi e con una severa recrudescenza alle porte dell’autunno. Nel faentino, udite le notizie allarmanti provenienti da altre regioni, s’apprestano disinfezioni e cordoni sanitari, più un tentativo di sovralimentazione in quanto l’influenza, come la tubercolosi, è ancora considerata malattia da carenza.Mentre il Municipio ancora in ottobre avverte che “tutte le voci diffuse sull’attuale epidemia influenzale sono prive di ogni e qual-siasi fondamento”, il primario Alberico Testi scrive al sindaco che è costretto a rifiutare i ricoveri per esaurimento di posti letto.L’epidemia dilaga e le scuole e le attività pubbliche sono sospese. Mentre la Croce Rossa locale rifiuta il trasporto degli ammalati, si tenta di aprire un ospedale ausiliario presso l’asilo Baldi.Frequenti le complicanze ferali a carico dell’apparato respirato-rio, mentre compaiono anche encefaliti irreversibili per lo stesso morbo. Col freddo fortunatamente il contagio tende a diminuire e si trova il tempo di festeggiare la fine della guerra.Poi tutto lentamente rientra nella norma, col numero dei decessi tenuto segreto, il ritorno dei reduci e nuovi problemi sociali che urgono. E l’affiato della vittoria e di ciò che da essa si attende fa presto scordare come, per motivi di guerra o di malattia, pratica-mente ogni famiglia sia stata visitata “dalla croce”.In Romagna e nel mondo la successiva epidemia influenzale, 1’“asiatica” del 1957, troverà a difesa gli antibiotici.
Veniero Casadio Strozzi
continua da pag. 12
o più poeti diventa un elemento di prestigio per questa o quella Signoria. Niente di simile al tempo di Dante. L’accoglienza che riceve, a Lucca presso Uguccione della Faggiuola, nel Casentino presso i Conti Guidi, a Forlì presso Scarpetta degli Ordelafii, o in qualsiasi altra potente famiglia, non è mai dettata da motivi di mecenati-smo. Che Dante sia o non sia un poeta, interessa molto poco questi signori, tutti ancora discretamente rozzi. Forse un’ eccezione può essere fatta per i Malaspina, la cui tradizionale, generosa ospitalità verso i poeti era ben nota in Toscana; o per Cangrande, il dedi-catario del Paradiso. Ma sta di fatto che anche presso costoro, il motivo principale dell’accoglienza era politico, non artistico; e Dante veniva onorato come uomo di cultura, come diplomatico i cui servigi potevano tornare utili, come teorico del ghibellinismo, magari anche come mago e negromante (esistono prove, infatti, di questa sua curiosa fama) ma non certamente per il lustro particola-re d’avere un poeta alla propria corte. La sua poesia, in fondo, riguardava solamente lui.Non sono difficili da ricostruire le tappe del suo esilio, prima e dopo quella discesa in Italia di Arrigo VII, che tante speranze sol-levò nel cuore dei Bianchi esuli e che doveva concludersi con la morte, deludente e precoce, dell’Imperatore. Le campagne sono meno mutate delle città; i castelli che gli dettero rifugio ancora levano le loro torri, brune sul verde delle colline, nel Casentino, in Lunigiana. Ma anche le due città più vive nei suoi ricordi d’esilio,Verona e Lucca, serbano ancora le tracce di lui, e ogni tanto c’è qualche pellegrino appassionato che va a riscoprirle. Non si può entrare nella stupenda basilica di San Zeno a Verona senza rammentarci ch’egli conobbe quel luogo, vi trovò raccoglimento e conforto, e qui rievocò lo spirito dell’abate Gherardo, relegato in Purgatorio fra gli accidiosi. Le arche scaligere, il palazzo dei Signori, le tracce solenni di Verona romana e medioevale non possono disgiungersi dalla me-moria di lui.E così è per Lucca, una delle città d’Italia che più gelosamente ha saputo conservare il suo nucleo storico. Lucca ha un posto a parte nei soggiorni d’esilio danteschi, poiché, come disse il Bassermann, è ha città ch’egli conobbe « ad onta di tutte le ombre, illuminata alfine da. un raggio d’amore » un riferimento alla misteriosa figu-rina di Gentucca, una giovinetta che, stando a quanto è malizio-samente accennato dall’anima di Bonagiunta, nel Purgatorio, con-fortò con la sua presenza gentile il poeta ramingo, in un momento di particolare sconforto, poiché il soggiorno lucchese ebbe luogo subito dopo la morte d’Arrigo VII, che portava con sé nella tomba tutte le speranze politiche dei Bianchi.Il viaggio terrestre del Poeta si chiude su una nota di pace. La pace si diffonde nel suo cuore insieme al mormorio musicale dei pini, che hanno nelle fronde il vento, odoroso nel vicino mare. È la Pineta di Ravenna, l’immagine del Paradiso Terrestre, al som-mo dell’aspra e dura montagna, al di là del travaglio e dell’espia-zione. Non a caso Ravenna gli suggerisce quest’immagine di pace sovrumana. I figliuoli e i nipoti sono venuti .a raggiungerlo, c’è ancora della dolcezza in serbo per l’esule, che così a lungo ha as-saporato il pane della solitudine. Gli anni del suo patire gli stanno alle spalle, come una lunga, fa-ticosa via. L’accoglienza di Guido Novello da Polenta è come un porto, in cui è dolce raccogliere le vele. Dante non è vecchio: può ancora svolgere incarichi diplomatici, ambascerie: lo farà fino al termine della sua vita, quando un at-tacco di febbri lo sorprenderà sulla via del ritorno da Venezia, e l’immagine del nascente splendore della Serenissima sarà l’ultima ad affacciarsi ai suoi occhi. È stanco però, e logoro prima del tempo. Ma nelle lunghe veglie, nel silenzio della notte, sulle pagine dell’opera che forse gli ria-prirà le porte dell’ingrata città, torna avere trentacinque anni, l’età bella, la pienezza della vita. È il Giubileo del 1300, ed egli ha Beatrice accanto, amorosa come non gli si è mai mostrata da viva, materna, pia, illuminata di gra-zia. E davanti ai loro occhi rapiti si spalanca, in una fiumana di luce, il Paradiso.
Massimo Rossaro
14 15
La biografia di Romolo Gessi presenta apparentemente rapporti assai scarsi con Ravenna e con la Romagna. La sua nascita, quasi a preannunciare il carattere cosmopolita della sua vita, avvenne su una nave in viaggio verso Costantinopoli il 30 aprile 1831. La sua formazione si svolse nella capitale dell’Impero ottomano poi nelle accademie militari austriache e tedesche. Allo scoppio della guerra di Crimea, arruolatosi nell’esercito inglese, Romolo Gessi divenne ufficiale interprete del generale Strenowhys e conobbe il tenente Charles George Gordon che tanta parte doveva poi avere nelle vicende africane. Nel 1859 rientrò in Italia per parte-cipare alla seconda guerra d’indipendenza e, dopo l’unificazione nazionale, richiesta e ottenuta la cittadinanza italiana, abitò per breve tempo a Ravenna, per poi partirne ben presto e riprendere i viaggi, verso la Romania, poi l’Africa: viaggi che continuerà a intraprendere fino alla morte avvenuta nel 1881.Scarsi dunque appaiono a prima vista i rapporti esteriori tra la storia di Romolo Gessi e quella della Romagna, ma se si guarda più attentamente forse un legame c’è: un legame tra l’azione e la vita di Gessi e la tradizione risorgimentale romagnola. La sua azione riformatrice nella regione del Bahr el-Ghazal, iniziata praticamente nel 1879, dopo la sconfitta dei mercanti di schiavi, rappresenta un tipico esempio di tale legame. L’opera di risana-mento e di ricostruzione dei territori devastati dalla guerra e in parte spopolati dalle passate incursioni dei negrieri, fu infatti condotta con baldanza ed energia straordinaria, tipica di un figlio della Romagna. L’atto più importante, che rappresentò il gesto rivoluzionario di Romolo Gessi nei confronti della vecchia classe dirigente colo-niale, fu quello di chiamare gli indigeni all’amministrazione degli stessi territori africani. In pratica significava anticipare metodi e conquiste del pieno Novecento coloniale e aprire alle popolazioni indigene vasti orizzonti di progresso culturale, civile e sociale. Ma l’opera riformatrice di Romolo Gessi, oltre alla valorizza-zione dell’indigeno nella responsabilità di governo, si rivolgerà anche allo studio razionale e sistematico delle risorse economiche dei territori sudanesi. In luogo dell’avorio e della carne umana,
considerati fino allora le vere ricchezze del paese, il Gessi incen-tivò lo sfruttamento dei prodotti naturali, come il tamarindo, il co-pale, l’olio di palma, il burro, l’arachide, l’introduzione del mais e soprattutto la raccolta della gomma e la coltivazione del cotone. L’indigeno diventava cosi un contadino, un coltivatore: l’econo-mia pastorale e nomade si trasformava in una economia agricola sedentaria, determinando un ulteriore altro fattore di rivoluzione nella storia della società indigena sudanese.Ora tutta questa azione riformatrice che il nostro esploratore riuscì a realizzare, con tanta tenacia e intelligenza, in terra d’Afri-ca, si può dire legata alla tradizione risorgimentale romagnola rappresentando quasi una sorta di continuazione del pensiero paterno. La figura del padre Marco Gessi, carbonaro. console ge-nerale a Bucarest, amico dell’ambasciatore inglese lord Canning, meriterebbe essere approfondita. E quella nave, su cui Romolo Gessi vide la luce, portava la sua famiglia, un’eminente famiglia ravennate verso l’esilio, costrettavi per la partecipazione del padre alle attività cospiratorie contro il potere temporale della Chiesa in Romagna. Gessi sarà cosi uno dei tanti figli di cittadini degli antichi stati italiani dispersi all’estero dall’emigrazione politica. Dopo di che la sua vicenda personale si ricongiungerà alla storia italiana con la partecipazione alla seconda guerra d’indipendenza, nel corpo garibaldino dei Cacciatori delle Alpi. Anche questo episodio centrale della sua vita dovrebbe essere approfondito. E forse anche l’impulso che spinse Gessi, dopo il soggiorno ravennate. a riprendere i viaggi, derivò dalla disillusione dei democratici e dei garibaldini per la conclusione del processo d’unificazione sotto la direzione della monarchia sabauda e dei liberali moderati. Questa ispirazione democratica Gessi la conservò comunque nella sua azione di esploratore e di capo militare. Il periodo africano di Romolo Gessi ebbe inizio nel 1873. quando il colonnello Gordon, nominato governatore delle provin-ce equatoriali lo invitò a seguirlo in Egitto col grado di maggiore dell’esercito egiziano e come membro della sua spedizione nel Sudan. Questa spedizione aveva due obiettivi: uno politico-mi-litare, rivolto a pacificare e riordinare il paese combattendo la piaga assai diffusa della schiavitù, e l’altro di cartografare il terri-torio e di esplorare le parti meno conosciute. Nel marzo del 1874, secondo le istruzioni ricevute, Romolo Gessi partì da Suakin ed attraversò il deserto fino a Berbera. Giunto a Khartum, iniziò la sua ardita opera di esploratore e di spietato avversario dello schiavismo, spingendosi fino a Bahr el-Ghazal, dove riordinò i vecchi presidi egiziani e liberò intere carovane di schiavi negri. La questione della lotta alla schiaivtù, come problema morale, politico, economico, demografico, era stata imposta negli anni 1860 del secolo scorso all’opinione pubblica internazionale da un grande evento, la guerra civile americana.La vittoria della tendenza abrogazionista aveva segnato, come e noto, la scomparsa della schiavitù negli Stati Uniti. Ma il commercio degli schiavi continuava in Africa, in particolare nel Sudan egiziano, col tacito consenso delle autorità in direzione dei grandi mercati di smistamento e di vendita del Sudan e del-l’Egitto, il trasporto dei negri veniva effettuato attraverso percorsi diversi, con esclusione della via fluviale e dei centri abitati Gli arabi della costa di Zanzibar erano i maggiori rappresentanti di questo traffico e costituivano la classe dirigente del mondo com-merciale mussulmano.«Molti grassi capitalisti arabi o turchi dell’Egitto» commentava un esploratore inglese, il Baker nel suo resoconto pubblicato nel 1876, «vivevano su quella vergogna, come sulla più onesta delle rendite, in quanto i musulmani avevano e hanno tuttora il massimo disprezzo per le persone non appartenenti alla loro religione». I mercanti di schiavi rappresentavano un pericolo continuo per le popolazioni animiste locali, i cui pacifici villaggi erano assaliti da grossi gruppi di armati che portavano via, legati a due a due, le
ROMOLO GESSI, “GARIBALDINO” D’AFRICA
16
donne, i ragazzi, oltre agli uomini validi e le bestie, per condurli nei centri di raccolta all’interno del Sudan, da dove i prigionieri venivano venduti ed inviati verso i porti del Mar Rosso. In se-guito alle fatiche e ai maltrattamenti dei «gelabbia», loro terribili custodi, tantissimi schiavi morivano lungo il percorso. Ma c’era anche di peggio, perché molti mercanti di schiavi non trovando abbastanza redditizio il semplice traffico della carne umana, ce-devano spesso le «bocche inutili» o gli individui meno atti alla marcia alle tribù antropofaghe, per averne in cambio avorio e pelli d’animali.Contro questa situazione, l’azione di Gessi fu estremamente energica, non esitando perfino a criticare l’opera del suo supe-riore. In una lettera del 23 luglio 1880 indirizzata al direttore della rivi-sta italiana “L’Esploratore”, esprimeva il suo disappunto sulla ge-stione Gordon con l’espressione: «Io dirò la verità sulla questione della schiavitù; Gordon non sapeva un’acca di quanto facevasi nella sua amministrazione». Il suo mandato di governatore delle terre, che lui stesso aveva liberato dai potenti mercanti di carne umana, fu caratterizzato dal rifiuto di ogni compromesso e debo-lezza. Per Romolo Gessi la tratta era «un fenomeno economico e sociale insieme, che andava colpito nel cuore dei territori dove si annidava e trovava alimento, senza riguardo a caste e ad interessi, ed eliminato attraverso una severa e sistematica opera di epura-zione e di elevazione civile, la quale, smantellando la caotica e rapace amministrazione egiziana, riportasse l’indigeno alla terra e ai commerci.. Le motivazioni morali dell’azione di Gessi appaiono chiare nei suoi scritti: sia dalle sue memorie. In una lettera scritta da Bahr el-Ghazal il 29 agosto 1879, a proposito dello stato d’animo dei gruppi di negri armati costituiti per la difesa del loro paese contro i mercanti di schiavi, Romolo Gessi così si esprimeva: ora «i neri non sono che desiderosi di vedere qualche compagnia negriera arrivare, essi li attendono come un cacciatore resta in imboscata aspettare una belva»..Sono noti gli aspetti dell’attività di Romolo Gessi connessi alla esplorazione geografica, come l’incarico di esplorare l’alto Nilo al fine di verificare se questo fosse effettivamente un emissario del lago Alberto. Tale incarico, oltre al carattere scientifico-esplo-rativo, aveva importanti risvolti sul piano politico militare: il Khedivé dell’Egitto, Ismail, continuando la conquista del Sudan iniziata da Mohammed Ali vedeva nel controllo delle acque e del-le sorgenti del Nilo un mezzo indispensabile per raggiungere la prosperità e la sicurezza del paese.Il viaggio di Gessi non fu tuttavia facile: partito con due barconi di ferro, il «Dufli e il Magungo», egli dovette affrontare difficoltà d’ogni genere, che seppe sempre risolvere con la sua consueta energia. Cosi, durante la spedizione, constatata l’impossibilità di proseguire nella navigazione fluviale a causa della inagibilità di un tratto del Nilo, il Gessi fece smontare le imbarcazioni e orga-nizzò il trasporto dei pezzi (oltre 40 mila tonnellate di materiale) per via di terra, su un terreno difficilissimo e con l’aiuto di un
migliaio di indigeni assoldati a tale fine. lI 7 marzo 1876. dopo aver rimontato le imbarcazioni, la spedizione poteva riprendere la marcia verso il lago Alberto, la cui imboccatura fu raggiunta dopo dieci giorni di navigazione, dimostrando così definitiva-mente che il Nilo ne era proprio l’emissario. Poi fu compiuta la circumnavigazione del lago fino a Magungo all’estremità nord, dove Romolo Gessi innalzò la bandiera egiziana prendendo uffi-cialmente possesso del lago e della regione circostante a nome del Khedivé Ismail. Le principali riviste europee pubblicarono la re-lazione del viaggio di esplorazione del lago Alberto presentata da Romolo Gessi, il quale fu largamente elogiato per la sua magni-fica e coraggiosa impresa da Gordon e dal governo egiziano. Ma un’amara delusione doveva attendere il nostro esploratore al suo ritorno, quando si vide assegnare una esigua gratifica in denaro e una modesta onorificenza mentre funzionari europei ed ufficiali egiziani, che avevano fatto meno di lui, ottenevano ricompense e riconoscimenti maggiori. Sdegnato per l’ingiusto trattamento subito e amareggiato da una espressione poco felice del Gordon, che forse non aveva intenzione d’offendere: «what a pity you are not an englishman!», (che peccato,voi non siete un inglese). Romolo Gessi diede le dimissioni e s’imbarcò per l’Italia metten-dosi a disposizione della Società Geografica Italiana presieduta da Cesare Correnti.Avvenimenti di portata mondiale, come l’apertura del canale di Suez avvenuta nel 1869, ed altri meno importanti ma egual-mente significativi, quali l’istituzione di regolari linee di navi-gazione per l’Oriente, nonché la fondazione della stessa Società Geografica italiana avvenuta a Firenze nel 1867, avevano preso a stimolare l’opinione pubblica italiana verso possibili conquiste in terra africana. Cosi nel settembre 1877, Gessi era nuovamente in Africa ad incontrare un altro grande esploratore, geografo e an-tropologo romagnolo: Pellegrino Matteucci, con il quale si spinse fino a Fadasi sulla frontiera del Kaffa, per poi tentare invano di penetrare nel paese dei Galla con lo scopo di liberare Cecchi e Chiarini, prigionieri della regina di Ghera. I risultati del viaggio furono pubblicati l’anno dopo da Pellegrino Matteucci nel volu-me Sudan e Gallas, che costituì una dettagliata relazione sulla natura dei luoghi e sulle caratteristiche delle varie razze africane.Ma l’aspetto dell’azione d’esplorazione di Gessi, che meglio ri-vela la sua ispirazione risorgimentale, come ho precedentemente accennato, rimane la sua lotta implacabile contro la tratta degli schiavi. Questa lotta fu anche l’aspetto che più appassionò l’opi-nione pubblica del tempo. Indubbiamente esso si collegava più direttamente alla tradizione risorgimentale, democratica e garibaldina e non a caso Gessi ver-rà chiamato da un suo biografo, Zavatti, il Garibaldi dell’Africa.
Salvatore Saccone
E’ zoch-periodico di attività culturali fondato nel 2002 da D. Franchini e G.F. FontanaAprile 2006, numero 20Autorizzazione del Tribunale di Bologna n.° 6718
Direttore : Daniele FranchiniDirettore responsabile : Gian Franco FontanaRedazione: Santerno Edizioni sas di Gian Franco Fontana e C.Via IV novembre, 7 40026 Imola BOE mail : [email protected] Fax 0542.35629Stampa: Offset Ragazzini & C. - Faenza - 0546 28230Questa pubblicazione è edita con i contributi dei soci del Tribunato e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Banca di Imola.
In questo numero scritti di:Alfeo Bertondini; Veniero Casadio Strozzi; Ugo Cortesi; Gian Franco Fontana; Marcello Novaga; Emilio Prantoni; Massimo Rossaro; Salvatore Saccone.
Le fotografie sono dell’archivio Gian Franco Fontana ©2006
Spedizione in Abbonamento Postale D. L.353/2003 conv.L.27-02-2004 n°46 art. 1 comma 1 DCB Bologna