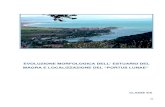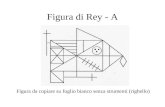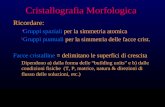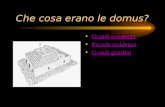NUOVI DISPOSITIVI SPAZIALI PER LA RIGENERAZIONE … · produzione beni e residenze, con una...
-
Upload
truongkiet -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
Transcript of NUOVI DISPOSITIVI SPAZIALI PER LA RIGENERAZIONE … · produzione beni e residenze, con una...
534
NUOVI DISPOSITIVI SPAZIALI PER LA RIGENERAZIONE URB ANA
Il caso studio delle caserme Caretto e Boscariello di Secondigliano a Napoli
Giovanni Zucchi 248 Parole chiave IT: spazio, misura, dismissione, centralità
Abstract IT Le aree dimesse, veri propri buchi neri nei tessuti urbani, rappresentano un’importante occasione per lo sviluppo delle città da contrapporre ai modelli dello sprawl, intervenendo come nodo centrale del dibattito e della ricerca urbana contemporanea. Bisogna però interrogarsi sulle possibilità del progetto di tali aree, le cui trasformazioni possono avere ricadute enormi sull’assetto della città stravolgendone la geografia e gli stessi rapporti posizionali. Considerare la rigenerazione un modello da contrapporre allo sprawl, necessita innanzitutto un’analisi di quei caratteri che hanno favorito i modelli di diffusione urbana, rendendoli appetibili sia agli investimenti che alle pratiche insediative. Bisogna quindi capire cosa porta una persona a preferire l’outlet alle vie del centro o la villetta suburbana all’appartamento in città. Si delinea così un nuovo modello di spazi per la città, che ibrida le tipologie tipicamente urbane con quelle più contemporanee dello spawl, secondo i dispositivi dinamici e flessibili della rigenerazione urbana. In questo senso si intende proporre il caso studio delle caserme Caretto e Boscariello situate a Napoli nel quartiere di Secondigliano ed oggetto della sperimentazione progettuale da me svolta nell’ambito della tesi di laurea in Ingegneria Edile-Architettura presso l’Università Federico II di Napoli. In questa vasta area militare sottoposta a dismissione dalla Variante al piano regolatore,si pensa di collocare un nuovo tessuto urbano che, in un territorio altamente complesso, vuole rappresentare una nuova forma di centralità urbana capace di riattivare l’intera periferia Nord di Napoli.
1. Premessa “Luogo della frammistione, la città contemporanea è per sua natura instabile; sede di continui cambiamenti che danno luogo al formarsi di situazioni critiche e a soluzioni transitorie dei problemi: case che diventano officine, officine che diventano teatri, scuole che diventano case, giardini che divengono parcheggi, tranquille strade che divengono assi di traffico intenso. L’uscita dalla modernità, come già fu quella dalla città antica, è anche dismissione, trasformazione e riuso di molte sue parti: dismissione di fabbriche, di scuole e caserme, di banchine portuali, di palestre, di stazioni e scali ferroviari.
248 PhD student "Architecture and Urban Phenomenology", Università degli Studi della Basilicata, Dipartimento DiCEM CdS di Architettura. Email: [email protected].
535
Frammistione e dismissione, inseguendosi, distruggono valori posizionali e di continuo propongo nuovi problemi culturali: quello del grado di tolleranza, di compatibilità e incompatibilità nei confronti dell’altro, delle sue pratiche, dei suoi usi e attività, dei rumori, degli odori e quello delle temporalità sovrapposte e intersecate”. (Secchi, 2000, pag. 80) A fronte di una diffusione urbana pulviscolare senza apparenti regole di crescita, che ha prodotto diverse densità, prevalenza del vuoto sul pieno e spazi aperti scarsamente progettati, residuali e senza identità, il progetto urbano deve interrogarsi sulla sostenibilità di tali processi insediativi, provando a prefigurare scenari per un migliore utilizzo del suolo. Le ragioni dello sprawl vanno ricercate prima di tutto nelle nuove pratiche sociali ed urbane in cui il senso collettivo originario delle civitas tende ad evaporare a favore di un individualismo consumistico sempre più forte e che vede nel grande Mall o nell’Outlet i nuovi centri aggregativi. Si viene a creare così un territorio amorfo, privo di identità particolari e profondamente bidimensionale, i cui punti di riferimento spesso divengono le grandi insegne pubblicitarie che costeggiano le strade a scorrimento veloce. In tal senso le questioni da considerare nel ragionamento su questo modello urbano sono a mio avviso due: 1- Lo sprawl è un modello sostenibile? 2- Qual è il campo in cui può muoversi il progetto urbano in tali contesti? Per rispendere al primo quesito bisognerebbe innanzitutto capire dove ci porterà lo sprawl, e quale forme assumerà in futuro. In tal senso però ci troviamo a confronto con una profonda complessità ed incertezza dell’evoluzione morfologica dello spazio urbano, un’incertezza sull’azione dei soggetti che oggi lo modificano e che lo modificheranno in futuro, e quindi un’incertezza sull’efficacia di quei dispositivi progettuali che oggi pensiamo siano efficaci, ma che forse domani non lo saranno più. Per questo non ci resta altro che provare ad immaginare un possibile futuro per un territorio che certamente non sopporterebbe uno sprawl infinito, data la finitezza del suolo disponibile. La risorsa suolo quindi è diventata quanto mai preziosa, per cui l’occasione per la trasformazione è offerta dal riempire quei vuoti che l’esplosione delle città si è lasciata alle spalle, molti dei quali sono sicuramente rappresentati dalle aree dismesse; si rende quindi necessaria una attenta riflessione sulla trasformazione di tali territori. Le aree dimesse, veri propri buchi neri nei tessuti urbani, rappresentano quindi un’importante occasione per lo sviluppo delle città da contrapporre ai modelli dello sprawl, intervenendo come nodo centrale del dibattito e della ricerca urbana contemporanea. Bisogna però interrogarsi sulle possibilità del progetto di tali aree, le cui trasformazioni possono avere ricadute enormi sull’assetto della città stravolgendone la geografia e gli stessi rapporti posizionali. Considerare la rigenerazione un modello da contrapporre allo sprawl, necessita innanzitutto un’analisi di quei caratteri che hanno favorito i modelli di diffusione urbana, rendendoli appetibili sia agli investimenti che alle pratiche insediative. Bisogna quindi capire cosa porta una persona a preferire l’outlet alle vie del centro o la villetta suburbana all’appartamento in città. Da qui ci si lega alla seconda questione proposta, ovvero quali strade può intraprendere il progetto per muoversi in questi nuovi campi di indagine urbana. Bisogna dunque innanzitutto approcciarsi alla città interrogandosi sui binomi che hanno contribuito alla sua costruzione – centro/periferia, continuità/discontinuità, regola/eccezione, densità/rarefazione ̶ e indagando sulla qualità degli spazi aperti e soprattutto dell’abitare caratterizzato dai binomi individualità/serialità, flessibilità/ampliabilità, modularità/variazione, chiusura/apertura. Il progetto dello spazio aperto, sia esso natura o progetto di suolo, considerato come tecnica principale della riuscita di un intervento e la cui trascuratezza è stata la causa del fallimento
536
prodotto dalla modernità, richiede un approccio particolare, legato ai temi del progetto di paesaggio. Il paesaggio e comunque le aree residuali, sono l’altro spazio di cui l’architettura ha bisogno oggi per assumere allo stesso tempo il ruolo di interno ed esterno. Eleggendo a proprio alleato il paesaggio, l’architettura inventa le regole di un nuovo gioco urbano: architettura e natura si fondono così in un'unica figura architettonica capace di coniugare potenziale ecologico con le esigenze di un buon abitare. Il tema del “giardino” urbano, termine preferibile a quello di “parco” perché evoca una necessità di cura e manutenzione dello spazio da parte del cittadino, rappresenta oggi un materiale imprescindibile del progetto. L’architettura contemporanea, d’altro canto, pare non aver ancora elaborato un sistema teorico capace di interpretare quei non luoghi, teorizzati da Augè, per superarli definitivamente e impostare un ragionamento approfondito sulla qualità dei nuovi spazi della città in estensione. Nel numero doppio di Casabella 597-598 dal titolo “Il disegno degli spazi aperti” Boeri, Lanzani e Marini nel loro saggio “Nuovi spazi senza nome” riflettono proprio sulla necessità da parte della città diffusa di rendersi riconoscibile attraverso nuovi modelli di spazi aperti. Nel saggio infatti, si legge: “Gli spazi della “città diffusa” mettono a dura prova la nostra capacità di descrizione. L’architettura e l’urbanistica dispongono di un articolato vocabolario per denotare luoghi dotati di una precisa identità di figura e di significato […] Che stabiliva una forte reciprocità tra l’evidenza formale e l’identità simbolica degli oggetti che nominava. Oggi, osservando i paesaggi della dispersione urbana, ci accorgiamo che molti spazi non hanno un significato chiaro e condivisibile”. (Boeri, Lanzani, Marini, 1993, pag. 74) La necessità di una formulazione di spazi simbolici e che diano identità ai territori della città in estensione pare quindi essere un problema quanto mai attuale ed irrisolto dal progetto urbano, il quale dovrebbe abbandonare quel “vocabolario” consolidato di quei luoghi che compongono la città storica di cui parlava l’articolo sopracitato e creare un nuovo campionario di possibilità di luoghi della città diffusa. Se da un lato il dibattito si interroga ancora sulla qualità degli spazi della città diffusa, prefigurando un possibile uso del consolidato vocabolario degli luoghi della città storica nei territori dello sprawl per creare centralità e identità; dall’altro si può pensare di utilizzare nelle aree urbane dismesse alcuni caratteri tipici del modello insediativo della diffusione come l’individualità, la frammentarietà e l’inclusione delle abitazioni, o il confort e il senso sicurezza che si può riscontrare negli spazi controllati dei centri commerciali. Si delinea così un nuovo modello di spazi per la città, che ibrida le tipologie tipicamente urbane con quelle più contemporanee dello spawl, secondo i dispositivi dinamici e flessibili della rigenerazione urbana. Le linee di ricerca che si legano a tale possibilità interessano temi diversi: la densità, come giusta misura della rigenerazione urbana; il ruolo degli spazi aperti come principale materiale della trasformazione contemporanea delle città; lo studio di nuove tipologie dell’abitare come matrice compositiva rigenerativa.
2. Il caso studio delle caserme Caretto e Boscariel lo di Secondigliano a Napoli In questo senso si intende proporre il caso studio delle caserme Caretto e Boscariello situate a Napoli nel quartiere di Secondigliano ed oggetto della sperimentazione progettuale da me svolta nell’ambito della tesi di laurea in Ingegneria Edile-Architettura presso l’Università Federico II di Napoli. In questa vasta area militare sottoposta a dismissione dalla Variante al Piano Regolatore, si pensa di collocare un nuovo tessuto urbano che, in un territorio altamente complesso, vuole
537
rappresentare una nuova forma di centralità urbana capace di riattivare l’intera periferia Nord di Napoli. Le caserme Caretto, Boscariello e Bighelli rappresentano un forte segno urbano all’interno del tessuto dell’area nord, sia per la dimensione che per la posizione a cerniera tra le diverse realtà urbane. Soprattutto l’area delle caserme Caretto e Boscariello con la sua posizione di centralità rappresenta un importante occasione di ricucitura di quelle slabbrature prodotte dalla costruzione della periferia per piccoli interventi autonomi che si voltano le spalle l’un l’altro. Sorte alla metà del Novecento, sono tra i primi edifici che vanno ad occupare un’area prevalentemente rurale a ridosso dell’asse storico di via Miano e si pongono quale elemento fondativo dell’impianto della 167 che prende la propria giacitura non dagli assi storici ma dal recinto stesso delle Caserme. Il P.r.g. del comune di Napoli individua per l’area la dismissione dell’attuale funzione militare e la creazione di un settore urbano capace di contenere nuove centralità urbane che possano avere una ricaduta sull’intera periferia nord, prevedendo l’insediamento di servizi per il terziario, produzione beni e residenze, con una particolare attenzione alla vocazione sportiva. La lettura morfologica dell’area delle caserme risulta quanto mai complessa ed articolata dato il numero e l’eterogeneità degli elementi che il luogo presenta. Segno fondativi dell’area, preso a riferimento nel ragionamento progettuale è la presenza del muro di recinzione che ha da sempre diviso l’area dal contesto circostante e che si giudica elemento di “permanenza” dei caratteri di eccezionalità e discontinuità del sito e che vogliono essere conservati e reinterpretati. E’ dunque importante considerare le possibilità compositive e di significato che offre la dismissione del muro e l’improvvisa messa in contatto dell’area con il contesto circostante. Si è considerato, dunque, interessante la possibilità di operare una lettura dell’area di progetto su due livelli, “dentro il muro” | “oltre il muro”. Dentro il muro c’è la regola - La presenza del limite murario ha da sempre isolato l’area dal contesto e conservato l’impianto originario delle caserme tutt’ora intatto e leggibile, non essendo mai stato contaminato dall’eterogeneità dei tessuti a contorno. Dato lo scarso interesse architettonico ricoperto dagli edifici esistenti che non si pensa di riutilizzare - capannoni semi-industriali ad un piano con tetti a doppia falda organizzati a doppia C secondo un impianto che caratterizza in maniera diffusa questo tipo di insediamento militare e che rende riconoscibile un uso ad uno sguardo dall’alto dei territori italiani –, si individuano tre elementi interni al muro che divengono materiali e tracce per il progetto: la misura della griglia regolatrice dell’impianto, la presenza di una tipologia a corte, i tre grandi vuoti corrispondenti alle piazze d’armi. La griglia ortogonale che regola rigidamente l’impianto delle caserme ha una dimensione 20X20 metri e risulta essere un elemento ordinatore forte per un area tanto vasta. La tipologia dei bassi capannoni delle caserme è quella classica della corte aperta che rispettando la griglia regolatrice si confronta con gli ampi spazi aperti con il lato chiuso o aperto. Altro elemento peculiare presente è la tripartizione del vasto spazio, un ritmo attraverso cui l’area viene articolata in pieni e vuoti attraverso i tre grandi spazi delle piazze d’armi sulle quali si attestano le corti che rappresentano, assieme alla griglia, gli elementi regolatori e misuratori dello spazio interno. Fuori al muro c’è la discontinuità e la eterogeneità della città, con i suoi tessuti, le sue strade e le sue scale diverse, le sue eccezionalità. L’eliminazione del muro delle caserme pone un problema di disegno del bordo che metterà l’area in contatto con queste realtà particolari e diverse.
538
Due sono le grandi questioni che a questo punto si pongono: che tipo di rapporto di continuità|discontinuità intraprendere con i materiali urbani presenti ai bordi e quali giaciture dell’area nord assumere nel progetto del nuovo. La questione dei bordi si presta ad una lettura articolata data la presenza di condizioni al contorno particolarmente eterogenee e singolari. Il disegno di masterpan si compone così di diversi temi di progetto leggibili attraverso un lavoro di sovrapposizione di layer, che riassumono la complessità degli elementi entrano in gioco con la dismissione del muro e quindi con l’apertura dell’area alla città. Si vengono a delineare due tempi del processo compositivo: un tempo “zero” appartenente all’impianto delle caserme protetto dal muro, ed un tempo “uno” che considera la dismissione del muro e l’ingresso nel disegno delle condizioni a contorno. La traccia delle caserme rimarrà leggibile nelle misure della griglia, nell’alternanza dei pieni e vuoti, nella scelta tipologica di base. A queste tracce di ciò che l’area era, il progetto unisce una lettura dei bordi che entrando in gioco attraverso giaciture, tipologie e approcci, modificano gli elementi regolatori delle caserme conformando un nuovo disegno di masterplan che unisce la specificità dell’area delle caserme all’eterogeneità del contorno. La creazione di nuove centralità rappresenta uno dei principali obbiettivi di riqualificazione dell’area Nord che si è data la Variante del Piano Regolatore di Napoli. L’area delle caserme per posizione e dimensione è considerata dalla Variante l’occasione più importante per creare spazi centrali di grande vocazione attrattiva. Tale opportunità progettuale può essere perseguita sia attraverso il posizionamento di grandi funzioni attrattive, sia attraverso una conformazione degli spazi aperti capace di costituire pause di qualità urbana. Le possibili funzioni sono suggerite dalla stessa Variante che prevede per quest’area, oltre che la costruzione di residenze, il collocamento di edifici per la produzione di beni rari, per il terziario, il commercio e per lo sport. L’idea di creare luoghi aperti di centralità porta invece alla creazione dei tre grandi vuoti dati dalla conformazione originaria delle caserme, articolati secondo tre differenti tipologie di usi. Nei due grandi vuoti laterali sono previste funzioni compatibili con le vicine residenze, al centro invece la grande agorà. Il primo vuoto a sud accoglie la piazza del mercato. La scelta del grande mercato semicoperto in relazione con le residenze nasce dalla suggestione del mercato rionale come elemento fortemente urbano che nel caso specifico diventa per dimensione e localizzazione un attrattore commerciale ad una scala maggiore di quella semplicemente rionale. Il lavoro progettuale nasce prima di tutto da un lavoro con il suolo, attraverso uno scavo che porta il suolo del mercato a degradare fino ad una quota sottoposto rispetto al piano zero di circa quattro metri. Questo gesto progettuale vuole conformare l’area del mercato secondo un suo spazio di pertinenza preciso occupato centralmente da elementi lineari che accolgono il bancone e la pensilina e creando sui margini dello spazio, lungo il salto di quota, ambienti di servizio e deposito seminterrati per la movimentazione delle merci. Il mercato è conformato dall’elemento base della pensilina e dalla sua articolazione spaziale, capace con il suo disegno di integrare elementi fissi come i banconi per la vendita dei prodotti. Sull’altro fronte, rispetto al mercato, si prevede un grande polo sportivo in relazione alla vocazione sportiva dell’area auspicata dalla Variante.
539
La strategia progettuale è la stessa del mercato, quindi si lavora con la tecnica dello scavo per delimitare l’area ed isolarla dalle residenza, prevedendo inoltre lungo i bordi in corrispondenza del salto di quota lo spazio per ambienti di servizio e spogliatoi. Il grande centro invece si pone come spazio pubblico e legato a pratiche commerciali e direzionali e come l’agorà è l’elemento fondamentale della città greca, in quanto ne rappresenta il centro nevralgico della vita politica e commerciale, così il grande spazio pubblico di progetto viene definito da un lungo porticato a tutta altezza, con la copertura praticabile, circondato da grandi edifici pubblici che vi si attestano secondo giaciture e misure differenti. Il Foro di Pompei rappresenta il riferimento tipologico ad una organizzazione secondo cui lo spazio aperto dà ordine alla complessità delle differenti morfologie all’intorno che vi convergono. Il progetto si completa con un ragionamento sulle residenze sperimentando due differenti modalità di approccio alla tipologia del maxi-isolato a corte verde, arrivando a definire due modelli abitativi che partono da premesse comuni per poi specificarsi in relazione alle condizioni al contorno. Nel primo si ritrovano elementi classici come il basamento cavo, una organizzazione strutturale puntuale a pilastri ed il giardino delimitato dalla corte. Nel secondo invece la corte si apre al parco seguendone in maniera più fluida l’andamento naturale, il basamento si frammenta in una sequenza di recinti murati che contengono abitazioni a patio aggregate a schiera ed i cui muri sorreggono una organizzazione più libera delle mensole sulle quali si impostano le diverse cellule abitative al piano. Infine le cellule abitative sono pensate secondo uno schema base aperto e flessibile che definisce solo la struttura portante e la posizione dei servizi, lasciando la massima libertà compositiva alla sagoma della cellula stessa, definibile secondo le possibilità di un eventuale ampliamento modulare per meglio conformarle alle diverse esigenze individuali. In entrambi i casi la filosofia seguita è quella dell’abitare individuale inserito in una aggregazione collettiva che conservi ampi spazi privati all’aperto, e definisca una struttura degli edifici molto permeabile e trasparente attraverso la quale si possa leggere in profondità la complessità del contesto ed il legame con il parco, e che al contempo simboleggi la complessità dell’architettura contemporanea come qualcosa in continua evoluzione e mutamento.
540
Figura 30– L’area delle caserme Caretto e Boscariello: la gr iglia regolatrice interna
Fonte: Tesi di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura_Criteri di intervento nella riqualificazione delle periferie: una proposta di disegno urbano per l’aera delle caserme di Secondigliano a Napoli (Zucchi, 2012).
541
Figura 2 – L’area delle caserme Caretto e Boscariello: la l ettura dei bordi
Fonte: Tesi di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura_Criteri di intervento nella riqualificazione delle periferie: una proposta di disegno urbano per l’aera delle caserme di Secondigliano a Napoli (Zucchi, 2012).
542
Figura 3 – Planimetria generale del piano terra
Fonte: Tesi di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura_Criteri di intervento nella riqualificazione delle periferie: una proposta di disegno urbano per l’aera delle caserme di Secondigliano a Napoli (Zucchi, 2012).
543
Figura 4 – Planovlumetrico
Fonte: Tesi di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura_Criteri di intervento nella riqualificazione delle periferie: una proposta di disegno urbano per l’aera delle caserme di Secondigliano a Napoli (Zucchi, 2012).
544
Figura 5 – Piante ai diversi livelli della residenza a cort e (tipo 1)
Fonte: Tesi di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura_Criteri di intervento nella riqualificazione delle periferie: una proposta di disegno urbano per l’aera delle caserme di Secondigliano a Napoli (Zucchi, 2012).
545
Figura 5 – Piante ai diversi livelli della residenza a cort e (tipo 2)
Fonte: Tesi di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura_Criteri di intervento nella riqualificazione delle periferie: una proposta di disegno urbano per l’aera delle caserme di Secondigliano a Napoli (Zucchi, 2012).
546
Figura 7 – Vista interna alla corte (tipo 1)
Fonte: Tesi di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura_Criteri di intervento nella riqualificazione delle periferie: una proposta di disegno urbano per l’aera delle caserme di Secondigliano a Napoli (Zucchi, 2012).
547
Figura 8 – Vista dello spazio pubblico centrale
Fonte: Tesi di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura_Criteri di intervento nella riqualificazione delle periferie: una proposta di disegno urbano per l’aera delle caserme di Secondigliano a Napoli (Zucchi, 2012).
548
Figura 9 – Vista interna alla corte (tipo 2)
Fonte: Tesi di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura_Criteri di intervento nella riqualificazione delle periferie: una proposta di disegno urbano per l’aera delle caserme di Secondigliano a Napoli (Zucchi, 2012).
549
Bibliografía AYMONINO, Aldo e MOSCO, Paolo Valerio. Spazi pubblici contemporanei. Architettura a volume zero. Milano. Edizioni Skira, 2006. ISBN: 978-88-7624-272-4 BIANCHETTI, Cristina. Abitare la città contemporanea. Milano. Edizioni Skira, 2003. ISBN: 88-8491-407-8 BOCCHI, Renato. Progettare lo spazio e il movimento. Roma. Gangemi editore, 2009. ISBN: 978-88-492-1812-1 BOERI, Stefani, LANZANI , Arturo, MARINI, Edoardo 1993. Nuovi spazi senza nome. In: Casabella, n. 597.598, gennaio-febbraio 1993. ISSN: 0008-7181 CORBOZ, Andre. Ordine sparso. Saggi sull’arte, il metodo, la città e il territorio. Milano. Franco Angeli editore, 1998. ISBN: 978-88-4640-569-2 ESPULEAS , Fernando. Il Vuoto. Riflessioni sullo spazio in architettura. Milano. Christian Marinotti edizioni, 2011. ISBN: 88-8273-056-5 FORTY, Adrian. Spazio, in Parole e edifici. Un vocabolario per l’architettura moderna. Bologna. Edizioni Pendragon, 2000. ISBN: 978-88-8342-343-7 GREGOTTI, Vittorio. Il territorio dell’architettura. Milano. Feltrinelli editore, 2008. ISBN: 978-88-07-72001-7 GREGOTTI, Vittorio. Architettura e postmetropoli. Torino. Giulio Einaudi editore, 2011. ISBN: 978-88-0620-729-8 INGERSOLL , Richard. Sprawltown, Roma: Maltempi editore, 2004, ISBN: 978-88-8353-292-4 JACOBS , Jane. Vita e morte delle grandi città. Torino. Giulio Einaudi editore, 1961. ISBN: 978-88-06-19724-7 KOOLHAAS , Rem. Delirious New York. Milano. Electa, 2001. ISBN: 88-435-6230-4 KOOLHAAS , Rem. Junkspace. Macerata. Quodlibet, 2006. ISBN 10 88-7462-112-4; ISBN 13 978-88-7462-112-5 LYNCH, Kevin. L’immagine della città. CECCARELLI, Paolo (a cura di). Venezia. Marsilio Editori, 2013. ISBN: 978-88-317-7267-8 PEREC, Georges. Specie di spazi, Torino. Bollati Boringhieri, 1989. ISBN: 978-88-3390-498-6 PURINI, Franco. Comporre l’architettura. Roma-Bari. Edizioni Laterza, 2011. ISBN: 978-88-420-6154-0 RAY, Mary-Ann, SHERMAN, Roger. The Dense-city. After the sprawl. In Zardini Mirko (a cura di). Milano. Electa, 1999. ISBN: 978-88-2890-989-7 REALE , Luca. Densità l città | residenza. Roma. Gangemi editore, 2008. ISBN: 978-88-492-1472-7 ROSSI, Aldo. L’architettura della città. Macerata. Quodlibet, 2011. ISBN: 978-88-7462-409-6 RYKWERT, Joseph. La seduzione del luogo. Storia e futuro della città. Torino. Einaudi editori, 2000. ISBN: 978-88-0616-550-5 SCALA , Paola. Elogio della mediocritas. La misura del progetto urbano. Napoli. CUEN, 2008. ISBN: 88-7146-759-7 SECCHI, Bernardo. Prima lezione dl urbanistica. Roma-Bari. Editori Laterza, 2000. ISBN: 88-420-6060-7 SECCHI, Bernardo. La città del ventesimo secolo. Roma-Bari. Editori Laterza, 2005. ISBN: 987-88-420-7710-7 SIMMEL, Georg. Sociologia. Roma. Edizioni di Comunità,1998. ISBN: 978-88-245-0549-9
550
SPIRITO, Gianpaola. Forme del vuoto. Cavità, concavità e fori nell’architettura contemporanea. Roma. Gangemi editore, 2011. ISBN: 978-88-492-2085-8 Vigano , Paola. La città elementare. Milano. Skira edizioni, 1999. ISBN: 978-88-811-8642-6 ZANINI, Piero. Significati del confine. I limiti naturali, storici, materiali. Milano. Bruno Mondadori, 1997. ISBN: 88-424-9425-9 ZEVI Bruno. Saper vedere la città. Torino. Einaudi Editori, 1997. ISBN: 978-88-06-14125-7 ZEVI, Bruno. Saper vedere l’architettura. Torino. Einaudi Editori, 2009. ISBN: 978-88-06-20106-7