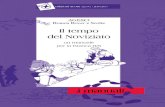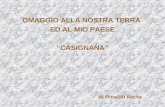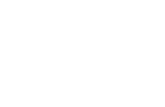NOVIZIATO DEL TASSO: II: LE RIME GIOVANILI PER LUCREZIA E IL «RINALDO»
-
Upload
antonio-di-pietro -
Category
Documents
-
view
214 -
download
1
Transcript of NOVIZIATO DEL TASSO: II: LE RIME GIOVANILI PER LUCREZIA E IL «RINALDO»

NOVIZIATO DEL TASSO: II: LE RIME GIOVANILI PER LUCREZIA E IL «RINALDO»Author(s): ANTONIO DI PIETROSource: Aevum, Anno 27, Fasc. 1 (GENNAIO - FEBBRAIO 1953), pp. 47-86Published by: Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro CuoreStable URL: http://www.jstor.org/stable/25820417 .
Accessed: 15/06/2014 10:34
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore is collaborating with JSTOR todigitize, preserve and extend access to Aevum.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 188.72.126.181 on Sun, 15 Jun 2014 10:34:21 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

ANTONIO DI PIETRO
NOVIZIATO DEL TASSO
II
LE RIME GIOVANILI PER LUCREZIA E IL ?RINALDO ? *
L'atmosfera di candido entusiasmo da cui nasce il Gierusalemme si
dirada rapidamente intorno al Tassino quand'egli si trasferisce da Vcnczia a Padova, per compiere i suoi studi universitari (1).
Padova, da secoli cittadella gloriosa deiraristotelismo, e, come e
noto (2), in questi anni, una delle capitali piu fervide, e forse la piu
spregiudicata, del Rinascimento: nel suo Studio convengono scolari da
ogni parte d'Europa ad ascoltare maestri illustri, quali il Sigonio, il Pic
colomini, il Robortello, il Passero, mentre uomini di lettere e d'arte si
raccolgono intorno a Sperone Speroni, che, discepolo del Pomponazzi e del Bembo e custode della tradizione degli Infiammati, e il regolatore supremo della vita culturale della citta. Segue il Tassino con particolare
(*) Per il primo capitolo di questo studio (/ primi uersi e il " Gierusa/emme ?), v.
?Aevum?, Anno XXVI, fasc. 1, gennaio-febbraio 1952, pp. 1-21.
(1) Giunge il Tassino a Padova negli ultimi mesi del 1560, per studiarvi, obbediente alia volonta paterna, legge (v. A. solerti, Vita di T. T., Torino, 1895, vol. I, p. 53-56). Tutto ci assicura che il suo interesse per le pandette e le decretali fu, in questi anni uni
versitari, di gran lunga inferiore a quello che dimbstro per le lettere; ma, mancando ogni documento sul suo curriculum studiorum (v. solerti, op. cit., I, p. 101) non sappiamo se e quando ottenne da Bernardo di abbandonare gli studi di diritto per dedicarsi a quelli di filosofia e d'eloquenza: certo, comunque, non ?col nuovo anno?, come vorrebbe il
Soierti (op. cit., I, p. 57), se nella prefazione al Rinaldo, pubblicato nell'estate del 1562, il poeta dice di dimorare a Padova ?per attendere agli studi de le leggi? (v. Rinaldo a cura di A. Bonfigli, Bari, Laterza, 1936, p. 2) e nella quintultima stanza del poema (XII, 90) allude con rammarico agli ?ingrati studi? da cui e oppresso.
(2) Vedi soprattutto: // Cinquecento di F. Flamini e quello di G. Toffanin nella Sto ria letteraria d'Italia (Milano, Vallardi) e L'umanesimo italiano di E. Garin (Bari, Laterza, 1952); e, per quanto piu specificamente riguarda il Tasso, oltre alia Vita di T. T. del Soierti (ed. cit., I, pp. 53-57), // T. a Padova di A. Malmignati (Verona, Drucker, 1889).
This content downloaded from 188.72.126.181 on Sun, 15 Jun 2014 10:34:21 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

48 A. DI PIETRO
interesse le lezioni sulla Poetica d'Aristotele del Sigonio e quelle di
filosofia naturale del Piccolomini (1); si mescola alia folia irrequieta
degli studenti; frequenta, ? non meno spesso e volentieri che le pubbli che scole ?, la casa dello Speroni, che gli sembra abbia (come dira, ri
cordando questi suoi giorni, piu tardi) ?la sembianza di quella Academia e di quel Liceo, in cui i Socrati e i Platoni avevano in uso di disputare? (2). E Taristotelismo laico deirautorevolissimo letterato, non incrinato ancora
dalle preoccupazioni moralistiche della Controriforma e non contraddetto dai maestri prediletti dello Studio, il libero costume goliardico, il pro rompere della giovinezza, tutto concorre ad allontanare il poeta, ormai
diciassettenne, dal mondo ingenuamente grandioso della sua adolescenza e ad orientarlo verso una visione piu concreta e moralmente piu disin
volta della vita e deirarte.
Non e ancora o e appena finito il primo anno di studi, e di questo nuovo orientamento il Tassino ha gia preso coscienza, tanto che decide di abbandonare, temporaneamente almeno, ?Y alta impresa? dei duci
crociati, per cantare le avventure di Rinaldo (3). A scegliere il nuovo
tema lo spinge, si, infatti, come egli stesso confessera, Timpazienza di una rapida affermazione, piu agevole da ottenersi con un breve romanzo
cavalleresco che con un grave poema eroico, e lo inducono il recente
(1) II Sigonio e ricordato dal Tasso con affetlo partigiano nella prefazione al Ri
naldo (ed. cit., p. 5), e l'insegnamento del Piccolomini, ?in Padova suo dottore. . .
non de la moral filosofia? ma ? De la naturale?, e rievocato con commossa ammirazione
nei dialogo della maturita // Costantino o aero de la Clemenza (v. Dialoghi a cura di
C. Guasti, Firenze, 1858-1859, vol. Ill, pp. 243-244).
(2) V. Discorsi de I'arte poetica e in particolare sopra il poema eroico in Prose
diverse a cura di C. Guasti, Firenze, Le Monnier, 1875, vol. I, p. 22.
Lo Speroni era in buone relazioni con Bernardo, che da lui aveva gia mandato il fi
gliolo in occasione della fiera di S. Antonio del 1559, a portargli alcuni canti de\Y Ama
digi, e a lui aveva chiesto, poi, di trovare una ?dozzina per Torquato ... In casa d'uo
mini dabbene e lontano da le male compagnie? (v. SOLERTI, op. cit, I, pp. 39-40 e
53, e II, p. 92). (3) Al Rinaldo il Tassino, pose mano tra la fine della primavera e Y inizio dell' estate
del 1561, se e vero che, com'egli stesso afferma nella prefazione, fu ? ne lo spazio di dieci
mesi condotto a fine questo poema* (Rinaldo, ed. cit. p. 4), e se si tien conto che 1'ope ra doveva essere gia pronta, o quasi, per la pubblicazione nell'aprile del 1562, quando
egli e i suoi amici cominciano a darsi attorno per ottenere dai vari stati italiani i privilegi per l'edizione: le lettere con cui il Tasso chiede che gli siano concessi i privilegi alia
repubblica di Lucca e al Doge di Venezia sono infatti del maggio 1562 (v. SOLERTI, op. cit, II, pp. 3-4), e del 23 aprile e la lettera a tal fine scritta da Scipione Gonzaga presumibilmente al Duca di Mantova (ibidem, II, pp. 94-95). Non e da escludersi tuttavia, ed e anzi molto probabile, che dopo questa data e fino alia pubblicazione, avvenuta nel
1'estate, il Tassino abbia dedicato al Rinaldo buona parte del suo tempo, apportandovi correzioni e modifiche. Incertezze gli rimanevano ancora infatti, evidentemente, nella pri mavera del 1562, se nella domanda alia Repubblica di Lucca chiama il suo romanzo Ri
This content downloaded from 188.72.126.181 on Sun, 15 Jun 2014 10:34:21 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

NOVIZIATO DEL TASSO 49
esempio paterno (1) e le sollecitazioni degli amici letterati (2); ma lo
costringe soprattutto il suo animo profondamente mutato dal clima spi rituale in cui vive. II vago e sconfinato ? desir di gloria? in cui si sen
tiva ?involto? (3) quando a Venezia iniziava il Gierusalemme, sognando per se un* immortalita sublime, simile a quella di Goffredo e dei suoi
?Cristiani Eroi ?, si e trasformato, nell'edonistico ambiente padovano, in
ansia di piu immediati successi e di piu tangibili soddisfazioni: e a dar
corpo ai suoi nuovi sogni, ben piu opportuna della guerra santa, si offre
la storia di un eroe giovinetto, che, fidente nel suo straordinario destino, affronta e supera ogni prova, per conquistarsi i doni piu ambiti dalla
giovinezza: la gloria, intesa come sensibile e incontrastato applauso del
mondo, e l'amore, sentito come inesauribile fonte di piacere. E verso questi doni il Tassino, come l'eroe di cui ha cominciato
a narrare le gesta, e tutto proteso, quando, a dare una forma precisa ai
suoi ancor fluidi desideri giovanili, e a scandire e ad accelerare i tempi della sua profana conversione, l'amore compare concretamente nella sua
vita, e compare nella persona di una giovane dama di corte.
* * *
Questa esperienza amorosa del Tasso e troppo chiaramente testimo
niata dal suo poema giovanile, che certo la presuppone, (e percio subito
qui se ne parla), per poterne dubitare. Quali siano state tuttavia le vicende
di questa sua prima passione e come precisamente si siano tradotte in
poesia e cosa di cui ben poco riusciamo a sapere. Sappiamo si, grazie alle laboriose indagini del maggior biografo tassiano, che tomato il poeia a Padova, dopo le vacanze estive, nel settembre del 1561, con i primi canti del Rinaldo gia stesi o abbozzati, incontra Lucrezia Bendidio,
quindicenne damigella di Eleonora d'Este, e se ne innamora (4); e che
naldo Innamorato, mentre in quella, di poco posteriore, al Doge di Venezia semplice
mente Rinaldo.
(1) Alia fine del 1560 era stato finalmente pubblicato, a Venezia, Y Amadigi, la cui laboriosissima composizione il Tassino aveva seguito fin dai suoi piu teneri anni e che
di recente aveva anche, probabilmente, copiato per la stampa e rivisto sulle bozze.
(2) II Verdizzotti si vanto (v. la sua lettera, gia citata, all'Ariosti, nella Vita di T. T. del Soierti, vol. II, p. 223) di aver persuaso il Tassino a scrivere il Rinaldo e di avergli mostrato anche, a tal fine, il suo Orlando; ma il Tassino non lo nomina affatto, quando,
nella prefazione (come vedremo), ricorda gli amici che lo incoraggiarono a comporre e
a pubblicare il poema.
(3) Vedi il sonetto ?Quest' umil cetra ond' io solea talora?, gia citato nei primo vca*
pitolo di questo studio.
(4) V. Solerti, op. cit., ed. cit. I pp. 65-70. Lucrezia Bendidio era al seguito della
sua Signora, che a Padova si trattenne circa un mese, per recarsi ai bagni termali di Abano.
Aevum - Anno XXVII - 4
This content downloaded from 188.72.126.181 on Sun, 15 Jun 2014 10:34:21 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

50 A. DI PIETRO
l'anno dopo la bella giovanetta va sposa, a Ferrara, dove Torquato ha
frequenti occasioni di incontrarla ancora, al Conte Baldassarre Machia
velli (1). Ma, oltre a quesli scarni dati di cronaca, altro non conoscia mo di sicuro: perche se le affermazioni del Solerti possono essere so
stanzialmente accettate per quanto riguarda queste poche notizie essen
ziali, non altrettanto accettabile appare lo sforzo ch'egli poi compie per descrivere diligentemente le varie fasi di questo amore, adducendo a documento delle occasioni che lo avrebbero generato e alimentato le
rime del poeta (2). Sforzo strenuo quanto sterile: e stato infatti di re
cente osservato (3) come i testi usati a tal fine dal Solerti, per essere
stati pubblicati quasi tutti troppi anni dopo la presunta vicenda biografica, e dopo troppe e troppo profonde rielaborazioni (4), non possono piu rimandarci l'eco immediata degli avvenimenti sotto il cui stimolo furono
la prima volta scritti; come, inoltre, quest*eco sia difficilmente reperibile anche nelle redazioni piu antiche, dato che il poeta non tende mai a
confessarsi, romanticamente, nelle sue liriche, ma piuttosto a staccare
le sue emozioni dalle loro radici esistenziali per adeguarle liberamente
alle misure predisposte di una tradizione letteraria; e come, infine, mal
fide siano anche le indicazioni biografiche deducibili dagli ?argomenti? e dagli ordinamenti imposti alle rime, perche gli uni e gli altri sono
spesso mutati, da raccolta a raccolta, sia per obbedire ad esigenze pra tiche, sia per avvicinarsi meglio al profilo ideale di una letteraria storia
d'amore. E a queste osservazioni, tutte opportune, bisogna aggiungere che, anche in sede puramente biografica, la identificazione degli episodi che fornirono le occasioni alle rime amorose in genere e affidata ad elementi estremamente ambigui: i rapporti del poeta con le donne che
(1) II Soierti, mentre neila Vita di T. T. (ed. cit., I, p. 74) dice che Lucrezia ?sposava a quel che pare, nell'estate del 1562?, nella nota premessa alle Rime per Lucrezia Ben didio (v. Le Rime di T. T. a cura di A. Soierti, Bologna, 1898-1902, vol. II, p. 6) afferma, senza addurre alcuna giustificazione, che le sue nozze avvennero ?nel carnevale di quel l'anno?. Sia nella Vita (I, p. 75) che nelle Rime (II, p. 6), asserisce poi, erroneamente, che ando in moglie, invece che a Baldassarre, a Paolo Machiavelli (v. G. Bertoni, Lu crezia Bendidio e T. T., in Poeti e poesie del Medio Eoo e del Rinascimento, Mode
na, Orlandini, 1922, p. 276).
(2) V. Vita di T. T., ed. cit., I, pp. 71-79, e la nota su ricordata (Rimet ed. cit., II,
p. 6), che riassume le vicende narrate nella Vita rimandando ai testi da cui sarebbero documentate.
(3) Da L. Caretti, nella ?comunicazione? Per una nuova edizione delle Rime del T. (Roma, Bardi, 1937) e poi ancora negli Studi suite Rime del T. (Roma, 1950), dove quella ?comunicazione? ricompare, riveduta, insieme con altri saggi, fra i quali qui particolarmente interessa quello sui Versi giouanili di T. T. (di cui vedi, soprattutto, le
pp. 143-146).
(4) La stragrande maggioranza delle rime ispirate, secondo il Soierti, da Lucrezia (co me, del resto, la stragrande maggioranza di tutte le rime tassiane) non fu pubblicata che nell'edizione aldina del 1581, e una parte addirittura solo nell'edizione Osanna del 1591.
This content downloaded from 188.72.126.181 on Sun, 15 Jun 2014 10:34:21 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

NOVIZIATO DEL TASSO 51
amd, o a cui fece omaggio di versi d'amore secondo il corrente costu me letterario e cortigiano, durarorto infatti, ciascuno, cosi a lungo, e
cosi inestricabilmente si intrecciarono tra loro, nella cornice di ambienti estremamente simili, che gli stessi dati di fatto rintracciabili nei testi
tassiani si possono troppe volte riferire, indifferentemente, a persone, a
luoghi e a tempi diversi (1). II canzoniere giovanile per Lucrezia, a cui fin da ieri tutta la critica,
sulla parola del Solerti, ha prestato intera e ingiustificata fede (2), non
e, dunque, in realta mai esistito. II disgregarsi della arbitraria sistema zione solertiana, sotto i colpi delle piii recenti indagini, apre pero nella storia umana ed artistica del Tasso un vuoto che gli ultimi studi non
hanno ancora colmato (3). E colmarlo adeguatamente si potra solo quan do un attentissimo esame filologico e stilistico di tutte le liriche tassiane
permettera di giungere, sulla scorta di elementi interni, a una diversa e
plausibile silloge delle rime che (liberate per quanto e possibile dalla
stratificazioni delle varianti piu tarde) vanno poste accanto al Rinaldo, a illuminarne la gestazione e ad allargare il panorama di quella poesia
(1) Particolarmente disperante e il tentativo di discernere le rime per Lucrezia Bendi
dio da quelle per Laura Peperara. Gli appigli esterni a cui di solito si fa ricorso per giun
gere ad una distinzione sono quasi sempre ambivalenti. L' una e l'altra donna furono
infatti conosciute, sembra, dal poeta mentre era studente universitario; con 1' una e con
l'altra per molti anni ebbe contatti, piu tardi, e lascio e ritrovo piu volte nei suoi frequenti
viaggi tra Ferrara e Mantova; ambedue infine, dame della stessa condizione sociale, usa
rono con lui secondo i modi sorvegliati dallo stesso costume. Ne le loro caratteristiche
fisiche e spirituali, quali si riflettono nella letteraria idealizzazione dei testi, aiutano a di
stinguere Tuna dall'altra: la stessa eccellenza nei canto, attribuita dal Soierti solo a Lu
crezia ( Vita di T. T.y ed. cit., pp. 67-69), e ritenuta poi elemento discriminante da tutti i
critici tassiani non escluso il Caretti (Studi suite rime del T., ed. cit., p. 144), e un dato
controvertibile, se si pensa che esibirsi nei canto era consuetudine comune delle gentil donne del Cinquecento e che Laura non meno di Lucrezia fu lodata dai contemporanei per le sue virtu canore (v. Bertoni, op. c/7., p. 304), celebrate del resto dal Tasso stesso in
alcune rime a lei dedicate. Ne sempre ci si puo fidare dei riferimenti ai luoghi: Mantova
non dista molto da Ferrara e molti luoghi (come le piu volte evocate rive del Po e dei
suoi affluenti) sono accessibili da ambedue le citta; per non dire che, come al poeta, an
che agli altri non era difficile recarsi da una citta all'altra (o da una localita all'altra
dei due ducati limitrofi), e che Laura e Lucrezia dall'inizio del 1579 in poi si trovarono accanto nella medesima Corte di Ferrara (v. solerti, Vita di L T.t ed. cit., I, p. 309 e
Rime di T. T., ed. cit., II, p. 212; e Bertoni, op. cit., pp. 304-305).
(2) Serie obbiezioni furono mosse infatti all'edizione solertiana delle Rimet prima che
dal Caretti, gia da V. Rossi, nei ?Giornale storico della letteratura italiana? del 1899
(vol. XXXIII, pp. 399-403). (3) Un contributo notevole alia ricostruzione della storia delle prime esperienze liriche
del Tasso, ha gia dato pero il Caretti, nei citato studio sui Versi giovanili di T. T.\ e un
aiuto indiretto G. Getto, nelle pagine che sulle rime ha finemante scritte nella sua recen
tissima Interpretazione del Tasso, Ed. Scientifiche Italiane, Napoli, 1951, pp. 251-340.
This content downloaded from 188.72.126.181 on Sun, 15 Jun 2014 10:34:21 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

52 A. DI PIETRO
tassiana che nel romanzo giovanile appunto ha il suo centro e la sua
espressione piu valida.
Se la mancanza di una siffatta silloge ci impedisce attualmente di
seguire con puntuale esattezza i vari momenti deH*itinerario tassiano
dair estate del 1561 a quella del 1562, non e tuttavia impossibile delle
troppe rime collocate in quest* anno dal Solerti (1) sceglierne un nume
ro sufficiente a suggerirci di quell* itinerario le tappe fondamentali. Ne
occorrera indugiarsi a sottolineare i vari errori rilevati, o rilevabili an
che ad un rapidissimo ulteriore sondaggio, nelPedizione solertiana delle
rime per la Bendidio (2): bastera fermare Tattenzione su quelle rime, che,
pubblicate solo pochi anni dopo il Rinaldo e i primi incontri del poeta con Lucrezia, ci danno la garanzia di essere, se non proprio le redazioni
originarie, redazioni almeno dalle originarie non molto diverse e frulto
comunque di rielaborazioni operate in un clima spirituale di poco mutato.
Ci soccorrono in questa ricerca le due antologie di versi giovanili tassiani, che compaiono Tuna nella raccolta De le rime di dioersi nobili
poeti foscani, stampate a Venezia nei primi mesi del 1565 a cura di
(1) II Soierti crede ispirate dalla Bendidio 128 liriche, di cui ben 112 ritiene siano state composte nell'anno che va appunto dal settembre del 1561 a quello del 1562 (V. Ri
me, ed. cit., II, p. 6): anche a prescindere da ogni altra considerazione, non sembra pro bai)ile che in un periodo di tempo tanto breve il Tassino trovasse modo di scrivere un
cosi cospicuo numero di rime amorose, mentre attendeva al Rinaldo e, in qualche modo
sia pure, ai suoi studi.
(2) Varra forse la pena tuttavia di accennare in margine (mentre attendiamo l'edizio
ne carettiana delle Rime) ad alcuni degli errori a prima vista piu evidenti o probabili, da
aggiungere a quelli gia indicati, per alcune delle rime amorose, dal Rossi e dal Caretti.
Ingiustificabile e, per esempio, la collocazione dell'anno 1561-62 del sonetto, ?Mentre ma
donna s'appoggio pensosa? (Rime, ed. cit., II, n. 89), dove il poeta esplicitamente dice
che la sua donna ?gia tant'anni si nega? (v. 11); come poco opportuna l'inserzione nei
canzoniere per Laura Peperara del sonetto ?I begli occhi ove prima Amor m' apparse ?
(Rime, II, n. 173), in cui quel ?prima?, stando proprio all'ipotesi del Soierti, sembrerebbe un riferimento all'amore per Lucrezia. Quanto poi ai madrigali attribuiti al Tasso diciot
tenne, mostrano non solo tutti, o quasi tutti, come e stato notato ( Caretti, op. cit., pp. 143
146), una tecnica piu adulta, ma molti (in particolar modo quelli che modulano il tema della lontananza) ricordano i versi scritti piu tardi per Laura; e ad esperienze esistenziali
ed artistiche posteriori fanno pensare alcuni componimenti carichi d'un dolore ignoto al
poeta giovane, come, per esempio, il sonetto ?Vissi: e la prima etate Amore e Speme ?
(Rime II, n. 73), e molti altri di quelli che insistono con accento particolarmente dramma
tico sul tema della gelosia, e per cui il pensiero corre piuttosto, semmai, alia passione che
lego Lucrezia al Cardinal Luigi d'Este dopo il 1570, per circa un decennio, e che rattristo,
sembra, il poeta (v. bertoni, op. cit, pp. 273-318): componimenti questi ultimi, del resto,
per cui anche il Soierti si mostra perplesso se, dopo aver nella Vita di T. T. (ed. cit., I,
p. 99) inserito il sonetto ? Geloso amante apro mill'occhi e giro ? nella storia d'amore
per Laura, lo trasferisce poi, senza spiegare il perche, nei canzoniere per Lucrezia (Ri me, II, n. 99).
This content downloaded from 188.72.126.181 on Sun, 15 Jun 2014 10:34:21 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

NOVIZIATO DEL TASSO 53
Dionigi Atanagi (1), e l'altra nel florilegio delle Rime de gli Academici
Eterei, pubblicato a Padova nel gennaio del 1567 (2). Solo tredici sonetti del Tasso contiene la prima raccolta, e di essi
non piu di sei sono d'amore. Gli altri setie, encomiastici o d'occasio
ne, sono variamente databili (3); quelli d' amore costituiscono invece,
crediamo, un saggio tanto esiguo quanto prezioso del primo gruppo di
rime scritte per Lucrezia Bendidio, nel periodo che va, verosimilmente, dal settembre 1561 alPinizio del 1562 (4).
Sono evidenti infatti in questi versi amorosi gli stessi modi stilistici
scolasticamente impacciati che caratterizzano i sonetti funerari per Irene
(1) V. De le rime di diuersi nobili poeti toscani, raccolte da M. Dionigi Atanagi, Libro primo, an Venetia, appresso Lodovico Avanzo, 1565, cc. 187-190. La dedicatoria del
r Atanagi a Piero Bonarello, Contc d'Orciano, porta la data del 7 aprile.
(2) V. Rime de gli Accademici Eterei dedicate alia Serenissima Madama Mar
gherita di Vallois Duchessa di Sauoia, pubblicate a cura degli stessi Eterei, senza data, ma con una dedicatoria datata ?di Padova il primo Genaro del 1567 ?.
(3) Non vanno comunque, sembra, oltre il 1562. ?Come s'uman pensier di giunger tenta? e ?In questi colli, in queste istesse rive? (v. la citata raccolta Atanagi, cc. 189
r. e 189 v., e Rime, ed. cit., Ill, nn. 3 e 2) nella loro prima redazione, probabilmente
rivista, rimontano, come si e gia detto nel primo capitolo di questo saggio, al periodo ur
binate; ?0 d'eroi figlia illustre, o d'eroi sposa? (Atanagi, c. 187 v., e Rime, III, n. 10), a cui anche si e gia accennato, e stato scritto fra il 1560 e 1562 (cfr. la nota apposta in
calce dal Solerti nella sua edizione); ?Veggio tenera pianta in su le sponde? (Atanagi, c. 188 v., e Rime, III, n. 11), che, degli encomiastici, e il sonetto piu felice, e stato com
posto per la nascita di Vincenzo Gonzaga, avvenuta nel settembre del 1562; ?L'idra no
vella che di tosco forse? (Atanagi, c. 189 v., e Rime, III, n. 30), che il Solerti, affidandosi
ad un'erronea data proposta dal Guasti, pone neirottobre del 1565 (v. la sua nota al
sonetto e cfr. le Leitere di T. T. a cura di C. Guasti, Firenze, 1853-1855, I, p. 14), e stato
scritto evidentemente prima, se nell'aprile del '65 era gia pubblicato, e probabilmente
proprio nel 1562, se e il sonetto che (come vuole, forse a ragione, il Guasti) fu inviato
dal poeta a Benedetto Varchi ?Di Ferrara, il di 11 di ottobre?, dato che in quell'anno
appunto a Ferrara il Tassino trascorse le vacanze estive e si fermo fino a novembre; ed infine ?Ben per alto destino il nome e dato? e ?Vago augellin, che chiuso in bel
soggiorno? (Atanagi, c. 187 r. e v., e Rime, III, nn. 15 e 16), per la cui datazione
mancano elementi, ma che nulla induce a ritenere piu recenti degli altri sonetti.
(4) Che tutti i sonetti encomiastici della raccolta Atanagi di cui e possibile stabilire la cronologia vadano posti, come si e visto, non oltre l'ottobre del 1562 e una consta
tazione che convalida notevolmente, ci sembra, questa nostra tesi. E lecito infatti pensare
che anche gli altri sonetti della esigua silloge tassiana non sicuramente databili siano da
collocarsi entro lo stesso limite di tempo; ne e illegittima l'ipotesi che tutti i versi del Tasso contenuti nella raccolta (con altri, forse, fra cui essi furono scelti) siano stati con
segnati all'Atanagi dall'autore stesso, durante uno dei periodi da lui trascorsi a Venezia
fra il 1561 e il 1562, prima per rivedere il padre (che in quella citta rimase fino al di cembre del 1561) e poi, forse, per provvedere alia pubblicazione del Rinaldo. Ipotesi tanto piu probabile se si pensa che la raccolta Atanagi, pubblicata nell'aprile del 1565, fu evidentemente messa insieme dal letterato veneziano in un lasso di tempo anteriore, che
si pud senza sforzo far durare dal 1562, appunto, al 1564.
This content downloaded from 188.72.126.181 on Sun, 15 Jun 2014 10:34:21 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

54 A. DI PIETRO
di Spilimbergo (1), ed e sufficicntemente palese altresi il graduale di
staccarsi del Tassino da quei modi verso forme espressive piu sue. Non
diversamente da Irene, Lucrezia, piu che donna, colta nella sua umana
concretezza, e, in quasi tutti questi componimenti, soltanto il ?belsole?, da cui il poeta e lieto di lasciarsi bruciare, come ogni buon petrarchi sta (2); nel trar fuori pero dal comune deposito petrarchesco quanto gli occorre per dare forma una volta di piu all'antica metafora, il Tassino
mostra una predilezione per i toni piu carichi e accesi, per i contrasti
piu risentiti, che e gia il sia pur timido indizio del determinarsi d'un
originale atteggiamento stilistico e, quindi, di un autonomo mondo poe tico. ?Ardere?, ?accendere?, ? sfavillare ?, ?splendere ? ; e ?fiamma?, ? foco ?, ?luce ?, ? ardore ?, ?
splendore?; e ? vivo?,'? fervente ?, ? lucen
te?; e ?rosso ?, ?vermiglio?, ?purpureo?: sono i termini che tornano, in questi versi, piu insistenti o piu densi di capacita espressiva. Termini tutti del piu ortodosso vocabolario petrarchesco, particolarmente frequen ti nei testi dei contemporanei bembisti e gia prediletti dal Tassino, can
tore del sole, nel Gierusalemme; che tuttavia, per il continuo ricorrere e per le alleanze che stringono fra loro, hanno spesso su queste pagine conteste di petrarchismi, lo spicco di macchie d'un colore piu recente e vivace su una tela sbiadita dal tempo. E, grazie a loro, un calore piu intenso di quello degli innumerevoli soli degli alunni del Bembo si irrag
gia talvolta dal ?sole? del Tassino, che non soltanto, quando appare, ?Di vermiglio splendor le membra adorno?, ?avvien che' cor distrug ga e arda? (1); ma, se avanza fra la neve,
... ecco ... in vivo foco il gielo
Cangiarsi, e 'n fiamme lc cadenii stille:
E qual gemma, ch'al lume arde e sfaville,
(1) Pubblicati a Venezia nel 1561, come si e detto nel primo capitolo di questo studio, anch'essi a cura di Dionigi Atanagi.
(2) In ben cinque dei sei componimenti d' amore si ripete, con industriose quanto mo
notone variazioni, il trito paragone fra la donna e il sole. Sono i sonetti: ?Fulvio, qui po sa il mio bel Sole allora?, ?La terra si coprio d'orrido ve!o?, ?Come va innanzi a l'altro
Sol 1'Aurora?, ?Re degli altri, superbo, altero fiume?, ?I freddi e muti pesci avezzi omai?.
Vedili nella raccolta Atanagi a cc. 188 r. e v., 189 v. e 190 r., e nel vol. II delle Rime (ed.
cit.), dove (riportati con alcune varianti) sono, rispettivamente, contrassegnati dai nn. 11,
40, 41, 83, 84. E vedi anche nello stesso vol. II delle Rime: ?Mira, Fulvio, quel sol di novo apparso? (n. 10) e ?Tasson, qui dove il Medoaco scende ? (n. 22), che, non pub blicati fra i sonetti della raccolta Atanagi, sono, il primo evidentemente e il secondo con
ogni probability, ad essi coevi.
(3) V. ?Fulvio, qui posa il mio bel Sole allora?: Atanagi, c. 188 v. (e Rime, II, n. 11).
Della raccolta dell'Atanagi non conserviamo, come gia per le citazioni dal Gierusa/emme,
le meno significative forme grafiche cinquecentesche.
This content downloaded from 188.72.126.181 on Sun, 15 Jun 2014 10:34:21 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

NOVIZIATO DEL TASSO 55
Splender le nubi e serenarsi il cieio (1);
e, se va lungo il mare, perfino I freddi e muti pesci avczzi omai
Ad arder sono, cd a parlar d'amore (2).
Ma piu viva che mai la sua luce ardente si riflette sul volto del
poeta innamorato:
E qual nel suo venir l'alba colora
Di purpureo splendor l'aria smarrita, Tal la mia faccia, ancor che scolorita
L'avesse il verno, rossa apparve fora.
E 'n quella guisa che T vermiglio suole Cambiarsi in rancio, quand'Apollo e giunto, Muto poi vista a l'apparir del Sole (3):
dove un sentimento non mentito tende gia a trasformare Y esteriore con
trappunto coloristico in interiore contrasto, fra la serenita della donna che incede e il poeta che l'attende col cuore in tumulto. E penetrato da
questo sentimento, riverbero quasi della sua stessa luce riflessa dal vol to e dal cuore del poeta, il ?sole? depone ormai i suoi fittizi attributi
astrali, per divenire, sempre piu umanamente, luce dei begli occhi e ca
lore di carne:
Su l'ampia fronte il crespo oro lucente
Sparso ondeggiava, e de' begli occhi il raggio Al terreno adducea fiorito maggio E iuglio a i cori oitra misura ardente.
Nel bianco seno Amor vezzosamente
Scherzava,^e non ardia di fargli oltraggio, E l'aura del parlar cortese e saggio Fra le rose spirar s'udia sovente.
Io, che forma celeste in terra scorsi, Rinchiusi i lumi, e dissi: Ahi com'e stolto
Sguardo che 'n lei sia d'arrischiarsi ardito.
Ma de l'altro periglio non m'accorsi:
Che mi fu per Torecchie, il cor ferito, E giro i detti ove non giunse il volto (4).
Una fonte e reperibile nel ?canzoniere? del Petrarca per ognuno qua si dei versi che compongono questo sonetto (5): ma e proprio percio
(1) V. ?La terra si coprio d'orrido velo?: Atanagi c. 188 r. (e Rime, II, n. 40).
(2) V. ?I freddi e muti pesci avezzi omai?: Atanagi c. 190 r. (e Rime, II, n. 84, do
ve, fra le altre varianti, il capoverso si legge: ?I freddi e muti pesci usati orhai?).
(3) V. ?Come va innanzi a 1'altro Sol l'Aurora?: Atanagi c. 188 r. (e Rime, II, n. 41).
(4) V. Atanagi c. 187 r. (e, con varianti a cui si accennera, Rime II n. 3).
(5) Sono gia nel ?Canzoniere? del Petrarca, per, dir solo delle reminiscenze piu pre cise: ?Le crespe chiome d'or puro lucente? (v. son. ?Gli occhi di ch'io parlai si calda
This content downloaded from 188.72.126.181 on Sun, 15 Jun 2014 10:34:21 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

56 A. DI PIETRO
piu evidente che una linfa nuova comincia a urgere nei rami dell'annosa
selva petrarchesca. Non peregrino, ne piu, certo, meraviglioso, e il let
terario prodigio dei fiori che sboccianO all'apparire deiramata con le
chiome al vento; ma la sensazione di vampa estiva, che si leva dal
?luglio oltra misura ardente? e investe e fa piu prepotente il rigoglio del
?fiorito maggio?, rivela subito Timpeto di un desiderio autentico, cosi
bruciante quale invano si cercherebbe nei testi del poeta di Valchiusa: e se poi il Tassino quel desiderio conculca, per dar la parte voluta dal
la tradizione al ?parlar cortese e saggio* e alia ?forma celeste? della sua donna, al rispetto ch'essa incute a lui e ad Amore, e pur chiaro che i suoi occhi, mentre nella finzione letteraria si rinchiudono timorosi, ce
dendo al piu spirituale senso dell'udito il compito di ferire il cuore, in
dugiano nella realta piu del dovuto sul ?bianco Seno? di lei, dove un
troppo malizioso amorino ?vezzosamente scherza?, e sulle ?rose? car
nalmente tepide delle sue labbra schiuse.
Puo considerarsi questo sonetto che, al posto d'onore, apre Pesigua antologia tassiana, Y ideal conclusione delFesperienza umana e stilistica
consegnata dal giovanissimo poeta alle rime amorose della raccolta
Atanagi: la calda vena di sensualita che, svelando la natura passionale del suo amore per Lucrezia, timidamente filtra negli altri componimenti, e qua e la zampilla, scorre ormai sempre piu turgida, e sempre piu im
petuosa preme contro i vecchi argini della tradizione petrarchesca. Que gli argini resistono validamente ancora; ma il processo di erosione si e
iniziato, e si sviluppera ormai ininterrotto. I pochi sonetti d'amore con tenuti nella raccolta deirAtanagi ne mostrano appena le prime tracce;
ma ben piu profonde esse gia ricompaiono nelle piu numerose rime tas siane della successiva raccolta.
Entro termini di tempo piu ampi di quelli assegnati ai versi della raccolta Atanagi, si dispongono le liriche scelte dal Tassino per il flori
legio degli Eterei; e portano i segni percio di un suo piu lungo cam mino: un cammino che dai sonetti di quella prima raccolta appunto prende le mosse, per spingersi ben oltre la pubblicazione del Rinaldo. Curata personalmente dal poeta nella primavera del 1566 (1), questa sua seconda e piu folta antologia contiene infatti quarantadue componimenti
? di cui sei gia precedentemente pubblicati (2) ?, che vanno dal periodo
mente?); ?riV begli occhi i rai? (v. son. ?Quando '1 pianeta che distingue l'ore?); ?l'an
gelico seno? (v. canz. ?Chiare, fresche e dolci acque?) e ?'lbel giovenil petto? (v. canz. ? Si e debile il filo a cui s'attene?); ?L'aura soave che dal chiaro viso Move col suon
de le perole accorte? (v. son. ?Lasso! quante fiate Amor m'assale ?); V ?angelica forma ?
(v. son. ?Erano i capei d'oro a l'aura sparsi?).
(1) V. Le lettere di T. T. a cuia di C. Guasti, Firenze, 1853-1855, vol. I, p. 15.
(2) Quattro nella raccolta Atanagi (?Su l'ampia fionle il ciespo oro luccnfe*, ?Re
This content downloaded from 188.72.126.181 on Sun, 15 Jun 2014 10:34:21 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

NOVIZIATO DEL TASSO 57
urbinate (1557-1559) ai primi mesi traseorsi dal Tasso a Ferrara quale
cortigiano di Luigi d'Este (1565-1566). La latitudine di questi limiti cro
nologici riguarda perd soprattutto i non molti componimenti encomiastici e d'occasione (1): in confini di tempo piu ristretti si addensano inveceUe
rime d'amore, il cui termine a quo non pud porsi prima dell'incontro del
poeta con la Bendidio e quello ad quern, eccezion fatta forse solo per
alcune, non sembra debba cadere oltre gli ultimi mesi del 1562, anche se sono molto probabili posteriori interventi sul testo delle prime stesu re. Raccomanda questa ipotesi non solo il fatto che con la fine del 1562, trasferitisi Torquato dallo Studio di Padova a quello di Bologna e Ber
nardo dalla corte di Ferrara a quella di Mantova (2), vennero meno, sino
alia fine del 1565, i frequenti contatti del poeta con Lucrezia da cui
traggono occasione quasi tutte queste rime; ma la raccomandano anche i non pochi riscontri che si possono istituire fra esse e il Rinaldo, e, ancor piu, 1'evident e coerenza con cui in esse si sviluppa quel processo di dissoluzione e di assimilazione del petrarchismo di cui si sono avver
titi i primi segni nei sonetti della raccolta Atanagi. Quale che sia Tentita dei successivi rimaneggiamenti (3), non e tale
infatti, pensiamo, da incidere profondamente sulla sostanza dei testi, se
il discorso iniziato a proposito dei versi contenuti nella raccolta Atanagi, trova allineati nelle liriche d'amore della silloge degli Eterei tutti gli
appigli per procedere senza deviaziohi e senza fratture: cosi da autoriz zarci a supporre che la composizione dei sonetti inseriti nella piu antica raccolta rimonti, come si e gia accennato, ai primi mesi deirinnamora mento del poeta per la Bendidio (4); mentre quella delle rime della piu recente silloge sia da porre per alcune, grosso modo, nello stesso pe riodo; per altre, le piu numerose, nei mesi immediatamente seguenti (5);
de gli altri, superbo, altero fiume?, ?I freddi e muti pesci avezzi omai?, ?In questi colli, in qucste istesse rive?), e due (?Chi '1 pelago d'amor a solcar viene?, ?Come fra T gelo d'onesta s'accende?) nella miscellanea di versi di vari autori premessa al dialogo U in
namoraio di Brunoro Zampeschi, pubblicato a Bologna, ?per Giovanni Rossi?, nei 1565.
(1) Sono otto, di cui il piu antico e il sonetto ?In questi colli, in queste istesse rive?, e i piu recenti il sonetto ?Ahi, ben e reo destin che 'nvidia e toglie? e la canzone ?Men
tre ch'a venerar movon le genti?, scritti a Ferrara in onore di Eleonora d'Este.
(2) V. Solerti, op. cit.f I, pp. 62-64.
(3) Rimaneggiamenti tanto probabili quanto irrilevanti in verita, se vanno tutti misurati
col metro delle rare e marginali correzioni apportate ai sei sonetti ripubblicati, a distanza
di qualche anno dalla prima edizione, nella raccolta degli Eterei, di cui a suo tempo diremo.
(4) I mesi che vanno cioe, approssimativamente, dal settembre 1561 al carnevale del
1562, quando il Tassino si reca, sembra, a Ferrara e vi ritrova Lucrezia,
(5) I rimanenti mesi del 1562, molti dei quali, dall'inizio delle vacanze estive alia sua partenza per Bologna, avvenuta nei novembre, il Tassino trascorse ancora a Ferrara, do
ve Lucrezia, ormai Contessa Machiavelli, sempre piu si affermava nella vita di corte.
This content downloaded from 188.72.126.181 on Sun, 15 Jun 2014 10:34:21 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

58 A. DI PIETRO
per altre poche infine, forse, anche piu tardi, quando cioe, come vedre
mo, il Tassino incontro ancora, dopo un intervallo di anni, Lucrezia (1). Distinzione cronologica questa che non e documentabile con precisi dati
biografici, ne pretende di essere in alcim modo categorica; ma che ci
sembra aderire tuttavia, con sufficiente approssimazione, alle successive
fasi del travaglio stilistico del Tasso, quale e possibile individuarlo, nel
le sue linee essenziali, in queste sue liriche giovanili. Degli stessi impersonali petrarchismi osservati nei sonetti della rac
colta Atanagi sono intessute ancora molte delle nuove rime dell'antolo
gia degli Eterei (2); e, come in quei sonetti, anche in queste rime fra i
triti petrarchismi si isolano note di piu viva sensualita, o anche, sempli cemente (che e poi lo stesso) di piu acceso colore, che denunziano ancora una volta il dissidio ormai aperto nell'anima del poeta fra il suo impegno di fedelta allo spiritualismo del Petrarca, ingenuamente assorbito nella sua prima adolescenza, e la nuova impetuosa volonta di godere, che prorompe dal tumulto del suo giovane sangue ed e con
fortata dairaltissimo esempio dei classici riletti con piu liberi occhi nel
Tedonistico clima padovano. Ne si distinguono queste rime da quei sonetti, di cui appunto sembrano coeve o di poco solo posteriori, se non per la maggior varieta dei temi che il Tassino attinge al consueto
repertorio petrarchesco e per il piu forte accento con cui dice, talvolta, la sua passione. Come nel sonetto che apre Tantologia tassiana conte nuta nelle raccolta degli Eterei, dove l'amore, gia fiamma ? oltra misura ardente? (3), divampa incontenibile e si allarga in inceridio divoratore:
Si mi sforzava il lusinghiero Amorc
Che s'avea ne' begli occhi albergo eletto:
(1) Ancora a Ferrara, dove fu di passaggio nei novembre del 1564 e si fermo defini
tivamente nell'ottobre del 1565.
(2) Pensiamo soprattutto ai sonetti: ?Avean gli atti leggiadri e'1 vago aspetto?, ?Nin
fa onde lieto e di Diana il coro?, ?Fuggite egre mie cure, aspri martiri?, ?Erbe felici
che gia in sorte aveste?, ?Chi di non pura fiamma acceso hail core?, ?Chi chiuder bra
ma ai pensier vili il core*, ?Non fia mai che T bel viso in me non reste?, ?Tu vedi amor, come col di se 'n vola?, ?Giacea la mia virtu vinta esmarrita?. Leggili nell'edizione cri
tica che dei versi tassiani contenuti nelle Rime de gli Academici Eterei (ed. cit., cc.
61r.-74v.) ha dato il Caretti negli Sfudi su/le rime del T. (ed. cit., pp. 151-193), in cui sono contrassegnati dai nn. I, III, IV, XII, XVI, XX, XXI, XXIII, XXIV. Nella stessa edizio ne i tre sonetti amorosi gia pubblicati nella raccolta dell'Atanagi hanno i nn. II, X, XI, mentre l'unico encomiastico ripubblicato di quella raccolta e i due premessi al dialogo dello
Zampeschi, anch'essi encomiastici, hanno, rispettivamente, i nn. XXXV, XXXVI, XXXVII.
Avvertiamo che, riportando dall'edizione del Caretti renderemo maiuscole le iniziali
dei singoli versi, per uniformita con le altre citazioni.
(3) Ricorda il citato sonetto ?Su V ampia fronte il crespo oro lucente?, pubblicato nella raccolta Atanagi e ristampato nell'antologia degli Eterei (v. ed. cit., n II).
This content downloaded from 188.72.126.181 on Sun, 15 Jun 2014 10:34:21 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

NOVIZIATO DEL TASSO 59
Quarto" ecco novo canto il cor pefcosse, E spiro nel suo foco; e 'n lui piu ardenti
Rcnde le fiamme da' bci lumi accesi.
Ne crescer si, ne sfavillar commossc
Vidi mai faci, a lo spirar de' venti,
Come il mio incendio allor forza riprese (1).
Un incendio a cui non vale piu sotirarsi, chiudendo gli occhi e gli orec
chi ?a l'apparir del Sole? (2), perclie si e appreso ormai al cuore del
poeta, che lo alimenta di se e vi si consuma, ?dolcezze soffrendo ama re ed acre ? (3). Ed e questo crescere ed approfondirsi della passione che
rifondendo, o respingendo via via ai margini, in una sempre piu corag
giosa ricerca di una espressione interamente a se adeguata, gli astratti
schemi della tradizione, da alle successive liriche amorose del Tassino,
pur inscritte nella nobilta della forma petrarchesca, una concretezza nuo
va. Una concretezza che non si rivela solo in una piu schietta confes
sione da parte del poeta dei suoi sentimenti verso la donna amata, ma
anche, e forse soprattutto, neHMmmagine della donna stessa, che, causa
prima di quei sentimenti, da oggetto irraggiungibile d'amore si trasforma via via in soggetto attivo: in termine indispensabile e complementare d'un sempre piu drammatico rapporto amoroso. II ?sole?, che, chiuso
inizialmente nella sua luce astrale, senza volerlo ?avvien che ' cor di
strugga e arda?, ? cosi come, inconscio fenomeno di natura, ?A1 terre
no adducea fiorito maggio? ?
(4), dopo aver fatto intravedere sotto le
spoglie della metafora una sua sia pur sovrumana realta femminile, ormai ?Di sua divinita parte si spoglia? (5), per inserirsi sempre piu vivacemen te nella dialettica della passione che ha generata: e a mano a mano che, declinando la sua ?divinita?, cresce la sua umana presenza, cresce in
sieme la verita delle emozioni che essa ispira al poeta e acquista una
piu realistica consistenza Tambiente stesso in cui si svolge Talterna vi cenda d' amore. Dai ?lumi? dell' amata non piu infatti, complice Amore, escono iperboliche fiamme incendiarie; ma ora, rincuorante, ?'l lampeg giar del riso umile e piano? (6), ora, raggelanti, sguardi ? turbati e scar
(1) V. Rime degli Eterei, ed. cit. n. 1.
(2) V. il sonetto citato, dall'edizione Atanagi, ?Come va innanzi a 1'altro Sol 1'Aurora*.
(3) V. il sonetto ?Chi chiuder brama ai pensier vili il core?, in Rime degli Eterei, ed. cit., n. XX.
(4) Vedi i sonetti citati, della raccolta Atanagi, ?Fulvio, qui posa il mio bel Sole allo ra? e ?Su l'ampia fronte il crespo oro lucente?.
(5) V. il son. ?Veggio, quando tal vista Amor m'impetra? in Rime degli Eterei, ed.
cit., n. IV.
(6) V. il son. ?Amor se fia giarriai che dolce i' tocchi?, ibidem, n. VI; e nota come quel vivace e tenero ?lampeggiar del riso umile e piano? nasca dalla felice contemina
zione del ?dolce riso umile e piano? e dal ?lempeggiar de 1'angelico riso? di Laura
This content downloaded from 188.72.126.181 on Sun, 15 Jun 2014 10:34:21 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

60 A. DI PIETRO
si? (1), ora sorrisi infidi o crudeli: e mentre il poeta, abbandonato V e
statico contegno dell'amante cortese, si protende ansioso a leggere in
quei troppo mutevoli occhi il suo destino, e spera e si tormenta e trema e impreca, non piu si schiudono intorno corolle di fiori, ma si spalanca no le sale, lucide d' ori e cristalli, dei salotti cinquecenteschi,
Ove tra care danze in bel soggiorno Si traean le notturne e placid'ore (2),
o s'aprono piu segrete camere, dove la donna con compiaciuta civetteria
affina allo specchio ?le dolci arme? della sua conturbante bellezza (3):
Ella da' pregi suoi tanti e diversi
Non torcea '1 guardo, di tal vista pago,
Gli occhi mirando e '1 dolce avorio e vago
Del seno, e i capei d'or lucidi e tersi.
E parea fra se dir: ?Ben veggio aperta L'alta mia gloria, e di che duri strali
Questa bellezza mia 1'alme saette?.
Cosi pur, cio ch'un gioco anzi credette,
Mirando l'armi sue si fe poi certa
Quai piaghe abbia il mio core aspre e mortali (4)
Questa nuova concretezza fa decadere certo l'amore dagli spirituali cieli a cui l'aveva sollevato il Petrarca (e da cui Than gia tratto del
resto, obbedienti al piu realistico sentire del tempo, i suoi tardi disce
poli bembisti), ma gli da in compenso, con l'impeto di una piu cocente
passione, una piu varia gamma di modulazioni. Una gamma che va dal
Tammirazione al disprezzo, dal sospiroso vagheggiamento all'esasperato scatto sensuale, dalla gratitudine confidente al sospetto amaro, dalle
promesse di fedelta eterna ai fieri propositi di vendetta dell'orgoglio ferito (5); e conosce anche il dolore delKabbandono, che piu bella fa
nell'accorata fantasia Timmagine del bene perduto:
Ch'io scorgo, in riva al Po, Letizia e Pace
Scherzar con Imeneo, che 'n chiaro suono
(v. nel ?Canzoniere? petrarchesco i sonetti: ?Ma poi che '1 dolce riso umile e piano? e ?Gli occhi di ch'io parlai si caldamente).
(1) V. il son. ?T vidi un tempo di pietoso affetto?, ibidem, n. XXV. (2) Ibidem, son. n. VII. (3) V. il son. ?Ai servigi d'Amor ministro eletto?, ibidem n. VIII.
(4) V. il son. ?Chiaro cristallo a la mi a donna offersi?, ibidem, n. IX.
(5) Vedi, nella solita edizione delle Rime degli Eterei, oltre ai sonetti ultimamente citati (nn. V, VI, VII, VIII, IX, XXV), i sonetti: ?Aura, ch'or quinci intorno scherzi e vo
le? (XV), ? Vedr6 da gli anni in mia vendetta ancora? (XVII), ?Quando avran queste luci e queste chiome? (XVIII), ?Quando vedrd nel verno il crine sparso? (XIX), ?M'apretalor madonna il suo celeste? (XXII), ? Qualor pietosa i miei lamenti accoglie? (XXVI).
This content downloaded from 188.72.126.181 on Sun, 15 Jun 2014 10:34:21 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

NOVIZIATO DEL TASSO 61
Chiama la turba ai suoi diletti intesa.
Licte danze vegg'io, che per me sono
Funebri pompe, ed un'istessa face
Ne 1'altrui nozze e nel mio rogo accesa;
E, quasi Aurora in oriente ascesa,
Donna apparir, che vergognosa in atto
I rai de' suoi begli occhi a se raccoglia, E ch'altri un bacio toglia,
Pegno gentil, dal suo bel viso intatto,
E i primi fior ne coglia (1);
e non ignora il tarlo ossessionante della gelosia:
Tu ch'a quei fiori, Amor, d'intorno voli,
Deh, come puoi soffrir ch'altri delibi Umor si dolce, e T tuo nettar finvoli?
Ohime, che '1 mio pensier cio che piu duole
A Talma inferma or di ritrar fa prova
E piu s'interna ognor ne le sue pene.
Ecco che la mia donna, in cui sol trova
Sostegno il core, or, come vite suole
Che per se stessa caggia, altrui s'attiene;
Qual edera negletta or la mia spene
Giacer vedrassi, s'egli pur non lice
Che la sostegna chi ad altrui s'abbraccia (2).
Questa nuova ricchezza di modulazioni del tema d'amore (3) nasce
evidentemente dalla maggiore varieta degli atteggiamenti della donna
amata, che, strappati i suoi cartacei travestimenti di madonna di ninfa o
di dea, si mostra alfine in tutta la sua vivace realta di dama del Cin
quecento che danza e si specchia e ama o gioca airamore. E discesa
senza schermi (o con schermi sempre piu trasparenti, che non la nascon
dono, ma la ricoprono solo d'unvelo elegante) dalla sua nicchia di rag
(1) V. la canzone ?Amor, tu vedi, e non hai duolo o sdegno? (ibidem, n. XVI, vv. 29-40),
scritta, come e molto verosimile (v. Solerti, op. cit., I, pp. 72-75), in occasione delle
nozze di Lucrezia; ma su cui il Tassino molto probabilmente torno piu tardi, prima di
pubblicarla, se bisogna giudicare dalla sua maturita stilistica.
(2) Vedi la stessa canzone: vv. 43-65 passim. E vedi anche, per il tema della gelosia,
il sonetto ?Amor, colei che verginella amai? (in Rime, ed. cit., II, n. 32), che non pub
blicato dagli Eterei, deve essere tuttavia di questa canzone coevo, se, come tutto lascia
supporre, si riferisce a Lucrezia di recente sposa.
(3) Ricchezza che potrebbe essere anche piu ampiamente documentata, se uno scru
polo filologico non ci facesse ritenere arrischiato, quanto del resto superfluo, citare molte
altre rime, che, non scelte per Tantologia degli Eterei, sembrano tuttavia essere, per mol
ti motivi che sarebbe qui troppo lungo esporre, ad esse contemporanee.
This content downloaded from 188.72.126.181 on Sun, 15 Jun 2014 10:34:21 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

62 A. DI PIETRO
giere polverose e di fiori appassiti, la donna, mentre chiama intorno a
se il mondo della Corte a farle corona, si avvicina sempre piu, arnica o nemica, al poefa fino a costringerlo a trasformare il suo petrarchesco
soliloquio in un dialogo d'amore:
?Vattene? disse ?e se '1 partir t'e grave
Non sia tardo il ritorno; e serba intanto
Parte almen viva del tuo foco interno? (1).
Un dialogo che soltanto talvolta chiaramente si scopre, ma che e in realta
in varia misura implicito in quasi tutti gli ultimi componimenti a cui si
e alluso; dove il poeta, piu che chiudersi in se ad ascoltare il suo cuore, e tutto attento a descrivere gli atti della donna amata e le proprie im
mediate reazioni, e, pur solo e lontano da lei, a lei parla a voce alta, come fosse presente o altri fosse in ascolto: rivelando cosi, insieme con
la sensitiva impulsivita del suo amore, la sua fondamentale vocazione
poetica, che, pur rimanendo, nella sua piu segreta essenza, lirica, tende
verso le forme piu mosse e corpose del romanzo e del dramma. Voca
zione poetica che liberamente si esprime nel Rinaldo, dove appunto il
cammino umano ed artistico del Tassino, documentato in maniera fram
mentaria e parziale dalle rime giovanili, ci si mostra in tutta la sua com
plessita ed ampiezza, e trova (anche se taluna di quelle rime (2) pud
supporsi di un tempo alquanto posteriore alia composizione del roman
zo) la sua piu efficace conclusions
* * *
Come, infatti, nel Gierusalemme si raccoglie intero il mondo spiri tual del Tassino adolescente, si compongono nel Rinaldo le piu varie
esperienze esistenziali e culturali della sua incipiente giovinezza. E che
di questa sua eta il Rinaldo sia una compiuta testimonianza ci da con
ferma il poeta stesso nelle pagine ?a i lettori? (3), dove rapidamente
(1) V. il son. ?Sentiv'io gia correr di mode il gelo?, in Rime degli Eterei, ed. cit., n. XXVII.
(2) Pensiamo soprattutto, per quanto riguarda le liriche amorose, oltre e piu che ai due
madrigali ?Poi che madonna sdegna? e ?Amor 1'alma m'allaccia? (v. Rime degli Eterei, ed. cit., nn. XIII e XIV), ai sonetti ?Arsi gran tempo e del mio foco indegno? (n. XXX), ?Non
piu cresp'oro ed ambra tersa e pura? (n. XXXI), ?Mentre soggetto al tuo spietato regno?
(n. XXXII), che (posti in fondo, quasi a conclusione della storia d'amore adombrata nel bre ve canzoniere tassiano della raccolta degli Eterei) sembrano esprimere, non solo nella fin zione letteraria, sentimenti di un periodo piuttosto lontano da quello dell' innamoramento, e
fanno parte a se per una violenza di accenti che non si trova, per esempio, nel precedente (e gia citato) sonetto ?dello sdegno?: ?Vedro da gli anni in mia vendetta ancora? (n. XVII).
(3) V. Rinaldo, nella citata edizione laterziana a cura del Bonfigli, pp. 3-6.
This content downloaded from 188.72.126.181 on Sun, 15 Jun 2014 10:34:21 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

NOVIZIATO DEL TASSO 63
ricorda la lotta superata contro i consigli della saggezza paterna, per
seguire ?il suo genio, il guale a la poesia sovra ad ogni altra cosa
/'inchina?, e per sommi capi espone i principi a cui si e attenuto nella
composizione di questo suo primo poema, che della validita del suo
?genio? vuol essere appunto, per se e per gli altri, la prova. Caute ed equilibrate, ci dicono subito queste pagine quanto e co
me sia mutato il Tassino dai tempi in cui attendeva, a Venezia, all* epo
pea di Gerusalemme. Non piu trascinato dal generoso e sprovveduto entusiasmo di quei giorni, il giovanissimo studente padovano si preoc
cupa, soprattutto, dopo aver portato a termine con attenta cura la sua
opera, di prepararle accortamente un' accoglienza quanto piu e possibile favorevole nelFambiente letterario in cui vive e da cui si aspetta i primi
playsi e il crisma di poeta. E, l'occhio rivolto a quell'ambiente, mentre con mal celato orgoglio si scusa della sua verdissima eta, ?la quale non ancora ai XIX anni arrival, e sollecita i consensi promettendo di
offrire, se incoraggiato, ?un giorno cosa piu degna?, schiera intorno al suo poema, a difesa, quanti piu nomi pud di uomini autorevoli nella
cultura contemporanea: ?T onoratissimo M. Danese Cattaneo, non meno
ne lo scrivere, che ne lo scolpire eccellente?, e ?M. Cesare Pavesi,
gentiluomo e ne la poesia e ne le piu gravi lettere di filosofia degno di molta lode?, che primi lo incoraggiarono a comporlo; ?i clarissimi
signor Molino e Veniero, il valor de' quali supera di gran lunga la gran dissima fama?, che lo esortarono poi ?caldamente a darlo fuori?; e in
fine ? P eloquentissimo Sigonio?, ?il dottissimo signor Pigna? e lo ?Spe roni, il quale tutte le arti e le scienze interamente possede?, dei cui
insegnamenti fece tesoro nel suo lavoro. E dietro i nomi dei suoi mae
stri e amici illustri, a fugare tutte le possibili ?arme de la maldicenza
altrui?, fa piu volte comparire la grande ombra di colui che torna ad essere ormai, specie a Padova, ?il maestro di color che sanno?: Aristotele.
Sui precetti deiraristotelismo padovano si fondano essenzialmente
infatti queste pagine; anche se il Tassino mostra di voler giungere piut tosto, con indipendenza di giudizio, ad una conciliazione tra il fortuna
tissimo esempio offerto dal Furioso e le solenni leggi della Poetica (?io desidererei che le mie cose ne da* severi filosofi seguaci d'Aristotele...
ne da i troppo affezionati de l'Ariosto fossero giudicate?): perche e
chiaro che il suo ambizioso tentativo di mediazione e solo il primo pas so di una strada che, nella ricerca di meno consueti orizzonti, tende a
dilungarsi sempre piu, sotto lo scudo dei canoni aristotelici, dalla divul
gata tradizione ariostesca. Mentre infatti quanto ha operato secondo i
dettami della Poetica e da lui messo in evidenza con compiacimento, come una novita degna di attenzione, quanto ha derivato dair esemplare ariostesco e presentato come una concessione necessaria ?a quel che
This content downloaded from 188.72.126.181 on Sun, 15 Jun 2014 10:34:21 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

64 A. DI PIETRO
richieggiono i costumi d'oggidi?: ?Ne credo che vi sara grave che io
discostatomi alquanto da la via de' moderni, a quei migliori antichi piu tosto mi sia voluto accostare: che non pero mi vedrete astretto a le piu severe leggi d' Aristotele, le quali spesso hanno reso a voi poco grati
que' poemi che per altro gratissimi vi sarebbono stati?. E (per tralascia re i problemi marginali e appena toccati) e evidente che nelle due que stioni trattate con maggiore impegno il Tassino opta per Aristotele. Nella
prima, la piu importante e la piu dibattuta, quella di una scelta fra l'unita
d'azione aristotelica e la varieta ariostesca, asserisce di essersi affaticato, ? ne l'ordir il suo poema?, ?in far si che la favola fosse una, se non
strettamente, almeno largamente considerata ? : dove quelValmeno dice da
solo, abbastanza chiaramente, come la scelta del poeta sia a favore del
Taristotelica ?favola una?, e soltanto all'altrui gusto sia dovuta la con
temporanea e opposta fatica da lui durata per fare in modo che alia
favola non mancassero anche ?alcune parti? che ?possano parere ozio se?. Scelta piu energicamente sottolineata quando, affrontando appunto la seconda questione della convenienza o meno di usare ??e' principi dei canti quelle moralita, e quei proemi ch'usa sempre rAriosto?, egli
nega, per tutti, 1'opportunity di tale uso, perche contrario al concetto
aristotelico della poesia intesa come imitazione, e la nega in particolar modo per se, perche, essendo quelle ?moralita? e quei proemi soltanto
fragili suture d'un discorso continuamente interrotto, non occorrono af
fatto a lui che, pur concedendo la sua parte alia varieta degli episodi, Tha disciplinata e ridotta ad unita raccogliendola tutta intorno ad un
unico eroe: ?io che tratto d'un sol cavaliero ristringendo (per quanto i presenti tempi comportano) tutti i suoi fatti in un'azione, e con perpe tuo e ininterrotto filo tesso il mio poema, non so per qual cagione cio
mi dovessi fare?.
Lo stesso empirico compromesso fra la Poetica e il Furioso propo sto dal Tassino, mediante la non molto originale soluzione dell'eroe
unico (1), e, del resto, nonche autorizzato, sollecitato dalle premesse deiraristotelismo padovano: la conciliazione e da lui tentata infatti solo
in nome del maggior ?diletto? che da essa pud derivare ai lettori: e
(1) La soluzione del protagonista unico era gia stata sperimentata, anni addietro, da
Luigi Alamanni nel Girone il Cortese e da G. B. Giraldi Cinzio ne L'Ercole; e su quel
la via si era anche incamminato, con piu stretta osservanza della dottrina aristotelica,
Bernardo, nella prima redazione dell' Amadigi, per tornare sui suoi passi poi, non ancora
compiuta 1'opera, spaventato dalla freddezza con cui furono accolti a corte i primi canti.
E soprattutto l'abbandonato tentativo paterno voile con ogni probability Torquato ripren
dere, per portarlo a termine con maggiore fortuna, piegandolo piu duttilmente al gusto
corrente: e V Amadigi infatti, anche cosi come lo leggiamo nella sua redazione definitiva,
senza alcun dubbio, la fonte principale del Rina/do.
This content downloaded from 188.72.126.181 on Sun, 15 Jun 2014 10:34:21 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

NOVlZIATO DEL TASSO 65
una logica conscguenza cioe deHMnterpretazione padovana della igSovig aristotelica, che assegnando all'arte come fine ultimo appunto il ?dilet
to?, non pud non ridurre ogni altro fine a mezzo, da usare con Tacco modante duttilita di tutti i mezzi. Ed e il ?diletto ? in realta la vera ed
unica preoccupazione del Tassino: non per un'estrinseca adesione ai
precetti appresi nello Studio o nei circoli letterari di Padova, ma perche
quei precetti sono venuti incontro opportuni alia sua giovinezza avida di
gioia e di gloria, ed egli al ? diletto? dei lettori soprattutto aspira perche sa che da esso gli potra venire il maggior numero di consensi da parte del pubblico indiscriminato e la piu ampia soddisfazione di quell'arden te ? desiderio di fars/ conoscere? che lo ha spinto a scrivere senza in
dugi il suo poema. Desiderio di mondano successo che, nascosto dietro
ogni rigo di queste pagine introduttive, e il segno sotto cui nasce e si
sviluppa appunto il Rinaldo, che proprio percio ci immerge, fin dai pri mi versi, in un'atmosfera tanto diversa da quella in cui germina e ma
tura Fincompiuto libro primo del Gierusalemme.
Canto i felici affanni e i primi ardori Che giovinetto ancor soffri Rinaldo, E come il trasse in perigiiosi errori
Desir di gloria ed amoroso caldo, Allor che, vinti dal gran Carlo, i Mori Mostraro il cor piu che le forze saldo; E Troiano, Agolante e '1 fiero Almonte
Restar pugnando uccisi in Aspramonte (1).
Ai temi della guerra e della vittoria del Gierusalemme succedono i
temi del ?desir di gloria* e dell' ?amoroso caldo?. Temi non nuovi, certo, nella poesia cavalleresca, e ricorrenti con particolare insistenza nel pa terno Amadigi (2). Nuovo e tuttavia l'atteggiamento del Tassino: che non e piu il cantore di gesta che evoca con cuore devoto ?L'armi pietose... e Talta impresa? di un mitico esercito avanzante, splendido d'insegne
(1) E la prima stanza del Rinaldo, che contiene la protasi: vedila nella citata edizione
del Bonfigli, a cui sempre ci riferiremo, allontanandocene solo per le maiuscole iniziali
dei versi e alcuni segni d'accentuazione (in omaggio alle solite ragioni di uniformita con
le altre citazioni), e talvolta anche per la punteggiatura e per qualche evidente errore.
(2) In cui in primo piano si accampano appunto ?L'eccelse imprese e gli amorosi
affanni Del principe Amadigi* (I, 1), che, come Rinaldo, alia gloria aspira per esser de
gno della sua donna:
Amadigi di Francia a tutti noto, Che la bella Oriana ebbe in sua sposa,
ricordato dal Tassino proprio nel primo canto del Rinaldo (st. 40), quasi a stabilire un'ideal
parentela fra il suo eroe e quello di Bernardo, ed a sottolineare subito la derivazione del
suo poema da quello paterno.
Aevum - Anno XXVII - 5
This content downloaded from 188.72.126.181 on Sun, 15 Jun 2014 10:34:21 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

66 A. DI PIETRO
e sonoro di trombe, alia conquista della citta santa, e non e neppure il
romanziere che narra, per il distaccato gusto del narrare, le mirabili
avventure d'un leggendario cavaliere; ma e il giovane poeta orgoglioso che, sempre presente a se stesso, al suo eroe prediletto si accosta con animo fraterno, partecipe dei suoi ?affanni? e dei suoi ?ardori?; che il suo eroe anzi, desideroso com'e soprattutto di parlare di se,
plasma quanto piu puo a sua immagine e somiglianza, per manifestare
piu liberamente, dietro il suo schermo, le pene reali che senza tregua
gli arreca la sua sete di gloria e d'amore (1). E cosi vicino alia crea
tura della sua fantasia egli si sente, che, scambiate con disinvoltura le
parti, egli stesso si atteggia eroicamente, mentre si mostra che ?audace
s'accinge ad alte imprese?, e (affatto immemore ormai della ?santa lu ce? di Dio e colmo solo di un'incrollabile fede nel suo valore) esorta
la sua Musa a uscire deir ombra delle ?selve? per seguirlo, arnica qua si e scudiera fedele, verso piu illustri arene (2).
Musa, che 'n rozzo stil meco sovente
Umil cantasti le mie fiamme accese,
Si che, stando le selve al suono intente,
Eco a ridir l'amato nome apprese; Or che ad opra maggior movo la mente
Ed audace m'accingo ad alte imprese, Ver* me cotanto il tuo favor s'accresca
Ch'a l'addoppiato peso egual riesca (I, 2).
E pur mentre si curva nell'interessato inchino al ?gran Luigi Estense? (3), non abbandona il suo contegno eroico: che, sotto la compunta umilta
(1) Anchc nel Gierusalemme, al ?bel Clotareo?, ?Giovinetto Regal d'invitto core?, il Tassino si e avvicinato con un moto spontaneo di simpatia fraterna; ma solo a lui, e
per un attimo solo, e con un'ombra di ammirata invidia che conserva la distanza fra il
poeta e la sua creatura. E se e tuttavia una distanza che tende evidentemente a raccor
ciarsi, e proprio perche, non per caso, Clotareo compare nelle ultime ottave del frammento:
quando cioe, scaricato nella descrizione della marcia dei crociati il suo primo entusiasmo, l'anima del Tassino si ripiega sempre piu su se stessa e comincia a mutarsi.
Per i confronti possibili fra il testo del Rinaldo e quello del Gierusalemme, vedi il nostro studio // "Gierusalemme? nella storia della poesia tassiana (Milano, 1951); ed
in particolare le pp. 1-10, 22-25, 30, 34-35, 38-39, 45, 52-54, 60-61, 67, 70, 89, 95-97,
129, 131, 133, 136-138, 147, 149, 152, 153, 159-160. (2) Non diversamente Rinaldo, che ?audace aspira A degne imprese, ad opre altere
e nove?, sprona il cavallo fuor ?de la selvetta > e va incontro al suo destine
(3) La dedica del Rinaldo al Cardinal Luigi d'Este fu, con tutta probability, suggerita al Tassino dal padre, che, lasciata l'Accademia Veneziana e trasferitosi nel gennaio del 1562 a Ferrara, al servizio appunto di quel Cardinale, pensava, verosimilmente, di conso
lidare i suoi vincoli di servitu col nuovo Signore e di procurare insieme un utile protetto re, per l'avvenire, a Torquato (cfr. Solerti, op. cit.f I. p. 58).
This content downloaded from 188.72.126.181 on Sun, 15 Jun 2014 10:34:21 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

NOVlZIATO DEL TASSO 61
del cortigiano che invoca al suo ?cantar grato favore? (1,4), mal sice la la compiaciuta fierezza del poeta, ansioso e insieme sicuro di poter,
quanto prima, ?cangiar la lira in tromba e 'n maggior carme? (I, 5) dare la piena misura delle sue virtu.
II prepotente bisogno di valere e di apparire che presiede alia na
scita del Rinaldo da quindi al romanzo, fin dalle prime ottave, un accen
to autobiografico che, ignoto al corale canto epico del Gierusalemme come ai precedenti poemi cavallereschi, sempre piu colora di se sia il tema del ?desir di gloria?, in cui quel bisogno piu scopertamente si
esprime, sia quello deir ?amoroso caldo?, in cui soprattutto confluiscono
le esperienze umane e stilistiche episodicamente consegnate dal Tassino
alle rime per la Bendidio. Solo in astratto infatti questi due temi si
possono nel romanzo distinguere: non tanto perche fra loro inestricabil
mente si stringono a intessere il canovaccio della ?favola? (Rinaldo, ?Ch,ha ne la gloria posto i sommi pregi? (I, 12), ha appena cominciato a inseguirla che, come Torquato, incontra la donna e sente che essa e
il trofeo piu bello a coronare i suoi trionfi, e ne fa cosi la causa e la
meta d'ogni suo atto glorioso), quanto perche un'osmosi ininterrotta
sempre piu li mescola dal fondo, e reciprocamente li feconda e li indi
vidua. E la passione per la donna soprattutto, infatti, a trasformare il
primitivo ?desir di gloria ? (quello di Torquato che poneva mano al Gie
rusalemme, come quello di Rinaldo che s' allontana ancora ignaro dalla
casa materna), la confusa aspirazione cioe deiradolescente verso gli in
definiti cieli di un* apoteosi sovrumana, nella cosciente ambizione del
giovane che chiede per se piu concrete e prossime ricompense, perche e proprio la donna, col ?sole? della sua bellezza, a rendere scialbi
quei cieli remoti e a illuminare di una luce tentatrice i terrestri pomi dell'albero della vita che intorno a lei intrecciano i loro festoni; ed e, a sua volta, ? di gloria e d'onor Taccesa cura? (1,38) che, attribuendo
anche e soprattutto alia donna il valore di un premio solenne, e per meando cosi Telementare passione d' amore con un sentimento di om
broso orgoglio, le da una dignita e una tensione inconsuete. E dal vi
cendevole compenetrarsi dei sentimenti della gloria e dell' amore nel cuore
del poeta, come in quello di Rinaldo e degli altri minori personaggi del
romanzo, e determinata, sulla pagina, la graduate fusione dei modi della
narrativa epico-cavalleresca con quelli della lirica amorosa petrarchesca,
che, sciogliendo le forme cristallizzate dell'eterogeneo materiale accu
mulato dalla tradizione (1), permette al Tassino di riplasmarlo con sem
(1) Per le fonti letterarie a cui il Tassino deliberatamente o incosciamente attinge nel
Rinaldo, vedi soprattutto: E. PROTO, Sul u Rinaldo ? di T. T? Napoli, Tocco, 1895; di cui ci sembra opportuno riportare qui le conclusioni essenziali, neH'insieme tuttora valide: nel Rinal
This content downloaded from 188.72.126.181 on Sun, 15 Jun 2014 10:34:21 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

68 A. DI PIETRO
pre maggiore liberta, fino a conquistare alia sua poesia rimmagine nuo
va del cavaliere e della dama cinquecenteschi, sul vivo sfondo della
corte rinascimentale, in cui egli pud alfine proiettare se stesso e la sua
donna e il suo mondo. Travagliata conquista, in cui e tutta la storia del
Rinaldo. Una storia che, svolgendosi parallelamente a quella delle con
temporanee rime per Lucrezia, ci ripresenta di quell'itinerario in esse
rintracciato, aperti su piu vasti orizzonti, 1' abbrivo, le tappe e gli approdi. Scritto velocemente, come si e detto, ?ne lo spazio di dieci mesi?
o poco piu, il Rinaldo, nei suoi dodici canti (composti verosimilmente uno dopo l'altro, senza il tempo di riposati ritorni e di decisive rielabo
razioni), mostra infatti, quasi puntualmente, i segni delle successive fasi
di quel dissidio, fra l'eredita della scuola e l'impeto di una sincera e
percio inedita passione, che abbiamo visto aprirsi e lentamente comporsi in quelle liriche. E tanto piu evidenti li mostra, quanto piu quel dissidio
non smaglia solo, nel romanzo, la sottile trama stilistica della pagina, in cui si disegna appena un profilo femminile, ma incrina la piu corposa
figura dei vari personaggi e insidia, quindi, la coerenza stessa del racconto.
E piu d'ogni altra indicativa, a tal proposito, proprio la figura del pro
tagonista, intorno a cui il Tassino ?con perpetuo e ininterrotto filo tesse
il suo poema?, non tanto per obbedire ai precetti aristotelici sull'unita
d'azione, quanto perl'intimo bisogno di sentirsi ininterottamente riflesso
nel suo eroe. Appare Rinaldo, nella sua prima e felice intuizione, come
l'immagine deli'adolescente che si rode d'invidia neH'impaziente attesa del giorno della sua rivelazione, ossessionato dal pensiero ?ch'ognun l'additi, e sciolga insieme... la lingua in suo disnore? (I, 14), e che al
primo incontro con la donna si sente tutto turbato da ?fiamma amorosa e maraviglia strana ? (I, 56). Ma questa immagine tenta appena di pren der forma, che il ? figliuol d'Amone? schiacciato dalle varie armature di
do dal Tasso ?pochissimo e preso dai grandi poeti greci, e quel poco da Omero e Teocrito;
qualcosa dal romanziere Eliodoro, che forse per allora conobbe in traduzione. Moltissimo,
invece, dai classici latini, che certo conoscea piu dei greci, specialmente da Virgilio, Ovi
dio e Stazio. Dei classici italiani Dante, Petrarca e, per non dir di altri quattrocentisti, il
Poliziano, e in fin i'Ariosto, gli hanno fornita gran parte della forma: e il Poliziano, il
Boiardo e TAriosto, in qualche proporzione, anche episodi e incontri sostanziali per la
tela del poema. Ma quel, che soprattutto Torquato tenne presente, fu il poema del padre,
1'Amadigi... Dei romanzi cavallereschi originali... soprattutto quelli della serie d'Ama
dis... Tutto questo il poeta intesseva sovrapponendo al Rinaldo di Montalbano, che, o
manoscritto, o piuttosto nelle stampe di quel tempo, egli dovette certamente leggere?.
(pp. 273-274). Vedi pero anche: G. Mazzoni, Del Rinaldo, in Opere minori in uersi di
T. Tasso, Bologna, Zanichelli, 1891, vol. I. pp. V-XLI; A. Capasso, Le "fonti,, del Ri
naldo, in Studi sul T. minore, e Commento al " Rinaldo ? di T. T. e // "Tassino,,, pub
blicati tutti a Genova, ed. Dante Alighieri, il primo nel 1940 e gli altri nel 1939; ed infine R. Battaglia, Dalla lingua dell*" Amadigi ? a quel fa della
a Gerusalemme ? in ?Cultura
Neolatina?, n. 1-2, 1941, pp. 94-115.
This content downloaded from 188.72.126.181 on Sun, 15 Jun 2014 10:34:21 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

NOVIZIATO DEL TASSO 69
paladino, di cavaliere arturiano, di guerriero antico, o costretto dai panni dell'amator cortese o neoplatonico di cui l'ostinata memoria del poeta lo ricopre, smarrisce il suo originate valore di poetica metafora del fi
gliuolo di Bernardo, per ridursi a manichino, che assume, con palese fatica, T atteggiamento delle vesti che volta per volta gli sono imposte, quando non perde ogni parvenza umana nelle classicheggianti similitudini natura
listiche che per uso antichissimo quelle vesti adornano. Cosi che, erran
do alia ricerca di avventure famose
Come al marzo errar suol giumenta mossa
Da gli amorosi stimoli ferventi (I, 29),
ora, tutto impeto e ferocia, irrompe fra gli occasionali nemici
Come rapido suol pieno torrente
Che ruinoso da l'Appennin cada,
Tanto piu gonfio girne e violente,
Quanto impedita piu gli vien la strada (IV, 38) (1);
e lancia contro di loro sassi ?d,immenso pondo? (II, 20), in tal ma
niera che
Non gian presso Pozzuol con tal furore
Gravi pietre per Faere intorno errando,
Pietre cui natural impeto fuore
Da l'imo centro al ciel spingea tonando (II, 21);
e, ripetendo con grottesca serieta gli spaventosi gesti omicidi dei cava
lieri degli antichi cantari,
Nel furor primo tre n' abbatte, e sei
N'impiaga, e quattro d'ogni senso priva (IV, 25);
ora, invece, tutto svenevole amore, si effonde in petrarcheschi monologhi, e
(1) II classico paragone del corso d' acqua che tutto travolge, gia usato, e piu oppor
tunamente (riferito com'e alia sua avanzata quasi fisicamente ineluttabile), per l'esercito
crociato, nel Gierusalemme (st. 16, cit. nel primo capitolo), e su cui qui insiste il Tassino,
e destinato nell' Amadigi (XXIX, 33) a Floridante, che, come Rinaldo appunto, Sembra un torrenle, che d'alpestre monte
Di molte onde gonfiato al basso chini; Che cio che trova, o che gli viene a fronte,
Con grande impeto suo svella o mini.
E nell' Amadigi (le citazioni si potrebbero moltiplicare) ha la sua fonte piu vicina la maggior parte degli atti e delle avventure incredibili attribuiti dal Tassino a Rinaldo e agli altri
personaggi del romanzo: sono di preferenza, infatti, i tradizionali elementi leggendari del
F epopea cavalleresca che giungono a lui attraverso il filtro del poema di Bernardo.
This content downloaded from 188.72.126.181 on Sun, 15 Jun 2014 10:34:21 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

70 A. DI PIETRO
... con l'aspre cure e co' sospiri
Accompagna il parlar tremante e basso (II, 3),
e ?Bagna il viso di pianto? (II, 9) e si dispera, tanto che
Sospiri accesi a stuol per I'aria sparsi, Gemiti tratti dal piu interno fuore,
Stridi e querele in lamentevol suono
Di quel ch'ei sente i minor segni sono (V, 6);
quando non si scopre, improvvisamente, amante privo di ritegni, che, ra
pita con la violenza la sua donna,
... in lei gli occhi bramosi gira
Or nel bel volto, or ne l'eburneo petto; E fatto audace e baldanzoso, aspira Di pervenire all'ultimo diletto (IV, 51).
Opposti contegni, suggeriti da opposti esempi, che si sovrappongono
spesso, senza intervalli, nel medesimo episodio: come avviene, in ma
niera particolarmente vistosa, proprio nel primo canto, quando Rinaldo
incontra per la prima volta Clarice e, da giovinetto che ha lasciato ap
pena ?i materni conforti? (I, 20) ed e ?ingombro ancor d'alto stupo re? (I, 55) per Pinattesa rivelazione della bellezza muliebre, si tramuta
in un baleno nel giovane spregiudicato
... che pronto era ed audace
E fortuna nel crin prender sapea (I, 58);
il quale, dopo aver, con galanteria da salotto letterario, rivolto alia don zella improvvisamente apparsa un saluto risonante di virgiliane e stilno
vistiche cadenze, le offre la sua servitu con un ardore cosi clamoroso e impaziente che vanno dispersi insieme il suo garbo mondano e la
cortesia delP antico ?servire ? :
... io son Rinaldo,
Solo di servir voi bramoso e caldo (I, 64).
E il maldestro cavalier servente ha appena finita la sua troppo pressante offerta, che, colmo ?di dolore e di vergogna? (I, 66) per Pumiliante oscurita della sua fama, si trasforma di colpo nel ?gran guerriero ? (I, 82) che con violenza inaudita fa strage di un'intera. schiera di valenti rivali;
per ridiventare poi, ancora intriso del loro sangue, P adolescente che sul calar del sole si accompagna, ?felice? (I, 88), alia fanciulla del cuore
e, trepidante,
This content downloaded from 188.72.126.181 on Sun, 15 Jun 2014 10:34:21 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

NOVIZIATO DEL TASSO 71
... tra via pur talvolta a lei movea
D' amor parole e tacite preghiere (I, 89),
e, troppo inesperto per scoprire sotto I'indifferenza ostentata e i dinieghi di lei la nascente passione, ferito nel suo orgoglio, bruscamente stabi
lisce di partire, deciso a non tornare se non quando potra mostrarsi a
lei coperto di gloria.
Questi atteggiamenti contraddittori, che (cosi simili ancora a quelli dei pochi eroi che in qualche modo agiscono nel Gierusaiemme), eli
dendosi, impediscono alia figufa di Rinaldo di assumere una consistenza
spirituale e perfino fisica, si succedono frequentissimi nei primi otto
canti del poema, dove piu folte si addensano quelle parti che ?possano parere oziose? concesse dal poeta ai ?costumi d' oggidi?: appunto per che, interrompendo esse di continuo lo sviluppo dell'azione principale, impediscono il consolidarsi dei nessi psicologici che la sorreggono e il
maturarsi quindi nel protagonista di una coerente personality. Ma sempre meno numerosi e stridenti appaiono negli ultimi canti, dove il poeta,
pagato largamente il suo tributo al gusto corrente e insieme alia sua
giovanile vanita di esibire tutti i suoi pezzi di bravura (1), stringe le fila
del racconto intorno all'unica vicenda veramente non ?oziosa? del ro
manzo, quella che sola davvero lo interessa perche sola interamente ri
specchia le sue reali esperienze e i suoi sogni piu cari: il trionfale in
gresso di Rinaldo nella vita delle corti, viste ormai non piu, con gli occhi innocenti del fanciullo di Urbino, come accolte solenni di uomini illustri,
ma come il luogo ideale delle ambizioni e dei piaceri, come il mondo
dei potenti che lodano, delle belle donne che s'offrono, delle aristocra
tiche folle che s'aprono al passaggio plaudenti. Quando infatti, neirambiente regale della corte di Floriana, la sim
biosi dei due temi dominanti della gloria e dell'amore raggiunge in
Rinaldo un suo durevole equilibrio, la sua figura si compone alfine, sotto
gli occhi della regina innamorata del suo valore, in armoniche propor zioni di virile bellezza:
Bionda chioma, neri occhi e nere ciglia, Lucidi e vivi quelli, e queste arcate,
Fronte ben larga, adorna a meraviglia D'alterezza viril, di maiestate;
Guancia leggiadra in un bianca e vermiglia, Piume nascenti allor crespe ed aurate,
(1) In cui trova modo, probabilmente, di utilizzare anche i suoi precedent sparsi eser
cizi letterari: come avviene, forse, per la composizione di ispirazione ovidiana sul ?duro caso? di Procri, ricordata dal poeta nel sonetto. ?Quest' umil cetra, ond'io solea talora*, che e presumibile sia stata in parte rifusa nell'episodio, piu d'ogni altro ?ozioso?, di
Clizia, che immotivatamente riempie di se una buona parte del canto settimo.
This content downloaded from 188.72.126.181 on Sun, 15 Jun 2014 10:34:21 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

72 A. DI PIETRO
Naso aquilin, de' regi segno altero,
Traggon tutti in stupor del cavaliero.
Oltre cio, larghe spalle ed ampio petto, Braccia lunghe, snodate e muscolose,
Ventre piano, traverso, a i fianchi stretto,
Gambe diritte ed agili e nerbose, Mobil vivacita, ch' in giovinetto Grazia aggiunge e decoro a l'altre cose,
Grata fierezza, altero portamento, Unite con mirabil tempramento (IX, 16-17).
Proporzioni ricalcate quasi su quelle di Goffredo che siede fra i suoi
duci, nel Gierusalemme (1); ma lo sguardo di Floriana, scorrendo desi
deroso suite membra dell'eroe, lo pervade di una nervosa sensualita, che trasforma la casta e statuaria bellezza del campione della fede nel
T agile venusta del ? cavaliero?, che si esibisce, elegante non meno che
forte, fra dame e baroni. Cosi che la somiglianza compositiva dei due
ritratti da solo risalto alia sostanziale diversita dei due mondi poetici di cui sono Tespressione; e serve insieme a mostrare, quasi simbolica
mente, in un frammento esemplare, come a creare questa diversita sia
soprattutto il tema d'amore, che, inserendo i suoi piu sensitivi fili nel
compatto tessuto eroico del Gierusalemme, ne allenta e indebolisce la
trama, e la rende piu morbida ed elastica.
Una parte della statuaria rigidita di Goffredo rimane tuttavia in que sta immagine di Rinaldo: la ?mobil vivacita? del giovinetto e ancora
impacciata dal laborioso ?tempramento? de
Le grazie si diverse unitamente
Per meraviglia giunte ed adunate (IX, 57):
la passione di Floriana non e ancora tanto partecipata del Tassino (2) da vietargli di indugiarsi troppo a lungo neirambizioso tentativo di pla smare, secondo canoni di oggettiva e astratta bellezza, T ideal modello
deirefebo gagliardo e formoso. Ma quando quella passione divampera
piu alta, investendo insieme i due amanti e il loro poeta, ogni residuo
di letterario mosaico si fondera alia sua fiamma: la bellezza di Rinaldo non sara piu, allora, visione parte a parte vagheggiata da Floriana, ma sensazione che la percuote violenta, quand'egli le si avvicina im
provviso, ?tacito e tremante? (IX, 79) di desiderio. E Rinaldo, divenuto,
(1) Vedi le stanze 49-50, citate nel primo capitolo di questo saggio. (2) Anche perche, forse, troppo impaccia la sua fantasia il ricordo degli innamora
menti, per tanti rispetti analoghi, di Lucilla per Alidoro e di Drusilla per Agramoro, del X Amadigi (v., soprattutto, XVII, 21-44, e LXXV, 43-65).
This content downloaded from 188.72.126.181 on Sun, 15 Jun 2014 10:34:21 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

NOVIZ1ATO DEL TASSO 73
per virtu cTamore, finalmente persona, non avra piu negli episodi sue
cessivi (se non nei momenti piu distratti del racconto) 1'inert e individua lity che gli deriva dal suo corpo e dai troppo definiti lineamenti del suo
volto, ma quella che sul volto gli imprimono, trasfigurandolo, i suoi af fetti diversi e gli affetti di quanti partecipano alia sua umana avventura; e non sara tanto la sua incredibile prestanza fisica a destare ammirazio
ne, quanto il ?grido altero? del suo valore che lo circonda come un'au reola e commuove la folia, allorche egli si presenta al campo di Carlo e sente, e tutti sentono insieme, che
La gloria sovra lui si spazia intanto
Battendo Tali d'or col dolce canto (X, 89);
e lo stesso terrore che egli incute avra per misura, piu che la forza del suo braccio, l'ira sua terribile di amante deluso e di cavaliere offeso,
quando dalla corte di Carlo si allontana e
... col manto al braccio avvolto, con tardi passi c con secura faccia, Verso la porta il pie va ritirando, E tiene ne la destra ignudo il brando (XI, 33).
II cammino che il tema dell'eroe, incarnato in Rinaldo, percorre, dai primi agli ultimi canti del poema, per raggiungere una sua armonica e originale misura, e lo stesso cammino che, necessariamente, percorre il tema complementare deU'eroina; il quale pur incarnandosi nelle due
distinte figure di Clarice e di Floriana, ha una sua unitaria linea di svi
luppo, che, anch'essa, e con analogia certo piu puntuale ed evidente, scorre parallela a quella delle rime per Lucrezia.
Come nelle prime liriche d* amore, infatti, la figura di Lucrezia e
soffocata dalle reminiscenze petrarchesche, e solo talvolta riesce a far
balenare fra gli astratti splendori delle metafore solari un lampo della sua came viva; cosi si affollano intorno a Clarice, nei primi canti del
poema, le immagini muliebri della piu illustre tradizione poetica classica e romanza, che solo a tratti la lasciano intravedere. Appare essa la pri ma volta mentre, ?in selva solitaria e adra? (I, 56), caccia, a cavallo, una polizianesca cerva ?piu che latte bianca? (I, 52), e
Mira il leggiadro altero portamento Rinaldo e 'nsieme il vago abito eletto; E vede il crin parte ondeggiare al vento, E parte in belli aurei nodi avvolto e stretto; E la veste, cui fregia oro ed argento, Sotto la qual traspar l'eburneo petto, Alzata alquanto, discoprir a l'occhio
La gamba e T piede fin presso al ginocchio (I, 54).
This content downloaded from 188.72.126.181 on Sun, 15 Jun 2014 10:34:21 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

74 A. DI PIETRO
Le chiome d'oro di Laura si confondono con quelie di Venere cacciatri ce (1), ma non esiste il volto della ?disposta e vaga giovinetta? (I, 53); che se ha una sua non letteraria realta, Tha solo nel conturbante can
dore deir?cburneo petto? (2) e del ?ginocchio nudo?, su cui si ferma
cupido lo sguardo di Rinaldo. Una realta interamente fisica e troppo embrionale per dare una fisionomia a Clarice, che continua a lungo a
dibattersi fra i disparati esempi a lei suggeriti dalle piu celebrate eroine
che nella vita della poesia l'hanno preceduta. Ed ha appena, infatti,
Al parlar di Rinaldo la donzella D'un oncsto rossor le guancc sparse (I, 61),
che muta il suo turbamento di fanciulla alia prima profferta d'amore, nella frigida crudelta della virago, che, dopo aver incitato il cavaliere or ora conosciuto a battersi contro i suoi devoti accompagnatori, lascia che egli ne faccia scempio, senza avere un moto solo di orrore o di
pieta, neppure per Alcasto, che l'ama, e giace
Ferito in testa d'aspra e mortal piaga Si che il terren di sangue intorno dllaga (I, 78);
delle gravi ferite sofferte dai suoi amici per lei si compiace anzi, tanto
che, mentre
... con immote ciglia Mira il valor del nobil giovinetto, Dal valor nasce in lei la maraviglia, E da la maraviglia indi il diletto: Poscia il diletto che in mirarlo piglia Le accende il cor di dolce ardente affetto; E mentre ammira e loda il cavaliero, Pian piano a nuovo amore apre il sentiero (I, 81):
dove il ?dolce ardente affetto? per Rinaldo e cosi remoto dalla sua
spietata indifferenza, che non riesce rriinimamente a persuadere, nono
stante la pedante analisi della sua genesi fatta dal Tassino col metro
(1) II modello piu prescnte e appunto quello di Venere che va incontro ad Enea, Virginis os habitumque gerens (Aen.,l, 315), e
... umeris de more habilem suspenderat arcum
Venatrix dederatque comam diffundere ventis
Nuda genu nodoque sinus collecta fluentis. (Aen. I, 318-320). Ma anche a Mirinda, nelF Amadigi (LXIII, 4-7), compare, ?all'uscir d'una verde sel vetta?, una donzella, dall'?abito adorno Com'uso un tempo di portar Diana?, che insegue una cerva.
(2) Cosi simile al ?bianco seno? di Lucrezia, con cui ?scherza? Amore, nei sonetto ? Su Tampia fronte il crespo oro lucente?.
This content downloaded from 188.72.126.181 on Sun, 15 Jun 2014 10:34:21 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

NOV1ZIATO DEL TASSO 75
d' un accademico padovano presecentista. Ne sono sufficienti a riscattare
questa prima Clarice i suoi successivi atteggiamenti, piu realistici (1), di ?donzella accorta? (I, 65), che ascolta lusingata le parole d'amore
del valoroso cavaliere,
Ma sempre o non intenderle fingea, O gli dav'ella aspre risposte altere (I, 89),
e che, quand'egli sta per andarsene offeso,
... a restar seco Tinvito cortese
Raddolcendo lo sguardo e la favella (I, 93).
Ne, piu tardi, riesce essa a darsi un coerente e convincente contegno
quando, rapita da Rinaldo, dimostra un' inspspettata fragilita leziosa,
mentre,
Umida i gigli e le vermiglie rose Del volto, e gli occhi bei conversa al piano,
Gli occhi onde in perle accolto il pianto uscia, La giovinetta il cavalier seguia (IV, 55) (2);
e troppo presto, poi, interamente rasserenata dalle parole di lui,
... il su' amador rimira
Soavemente e con pudico affetto (IV, 51).
II tema dell' amoroso ?affetto? di Clarice, due volte interrotto, dalla par tenza di Rinaldo prima e daH'improvviso intervento del mago Malagigi
poi, e ereditato da Floriana; che, esclusivamente creatura d'amore, lo
sviluppa e lo approfondisce, caricandolo di tutta la forza dei suoi gio vani sensi. Una sensualita che, ancora acerba in principio, prorompe irruente e discontinua, creando acute dissonanze tra Floriana, sorella
minore di Didone, che
Trae, gia cenato de la notte Tore
... in parlar vario e giocondo, E non men che Torecchie il lungo amore
(1) Attcggiamenti che non e da escludersi siano il segno di varianti apportate alia
originaria stesura del primo canto, una volta terminato il poema.
(2) II modello da cui palesemente deriya quest'immagine di donna piangente e nel 1' Amadigi:
Ella col capo chino e vergognosa,
Umida i lucidi occhi, e i bianchi gigli Pinta del viso di color di rosa (XXXIV, 16).
This content downloaded from 188.72.126.181 on Sun, 15 Jun 2014 10:34:21 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

76 A. DI PIETRO
Bee che per gli occhi e '1 manda al cor profondo (IX, 31) (1);
e Floriana, smaniosa adolescente, che alia nutrice Elidonia troppo aper tamente confessa:
Madre, tel dird pur, madre, vorrei
Spegner la sete de l'acceso affetto (IX, 68),
e, senza verginali esitazioni, medita poi
Di far il suo desir contento a pieno (IX, 73).
Ma quando i primi e quasi incosci impulsi deiristinto si maturano e si
articolano fino a diventare passione, con l'aiuto appunto dell'esempio sempre presente dell'infelice regina virgiliana, Floriana trova alfine se
stessa: e si mostra in tutta la sua grazia di fanciulla innamorata, mentre
s'adorna allo specchio, con i gesti di Lucrezia Bendidio, e
Poi lieta si contempla a parte a parte,
vagheggiandosi come
... augellin dopo la pioggia al sole
Polirsi i vanni e vagheggiarsi suole (IX, 75) (2);
o appare, non meno di Rinaldo, trasfigurata dalPintensita spasimante del comune desiderio, quando, in una cornice d'erbe d'acque e di fiori, remoti da tutti, inattesamente si incontrano, e ad ambedue
Lampeggia, come '1 sol nel chiaro umore, Ne gli umidi occhi un tremulo splendore (IX, 79) (3)
e
L'un nel volto de l'altro i caldi affetti
E iMnterno voler lesse e comprese (IX, 80).
La passione di Floriana pero, se riesce a fondere le sovrastrutture let
(1) L'esempio e virgiliano: Nec non et vario noctem sermone trahebat
Infelix Dido longumque bibebat amorem (Aen. I, 748-749); ma e cvidentcmente mediato dall' Amadigi, dove Lucilla, guardando Alidoro,
. .. beveva ad ora ad or con gli occhi D'un immenso piacer l'empio veleno (XVII, 44).
(2) Con minore ingenuita Lucrezia ?al candido viso ed al bel petto, Vaga di sua bel ta, gli occhi volgea? (v. il son. cit. ?A i servigi d'Amor ministro eletto?).
(3) E ?'l lampeggiar del riso umile e piano? di Lucrezia (del son. cit. ?Amor, se fia fiiamai che dolce F tocchi?), che acquista una piu viva e molle sensualita sul volto di Floriana e di Rinaldo.
This content downloaded from 188.72.126.181 on Sun, 15 Jun 2014 10:34:21 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

NOVIZIATO DEL TASSO 77
terarie che comprimono la vita poetica deir eroina e di Rinaldo, e inca
pace di trascendere ancora, tutta la calata nel senso, V immcdiato stimolo
fisico per raggiungere la sfera del sentimento e farsi storia. Dopo la
prima ora di volutta, null'altro accade ai due amanti se non che
II Paladino in cosi dolce vita Trasse piu di con la real donzella (IX, 81);
e quando, per ? strana ventura? (IX, 81), come ad Enea Mercurio, appa re a Rinaldo in sogno Clarice ed egli precipitosamente parte, Floriana,
dopo essere rimasia per un poco oppressa da un sincero dolore, tanto
che
Talor si nei pensier giace sepolta Che non vede, non sente, e non ascolta (X, 3),
si disperde di nuovo, e non sa che ripetere, con melodrammatica enfasi, i disperati gesti di Didone abbandonata; per acquietarsi poi repentina
mente, per opera d' incanti (1), fra le braccia della zia Medea, nell'?iso
la del Piacere?, dove
Non piu la punge l'amorosa spina, Non piu '1 perduto bene or la molesta, Ben fiso in mente tien l'avuto danno,
Ma non pero ne pud sentir Taffanno (X, 34).
Solo quando la passione, da Floriana, torna ancora a Clarice, ed e
da lei inserita in una piu vasta trama di relazioni umane, riesce alfine a
superare Y elementare dialettica deir istinto per svilupparsi in un ben piu complesso e scaltro contrappunto psicologico. A Clarice, che non e, co me Floriana, incontrastata signora di una coreografica reggia d'Oriente, ma, come Lucrezia, damigella fra le damigelle in una corte cristiana, non e concesso di esprimere impunemente il suo desiderio, ne di appagarlo liberamente in grembo alia natura, ne le e permesso di gridare il suo
dolore: glielo proibisce, se non una piu vigile coscienza morale, il sor
vegliatissimo costume cortigiano, alle cui rigide leggi essa non puo da
sola sottrarsi, senza avvilirsi agli occhi delle temute rivali e di Rinaldo, e senza quindi umiliare in se stessa il suo piu geloso orgoglio femmini
le. Ma proprio da questo suo sempre desto orgoglio di giovane dama, che in ogni attimo doma in lei l'impulso cieco del sangue, deriva alia
passione di Clarice una molteplicita di reazioni ignote alle ?brame gen til? (IX, 18) della regina di Media. E deriva a Clarice una vita affettiva
che, mentre non si esaurisce nell'attrazione amorosa, neH'amore fa sen
(1) Come Lucilla, abbandonata da Alidoro, neW Amadigi (XLII, 50).
This content downloaded from 188.72.126.181 on Sun, 15 Jun 2014 10:34:21 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

78 A. DI PIETRO
tire intera la presenza di lei inconfondibile: la presenza cioe della no
bile giovinetta, altera non meno che ardente, in cui il tradizionale con
trasto fra amore e onore, gia astrattamente proposto da Rinaldo (II, 3) e da Floriana (IX, 18-19), acquista una concretezza affatto nuova e si
esprime, nonostante il vecchio canovaccio di equivoci che lo sorregge, con una inconsueta modernita di atteggiamenti. Airarrivo inatteso dell'a
mato ritenuto infedele, mentre
Fan le donne tra lor dolce conflitto In onorar il vincitor soprano (X, 91),
si apparta Clarice, offesa ancor piu che gelosa, e
Tra se fremendo l'accoglienze mira
Che fan quell*altre al gran figliuol d'Amone (XI, I);
e subito, piu che il dolore, pud in lei la preoccupazione di tradirsi e il
desiderio di vendicarsi:
?S'egli e perfido e lieve, io come soglio Ancor dunque saro fida e leale?
Ah! non fia ver, ch'a lui scoprir mi voglio Ne la costanza e ne la fede eguale (XI, 4) (1).
Desiderio di vendetta che, alimentato dal suo orgoglio e dal suo amore, la fa vibrare tutta, mentre Rinaldo, ignaro, la pone a cavallo,
E ben che con la lingua immobil taccia, E il suo tacer d'aspre querele pieno (XI, 9) (2);
e le suggerisce poi le parole amare, in cui pur trema il pianto (XI, 15),
?Diavi nel vostro mal, diavi conforto
Chi vi die contra me forza ed ardire? (XI, 13);
e le da una grazia felina, quando, mentre Rinaldo continua a supplicarla,
(1) Invertite le parti, ?perfida? e Lucrezia, per Torquato che sdegnato medita, come
Clarice, la vendetta, nel sonetto ?Arsi gran tempo e del mio fuoco indegno* (XXX delle Rime degli Eterei, ed. cit.).
(2) Simile, ancora una volta, a Lucrezia, che (v. son. cit. ?F vidi un tempo di pietoso
affetto*):
Ora (ne so perche) la fronte e '1 petto Usa di sdegno e di fierezza armarsi, E coi guardi ver me turbati e scarsi
Guerra m'indice, ond'io sol morte aspetto.
This content downloaded from 188.72.126.181 on Sun, 15 Jun 2014 10:34:21 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

NOVIZIATO DEL TASSO 79
... al suo dir la via troncando
Lo scherni, lasso I con astuzia ed arte, Ch'a se chiamo cortesemente Orlando, II qual da tutti gli altri iva in disparte (XI, 16).
E quando, cresciuta la gelosia per Y invito al ballo di Alda, riceve da un
messo di Rinaldo una lettera, Clarice preme il suo cuore e
... Tun minaccia e l'altra gitta, Crudel forzando il suo volere istesso (XI, 38);
e, rimasta sola, ancora non piange, ma soffoca con lo sdegno il dolore,
per non mostrarsi, neppure a se stessa, vinta. Vinta sara solo allorche
vedra Rinaldo combattere per lei il mortale duello con Mambrino: e
certa ormai del suo amore, e disarmato il suo orgoglio,
... come varia del pugnar la sorte
Varia ella il viso, varia sfato al core (XII, 62);
e quando, finito il combattimento, egli viene finalmente a lei, i suoi oo
chi si illuminano di un sorriso, in cui e tutta, indifesa, la sua anima
innamorata:
Venne e Clarice, che dal dolce guardo Gli dimostrava quel che '1 cor chiudea (XII, 69).
La parabola tracciata concordemente dalle immagini di Rinaldo e di
Clarice, dai loro primi sbandati atteggiamenti fino alia conquista di una
loro viva personality, non e reperibile (se non parzialmente, come si e
visto, in Floriana) nei personaggi minori del poema. Troppo velocemen te essi compaiono e scompaiono, perche sia possibile osservare una so
stanziale evoluzione nei loro contegni. E anche quando, raramente durano
piu a lungo sulla scena, di evoluzione non si pud parlare, che troppo disattento si posa sopra di loro Tocchio del poeta, costantemente preoc
cupato dei protagonisti, in cui adombra se stesso e la donna che ama:
come clamorosamente dimostra la figura di Florindo, in cui il femmineo
?pastorello adorno? (V, 12) della prima apparizione e cosi remoto dal
?fier barone? (VIII, 61) e dal ?romano eroe? (XII, 43) delle comparse
successive, che non si pud ritenerlo, in realta, neppure fisicamente, un'u
nica figura umana. Se pero si considerano i personaggi minori non con
clusi nella loro autonoma vita, ma come successive incarnazioni dei temi deU'eroe e dell'eroina, la parabola osservata nei protagonisti si
ritrova in essi puntualmente: incerti e scialbi nei primi canti del poema, si fanno essi infatti piu vivi e concreti via via che Timmagine dei pro
This content downloaded from 188.72.126.181 on Sun, 15 Jun 2014 10:34:21 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

80 A. DI PIETRO
tagonisti poeticamente si mahira; e di quella maturazione restano, nel
poema, quasi a segnare le fasi, quando ad essa non collaborano anche, colmandone gli intervalli (come avviene, in maniera particolarmente ri
levante, per Floriana appunto rispetto a Clarice). A mano a mano che, i gesti incoerenti e abnormi di Rinaldo guerriero feroce e amante lacri
moso si compongono neirimmagine di Rinaldo cavaliere valoroso e
innamorato, si allineano lungo le pagine del poema (per citarne solo
alcune) le figure insignificanti di Isoliero, di Ransaldo il Fiero (c. II) e del ?cavaliere della Sirena? (c. Ill); quelle fra loro antitetiche di Florindo
pastorello (c. V) da una parte e dei guerrieri fortissimi Atlante e Orlan do (c. VI) dairaltra; quelle piu complesse, di guerrieri amanti, dell'in felice marito di Clizia (c. VII) e di Francardo (c. VIII); e quelle, infine, piu ricche di verita umana o di forza drammatica, del superbo Ansel mo (c. XI) e del furibondo re Mambrino (c. XII). E mentre Clarice e
assente, e si direbbe approfondisca lontana da Rinaldo il suo amore e insieme il suo carattere di donna di code, sfilano, prima di Floriana, Tincolore Clarinea (c. Ill); Tidilliaca e altera Olinda (c. V); la dolce e
fragile Clizia, che, morendo mentre il marito disperato le giura il suo
amore,
Parve che l'aere fosco asserenasse
Del volto suo... tai cose udendo, E che gioia e letizia alta mostrasse
L'alma da la prigion terrestre uscendo (VII, 41);
e infine, dopo Floriana, accanto a Clarice, la sua arnica prediletta e ca ra compagna d'infanzia di Rinaldo, ? Alda la bella?, fissata in un gesto solo di vivacissima naturalezza, quando, invitata a ballare contempora neamente da Rinaldo e da Anselmo,
Chind a terra lo sguardo e l'aurea testa, Ne quel ne questo col parlar ricusa, Ma tacendo si sta dubbia e confusa (XI, 26).
E la stessa curva descritta dai temi deU'eroe e deir eroina (siano essi calati nel processo genetico deH'immagine poetica dei protagonisti o siano astratti dai singoli personaggi minori in cui volta per volta
s'incarnano) e reperibile, ovviamente, nei temi delle varie passioni, di cui e intessuto il dramma, e quindi Tanima stessa, d'ogni eroe e d'ogni eroina. Cosi e evidente (per riferirci solo, con un rapido esempio, alle
passioni dominanti e alle situazioni in cui esse si manifestano meno
confuse da reciproche contaminazioni) che, mentre cresce la presen za spirituale dei personaggi, cresce la tensione sentimentale dei duetti
This content downloaded from 188.72.126.181 on Sun, 15 Jun 2014 10:34:21 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

KIOVIZIATO DEL TASSO 81
d'amore: dai primi impacciati incontri di Clarice con Rinaldo (cc. I e IV), al morbido idillio di Florindo e Olinda (c. V), alia melodrammatica tra
gedia di Clizia e'del marito (c. VII), alia travolgente passione di Floriana e di Rinaldo (c. IX), alle ultime schermaglie amorose e air incontro fi nale di Clarice e Rinaldo (cc. XI e XII). E cresce analogamente, la carica
passionale dei duelli (in cui piu nudo si esalta il tema della gloria co
me volonta di potenza): che piu agili ed esperti e crudeli si fanno, via
via che, dai primi rodomonteschi combattimenti di Rinaldo con i cavalieri di Clarice (c. IV), si passa ai suoi durissimi scontri con Atlante e Or
lando (c. VI) e alia sua strenua contesa con Mambrino (c. XII). Ne solo le passioni crescono e si affinano nel cuore dei personag
gi, che concordemente intorno ad essi si trasforma l'ambiente in cui
combattono ed amano. Sempre piu leggiadri e accoglienti si fanno tem
pii e padiglioni e castelli, man mano che le immagini degli eroi e delle
eroine si proporzionano e si raggentiliscono: e intorno ad esse successi
vamente si spiegano la pompa ancora sbiadita dei tempii della Belta (c. Ill) e deirAmore (c. V), il lusso raffinato dell* ?albergo de la Cortesia? (c. VIII), il fasto esotico del padiglione di Francardo (c. VIII), la regale ricchez
za del palazzo di Floriana (c. IX), la mondana eleganza delle sale di
Carlo Magno (c. XI). E sempre piu varia e partecipe della loro umana vita
intorno ad esse si apre la terra: dalle selve e dai prati di maniera in cui
si svolgono i primi incontri di Clarice con Rinaldo e i primi duelli, al pre zioso mondo arcadico in cui si muovono Florindo e Olinda (c. V), al ?bel
lito? tirreno ed al ?fiorito piano ? che circondano il castello della Cortesia
(c. VII); al lussureggiante giardino di Floriana (c. IX); alia natura maga ta dell'isola del Piacere (c. X) e della valle del Dolore e del colle della
Speranza (c. XI). E sempre piu condiscendente alle loro passioni su di
esse si incurva il cielo: che, quasi assente nei primi canti del poema,
saluta, luminosissimo, il lieto risveglio di Rinaldo e di Florindo nell'al
bergo della Cortesia, ?Quando i guerrier, lasciato il pigro letto ? (VIII,
2), per correre, sulla barca incantata, verso nuove avventure, vedono che
Gia svegliata Y aurora al dolce canto
De lascivetti augei vaga sorgea,
E con le rosee mani il fosco manto
De la notte squarciava e dissolvea;
I suoi tesori vagheggiando intanto
L'aria, l'acqua, il terren lieto ridea,
E giu versava dai bel volto il cielo Formato in perle il matutino gelo (VIII, I);
e avvolge poi d' ombre morbidissime il dolce amore del Paladino e di
Clarice, e per loro si popola di canti e di mitologici sogni:
Aevum - Anno XXVII - 6
This content downloaded from 188.72.126.181 on Sun, 15 Jun 2014 10:34:21 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

82 A. DI PIETRO
Gia nc venia con chiari almi splendori Cinzia (1), versando in perle accolto il gelo, E senza ombre noiose e senza orrori
Candido distendea la notte il velo; Gia spargea Imeneo co' i vaghi amori
Fiori e frondi nel suol, canti nel cielo,
Quando di propria man Venere bella
Congiunse in un Rinaldo e la donzella (XII, 88) (2).
E come il pifii vasto ambiente fisico che accoglie in se i personaggi
gradualmente ad essi si adegua, cosi via via piu fini diventano, uno per uno, tutti quei minori oggetti di cui i personaggi si cirqondano e rico
prono: e di una luce sempre piu tersa risplendono le mense adorne di
lini e di cristalli, le vesti ricamate di gemme, le armature intarsiate d'o ro e d'argento, le?imprese? policrome; e un suono piu limpido manda no i ?musici stromenti? e l'urto, perfino, dei ferri incrociati.
Ma in maniera ancor piu evidente che nei temi finora partitamente osservati, il costante processo osmotico che lega i personaggi fra loro e al loro ambiente appare nel tema della folia, in cui, forse piu che in
(1) Correggiamo con ?Cinzia? il ?Cinta? deU'edizione Bonfigli, che ci sembra evi
dentemente errato: ?Cinzia? infatti troviamo nell'edizione del Mazzoni (// Rinaldo e VA
minta di T. T. a cura di G. Mazzoni, Firenze, Sanzoni, 1884) e ?Cintia? in lutte le altre
piu antiche edizioni da noi consultate.
(2) E una delle ultime stanze- del Rinaldo (Vultima del racconto). E a segnare il
cammino percorso dal Tassino dai primi canti del romanzo, ancora impacciati dal pres sante esempio paterno, agli ultimi esiti del suo lungo esercizio poetico, vale la pena di
citare i versi con cui Bernardo descrive, nell' Amadigi, 1'episodio culminante dell'amore
di Alidoro e Mirinda: La bella Dea che '1 terzo Cielo onora,
E per pieta di lor pianse sovente
Presta discese col suo carro allora
E volse a le lor nozze esser presente; E quante sparse avean Favonio e Flora
Ivi ricchezze, fe subitamente
Coglier a un nembo di piccioli Amori, Che 'ntorno a lei facean leggiadri errori.
E d'una nube d'or con questi testa
Fe subito coprir d'intorno il loco:
Tutta a cio far quella famiglia e presta, E seco insieme l'Allegrezza e '1 Gioco; L'Aura l'erbette d'ogni intorno desta; Fa un mormorio il ruscel soave e roco;
E gli Amoretti, al lor servigio intenti,
Tempran con Tali d'oro i caldi ardenti (LXXXI, 81-82). La greve e farraginosa coreografia di Bernardo si e sciolta e ricomposta ormai in una
lieve trama di suggestioni musicali.
This content downloaded from 188.72.126.181 on Sun, 15 Jun 2014 10:34:21 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

NOVIZIATO DEL TASSO S3
ogni altro, quasi in nuce e visibile Tunitario proccsso di approfondi mento che caratterizza la composizione del Rinaldo e piu chiari appaio no (anche perche quello della folia e il tema dominante del Gierusa
lemme) i termini estremi entro cui quel processo si svolge. La ?nobil
compagnia? di Clarice (c. I), in cui si imbatte Rinaldo uscito appena dalla solitudine delle selve, non esiste se non per i grandi colpi di spa da ch'egli distribuisce agli impersonali cavalieri che ne fanno parte. Ben
piu lunga e l'attenzione che il Tassino dedica al successivo corteo di
Galerana (c. IV); ma e un'attenzione tutta esterna (1): la descrizione minutissima e la pompa profusa a piene mani non riesce a dare un ani ma alle ?vaghe donzelle? e alia ?bella schiera? dei loro cavalieri, che
sfilano non meno rigidi e assenti dei duci e dei cavalieri erranti nella
parata finale del Gierusalemme: ne la furia di Rinaldo smuove inti
mamente queste sontuose statue di cera, intorno a cui sono muti il cielo e la terra, e muta scorre, come su una carta geografica, la Senna. Ma
gia meno pesantemente coreografico e l'arazzo di Olinda che esce dal
?castel che signoreggia intorno Tutto il paese? (V, 43),
Coi primi rai, con l'aura mattutina,
Allor che le verdi erbe e i vaghi fiori Sparsi ed umidi son d'argentea brina.
Cinta da cavalier, da cacciatori,
E da schiera di dame pellegrina; Ed or seguiva lepri e i cervi snelli,
Or tendea reti a semplicetti augelli (V, 44).
E, quando Rinaldo e Florindo giungono ?La dove il Franco e '1 Saracin s' aduna?, gia piu vivace e il quadro che ai loro occhi si apre:
E vider tremolar Tinsegne altere
Al vento, e fiammeggiar Farmate schiere.
S'alzava il sol dal mar con Tore a paro ne di nubi copria le gote ardenti,
E, ferendo per dritto il vario acciaro,
Mille formava in ciel lampi lucenti, E con un corruscar tremulo e chiaro
Fea con ingrata offesa a gli occhi intenti;
Tal ch'il campo sembrava Etna, qualora L'aer con spessi fuochi orna e colora (VI, 5-6).
Non ha questa massa d'armati l'epica forza dell'esercito crociato che
marcia compatto, nell'ardente mattino orientale, su Gerusalemme (2); ma
(1) II Tassino gareggia qui ancora, infatti, con impegno puramente letterario, con la
descrizione del favoloso corteo marino della maga Argea, de\V Amadigi (C, 56-64).
(2) Vedi soprathitto la st. 11, ma anche le stanze 9 e 10, del Gierusalemme, citate
nel precedente capitolo.
This content downloaded from 188.72.126.181 on Sun, 15 Jun 2014 10:34:21 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

84 A. DI PIETRO
piu mobile si riflette la luce multicolore sul ?vario acciaro? e piu leg gere e liete tremano al vento, innumerevoli, le bandiere. Ancora tuttavia
impediscono la limpida visione deir ariosa scena le opache ?gote? del
sole e gli ?spessi fuochi? dell'Etna. E solo quando gli occhi di Rinaldo si saranno abituati a gustare la fragile grazia del ?nobil drappelletto? delle fanciulle che lo servono nell'albergo della Cortesia (c. VII) e avranno imparato a scoprire nel volto di Floriana gli impercettibili tra
salimenti dell'amore, vedranno, affatto sgombri di letterari veli, la folia delle dame e dei baroni che circondano Carlo Magno sulla fiorita pia nura di Parigi:
Come fu presso, il pian ripieno scerse
D'illustri cavalieri e di donzelle, I quai d'oro, d'acciaro e di diverse
Sete ornavan le membra altere e belle; Altre vermiglie, altre turchine, o perse, Candide queste e verdeggianti quelle: E '1 sol che riflettendo indi splendea, Di nova iride vaga il ciel pingea (X, 81).
Questa folia variopinta e, comunque, ancora solo un piacevole spettaco lo (1) e un'elegante cornice airincruento duello di Rinaldo con Grifone.
Ma quando, poco dopo, Grifone cade
Sendo percosso e, '1 suol premendo, rese
Alto rimbombo il lucido metallo (X, 87),
e tutti si accostano festosi al Paladino raggiante di gloria e
... il padre Amone al petto alquanto il tiene E sente alto diletto ir per le vene (X, 90).
e ?T accolgon lieti ? il re e la regina, e le donzelle soprattutto fan res sa intorno a lui per manifestargli, ?in quanto e lor da Ponesta concesso?, la loro ammirazione (X, 91), suscitando cpsi le gelosie di Clarice, allora
questa folia, da immobile sfondo, si trasforma rapidamente in coro com mosso. Un coro che sempre piu attivamente partecipa alle azioni dei
protagonisti, quando ha inizio il ballo di corte: e lusso di vesti, armonie
(1) 11 tema e gia neir Amadigi:
Scoperse di lontano una campagna Piena di cavalieri e di donzelle Partiti in schiere graziose e belle (L1II, 54);
ma (e vale a sottolineare, ancora, una distanza) quanto nel poema di Bernardo e solo
generico, e diventato nel Rinaldo vivacemente impressionistic?.
This content downloaded from 188.72.126.181 on Sun, 15 Jun 2014 10:34:21 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

NOVIZIATO DEL TASSO 85
di canti, bellezza di dame e cavalieri, fiammeggiare di lame snudate, ire
ed amori (tutti i temi che nel poema si rincorrono in un continuo cre
scendo), affollandosi con ritmo concorde intorno al tema centrale della
contrastata passione di Rinaldo e Clarice, tessono, nelle ?stanze reali?
di Carlo Magno, che risplendono di lumi nella notte stellata, un quadro indimenticabile di vila cortigiana (1):
Gia la notte, stendendo umida Tali,
Gli almi ed eterni fochi in cielo accende, La donde il bene e T mal tra noi mortali Con varia sorte ognor deriva e scende;
Gia soave armonia per le reali
Stanze altamente risonar s'intende,
E concorde a' soavi e dolci accenti
Va misto al ciel il suon degli istromenti. D'alti guerrier, di donne adorne e belle
II palagio real tosto e ripieno E come suol tra le men chiare stelle
Splender Venere e Giove in ciel sereno,
Cosi tra* cavalier, tra le donzelle
Clarice e '1 suo amator splende non meno;
E dai bei lumi lor fiammelle aurate Escon d'empia dolcezza avvelenate (XI, 22-23);
e, a un tratto, il drammatico colpo di scena: caduto Anselmo sotto ?il
pugnal? di Rinaldo (XI, 29), ecco che s'interrompono le danze, ed ecco
nelle sale
... lampeggiar mille lucenti
Ferri in quel punto ancor quai fochi accesi (XI, 31);
e, mentre Chiaramontesi e Maganzesi accorrono gli uni contro gli altri, e le dame, ?Pallidi i volti e palpitanti i cori? (XI, 32), si stringono in
torno alia regina, e Carlo s'interpone indignato, Rinaldo, la spada in
pugno, esce ?alteramente? (XI, 35), aprendosi la via (come nelFultimo
atto d'un melodramma) fra gl'incauti vendicatori di Anselmo, che
Pur col mover de l'armi e con le voci
Si mostravan da lungi assai feroci (XI, 34).
Raggiunge forse in questo episodio del canto undecimo (i succes
sivi episodi avventurosi servono solo a chiudere in qualche maniera il
(1) Le sale della corte estense, ?Ove tra care danze... Si traean le notturne e pla
cid'ore* (v. il son. cit. ?Ove tra care danze in bel soggiorno?), e dove, come Rinaldo e
Clarice, si incontravano Torquato e Lucrezia, sono certo presenti alia fantasia del poeta.
This content downloaded from 188.72.126.181 on Sun, 15 Jun 2014 10:34:21 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

86 A. DI PIETRO
racconto) il limite estremo delle sue possibility e la sua piu naturale
conclusione la poesia del Rinaldo: che e appunto, essenzialmente, poe sia della Code, nel tempo stesso che e compiuta espressione delTansia
di vita del Tassino alle soglie dei suoi vent'anni. Perche il mondo del
la Code, in cui meglio che in ogni altro le sue passioni fondamentali,
piacere e onore, trovano luogo, non circonda soltanto il poeta, come am
biente fisico e sociale, ma in lui vive come modo d' essere e di sentire, come ritmo che scandisce il palpito stesso del suo sangue.
Quel ntmo che, sulla pagina, pulsa nella musica nuova che sempre
piu colma invade le ottave. Man mano infatti che i temi e i modi fanta siosi del romanzo cavalleresco si commisurano al concreto mondo sto rico della Code cinquecentesca, e piu urgente diventa la padecipazione sentimentale del poeta alle azioni dei suoi eroi, il tessuto narrativo del
Rinaldo si gonfia di un respiro lirico; cosi come, con moto inverso e
concorde, per Tintervento del coro della Code appunto, assumono mo venze narrative e drammatiche le contemporanee rime per Lucrezia. Un
respiro lirico che deforma e spezza, prima, a fatica, il nitido disegno e
la sorvegliata armonia delTottava di stampo ariostesco, per scioglierla poi, vittorioso, sempre piu spesso, nell'onda di una musica suggestiva (1). Musica che tanto e remota dall'incalzante cadenza eroica del Gierusa
lemme, quanto remote sono le ?reali stanze? di Carlo Magno dalle disadorne tende di Goffredo; che di quella cadenza conserva tuttavia il timbro solenne pur nel suo piu morbido e vario contrappunto: cosi come dura nel cuore del Tassino, pur nella rapina dei sensi della sua
incipiente giovinezza, l'ideale tensione verso la gloria della sua pri ma adolescenza; cosi come rimane neir edonistico costume della Code rinascimentale una memoria altera di antiche tradizioni militari e
cortesi.
E questa musica, che, a qualunque tema si pieghi, fonde in un ori
ginalissimo impasto, il linguaggio sostenuto e sonante delTepica con
quello molie e sottile della lirica, e, in sede stilistica (nella sede cioe che tutte le altre contiene), il risultato ultimo e piu valido a cui giunge il lungo e necessario esercizio durato dal Tassino, parallelamente, nel
Rinaldo e nelle rime per la Bendidio: ed e il segno piu certo della sua svelata voce di poeta e delle vie destinate ormai al suo canto.
(1) Una spia del graduale acquisto di musicalita dell'ottava del Rinaldo e l'evidente moltiplicarsi degli enjambements, via via che, dai primi, ci avviciniamo agli ultimi canti.
This content downloaded from 188.72.126.181 on Sun, 15 Jun 2014 10:34:21 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions