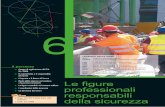Nominativi Fritti e Mappamondi
description
Transcript of Nominativi Fritti e Mappamondi
-
STU D I E SAG G I
COLLANA DIRETTA DA
PAO LO O RVI ETO
49
-
SALERNO EDITRICE
ROMA
NOMINATIVI fRITTI E MAPPAMONDI
IL nonsense NELLA LETTERATURA ITALIANA
Atti del Convegno di Cassino 9-10 ottobre 2007
a cura di
GIUSEPPE ANTONELLI E CARLA CHIUMMO
-
ISBN 978-88-8402-684-2
Tutti i diritti riservati - All rights reserved
Copyright 2009 by Salerno Editrice S.r.l., Roma. Sono rigorosamente vietati la ri pro-duzione, la traduzione, ladattamento, anche parziale o per estratti, per qualsiasi uso e con qualsiasi mezzo effet tuati, compresi la copia fotostatica, il microfilm, la memorizzazione elettronica, ecc., senza la preventiva autorizzazione scritta della Sa lerno Editrice S.r.l.
Ogni abuso sar perseguito a norma di legge.
Alla realizzazione della presente pubblicazione ha concorso con i propri fondi lUniversit degli studi di Cassino -
Dipartimento di Filologia e storia.
-
7PREMESSA
Come dare un senso al nonsenso? Il terreno scivoloso, ma proprio per questo invitante. Da una parte, la sfida critico-metodologica del definire e delimitare un genere (o una tecnica? o uno stile? o un linguaggio?) che di per s non pu essere rigidamente imbrigliato, pena la dissoluzione. Dallaltra, lattraversamento di una tradizione nonsensical italiana che, pur con le sue specificit, si inserisce a pieno titolo nella grande tradizione europea: dalle fratrasies a Beckett, passando per Rabelais, Sterne, Lear, Carroll, Jarry.
Da qui il Convegno organizzato presso il Dipartimento di filologia e Storia dellUniversit di Cassino ( nominativi fritti e mappamondi . Il non-sense nella letteratura italiana, 7-9 ottobre 2007). Gli interventi partono dallindagine su una possibile preistoria medievale del nonsense italiano (Berisso) per passare subito alla nascita ufficiale e al trionfo di questa tradizione poetica, con il nome di Burchiello e dei cosiddetti burchielle-schi ad occupare, con discrezione ora minore ora maggiore, lmbito quattro-cinquecentesco (Zaccarello, Decaria, Chiummo). Una tappa obbligata si rivela il Seicento in versi e in prosa (Crimi, Guaragnella) e, dopo una pausa settecentesca, ecco dispiegarsi un variegato e a tratti pi-rotecnico spazio tra fine Ottocento e, ancor pi, primo e secondo Nove-cento: non a caso, in questi Atti, con il maggior numero di interventi ad occuparsi di lingue inventate e strane miscele di surrealismo e nonsen-so vero e proprio, nel secolo post-cartesiano (e post-hegeliano: e si po-trebbe continuare con molti altri aggettivi accanto a quel prefisso squisi-tamente novecentesco) appena trascorso (Castoldi, Iermano, Anglani, Cedola, Baglioni, Afribo, Serianni).
Romanzi, poesie, opere e autori pi o meno noti, ma comunque illu-minanti per una nuova rilettura del rapporto antico/moderno e soprat-tutto per la fondazione del concetto stesso di modernit (Antonelli), a conferma della carica eversiva, e allo stesso tempo tuttaltro che pura-mente comico-autoreferenziale, del nonsense, parziale o assoluto, in un contesto refrattario alle barriere alto/basso, dlite/di consumo, che vive anzi di travasi e travisamenti di ogni tipo. Come nella speciale e ricorren-
-
premessa
8
te contiguit, quando non sovrapposizione, con i pi svariati settori e linguaggi: da quello pittorico a quello teatrale e persino da schietto avan-spettacolo, o dalla trattatistica (paradossalmente) pi seria alla riscrittura tra parodia e metaletteratura. Si tratta di una sfida metodologica e di unindagine storico-letteraria che nel presente volume interessa, nello specifico, un territorio come quello italiano, nel quale questa tradizione tanto ricca quanto ancora poco indagata. forse perch troppo anticano-nica in una storia letteraria considerata fin troppo classicistica, o perch ritenuta poco rappresentativa, sebbene annoveri tra i suoi incunaboli lenigmatico Pape Satn Pape Satn Aleppe , insieme ad autori, ben oltre Dante, quali Pulci, Burchiello, folengo, e via di seguito, che hanno portato frutti tra i pi ricercati in ogni angolo dEuropa. E sebbene pro-prio negli ultimi anni sempre pi studiosi si siano impegnati a raccoglie-re e commentare un materiale cospicuo, per quantit e qualit, che fa ben sperare in un futuro ancora assai ricco di sorprese in questo peculia-re campo dindagine.
Desideriamo qui ringraziare il Dipartimento di filologia e Storia dellUniversit di Cassino, e in particolare i direttori, Silvana Casmirri e poi Edoardo Crisci, che hanno seguto con generosit e sollecitudine lorganizzazione del Convegno e la pubblicazione degli Atti.
Cassino, dicembre 2008Giuseppe Antonelli
e Carla Chiummo
-
9Giuseppe Antonelli
Il nonSoch dEl nonSEnSo*
1. Lessenza del nonsenso
Dare un senso al nonsense pu essere rischioso. In un divertissement di qualche anno fa, Umberto Eco sottoponeva una delle pi note filastroc-che infantili italiane quella che comincia Ambarab cicc cocc / tre civette sul com a una dottissima analisi in cui lerudita (e immagina-ria) bibliografia ostentava il ricorso ai pi raffinati, e allepoca modaioli, strumenti dindagine testuale.1 Prima la filologia, con la fissazione del testo critico in lingua originale e nelle traduzioni francese, tedesca e in-glese; poi la semiotica strutturalista, per evidenziare simmetrie semanti-che e opposizioni fonologiche, la psicanalisi di stampo lacaniano e la linguistica trasformazionale di Chomsky ( la WP ambarab cicc cocc dove WP sta per What? Phrase, dalla esclamazione di Dwight Bolin-ger quando era stato esposto, come native informant, alla utterance del qui-nario ). Tutto questo per giungere passando per gli pseudo Bloom e Derrida, Searle, Greimas a un parziale scacco ermeneutico: questo, e non altro, chiede a noi la Poesia .
Il nonsense al quadrato prodotto da una simile parodia (ancor pi effi-cace perch applicata a un testo irrilevante, oltre che insignificante)2 suo-na quasi come un ammonimento: lessenza del nonsense sfugge a una
* Devo preziose indicazioni a Carla Chiummo, Giuseppe Crimi, Luca Serianni, Elisa-betta Tarantino, Michelangelo Zaccarello: a tutti loro va il mio pi sentito ringraziamen-to. Una versione in inglese di questo contributo stata pubblicata come introduzione al volume nonsense and other senses. Regulated Absurdity in Literature, a cura di Elisabetta Ta-rantino con la collaborazione di Carlo Caruso, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, pp. 1-21.
1. U. Eco, Tre civette sul com, in Id., Il secondo diario minimo, Milano, Bompiani, 20012, pp. 164-75.
2. Ci non toglie che ci sia stato chi ha tentato sul serio una ricostruzione etimologica della filastrocca, ipotizzando un antenato latino *hanc para ab hac quidquid quodquod: non che la filastrocca latina offra molto pi senso di quella italiana, ma questo un dato costante delle filastrocche infantili (V. Brugnatelli, Per unetimologia di am ba-
-
giuseppe antonelli
10
lettura meccanicamente scientifica; anzi: la scienza del nonsense pu dare come risultato il nonsense della scienza. Eppure, sintitolava proprio The science of nonsense uno dei primi interventi critici dedicati alla questione. Nel saggio, apparso sullo Spectator il 17 dicembre 1870, i versi di Lear erano definiti a trifle nearer to the grave talk of an idiot asylum, than to the nonsense of sane people . Il nonsense di Lear, daltra parte, aveva rap-presentato una decisa novit nel quadro della letteratura inglese dellepo-ca, e in particolare della letteratura per linfanzia:
when Lears first work appeared, the childrens literature market was in a fairly dire state, being dominated on one hand by utilitarian efforts at edification and on the other hand by moralistic and didactic religious works. To the children and adults forced to read such works, Lears nonsense must have displayed a remarkable freshness and originality.3
2. La sensazione del nonsenso
Com noto, Lear che aveva gi viaggiato a lungo in Italia scelse di trascorrere gli ultimi anni della sua vita sulla costiera ligure (mor a San-remo nel 1888). A quel tempo, in un paese che aveva da poco compiuto il processo di unificazione nazionale, il campione della letteratura per linfanzia era il burattino Pinocchio (1873) con il suo naso rivelatore di bugie: una deformazione punitiva che, pur in un contesto comico-fan-tastico, agiva ancora in senso pedagogico-moralistico.4 Niente che vede-
rab cicc cocc , www.brugnatelli.net/vermondo/articoli/ambara.html; tutta la sitografia aggiornata al 30 novembre 2009).
3. M.B. Heyman, Isles of Boshen. edward Lears Literary nonsense in Context, Thesis sub-mitted for the degree of PhD, Univ. of Glasgow, Department of English Literature, June 1999 (https://dspace.gla.ac.uk/bitstream/1905/330/1/HeymanThesis.pdf, p. 271). Tra laltro, una delle opere pi fortunate di Lear (The owl and the Pussycat, pubblicato per la prima volta nel 1869 e a tuttoggi un classico della letteratura per linfanzia) ha per prota-gonista una civetta e, come le tre civette di Eco, stata recentemente oggetto di una pa-radossale e anche in questo caso ironica interpretazione esoterica: the poem by Edward Lear might not have been just nonsense. Is it possible that beneath this innocent poem lurked a dark and sinister tale? (S. Ward, The owl and The Pussycat: a Conspiracy Theory, www.authorsden.com/categories/article_top.asp?catid=19&id=34621).
4. Perch il nonsense trovasse ufficialmente posto nella letteratura italiana per linfanzia
-
il nonsoch del nonsenso
11
re con i nasi allegramente iperbolici svettanti nei limerick di Lear, in cui la deformit non mai vissuta come un dramma e la parte del corpo in grottesca espansione anzi spesso orgogliosamente esibita :5
There was an Old Man with a nose,Who said, If you choose to suppose,That my nose is too long,You are certainly wrong! That remarkable Man with a nose.
There was a Young Lady whose nose,Was so long that it reached to her toes;So she hired an Old Lady,Whose conduct was steady,To carry that wonderful nose.
There was an Old Man, on whose nose,Most birds of the air could repose;But they all flew away, at the closing of day,Which relieved that Old Man and his nose.6
si sarebbe dovuto aspettare esattamente un secolo: nella Grammatica della fantasia di Gian-ni Rodari (1a ed. 1973), uno dei capitoli sintitola proprio Come si costruisce un limerick. Va detto tuttavia che la storiografia recente (vd. da ultimo P. Boero-C. De Luca, La let-teratura per linfanzia, Roma-Bari, Laterza, 2007) ha individuato una linea maestra che da Collodi porta giusto a Rodari, passando per due scrittori-disegnatori come Antonio Ru-bino (nato a Sanremo nel 1880, pochi anni prima che vi morisse Lear) e Sergio Tofano, e per la produzione fantastica di Italo Calvino: cfr. C. Schwarz, Capriole in cielo. Aspetti fantastici nel racconto di Gianni Rodari, Tesi di Dottorato pubblicata dal Dipartimento di francese, italiano e lingue classiche dellUniv. di Stoccolma nel 2005 (http:/ /s.diva-por-tal.org/smash/get/diva2:200325/fULLTEXT01, p. 29).
5. Il pi soggetto a deformazioni il naso che, com noto, fra i motivi grotteschi pi diffusi e si conserver molto a lungo in questo tipo di imagery (A. Caboni, non-sense: edward Lear e la tradizione del nonsense inglese, Roma, Bulzoni, 1988, pp. 110 e 109). Gi C. Izzo aveva notato che il libro di Lear pieno di nasi spropositati (Lumorismo alla luce del Book of nonsense, in Ateneo veneto , ccxxvi 1935, vol. 119 pp. 211-19, a p. 217). Si pu ricordare qui, di sfuggita, che prima di Pinocchio Collodi aveva pubblicato (nel 1880) una raccolta di bozzetti intitolata occhi e nasi: non una mostra di figurine intere. piuttosto una piccola raccolta docchi e di nasi, toccati in punta di penna e poi lasciati l, senza finire (si cita dalla rist. an., firenze, Bemporad, 1980).
6. E. Lear, The Complete Verse and othier nonsense, a cura di V. Noakes, London, Pen-
-
giuseppe antonelli
12
Per capire il differente contesto nel quale ci si muove in Italia, basta leggere le parole che nella sua fondamentale storia della letteratura italia-na (1870-1871) francesco De Sanctis dedicava al Giorno di Parini, messo a confronto con i modelli di Boccaccio e di Ariosto: l era lironia del buon senso, qui lironia del senso morale .7 Non stupir pi di tanto, allora, che nello stesso periodo in cui il dibattito sul nonsense conosce in Inghilterra alcuni dei suoi episodi fondativi (il saggio di Edward Strachey nonsense as a Fine Art esce nel 1888, Defense of nonsense di Gilbert Chester-ton nel 1901), Pietro Micheli pubblichi a Livorno il suo Letteratura che non ha senso,8 in cui ignora sia Lear sia Carroll, per dedicarsi piuttosto al sim-bolismo di Verlaine:9 quando queste allitterazioni, ripetizioni di suono, non vanno daccordo con lidea, si ha il bisticcio; quando sopprimono assolutamente lidea, si ha il non senso .10
guin, 2001, pp. 158, 91, 178. Potrebbe essere proprio Lear, forse, la fonte di una delle tante interpolazioni del Pinocchio disneyano (cfr. M. Bernardinis Pellegrini, Il comico nel Pi-nocchio cinematografico: la versione di Disney e di Comencini, in Pinocchio sullo schermo e sulla scena, a cura di G. Flores dArcais, firenze, La Nuova Italia, 1994, pp. 29-43). Limmagine degli uccellini che si appoggiano sul naso manca infatti nella versione collodiana, dove si pu trovare tuttal pi una scena di timbro ben diverso: alcuni uccellacci notturni, traversan-do la strada da una siepe allaltra, venivano a sbattere le ali sul naso di Pinocchio, il quale facendo un salto indietro per la paura gridava: Chi va l? (Le avventure di Pinocchio, ed. critica a cura di O. Castellani Pollidori, Pescia, fondazione Nazionale Carlo Collodi, 1983, pp. 41-42).
7. storia della letteratura italiana, a cura di N. Gallo, Torino, Einaudi, 1958, vol. ii p. 912.8. Livorno, Raffaello Giusti, 1900; ma alcune parti erano uscite in rivista gi nel 1895:
cfr. infra il contributo di Massimo Castoldi.9. Laccostamento col simbolismo rimarr piuttosto comune almeno fino alla met del
secolo: nella sua Antologia burchiellesca recensita da Emilio Cecchi (1950), Eugenio Giovan-netti spiega ancora come il simbolismo, in ultima analisi, non sia che un burchielleggia-mento squisito, in guanti bianchi , mentre la gazzarra parolibera cui abbiamo assistito in questi ultimi anni sarebbe da considerarsi un burchielleggiare truculento (Burchiel-lesca, in E. Cecchi, Libri nuovi e usati. note di letteratura italiana contemporanea, Napoli, Esi, 1958, pp. 33-37; la citaz. a p. 34).
10. P. Micheli, Letteratura che non ha senso, Livorno, Raffaello Giusti, 1900, pp. 77-78. Ancora nella monografia La poesia giocosa e lumorismo, di C. Previtera, Mi lano, Vallardi, 1939-1942 (due volumi poi ripubblicati nel 1953 dalla Vallardi di Milano), pur in presenza di una panoramica piuttosto ampia dedicata alla letteratura inglese ( per molti lhumour propriet esclusiva deglInglesi o almeno dei popoli anglosassoni: una pianta indigena che vegeta fra le brume di Albione , vol. i p. 36), manca qualunque riferimento a Carroll e
-
il nonsoch del nonsenso
13
La tentazione, a questo punto, sarebbe quella di dar ragione a Giusep-pe Tomasi di Lampedusa, che in una delle sue lezioni di storia della let-teratura inglese (1953-1954) scriveva:
La letteratura italiana la pi seria delle letterature. Un libro che sia nello stesso tempo ben scritto e umoristico si pu quasi dire non esista. Siamo costretti a fingere di sbellicarci per lumorismo con il quale disegnato Don Abbondio e a trovare Ariosto divertentissimo. [] In Inghilterra lo scrittore comico ha da circa cento anni scelto la strada del nonsense, della cosa scritta che non ha senso alcuno, formata da un (apparentemente) fortuito accozzamento di associazioni le quali, suscitando una serie di immagini disparate, riescono ad un effetto talvolta forte-mente umoristico. [] Chi non capace di ridere di un limerick in fondo non capir mai nulla dellInghilterra e della sua letteratura: lInghilterra il paese dellirrazionale nel quale la logica val pochino. [] Il nonsense qui non pu aver successo. Come dice france, nous sommes srieux comme des nes .11
E invece, se si attraversa con sguardo diverso la storia della letteratura italiana, ci si rende conto che una certa erosione (un volontario occulta-mento) del senso ha agito in momenti a volte lontani tra loro, dando vita a un filone carsico rispetto al codice dominante. Scrive in proposito Ales-sandro Caboni:
Una letteratura tradizionalmente considerata poco incline al fantastico come quella italiana, tuttaltro che priva di esempi di nonsense: basti pensare al ricco repertorio della poesia giullaresca medievale, a quella burlesca del Burchiello, di Berni, ai capricci dei poeti barocchi popolareggianti quali Giulio Cesare Cro-ce e Anton francesco Doni, o alle mirabolanti metafore di Giambattista Basile; una tradizione che sopravviver nella cultura popolare dei secoli successivi, fino a trovare poi, con la rivalutazione dei generi minori, degli sbocchi autonomi, ad es. nelle misteriose filastrocche della poesia pseudo-simbolistica di Aldo Pa-lazzeschi, nel nonsense cripto-satirico di Petrolini, in quello comico-surreale di Achille Campanile, nei sofisticati e oscuri paradossi di Tommaso Landolfi. fra i tentativi contemporanei di poesia nonsensical riportata alloriginaria destinazio-
Lear e alla nozione stessa di nonsense (anche se cronologicamente ci si spinge fino a Geor-ge Bernard Shaw).
11. G. Tomasi di Lampedusa, opere, intr. e premesse di G. Lanza Tomasi, Milano, Mondadori, 1995, nella sez. Letteratura inglese, pp. 527-1330, alle pp. 1167-69.
-
giuseppe antonelli
14
ne infantile si possono ricordare autori quali Nico Orengo, Antonio Porta, Toti Scialoia.12
Il culmine potrebbe essere indicato nelle esperienze neoavanguardi-stiche degli anni Sessanta e nella loro successiva presa di coscienza. Il Poema Chomsky di Alfredo Giuliani (1979) affronta di petto la questione teorica, versificando in variazioni diverse la frase che il linguista ameri-cano aveva addotto a modello di nonsense ( furiosamente verdi dormono idee senza colore / tra rosee zampe a becco furiosamente il prato /dor-me del verde fuori alato corpo dacqua pietra ).13 I titoli scelti da Edoardo Sanguineti per due sue raccolte Bisbidis (1987) e la riassuntiva Il detto del gatto lupesco (2002) sembrano voler chiudere deliberatamente il cerchio di questa linea, riallacciandosi a produzioni medievali in cui Zaccarello riconosce a non-sense effect .14
La letteratura italiana, insomma, un territorio nel quale il nonsense si aggira come la pantera odorosa dei bestiari medievali, di cui dappertutto si sente il profumo senza che nessuno sia mai riuscito a vederla.
3. Lestensione del nonsenso
Siamo nellmbito di quelle che Andrea Afribo chiama in riferimen-to alla poesia tardonovecentesca approssimazioni al nonsense (cfr. infra, p. 000), o di quello che per risalire allaltro capo della cronologia Paul Zumthor definiva il nonsense relativo di alcuni componimenti medievali.15 La nozione di nonsense letterario, daltra parte, ha assunto ben presto tratti metastorici e metanazionali. Dal nonsense propriamente
12. Caboni, nonsense, cit., p. 15.13. Lepisodio valorizzato da S. Bartezzaghi nella sua Prefazione allantologia di P.
Rinaldi, Il piccolo libro del nonsense, Milano, Vallardi, 1997, pp. 17-32.14. M. Zaccarello, off the Paths of Common sense: From the frottola to the per motti and
alla burchia Poetic styles, in nonsense and other senses, cit., pp. 89-116, alle pp. 93, 97, 100 e passim.
15. P. Zumthor, Fatrasie, fratrassiers, in Id., Langue, texte, nigme, Paris, Seuil, 1975, pp. 68-88, a p. 77. Cfr., da ultimo, J.V. Molle, oscurit e straniamento. Per uninterpretazione del nonsenso fatrasico, in obscuritas. Retorica e poetica delloscuro, a cura di G. Lachin e F. Zambon, Trento, Univ. di Trento, 2004, pp. 131-51.
-
il nonsoch del nonsenso
15
detto (istituzionale o per quanto possa suonare assurdo a proposito di un genere come questo ortodosso) si sviluppata progressivamente una serie di proiezioni e di recuperi tale da creare, rispetto al nucleo vit-toriano, un complesso albero genealogico di antenati e successori con discusse paternit ed eredit molto contestate.16 Il tempo del nonsense si cos dilatato, fino a comprendere secoli e secoli di nonsense ante litteram.
Stando ai dizionari, la prima attestazione di nonsense in inglese risale (in accezione generica: Often used exclamatorily to express disbelief of, or surprise at, a statement ; cfr. oeD, s.v., par. 1a)17 al 1614, nella spe-cifica accezione di A meaning that makes no sense (par. 4) al 1650; laggettivo nonsensical attestato invece dal 1655. In francese, la prima ci-tazione di nonsense databile al 1672 (Le spectateur, ed. 1737); ladattamen-to non-sens impiegato da Voltaire av. 1778 (cfr. TDF, s.v. non-sens; le comp. nonsens existait, au sens de deraison, sottise, en a. fr. ), ma ancora nel 1769 lo stesso Voltaire usava nonsense in corsivo18 e langlicismo crudo entrer nelluso solo dal tardo Novecento: LGR, s.v. nonsense, lo data al 1962, specificando: une fois en 1829, Jacquemont, avec la valeur non-sens: Caractre absurde et paradoxal, en littrature .
Quanto allitaliano, nonsenso attestato la prima volta il 15 aprile 1754, in una lettera di Baretti scritta da Londra al canonico Agudio19 (cfr. DeLI,
16. La relativa maggior fama dei generi nonsensical della poesia francese medievale [rispetto alle corrispondenti esperienze dellarea italiana] andr imputata pi ai recuperi e alle predilezioni novecentesche dei surrealisti che ad una loro effettiva incidenza sul panorama ad essi coevo (M. Berisso, infra, p. 000); sulle forzature derivanti da letture proiettive insiste anche Molle, oscurit e straniamento, cit., pp. 136-37.
17. Di seguito lo scioglimento delle abbreviazioni usate: oeD = oxford english Dictio-nary, Oxford, Oxford Univ. Press, 19892; TDF = Trsor de la langue franaise. Dictionnaire de la langue du XIXe et du XXe sicle (1789-1960), Paris, Gallimard, 1971-1994; LGR = Le Grand Robert de la Langue Franaise, Paris, Le Robert, 198512.
18. I. Klajn, Influssi inglesi nella lingua italiana, firenze, Olschki, 1972, pp. 120-21.19. Della poesia ne faccio molto moderato uso; e una tenebrosa meditazione di Sher-
lock o di Young sopra la morte o una filosofichissima dissertazione morale di Tillotson o di Johnson, ti dico il vero, calonaco, mi cominciano a quadrar pi che non tutto il nonsen-so del Petrarca e del Berni, che un tempo mi parvero il non plus ultra dellumano intelletto (G. Baretti, epistolario, a cura di L. Piccioni, Bari, Laterza, 1936, vol. i pp. 96-99, alla p. 98). Sul rapporto di Baretti con lopera di Berni: G. Brberi Squarotti, Baretti: in rima,
-
giuseppe antonelli
16
s.v.);20 poi, con una certa continuit, a partire dal primo Ottocento (nes-suno degli esempi riportati dal GDLI, s.v., si riferisce per alla letteratu-ra). Mentre il DeLI parla di nonsenso come di un calco sullinglese (anche sulla scorta del fanfani-Arla, cit. ivi, che lo considera un modo di dire angloitaliano ), il GDLI lo ritiene giunto per tramite francese (forse sulla scorta del Panzini s.v.: dal fr. non-sens, locuzione con valore di sostantivo che i francesi tolsero a loro volta dallinglese nonsense ); cos anche il DeI, s.v. non ( dal fr. non-sens, ingl. nonsense ), che data generi-camente non-senso al XIX secolo.
nonsense e nonsensical compaiono la prima volta in un articolo del Conciliatore (13 settembre 1818) a firma di Grisostomo (pseudonimo di Giovanni Berchet), in bocca a un Mylord che intende perfettamente litaliano; ma nol parla troppo bene, ed usa dintarsiarvi talvolta vocaboli inglesi .21 Lacclimarsi dellanglicismo integrale risulta, comunque, mol-to pi tardo: il supplemento del GDLI, s.v. nonsense riporta solo un passo di Giorgio Manganelli (1986) in cui il sostantivo indica un componimen-to letterario; senza riportare esempi, lo Zingarelli data 1985, il GRADIT 1975, il Devoto Oli 1967 e il Sabatini Coletti Grav. 1967.
Quando, nel 1908, Camilla Del Soldato traduce per la prima volta al-
anzitutto il Berni, nel vol. Giuseppe Baretti: Rivalta Bormida, le radici familiari, lopera, a cura di C. Prosperi, Alessandria, Edizioni dellOrso, 1999, pp. 21-40.
20. DeLI = M. Cortelazzo-P. Zolli, Dizionario etimologico della lingua italiana, Bolo-gna, Zanichelli, 2a ed. a cura di M. Cortelazzo e M.A. Cortelazzo, Bologna, Zanichel-li, 1999; GDLI = Grande dizionario della lingua italiana, fondato da S. Battaglia, Torino, Utet, 1961-2002, con il supplemento 2004, diretto da E. Sanguineti, ivi, id., 2004; Panzini = A. Panzini, Dizionario moderno, Milano, Hoepli, 1942; DeI = C. Battisti-G. Alessio, Dizionario etimologico italiano, firenze, Barbra, 1950-1957; GRADIT = Grande Dizionario Italiano delluso, ideato e diretto da T. De Mauro, Torino, Utet, 20072; Zingarelli = Lo Zingarelli 2008. Vocabolario della lingua italiana, Bologna, Zanichelli, 2007; Devoto Oli = G. Devoto-G.C. Oli, Il Devoto-oli 2008. Vocabolario della lingua italiana, a cura di L. Serianni e M. Trifone, firenze, Le Monnier, 2007; Sabatini Coletti = Il sabatini Coletti. Diziona-rio della lingua italiana 2008, di F. Sabatini e V. Coletti, firenze, Sansoni, 2007.
21. Oltre a esclamare continuamente All nonsense! (in un caso: What a positive token of nonsense! ), il Mylord considera a very nonsensical petulancy la disinvoltura con cui le signore milanesi straparlano di classico e di romantico: amereste voi che la prediletta del vostro cuore fosse una delle nonsensical creatures, di cui vho parlato? (Il Conciliatore. Foglio scientifico-letterario, a cura di V. Branca, firenze, Le Monnier, 1965, vol. i pp. 62-70).
-
il nonsoch del nonsenso
17
cuni limerick di Lear nella versione italiana della londinese The Childrens encyclopaedia (Lenciclopedia dei ragazzi, Milano, Cogliati),22 li fa precedere da una presentazione (intitolata Le sciocchezze di edoardo Lear), in cui i nonsense sono definiti ciuccherie . Anche la prima traduzione integrale (a cura di Carlo Izzo, Vicenza, Il Pellicano, 1946, e in ristampa, Venezia, Neri Pozza, 1954) esce con il titolo Il libro delle follie, che solo nel 1970 di-venter Il libro dei nonsense (Torino, Einaudi; la nuova traduzione di Otta-vio fatca, ivi, id., 2002, sintitola Limericks). Lo stesso Izzo, tuttavia, aveva pubblicato nel 1935 il testo di una sua conferenza (Lumorismo alla luce del Book of nonsense, cit.) in cui nonsense (sempre tra virgolette) utiliz-zato in diversi contesti e con diverse funzioni23 (di nonsense stavolta in corsivo si parla anche nella sua postfazione alla traduzione del 46), mentre al nonsense verse (ancora in corsivo) accennava gi Mario Praz in suo articolo del 38.24
Il vocabolo inglese nonsense penetra in tempi diversi nelle grandi lin-gue di cultura europee, nelle quali oggi mantiene spesso proprio per il suo riferirsi a una specifica categoria letteraria una certa autonomia rispetto agli adattamenti e ai calchi sviluppatisi in precedenza (fr. nonsens, it. nonsenso, ma anche ted. Unsinn, sp. sinsentido).25 Solo che questa catego-ria, nelle diverse tradizioni di studi, ha finito con lespandere sempre di pi i suoi confini, fino a inglobare territori un tempo dominio della reto-rica tradizionale come il paradosso, lossimoro, ladunaton.26 Il risultato
22. Per la storia della ricezione di Lear in Italia, cfr. P. Rinaldi, Un girotondo intorno al limerick, postfaz. a M. Manfredi e M. Trucco, Il libro dei limerick, Milano, Vallardi, 1994, pp. 143-246, con bibliografia ivi citata (sullenciclopedia dei ragazzi, le pp. 196-204).
23. Tra le altre: la letteratura del nonsense, del non-senso, dellassurdo (p. 213); il nonsense schietto umorismo? (ibid.); risibile: un nonsense (p. 217); addito nel nonsense il sale di cui sarebbe condito lumorismo (p. 218).
24. La Stampa , 4 giugno 1938; poi in M. Praz, Motivi e figure, Torino, Einaudi, 1945, pp. 92-95, a p. 93.
25. Ad es., in German scholarship on the subject, a useful distinction is made betwe-en Unsinn (in Hildebrandts terms: folk and ornamental nonsense) and nonsense (literary or pure nonsense) (W. Tigges, An anatomy of literary nonsense, Amsterdam, Rodopi, 1988, p. 18).
26. Sulla fortuna antica e moderna di queste figure, cfr. G. Cocchiara, Il mondo alla rovescia, Torino, Boringhieri, 1963.
-
giuseppe antonelli
18
a tuttoggi lestendersi di una periferia (il near-nonsense, come lo chiama Heyman)27 sempre pi affollata di satelliti circanonsensical .28
Una delle cause di questa situazione andr ricercata nella sproporzio-ne fra gli studi dedicati alla dimensione anacronica del nonsense (per usare la terminologia di Lecercle)29 e quelli che ne hanno indagato la dimensione diacronica. Pi che dedicarsi alla ricerca di anelli di congiun-zione (nel tempo e nello spazio) che potessero dimostrare lo sviluppo di una tradizione con alcuni elementi condivisi, come ad esempio fonti co-mu ni,30 ci si impegnati in uno strenuo tentativo di classificazione del nonsense come nozione universale (senza spazio e senza tempo). Per giu-dicare leventuale corrispondenza al profilo tracciato, si sono poi calate queste definizioni nella storicit dei singoli prodotti: il momento indut-tivo ha finito cos per prevalere su quello deduttivo e leffetto paradossa-le in un continuo gioco di agnizioni e disconoscimenti stato quello di sfumare i confini della categoria proprio mentre si cercava di circoscri-verla con maggiore precisione ( unfortunately, there are as many defini-tions of sense, nonsense, and literary nonsense as there are critics ).31
Un secolo di questi sforzi si trova magistralmente riassunto nel primo capitolo del cruciale lavoro di Tigges32 e, in maniera meno sistematica ma non meno efficace, nella tesi di dottorato di Heyman, premessa indi-spensabile per la sua introduzione a The Tenth Rasa33 intitolata An Indian nonsense naissance.
27. Heyman, Isles of Boshen, cit., p. 1.28. Vd. il saggio di A. Afribo, infra, p. 000.29. J.J. Lecercle, Philosophy of nonsense. The Intuitions of Victorian nonsense Literature,
London, Routledge, 1994, p. 2.30. Incontrando in una poesia di Scialoja la gazza fragorosa / che fa gli stridi in greco ,
Serianni riporta infra (p. 000) una segnalazione di Zaccarello e Crimi che riguarda un precedente burchiellesco ( et una gazza che parlava in greco , xviii). Anche io devo a Crimi lindicazione di alcune analogie tra Lear e Burchiello; tra queste, limmagine degli uccelli che studiano: There was an Old Person of Hove, / Who frequented the depths of a grove; / Where he studied his Books, / With the Wrens and the Rooks ; cfr. e le civette studiano in gramatica (viii 17 delled. Zaccarello).
31. Heyman, Isles of Boshen, cit., p. 203.32. An anatomy of literary nonsense, cit., pp. 47-88.33. The Tenth Rasa. An Anthology of Indian nonsense, ed. by M. Heyman, S. Satpathy and
A. Ravishankar, New Delhi, Penguin, 2007.
-
il nonsoch del nonsenso
19
4. La rinascenza del nonsenso
Questa tradizione di studi si fondata soprattutto su testi dellarea an-glofona (in seconda e terza battuta francofona e germanofona), riser-vando scarsa attenzione almeno fino a qualche tempo fa al filone nonsenselike della letteratura italiana e al suo contributo nel formarsi del nonsense propriamente detto. Il riferimento in primo luogo alla cosid-detta funzione-Burchiello . Come dimostra con dovizia di riscontri te-stuali un recente libro di Giuseppe Crimi,34 quel modello (solo in parte riconducibile a precedenti medievali) influenz profondamente la poe-sia rinascimentale italiana: bastino i nomi di Luigi Pulci, di Lorenzo de Medici e appunto del Berni tanto caro al Baretti. Di certo quel modello giunse anche, direttamente o indirettamente, alle altre letterature euro-pee.
La fortuna del Burchiello fuori dItalia un tema che a quanto mi risulta aspetta ancora di essere esplorato sistematicamente. Noel Mal-colm,35 tuttavia, ritiene che John Hoskyns (liniziatore del filone nonsense della letteratura inglese secentesca) dovesse avere ben presente quel mo-dello:
the widespread popularity and frequent reprintings of Burchiellos verses thou-ghout the sixteenth century make him and his well-known imitators, such as Croce by far the most likely model for Hoskynss own poem; so too does the very Burchiellesque density of absolute nonsense which Hoskyns achieved. The case of transmission from Italy to England is very strong, although direct proof is lacking.
Quanto alla francia, Zaccarello segnala levidente presenza del Bur-chiello in alcuni componimenti di Mellin de Saint Gelais;36 per la Spa-
34. G. Crimi, Loscura lingua e il parlar sottile. Tradizione e fortuna del Burchiello, Manziana, Vecchiarelli, 2005.
35. The origins of english nonsense, London, fontana-H. Collins, 1997, pp. 76-77.36. Cfr. L. Spitzer, Zur nachwirkung von Burchiellos Priameldichtung, in Zeitschrift fr
Romanische Philologie , lii 1932, pp. 484-89 (si tratta del sonetto In ny a tant de barques en Venise di Mellin, che con no tiene tanta miel tica hermosa di Lope citato come esempio di Priameldichtung mutuata da Burchiello, son. lxvi, non tanti babbion nel mantovano. Cen-ni sulla fortuna del Burchiello in francia si trovano inoltre in J. Vianey, La part de limita-
-
giuseppe antonelli
20
gna, Spitzer aveva gi indicato calchi burchielleschi in Lope de Vega e pi di recente uno studio di Adrienne Laskier Martn riconosce che
the pre-Cervantine burlesque sonnet in Spain still operates clearly within the Renaissance tradition of imitatio; the Spanish comic poets of this period remain closely tied to their Italian models. The types of comicity in which they indulge are those popularized by the classical and by the Italian burlesque sonnet tradi-tion: anti-Petrarchism, eroticism, burlesque Anacreontic themes, adoxography, facetiae, and the beginnings of personal and professional invective. While se-rious Renaissance poets continue to look to Petrarch and Garcilaso for their inspiration, comic poets still look to the comic hyperbole of Berni and his followers.37
Posto fuori del suo contesto originario, il senso preciso dei sonetti alla burchia era cos opaco da risultare oscuro gi ai commentatori cinque-centeschi (come il Lasca) e poi a fortiori a quelli secenteschi (come il Cinelli Calvoli) e primosettecenteschi (come il Salvini).38 Inevitabile, anche per questo, che nella tradizione dei testi sincrostassero lezioni sempre pi divergenti rispetto alla vulgata quattrocentesca, solo da poco restituita dalledizione critica di Michelangelo Zaccarello.39 fino a que-sta edizione e da oltre due secoli il testo di riferimento era rappresen-tato, com noto, da una raccolta pubblicata nel 1757 a Livorno con la falsa indicazione di Londra.40 In quegli anni, i versi del Burchiello veni-
tion dans les Regrets, in Bullettin italien , iv 1904, fasc. 1 pp. 30-48; P. Toldo, tudes sur la poesie burlesque franaise de la Renaissance, in Zeitschrift fr romanische Philologie , xxv 1901, fasc. v pp. 71-93, 257-77, 385-410, 513-32, e Id., Ce que scarron doit aux auteurs burlesques dItalie, Pavia, fusi, 1893.
37. A. Laskier Martn, Cervantes and the Burlesque sonnet, Berkeley-Los Angeles-Ox-ford, Univ. of California Press, 1991 (content.cdlib.org/xtf/view?docId=ft4870069m&brand=eschol).
38. Cfr. M. Zaccarello, La dimensione vernacolare nel lessico dei sonetti di Burchiello, in Cuadernos de filologa Italiana , 3 1996, pp. 209-19 (www.ucm.es/BUCM/revistas/fll/11339527/articulos/CfIT9696110209A.PDf), alle pp. 209-11.
39. sonetti del Burchiello, ed. critica della vulgata quattrocentesca, Bologna, Commissio-ne per i testi di lingua, 2000; poi, con ampio commento, I sonetti del Burchiello, a cura di M. Zaccarello, Torino, Einaudi, 2004.
40. sonetti del Burchiello del Bellincioni e daltri poeti fiorentini alla burchiellesca, London [ma Livorno, Masi] 1757: cfr. M. Berisso, La poesia del Quattrocento, in storia della letteratura ita-
-
il nonsoch del nonsenso
21
vano considerati alla stregua delle stravaganze dun ubbriaco ;41 quello che nella Londra reale era il nonsense, nella Londra immaginaria diventa-va un insieme di corbellerie.42 N le cose sarebbero cambiate per tutto il secolo successivo: anzi, ancora alla met del Novecento c chi continua a parlare di un faticoso e noioso accumularsi di stupidaggini idiote e goffe .43
Al di l del riconosciuto carattere enigmatico di buona parte dellope-ra di Burchiello , scrive Zaccarello, lo scacco esegetico palesato dalla critica anche in anni pi recenti da ricondursi a un problema di stori-cizzazione: al momento della ricezione moderna del testo, [] il ri-schio la mancata contestualizzazione del dato espressivo, se non la perdita o lappiattimento di una prospettiva storico-linguistica .44 Sulla stessa linea anche Danilo Poggiogalli che, in apertura di un suo recen-te saggio, ricostruisce il lungo dibattito tra chi di quei sonetti ha cercato il senso e chi invece ha preferito attribuirli al nonsenso: per parte sua, quello burchiellesco un non-sense fittizio, cio solo superficiale e appa-rente, elaborato mediante una tecnica combinatoria razionale, decrip-tabile .45 Secondo Crimi, daltra parte, il rubricare questa poesia come nonsense ha rappresentato spesso una soluzione di comodo, visto che letichetta di non senso [] permette di congedarsi con facilit senza sforzi dallargomento .46
Insomma: i filologi (almeno quelli italiani) sembrano oggi piuttosto compatti nel negare che allepoca di Burchiello o addirittura prima si potessero dare casi di nonsense volontario , mostrandosi convinti (co-me nota Berisso, infra, p. 000) che le zone di oscurit pi o meno ampia presenti in determinati testi siano da attribuire a difficolt interpretative
liana, dir. E. Malato, vol. x. La tradizione dei testi, coord. C. Ciociola, Roma, Salerno Editrice, 2001, pp. 493-544, alle pp. 524-26.
41. Saverio Bettinelli (in Crimi, Loscura lingua, cit., p. iv).42. Cos Baretti traduce nonsense nel suo A Dictionary of the english and Italian Languages,
London, C. Hitch and L. Hawes et al., 1760.43. Previtera, La poesia giocosa, cit., vol. i p. 261.44. Zaccarello, La dimensione vernacolare, cit., p. 209.45. D. Poggiogalli, Dalle acque ai nicchi. Appunti sulla lingua burchiellesca, in Studi di
lessicografia italiana , xx 2003, pp. 65-126, alle pp. 66-71; la citaz. da p. 71.46. Crimi, Loscura lingua, cit., p. iv.
-
giuseppe antonelli
22
dovute al gap storico-culturale . Ma quanto di questo rifiuto, si chiede lo stesso Berisso, legato a una particolare forma mentis? Quanto al deside-rio di mantenere linterpretazione nellmbito delle proprie competen-ze? Si potrebbe rispondere che la sfida esegetica avr sempre bisogno di un senso da trovare e i vuoti di senso tenderanno sempre a essere satura-ti dallinterpretazione. Solo, altre scuole critiche reagiscono in modo di-verso allhorror vacui: vale a dire cercando un senso a posteriori che spesso consiste in un meta-senso.
Anche rimanendo allinterno della letteratura, si dovranno distingue-re allora due nonsense diversi tra loro: da una parte, il nonsense filosofico dello strutturalismo, del decostruzionismo, della psicanalisi, ecc.; dallal-tra, il (non)nonsense filologico della tradizione storicistica. Ci che nel primo va letto come il rimosso , ad esempio, nel secondo andr ascritto al represso ;47 ci che per gli uni si spiega ricorrendo a definizioni ana-cronistiche come scrittura automatica o fantasia diluita di alcuni in-consci collettivi ,48 per gli altri pu essere compreso solo rifacendosi al contesto linguistico e culturale in cui i testi sono stati prodotti.
5. Il suono del nonsenso
Loscurit nasce spesso dalla frantumazione del testo,49 che ha leffetto dindebolire anche il significato delle singole parole: come nota Zacca-rello, the text progresses through strategies of verbal association, such as wordplay, and the interconnecting elements seem to be predominan-
47. Ci sono buonissime ragioni culturali per sostenere che determinati temi di ordine sessuale, soprattutto quelli relativi a pratiche ritenute degne addirittura di condanna pe-nale (come la sodomia, etero ed omosessuale), potessero essere espressi solo attraverso la creazione di una sorta di codice cifrato il quale, una volta organizzato in un testo, finiva con loriginare evidentemente un nonsense anche se solo apparente (Crimi, loc. cit.). Il riferimento al discusso lavoro di J. Toscan, Le carnaval du langage. Le lexique rotique des potes de lquivoque de Burchiello Marino (XVe-XVIIe sicles), 4 voll., Lille, Presses Univ. de Lille iii, 1981; cfr. infra il contributo di Carla Chiummo.
48. Cfr. Molle, oscurit e straniamento, cit., p. 140.49. Nel caso di Sacchetti, lautore stesso specifica come il sonetto sia stato costruito
per motti, cio montato in modo che prevalga il gusto per le parole, per le locuzioni e per le espressioni singolari (Crimi, Loscura lingua, cit., p. 172).
-
il nonsoch del nonsenso
23
tly formal and non-semantic (mainly of a rhythmic and phonic kind); moreover, such texts often escape the logical concatenation that charac-terizes poetry with traditional content .50 Linsignificanza (vera o pre-sunta) esalta quella che Gian Luigi Beccaria chiamava lautonomia del significante ,51 tanto da aprire le porte a significanti dal significato evane-scente, come le parole inventate52 o nei casi pi estremi a sequenze di significanti irrelati, come quelli delle lingue inventate.53
Lo scivolamento dal piano fonematico a quello puramente fonetico rende il suono del nonsense una sorta di mantra che acquista un suo senso grazie alla rigida (a volte rigorosa) messa in forma; come osserva Lecer-cle, there is an excess of phonetic rules in nonsense: rules of phonotac-tics, of accentuation, of prosody and metrics .54 E qualcosa di analogo avviene anche sul piano della testualit: in Scialoja ancora frequente un procedimento, ampiamente praticato gi dal Burchiello, per il quale la perdita di coerenza si accompagna a un forte aumento degli indicatori della coesione testuale, cio dei connettivi tipici di un discorso organiz-zato razionalmente (Serianni, infra, p. 000). questa, in fondo, la diffe-renza con le parole degli ubriachi, che di solito non solo non hanno senso, ma non fanno vista di averlo: condizione necessaria in un libro stampato .55
Piacere del significante pu significare nelleccesso forma senza contenuto, affabulazione senza fabula, mutilazione zoppa del bicipite se-
50. Zaccarello, off the Paths of Common sense, cit., p. 93.51. G.L. Beccaria, Lautonomia del significante. Figure del ritmo e della sintassi. Dante, Pascoli,
DAnnunzio, Torino, Einaudi, 1975.52. Come accade, ad esempio, nelle Fnfole di fosco Maraini: Il lonfo non vaterca n
gluisce / e molto raramente barigatta, / ma quando soffia il bego a bisce bisce / sdilenca un poco, e gnagio sarchipatta (cfr. D. Baglioni, Poesia metasemantica o perisemantica? La lingua delle Fnfole di Fosco Maraini, in studi linguistici per Luca serianni, a cura di V. Della Valle e P. Trifone, Roma, Salerno Editrice, 2007, pp. 469-80).
53. Nel Dialogo dei massimi sistemi di Landolfi, ad esempio, il protagonista ha scritto una poesia in una lingua sconosciuta, da lui stesso dimenticata: Aga magra difra natun gua mescin / Snit guggrnis soe-wli trussn garigr / Gnga bandra kuttvol jers-ni gillra. / Lvi girrscen suttrer lunabinitr (cfr. infra il contributo di Baglioni).
54. Lecercle, Philosophy of nonsense, cit., p. 38.55. Come nota Manzoni a proposito dei discorsi di Renzo ubriaco (A. Manzoni, I
Promessi sposi, a cura di L. Caretti, Torino, Einaudi, 1971, vol. ii p. 339).
-
giuseppe antonelli
24
gno linguistico, corpulenza senzanima; ma anche, e converso, ludico e lucido calembour capace di sprigionare concetti originali, gioco coi topoi che fa della lingua il luogo delentropia. A partire almeno dal nonsense vittoriano, significa contestare la rappresentazione realistica della realt per creare una realt diversa (il nonsense non figurativo: nella sua forma pi pura , potremmo dire, astratto). A questobiettivo risponde una scrittura che per certi versi lequivalente letterario delle geometrie non euclidee o anche di quella logica onirica a cui Ignacio Matte Blanco dar lantiaristotelico nome di logica simmetrica.
6. Il dissenso del nonsenso
La dissimulazione del dionisiaco sotto mentite spoglie apollinee alla base dellambiguo statuto del nonsense, che is on the whole a conserva-tive-revolutionary genre. It is conservative because deeply respectful of authority in all its forms: rules of grammar, maxius of conversation and of politeness, the authority of the canonical author of the parodied text .56 Questo rispetto esteriore che corrisponde in realt a uno svuo-tamento dallinterno di modelli, codici, canoni accomuna il nonsense ottonovecentesco a precedenti molto pi antichi:
il sonetto alla burchia pu essere descritto come una forma di duplice attacco alla poetica tradizionale, dallinterno e dallesterno: da un lato la peculiare sin-tassi di quei versi sovverte le pi elementari concatenazioni logiche, impiegan-do in modo volutamente incongruo gli operatori sintattici; dallaltro le molte-plici forme di satira del falso sapiente [] collocano la polemica sulla rivendica-zione di un linguaggio concreto.57
La parodia si conferma uno dei tratti costitutivi del genere gi nei suoi pi remoti antecedenti. Prima della dicotomia senso/nonsenso viene quella codice/trasgressione, che si risolve in una resa deformata e stra-
56. Lecercle, Philosophy of nonsense, cit., pp. 2-3.57. Zaccarello, Burchiello e i burchielleschi. Appunti sulla codificazione e sulla fortuna del
sonetto alla burchia, in Gli irregolari nella letteratura. eterodossi parodisti funamboli della parola. Atti del Convegno di Catania, 31 ottobre-2 novembre 2005, Roma, Salerno Editrice, 2007, p. 117-43, a p. 142.
-
il nonsoch del nonsenso
25
volta del primo elemento. Un saggio di qualche anno fa dedicato ad al-cune Considerazioni sul ritratto poetico e la comunicazione lirica era stato sug-gestivamente intitolato da Amedeo Quondam Il naso di Laura;58 la gi citata recensione di Emilio Cecchi a unAntologia burchiellesca del 1950 sintitolava Il naso di Burchiello.59 nasi cornuti e visi digrignati si apre il sonet-to di franco Sacchetti ritenuto il primo esempio di questo genere di poesia (in principio era il naso, dunque) e una galleria di nasi deformi occupa un trittico di sonetti che la tradizione attribuisce al Burchiello;60 queste, rispettivamente, le quartine iniziali:
Io vidi un naso fatto a bottoncini,che paion paternostri di corallo,et ha la cresta rossa comun gallotutta coperta di balasci fini;
Un naso Padovano qui venuto,che si berebbe ottobre, e San Martino;sed egli avesse in suo potenza el vino,berebbe una ricolta con un fiuto.
Se tutti i nasi avessin tanto cuoredi vivere a comune, e fare anziani;i ve ne metterei uno alle mani,che par de nasi natural signore.
Ma il naso del Burchiello potrebbessere anche quello del Burchiello-maschera, il personaggio Burchiello che secondo una sorte toccata molto pi tardi anche a Edward Lear 61 diventa, fin dalla sua morte,
58. Ora in A. Quondam, Il naso di Laura. Lingua e poesia lirica nella tradizione del Classici-smo, Modena, Panini, 1991, pp. 291-328; la domanda , con le parole della Civil conversazio-ne di Stefano Guazzo: per qual cagione Petrarca, nel lodar laltre parti belle di madonna Laura non avesse mai fatto menzione di questa, se forse egli la tacque perchella avesse il naso o schiacciato o camuso o gibbuto o torto o smisurato in grossezza o in lunghezza (p. 293).
59. Poi ripubblicata col titolo Burchiellesca, cit.60. Si cita dalled. Einaudi cit., pp. 290-92. Come specifica Zaccarello nellintroduzione
alled. del 2000, si tratta di testi infiltrati, che attribuzioni pi affidabili assegnano a Barto-lomeo da Lucca; una rubrica indica forse che si tratta di un sottogenere: soneti nasorum.
61. Cfr. www.nonsenselit.org/wordpress/archives/2007/02/13/fictional-edward-lear.
-
giuseppe antonelli
26
licona da affiancare a quella del Petrarca come modello di una poesia di-versa: Petrarca e Burchiello piacevole, / che per sonetti han cotanta me-moria / lun per dir bene e laltro dilettevole .62
Rispetto al senso della poesia laureata, quello della frottola e della ri-meria alla burchia si presenta secondo lindovinata definizione di Rus-sell 63 come un controsenso; allo stesso modo, il nonsense veniva defini-to, nel classico saggio di Strachey, the proper contrary of Sense .64 Il senso del nonsenso potremmo dire allora nel suo essere il versante cattivo del buonsenso. Una modalit (non solo linguistica) che demoli-sce linterpretazione del mondo dominante e condivisa, e su quelle ma-cerie costruisce un mondo rovesciato,65 altro rispetto al senso comune: in un certo modo, un non-luogo referenziale .66
62. Cfr. G. Crimi, Burchiello e le sue metamorfosi: personaggio e maschera, in Auctor/Actor. Il personaggio scrittore nella letteratura italiana. Atti del Convegno di Roma, 16-17 giugno 2005, Roma, Univ. di Roma Sapienza , i.c.s. (www.disp.let.uniroma1.it/fileservices/filesDISP/07_CRIMI.pdf); la citaz., tratta da un manoscritto quattrocentesco, riporta-ta a p. 91.
63. R. Russell, senso, nonsenso e controsenso nella frottola, in Ead., Generi poetici medievali. Modelli e funzioni letterarie, Napoli, Societ Editrice Napoletana, 1982, pp. 147-61.
64. Il testo in www.nonsenselit.org/Lear/pdf/nonsense.pdf (la citaz. a p. 515).65. Cfr. G. Angeli, Il mondo rovesciato, Roma, Bulzoni, 1977. Per il nonsense ante litteram,
il discorso incrocia qui laltro assai complesso e ancor pi vasto del rovesciamento parodico, apotropaico associato alle festivit carnevalesche e ai testi ad esse collegati. Il buonsenso potrebbe cos parallelamente ricondursi alla polarit quaresimale (per lintrec-cio di leggi, costumi, rituali associati a questi due universali del mondo medievale e rina-scimentale: cfr. G. Ciappelli, Carnevale e quaresima, Roma, Edizioni. di Storia e Letteratu-ra, 1997).
66. Molle, oscurit e straniamento, cit., p. 146. Il non-luogo (recente calco dal non-lieu del francese Marc Aug) come il non-compleanno (calco pi vecchio dallun-birthday dellin-glese Lewis Carroll): bella propriet della lingua italiana, massime antica, propriet in mille casi utilissima al dir breve, anzi allevitare un lunghissimo circuito di parole, pro-priet daltronde comune anche al francese (nonchalance, nonchaloir []), allinglese (non-sense, nonsensical ec.) ec., quella di certi negativi, sia nomi, sia verbi, avverbi ec. fatti dal positivo, premessavi la non, congiunta o disgiunta da essa voce (G. Leopardi, Zibaldone di pensieri, 17 ottobre 1826, p. 4223 si cita dalledizione commentata e revisione del testo critico a cura di R. Damiani, Milano, Mondadori, 1997, p. 000).
-
27
Marco Berisso
PREIStoRIA (MAncAtA) dEl nonsense nEllA PoESIA MEdIEvAlE ItAlIAnA
Credo sia prima di tutto necessario premettere qualche parola a spie-gazione del titolo che ho scelto. Quello che volevo suggerire, proprio in via preliminare, che, ponendo come punto di avvio della storia del nonsense in Italia il nome e il caso di Burchiello (come corretto fare), risulta molto difficile poi recuperare una rete pi o meno coerente di testi e autori tale da poter giustificare la gestazione di quellesperienza, una tradizione che a quel nome e a quel caso abbia condotto. In realt, come preciser tra poco, abbiamo gi a disposizione oggi unutile guida alle tracce di una possibile tradizione del nonsense italiano che dai testi del Due-Trecento conduca ai primissimi decenni del Quattrocento, e qual-che altro piccolo elemento ulteriore forse possibile aggiungerlo, o al-meno cercher di farlo. Detto questo, per, nulla di quanto si pu arri-vare a dedurre seguendo questa strada assimilabile a quanto si gi da tempo verificato in territori a noi limitrofi, come quello della poesia oi-tanica con le fatrasies/fatras e le resveries e persino di quella occitana con i devinalhs, dove pure qualche distinguo andrebbe fatto.1
1. Del corpus (non imponente: si veda quanto verr detto tra poco) delle fatrasies e delle fatras abbiamo unottima traduzione italiana, Fatrasies. Fatrasies dArras, Fatrasies di Beauma-noir, Fatras di Watriquet, a cura di D. Musso, Parma, Pratiche, 1993, che si raccomanda anche per la dettagliata Introduzione (pp. 7-34). La bibliografia in merito piuttosto ampia: si vedano almeno P. Bec, La lyrique franaise au Moyen ge (XIIe-XIIe sicles). Contribution a une typologie des genres potiques mdivaux, Paris, Picard, 1977, 2 voll., i pp. 167-83; P. Zumthor, Fatrasie, fatrassiers, in Id., Langue texte nigme, Paris, ditions du Seuil, 1975 (cito dalla trad. it. Lingua testo enigma, Genova, Il Melangolo, 1991, pp. 99-126); P. Uhl, La constellation potique du non-sens au moyen ge. onze tudes sur la posie fatrasique et ses environs, Paris, LHarmattan, 1999; M. Suchet, Les Fatrasies: une exprience de la lecture, mmoire de matrise de Lettres Modernes, cole Normale Suprieure Lettres et Sciences Humaines- Univ. Lumire Lyon ii, a.a. 2003-2004 (consultabile in rete allindirizzo http://perso.ens-lyon.fr/florent.bouchez/myriam.suchet/maitrise.php#htoc60). Sulla resverie (oltre a Bec, La lyrique franaise, cit., pp. 163-66) si tenga conto di G. Angeli, Il mondo rovesciato, Roma, Bulzoni, 1977. Per il devinalh rimane ancor oggi imprescindibile N. Pasero, Devinalh, non senso e
-
marco berisso
28
Anche a questo proposito, comunque, va aperta una breve parentesi. Trascuriamo pure il caso dei devinalhs, che si presenta controverso anche sotto il rispetto della appartenenza o meno di alcuni testi al genere, e restiamo a quello molto pi pacifico delle fatrasies (e fatras) e delle resveries. Il numero dei testi, e soprattutto quello dei testimoni, pertinenti tuttal-tro che cospicuo, come noto: due raccolte di fatrasies, una pi ampia (Fa-trasies dArras, 54 poesie) ed una seconda molto pi esile (Fatrasies di Beau-manoir, 11 poesie), pi una di fatras (Fatras di Watriquet, 30 poesie), tutte e tre a tradizione unica.2 Stessa cosa per quel che riguarda le resveries: sono solo tre i testi riconducibili al genere, ognuno riportato da un solo codi-ce.3 A questo non amplissimo patrimonio si potranno aggiungere le due fatras (seppure a schema anomalo) e la lista di incipit non meglio precisa-bili quanto al genere che sono conservati nelle interpolazioni di Chail-lou de Pesstain al Roman de Fauvel riportate nel manoscritto fr. 146 della Bibliothque Nationale di Parigi (il cosiddetto ms. E).4 Insomma, il qua-dro complessivo che ne deriva sembra suggerirci che ci troviamo di fron-te a testi (e quindi a generi) marginali, anche considerando (e non ele-mento secondario) la data relativamente alta a cui essi possono ricondur-si (tra met e fine XIII secolo per fatrasies e resveries, addirittura primo decennio del XIV per i fatras). certo vero, come dichiara Daniela Mus-so, che questa esiguit [] probabilmente non rispecchia affatto la rea-le diffusione dei due generi [] (e lo stesso discorso vale, ovviamente,
interiorizzazione testuale: osservazioni sui rapporti fra strutture formali e contenuti ideologici nella poesia provenzale, in Cultura Neolatina , xxviii 1968, pp. 1-34, a cui si aggiunga adesso M. Lecco, Gli enigmi del devinalh, in Lenigma. Atti del Seminario di Genova, 23 maggio 2008, a cura di M. Lecco, i.c.s.
2. Per la tradizione testuale delle fatrasies e fatras cfr. la nota informativa in Fatrasies. Fatra-sies dArras, Fatrasies di Beaumanoir, Fatras di Watriquet, cit., pp. 35-38.
3. Cfr. Bec, La lyrique franaise, cit., pp. 164-6, anche per la tradizione manoscritta: i testi in questione sono lanonima e anepigrafa nus ne doit estre jolis, la resverie di Philippe de Beaumanoir en grant esveil sui dun conseil e lanonimo Dit des traverces (tutti pubblicati e tradotti in appendice a Angeli, Il mondo rovesciato, cit., pp. 107-41).
4. Del ms. E del Roman de Fauvel esiste una riproduzione in facsimile: Le Roman de Fauvel in the edition of Mesire Chaillou De Pesstain: a reproduction in facsimile of the complete ma-nuscript Paris, Bibliotheque nationale, Fond Francais 146, a cura di E H. Roesner, F. Avril e N. Freeman Regalado, New York, Broude Brothers, 1990 (il testo del Roman de Fauvel stato pubblicato e tradotto in italiano da M. Lecco, Milano-Trento, Luni, 1998).
-
preistoria del nonsense nella poesia medievale
29
per le resverie) 5 e forse dobbiamo perci ipotizzare un pi ampio patri-monio perduto, magari di diffusione primariamente orale come sembra appunto suggerire la didascalia che introduce i fatras interpolati del Fauvel col suo esplicito riferimento a sotes chanons que [] font le chalivali chantent . per altrettanto vero che casi paralleli dal punto di vista sia dellideologia di riferimento sia dellesecuzione (penso ad esempio ai fa-bliaux) hanno avuto ben altra fortuna e che, insomma, una tale latenza testimoniale e recenziorit cronologica potr ben rispecchiare la margi-nalit pi o meno eretica dei generi di cui stiamo discutendo: generi che, non a caso, verranno in parte addomesticati ( il caso dei fatras) nei secoli successivi. Nulla di paragonabile insomma, per intenderci, alla clamorosa fortuna manoscritta di Burchiello, fortuna che nel suo caso va a compensare la tarda, anche in questo caso, collocazione cronologica del genere. Insomma, la poesia del nonsense non sembra aver avuto uno spazio particolarmente ampio nella mappa dei generi e degli stili dei primi secoli neppure in letterature che, allapparenza, le hanno concesso unudienza ben pi antica della nostra. E va aggiunto, per concludere davvero, che la relativa maggior fama dei generi nonsensical dellantica poesia francese andr forse imputata pi ai recuperi e alle predilezioni novecentesche dei surrealisti che ad una loro effettiva incidenza sul pa-norama letterario medievale.
In Italia, come dicevo, e per riprendere il filo, non comunque possi-bile rinvenire neppure una simile tradizione, residuale forse ma almeno morfologicamente piuttosto compatta e come tale riconoscibile in quan-to genere autonomo. La stessa etichetta con cui comunemente vengono indicate le poesie del nonsense a partire dal Cinquecento, quella cio di poesie alla burchia o alla burchiellesca, indica del resto come pi esplicitamente non si potrebbe desiderare una definizione di ordine an-tonomastico, non formale: e che poi tale primogenitura sia probabil-mente da togliere a Burchiello per essere spostata allindietro di qualche decennio ed essere devoluta allOrcagna (il nipote Mariotto, morto nel 1424, non il ben pi famoso Andrea, di cui non si hanno notizie dopo il 1368) oggi un dato di fatto che per non cambia pi di tanto i termini
5. Fatrasies. Fatrasies dArras, Fatrasies di Beaumanoir, Fatras di Watriquet, cit., p. 8.
-
marco berisso
30
della questione, come si vede, n come ambiente culturale n cronolo-gicamente (siamo sempre insomma nella firenze medicea della prima met del secolo).6 Pu essere interessante, semmai, verificare cosa la tra-dizione critica antica percepisse come assimilabile al gusto alla burchia nel momento in cui essa si allontanava dalla pure gi altamente infida vulgata esplicitamente riconducibile a Burchiello, nel tentativo di recu-perare testi sparsi da ricondurre alla medesima costellazione. Mi riferi-sco, insomma, alla famosa e quasi famigerata stampa pseudo-londinese del 1757 e in particolare alla terza sezione di essa, quella in cui, secondo lesplicita ammissione introduttiva dei curatori, vengono travasati sonet-ti che si sono trovati in altri Testi sotto suo nome .7 Le presenze allotrie, come noto, sono qui molte, e alcune clamorosamente due-trecentesche: notissimo il caso dei due sonetti Bicci novel e Ben so che fosti, conclusivi della tenzone tra Dante e forese, ma non manca addirittura un sonetto, Messer Tortoso, quanto pi ripenso, che riproduce, mutato il destinatario, la dispersa petrarchesca Conte Ricciardo, quanto pi ripenso.8 Un controllo si-stematico rivela altre acquisizioni trecentesche: intanto, topografica-mente lontano dal testo petrarchesco che gli risponde, si trova anche il missivo di Ricciardo il Vecchio Ben che ignorante sia, io pur mi penso.9 Si
6. Per lidentificazione di Orcagna con Mariotto di Nardo di Cione cfr. riassuntiva-mente su tutto F. Bausi, orcagna o Burchiello? (sul sonetto Molti poeti han gi descritto Amore), in Interpres , xiii 1993, pp. 275-93.
7. Cfr. i Sonetti | Del Burchiello | Del Bellincioni | e DAltri Poeti | Fiorentini | Alla Burchiellesca, in Londra [ma Livorno, Masi] 1757: la cit. dalla didascalia intro-duttiva della terza parte, p. 145.
8. Il sonetto presente a p. 153 delled. pseudo-londinese. Cfr. in proposito I sonetti del Burchiello, a cura di M. Zaccarello, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 2000, pp. cx-cxi.
9. Il sonetto a p. 241 delled. pseudo-londinese. Lo si pu leggere in D. Piccini, Un rimatore trecentesco che non c pi: i due conti Ricciardo e lignoto Guido di Bagno, in Studi petrar-cheschi , n.s., xiv 2001, pp. 115-97, a p. 160. Dalle non poche testimonianze del sonetto nella tradizione manoscritta non risulta alcuna attribuzione a Burchiello (cfr. le pp. 127-37) ma la coppia (in ordine inverso rispetto al corretto e con attribuzione al Burchiello del-lanta petrarchesca del dittico) gi nelledizione burchiellesca del 1490 (sonecti del Bur-chiello, s.i.t. ma firenze, Bartolomeo de Libri, 1490), mentre la sostituzione incipitaria di Messer Tortoso a Conte Ricciardo risale al Doni (Rime del Bvrchiello comentate dal Do-ni, Venezia, francesco Marcolini, 1553; cfr. Piccini, Un rimatore trecentesco, cit., p. 192).
-
preistoria del nonsense nella poesia medievale
31
possono trovare poi un rifacimento piuttosto libero (viene rimaneggiato anche lo schema, che passa da ABAB ABAB CDC DEE a ABBA ABBA CDC DCD, ed aggiunta una coda DEE) del sonetto di Niccolo de Rossi La femena ch del tenpo pupilla10 e il sonetto di Ventura Monachi a Giovan-ni frescobaldi Giovanni, io son condotto in terraquatica.11 Procedendo un po avanti con gli anni e verso autori attivi sul finire del secolo XIV, andran-no segnalati cinque sonetti attribuibili con varia attendibilit ad Antonio Pucci, uno conteso tra Burchiello e Niccol Soldanieri12 e la seconda pa-ne ruzzola in terza rima di Nicol Povero, s duramente un sonno mi percosse;13 quindi, passando ai primi decenni del Quattrocento (e dunque ai con-
10. Il sonetto a p. 173 della pseudo-londinese. Per il testo di partenza cfr. F. Brugnolo, Il canzoniere di niccol de Rossi, 2 voll., Padova, Antenore, 1973-1977, vol. i p. 155. Cfr. anche Rimatori del Trecento, a cura di G. Corsi, Torino, Utet, 1969, p. 686, che segnala la presenza del sonetto con attribuzione a Burchiello anche nei mss. Laurenziano XL 48 e Riccardiano 1109. Niccol de Rossi autore che peraltro si presta bene a riscritture: una, particolarmente articolata e trdita da tre codici (i mss. Conventi Soppressi 122 e Redi 184 della Biblioteca Laurenziana e il codice C 43 della Biblioteca Comunale Augusta di Pe rugia), del sonetto A fare una donna bella soprano (per cui cfr. Brugnolo, Il canzoniere di niccol de Rossi, cit., p. 57) segnala M. C. Camboni, sulla fortuna di niccol de Rossi, in Stu-di di filologia italiana , lxiv 2006, pp. 21-31.
11. Il sonetto a p. 228 delled. pseudo-londinese. Lunica edizione integrale di Ventu-ra Monachi (morto nel 1348) sonetti editi ed inediti di ser Ventura Monachi rimatore fiorentino del sec. XIV, a cura di A. Mabellini, Torino-Roma-Milano-firenze-Napoli, Paravia, 1903, tuttaltro che attendibile. Una scelta di sonetti (da cui Giovanni, io son condotto per esclu-so) anche in Rimatori del Trecento, cit. Il sonetto riportato nelledizione burchiellesca comunque di uno dei maggiormente attestati di Ventura (anzi, lunico, visto che il pi diffuso di tutti, se la Fortuna tha fatto signore, non di attribuibilit indiscussa).
12. Si tratta di Posto mho n cuor di dir ci che maviene, a p. 175 della pseudolondinese. Zacca rello, nelleditio minor delle Poesie del Burchiello (Torino, Einaudi, 2004, p. 276) segna-la la non inappuntabile attendibilit dellattribuzione a Burchiello, stante i due soli codici (Riccardiano 1109 e Vaticano Barb. lat. 3917) che riportano il sonetto e ne corroborano linclusione nella vulgata quattrocentesca istituita dalla princeps. Per altro lattribuzione a Niccol si regge anchessa su ununica esplicita didascalia, quella del ms. 1147 della Biblio-teca Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma, di contro alla diffusa adespotia del so-netto (cfr. Rimatori del Trecento, cit., pp. 736-37).
13. alle pp. 177 e sgg. della pseudolondinese. Alla riedizioni dei due capitoli di Nico-l ha atteso nella sua tesi di laurea Vittorio Celotto (tesi specialistica discussa presso lUni-versit di Napoli, a.a. 2008-2009, relatore Andrea Mazzucchi): nel frattempo rimane im-prescindibile E. Levi, niccol Povero, giullare fiorentino, in Id., Poesia di popolo e poesia di corte nel Trecento, Livorno, Giusti, 1915, pp. 79-114 (i testi alle pp. 105-14; gi apparso col titolo Le
-
marco berisso
32
temporanei di Burchiello) ritroviamo parecchie figure dellambiente fiorentino (da Antonio Matteo di Meglio a Anselmo Calderoni a filippo Brunelleschi) non di necessit, per, in contatto diretto col barbiere. In-fine, con clamoroso ma eloquente anacronismo, la silloge pseudo-londi-nese finisce con lincludere anche due sonetti di Luigi Pulci in tenzone con Matteo franco.14 Il quadro che viene fuori di quella che potremo definire la funzione-Burchiello secondo la stampa pseudo-londinese dunque particolarmente variegato. fermiamoci anche ai soli testi due-trecenteschi. Il Niccol de Rossi en travesti, la tenzone Petrarca-conte Ricciardo, i vari Pucci e il conteso Soldanieri rinviano tutti insieme ad un generale gusto per il sonetto gnomico15 che poteva tranquillamente ap-parire ai curatori (e tale era in effetti) come pertinente in pieno alla tem-perie stilistica quattrocentesca ma che non ci riguarda in questa sede specifica. Un po pi vicino risulterebbe invece Ventura Monachi, che col suo sonetto ipertecnico (infatti, come molti dei suoi, interamente costruito su rime sdrucciole) e a tratti involontariamente oscuro rinvia comunque ad un settore ben presente nel Burchiello (e non solo), vale a dire quello dellinvettiva contro popolazioni e citt italiane reputate bar-bare di costumi e spesso anche di lingua (qui ad essere sottoposta a repri-menda Venezia).16 Con lo scambio di sonetti tra Dante e forese, inve-
paneruzzole di nicol Povero (contributo alla storia della poesia giullaresca nel medio evo italiano), in Studi medievali , iii 1908, pp. 81-108).
14. Per i rapporti tra Pulci e Burchiello cfr. G. Crimi, Loscura lingua e il parlar sottile. Tradizione e fortuna del Burchiello, Manziana, Vecchiarelli, 2005, pp. 317-53.
15. Magari espressionisticamente un po pi acceso nel primo testo della sequenza, giusta la tematica misogina: ma dal punto di vista linguistico e stilistico il sonetto subisce dalla versione veneta a quella toscana un evidente depauperamento (stante comunque la gi non eccelsa fattura del testo di partenza). Basti qui a dimostrazione mettere idealmen-te a fronte anche solo la prima quartina derossiana ( La femena ch del tenpo pupilla / le plu parte si trova glotta e ladra; / e quando viene en etate nubilla, / sendo ben puita, alor se tien liadra ) col suo pi tardo remake ( La femina, che del tempo pupilla, / Le pi volte si trova ghiotta, e ladra, / Sendo ben brutta allor si tien leggiadra, / Mentre che giovinezza il fior distilla ).
16. In un altro scambio con Ventura, sar Giovanni a insinuare nel sonetto Due foresette, ser Ventura, bionde 20 che a Pisa [] ogni femmina v per lo ber crespa (cito dalledizio-ne di Ventura che sto allestendo da ormai troppo tempo). Il motivo comunque ben trecentesco e lo si ritrova ad es. in Giovanni Quirini, nei due sonetti Io sum tra gente barba-
-
preistoria del nonsense nella poesia medievale
33
ce, siamo arrivati davvero molto prossimi allarea del nonsense: non in senso stretto, ovviamente, ma in quanto una certa cripticit probabil-mente indotta dal genere tenzone (in cui i due corrispondenti non ne-cessariamente hanno interesse a che le allusioni siano comprensibili an-che, per dir cos, allesterno)17 poteva suggerire il sospetto di una inten-zionale sospensione del significato. Cos ad esempio ai vv. 3-4 e 9-11 del sonetto di Dante ( Gi per la gola tanta rema ha messa / Che a forza gli convien tor dellaltrui / [] / E tal giace per lui nel letto tristo / Per tema non sia preso il Lombolare / Che gli appartien quanto Giuseppe a Cri-sto ) oppure nelle terzine intere del sonetto di forese ( Buon uso ci ha recato, ben tel dico / Che quel ti caric ben di bastone / Colui hai per fratello, o per amico. / Ed il nome ti di delle persone, / Che fanno poca stima del panico; / Dillomi, chi vuo metterlo a ragione ).18 E non sar allora un caso, sia detto di velocissimo passaggio (su questo torner tra poco), che della tenzone Dante-forese sia stata fornita in tempi recenti uninterpretazione (per quanto scarsamente fondata) allinsegna delle-qui vocit linguistica a sfondo (omo-)sessuale, in accordo a quanto accade spesso con testi riconducibili allarea del nonsense. Infine pienamente per-tinente al nostro ambito il capitolo di Nicol Povero, ricetta medica parodizzata la cui aggregabilit, quanto al tema, allambito burchiellesco
re e crudele e sio torno al bel paese di Franchia (cfr. G. Quirini, Rime, a cura di E.M. Duso, Roma-Padova, Antenore, 2002, risp. pp. 78 e 80). Per un parallelo in Burchiello baster citare Crimi, Loscura lingua, cit., p. 22, che ricorda come gli abitanti di Arezzo vengano citati nel corpus in pi di unoccasione per la loro stupidit .
17. Incidentalmente, ma forse non casualmente, si noti come siano proprio i testi in tenzone quelli preferibilmente cooptati nellorganismo della pseudo-londinese dal con-testo due-trecentesco: oltre a Dante-forese e Petrarca-Ricciardo un missivo altrove dotato di risposta (anzi, di pi risposte) anche il sonetto di Ventura.
18. Cito ovviamente dal testo della pseudo-londinese. Il testo critico per molti versi pi lineare (risp.: gi per la gola tanta rob hai messa, / cha forza di convien trre laltrui / [] / E tal giace per lui nel letto tristo, / per tema non sia preso a lo mbo lare, / che gli apartien quanto Giosep a Cristo e Buon uso ci ha recato, ben ti l dico, / che qual ti carica ben di bastone, / colu ha per fratello e per amico. / Il nome ti direi delle persone / che vhanno posto s; ma del panico / mi reca, chi vo metter la ragion : cito da D. Alighieri, Rime, a cura di D. De Robertis, firenze, Edizioni del Galluzzo, 2005, pp. 465-72, edizione commentata che anche revisione del testo critico fissato nelleditio maior firenze, Le Lettere, 2002, 3 voll. in 5 to.).
-
marco berisso
34
stata ampiamente chiarita in questo nostro convegno da Michelangelo Zaccarello (e ancor pi pertinente sarebbe stata laltra, prima, paneruz-zola, non inclusa nella pseudo-londinese).
La chiamata in causa di Nicol mi d finalmente il pretesto per citare quella mappa per i territori del nonsense pre-burchiellesco a cui allude-vo allinizio. Si tratta, come si sar capito, del saggio di Giuseppe Crimi Loscura lingua e il parlar sottile, dedicato appunto, come recita il sottotitolo, alla Tradizione e fortuna del Burchiello.19 Un libro importante e ricco di in-formazioni e analisi (persino troppe, se si vuole, tanto che occorre per-correrlo senza impazienza) e al quale bisogna riconoscere, per quel che riguarda il tema che sto cercando di frequentare, di aver quasi esaurito il discorso. In particolare, i tre capitoli iniziali esaminano minuziosamente le interazioni possibili tra Burchiello e, nellordine, fatrasies e fatras, tradi-zione giocosa mediolatina e volgare, Niccol Povero (appunto) e lopera di franco Sacchetti, incluse per questultimo possibili intersezioni con il Trecentonovelle. Il percorso affrontato da Crimi largamente sottoscrivi-bile: e varr infine la pena di ricordare, per riprendere in mano unultima volta ledizione pseudo-londinese, che il sonetto di Sacchetti nasi cornuti e visi digrignanti, attentamente analizzato in Loscura lingua e tradizional-mente indicato come il pi rilevante precedente della poesia del nonsense, anchesso incluso in quelledizione, anche se (con lapsus di prospettiva che mi pare particolarmente significativo) non nella terza ma nella quar-ta parte, quella dedicata ai sonetti alla burchiellesca di tarda imitazio-ne.20 Un rilievo particolare assume, nella prospettiva di Crimi, il doppio binario dellanalisi, che da un lato si richiama alle tecniche compositive, retoriche e sintattiche, dallaltro scava in un serbatoio metaforico e figu-rativo che sembra ripresentarsi immutato da un secolo allaltro. Proprio a partire da queste premesse mi pare specialmente persuasiva la rivaluta-
19. Cfr. sopra, n. 14.20. Il lapsus insomma fa coppia con quello prima segnalato, e di segno inverso, circa
Luigi Pulci arretrato cronologicamente a ridosso di Burchiello, a conferma dellappiatti-mento generale di prospettiva che sottende alledizione pseudo-londinese e di l si propa-ga alla vulgata editoriale e interpretativa per lungo tempo. Sul sonetto di Sacchetti (il testo leggibile in F. Sacchetti, Il libro delle rime, a cura di F. Brambilla Ageno, firenze-Perth, Olschki-Univ. of West Australia Press, 1990) cfr. Crimi, Loscura lingua, cit., pp. 166 sgg.
-
preistoria del nonsense nella poesia medievale
35
zione compiuta dellopera di franco Sacchetti, anche attraverso la messa a sistema degli sparsi rilievi recuperabili nella storia critica sullautore,21 cos da riuscire a raggruppare attorno a nasi cornuti alcuni, seppur non moltissimi, episodi del suo sin troppo ampio Libro delle Rime. E qui apro una velocissima parentesi per esortare ad un rilancio degli studi su que-sto tutto sommato non cos frequentatissimo rimatore, per il quale ab-biamo ottime analisi linguistiche e filologiche che sono per controbi-lanciate da una sostanziale povert sul versante interpretativo e dei rap-porti intertestuali.22
Affermato dunque il ruolo di rilievo che va attribuito a Sacchetti e Niccol Povero (due esperienze poetiche, va aggiunto, fondamental-mente provinciali se non addirittura anguste, che ribadiscono una volta di pi come la preistoria di Burchiello sia, come peraltro la sua storia, in buona sostanza tutta fiorentina), bisogner precisare che lindividuazio-ne di ulteriori tessere per il mosaico incontra, tra gli altri. anche un osta-colo quasi insormontabile in una peculiare condizione psicologica di noi moderni lettori ed esegeti di poesia medievale e che, molto semplice-mente, ci rende difficile o addirittura impossibile ammettere che prima di Burchiello si potessero dare casi di nonsense volontario. Da qui ne con-segue che le zone di oscurit pi o meno ampia presenti in determinati testi sarebbero da attribuire semmai a difficolt interpretative dovute al gap storico-culturale che ci separa dalla poesia dei primi secoli. La stessa ben nota e discussa operazione di Jean Toscan, per non dire di alcune applicazioni condotte a ritroso su testi due e trecenteschi (a cui neppure io mi sono sottratto, anche se spero in maniera sufficientemente cauta),23
21. Cfr. ivi, p. 165 n. 1.22. Basti ricordare che la magistrale ed. cit. di franca Ageno corredata da un com-
mento inappuntabile, certo, ma tuttaltro che ampio e prevalentemente di carattere lin-guistico.
23. Il riferimento ovviamente a J. Toscan, Le carnaval du langage. Le lexique rotique des potes de lquivoque de Burchiello Marino (XV e-XVII e sicles), 4 voll, Lille, Presses Univ. de Lil le iii, 1981. Non rari gli esempi di applicazione del lessico di Toscan alla poesia duecen-tesca, soprattutto da parte di Mauro Cursietti: oltre che sulla tenzone Dante-forese (da lui considerata una falso quattrocentesco, contro ogni evidenza paleografica: cfr. M. Cursietti, La falsa tenzone di Dante con Forese Donati, Anzio, De Rubeis, 1995), lo studioso ha sperimentato il medesimo metodo soprattutto su Cavalcanti, sempre deducendone con-
-
marco berisso
36
forse leggibile anche in questa chiave, come sintomo di un rigetto di fronte alla possibile assenza di un significato logicamente restituibile. Il terreno scivoloso e sicuramente non da attraversare in questa occasio-ne. Va detto che ci sono buonissime e condivisibili ragioni culturali per sostenere che determinati temi di ordine sessuale, soprattutto quelli re-lativi a pratiche ritenute degne addirittura di condanna penale (come la sodomia, etero ed omosessuale), potessero essere espressi solo attraverso la creazione di una sorta di codice cifrato il quale, una volta organizzato in testo, finiva con loriginare evidentemente un nonsense apparente. Non sar un caso, a riprova di questo, che marcate allusioni alla sessualit sia-no rinvenibili in quasi tutti i testi che sino ad oggi sono stati ricondotti alla pratica del nonsense, dalle fatrasies, appunto, sino a Burchiello, ma an-che alle per molti versi analoghe coplas de disparates iberiche. Detto que-sto, per, pretendere di fornire allanagrafe di questo codice linguistico il nome di un padre ed una precisa data di nascita (come pure si credu-to possibile fare) o utilizzare tutto questo come improbabile passepartout per superare difficolt che forse sono insuperabili (perch il significato in quel testo o in quella zona di quel testo , molto semplicemente, sospe-so) sono nel complesso operazioni che a mio avviso eccedono la verosi-miglianza.
In questa chiave possibile indicare almeno un caso notevole in cui lutilizzo dellequivoco linguistico ottiene esiti che ormeggiano molto da vicino il nonsense, ed quello di alcuni sonetti opera di quellenclave di poeti operanti nella Perugia di met Trecento dei quali mi sono occupa-to ormai parecchi anni fa.24 Da quel corpus, in realt tuttaltro che vasto rispetto allinsieme della silloge, mi limito a segnalarvi come esemplare
seguenze di ordine cronologico (cfr. in partic. Id., Una beffa parallela alla falsa Tenzone di Dante con Forese Donati: la berta di Cavalcanti cavalcato, in LAlighieri , xl 1999, pp. 91-110, e Id., I doppi sensi del sonetto se non ti cagia la tua santalena, in La parola del testo , iii 1999, pp. 75-83). Una sistematica interpretazione basata sullequivoco linguistico a sfondo ses-suale stata di recente avanzata da Silvia Buzzetti Gallarati in pi studi sul Rustico filip-pi comico, culminati in una nuova edizione commentata (R. Filippi, sonetti satirici e gioco-si, a cura di S. Buzzatti Gallarati, firenze, Carocci, 2005). Lautoallusione a M. Berisso, La raccolta dei poeti perugini del Vat. Barberiniano lat. 4036. storia della tradizione e cultura poetica di una scuola trecentesca, firenze, Olschki, 2000, in partic. pp. 257-322.
24. Appunto in Berisso, La raccolta dei poeti perugini, cit. Per i testi cfr. Poeti perugini del
-
preistoria del nonsense nella poesia medievale
37
il sonetto di Cecco Nuccoli, Andando per via nova e per via maggio. Che si tratti di un caso eccezionale pure per lepoca e per quel contesto lettera-rio dove certo non mancavano eccessi stilistici segnalato dalla presenza, nel codice che solo lo riporta, il Barb. lat. 4036, di una manicula a margine, una delle due uniche che un lettore ancora trecentesco (forse lo stesso copista) vi ha apposto. Altrettanto indubbia la prossimit al nonsense del testo. In effetti, se anche le tecniche retorico-sintattiche utilizzate da Nuccoli non si avvicinano molto a quelle caratteristiche del sonetto bur-chiellesco, qualche punto di contatto mi pare degno di nota: penso qui soprattutto alluso degli antroponimi e pi ancora di una toponomatica irrazionale che accosta Etiopia e Parigi, fiandra e francia e Galizia.25 Ammessa per la superficie del testo para-burchiellesca, il sonetto An-dando per via nova riceve comunque una luce forse non totale ma neppu-re episodica se lo si legge in chiave di racconto cifrato di una anche due avventure erotico-amorose, magari usufruendo alloccasione proprio del lavoro di Toscan.26 Procedure analoghe a quella da me operata sul sonetto di Nuccoli sono applicabili anche a qualche altro testo di appar-tenenti alla scuola, soprattutto quelli in tenzone (il che ci riporta a quan-to detto in precedenza a proposito di Dante e forese), spesso confer-mando intuizioni critiche gi presenti nella invero non ampia bibliogra-fia su questi autori. Va per aggiunto che la superficie dei sonetti in que-stione non forma mai un intrico di sistematica insensatezza come An-dando per via nova. fa parziale eccezione il sonetto di Cione a Neri Mo-scoli Da po chio foi ne la cit del Tronto, con la risposta (ben pi lineare, al punto che a partire da essa che possibile decifrare almeno in parte il missivo) di Moscoli Ben ve mostra fornito, el vostro conto.27 Anche in que-staltro caso la formulazione nonsensical del testo viene prevalentemente a coagularsi attorno ad una serie di elementi geografici, qui per regio-nalmente congruenti (Tronto, Pugnano, Offida), nonch al campo lessi-
Trecento (Codice Vaticano Barberiniano Latino 4036), a cura di F. Mancini, 2 voll, Perugia, Guerra, 1996-1997.
25. Al proposito cfr. ad es. Crimi, Loscura lingua, cit., pp. 24-25.26. Gli esiti dellesperimento si possono leggere in Berisso, La raccolta poeti perugini,
cit., pp. 257-69.27. Cfr. ivi, pp. 301-9.
-
marco berisso
38
cale della guerra, ben familiare tanto ai frequentatori delle fatrasies quan-to a quelli del sonetto burchiellesco (ma nemmeno paragonabile per ol-tranza duso, sia chiaro). Ancora una volta per il nonsense in realt solo apparente, il segnale codificato che lautore invia al lettore (che spesso un lettore ben determinato, vale a dire il destinatario del sonet-to) per segnalargli lentrata nei territori del linguaggio erotico equivoco. Da tutto quanto detto sin qui, insomma, spero risulti ben evidente che il ricorso ad un lessico cifrato di matrice oscena in concomitanza con un primo livello testuale organizzato intorno al nonsense rinvenibile episo-dicamente anche ben prima del Quattrocento. Non meraviglieranno, al-lora, le concordanze rinvenute da Crimi tra Burchiello e lautore che pi sistematicamente ha praticato lequivoco linguistico, Stefano fininguer-ri, se le si interpreta come tracce di una relazione pi ampia e forse in parte ancora da indagare.28 Nello stesso tempo, per, non dobbiamo di-menticarci che nel caso dei poeti perugini ci troviamo di fronte ad un contesto socio-culturale molto particolare, ad un gruppo di poeti che condividono il medesimo milieu sociale e politico e che, per di pi, af-fiancano a complessivamente pochi sonetti di questo tipo altri sonetti comici in senso pi tradizionale (oltre, va aggiunto, ad una strabordante quantit di testi lirici). Insomma, sono appunto casi eccezionali. Altro conto sar dunque estendere la toscanizzazione (mi si permette il gioco di parole, che per non va lontano dal vero, per la magica virt che tal-volta i giochi di parole hanno) a testi che non rispondono a queste carat-teristiche socio-culturali o ad interi corpora testuali.
Per tornare al punto lasciato in sospeso, la resistenza ad ammettere che anche prima del Burchiello vi sia la possibilit di organismi testuali allinsegna del nonsense, come dicevo, comunque fortissima. Vorrei fare un caso recentemente tornato in discussione, quello del Pataffio, per il quale federico Della Corte ha avanzato di recente la candidatura alla paternit di franco Sacchetti, rovesciando (a mio avviso in modo con-vincente) linterpretazione delle concordanze lessicali e stilistiche tra il poeta fiorentino e lautore del poemetto che la tradizione critica aveva gi indicato, salvo vedere nel secondo un imitatore/emulatore del pri-
28. Cfr. Crimi, Loscura lingua, cit., pp. 261-316.
-
preistoria del nonsense nella poesia medievale
39
mo.29 Ma la novit pi consistente delloperazione editoriale di Della Corte sta nellaver creduto di potere individuare attraverso il dipanarsi dei dieci capitoli del Pataffio una vera e propria trama, sviluppata nelle forme di unautentica pice teatrale con tanto di scambi di battute. E quando dico trama non eccedo quanto proposto dallo studioso ma ne cito esattamente i termini. Ecco infatti quanto dice Della Corte: Ma se il Pataffio avesse invece una trama e un senso? discontinui e arruffatissimi quanto si vuole, ma li avesse? .30 Prima ancora,31 a rendere ancora pi perspicua lipotesi interpretativa di fondo, veniva fornito uno schemati-co ma ben conseguente plot ( di nuovo un termine usato da Della Corte) per la vicenda. Restituita coerenza alla macrostruttura, loltranza lessicale del poemetto finir per nascondere, secondo lo studioso (o tra-vestir, magari, per sovrappi di carica ludico-grottesca), un triangolo erotico [] con la presenza del seduttore, della donna disponibile 32 che getta ponti altrimenti insospettabili verso il fabliaux e che per, per col-mo di ironia, si dimostra anche e al tempo stesso un preciso camuffa-mento di vicende biografiche sacchettiane, che vedono coinvolti franco, il fratello di lui Giannozzo (anchegli rimatore, come si sa)33 e la moglie
29. Cfr. f. Sacchetti, Il Pataffio, a cura di F. Della Corte, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 2005 (da integrare con il preparatorio F. Della Corte, Proposta di attribu-zione del Pataffio a Franco sacchetti, in filologia e critica , xxviii 2003, pp. 41-69). Sulledi-zione si vedano le recensioni di G. Marrani, in Medioevo romanzo , a. xxxi 2007, pp. 221-25, e di G. Crimi, in Bollettino di italianistica , n. s., v 2008, pp. 144-56. Va sottoline-ato che un netto avvicinamento tra Sacchetti e il poemetto era gi stato effettuato da Roberto Ballerini, prima per cenni nellarticolo R. Ballerini, Rebus di lingua nelle liriche del sacchetti, in Studi e problemi di critica testuale , num. 21 1980, pp. 25-47, poi pi espli-citamente (anche se non proponendo la paternit del fiorentino ma dettagliando la rete delle coincidenze) in Id., Per la fortuna di Franco sacchetti nel Quattrocento: il caso del Pataffio, ivi, num. 25 1982, pp. 5-17.
30. Sacchetti, Il Pataffio, cit., p. xxiv.31. Ivi, pp. xvii-xviii.32. Ivi, p. xxvii.33. Come ricorda Crimi, rec. cit., p. 145, la candidatura di Giannozzo come autore del
Pataffio stata affacciata da D. Puccini, rec. a Della Corte, Proposta di attribuzione, cit., in Lingua nostra , lxvi 2005, pp. 127-28. Delle poesie di Giannozzo abbiamo una recente edizione critica, G. Sacchetti, Rime, a cura di T. Arvigo, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 2005.
-
marco berisso
40
di costui Ghita, al punto da far supporre allo studioso che ci si trovi di fronte al volontario oscuramento del senso di un canovaccio biogra-fico [] ingombrante e imbarazzante .34 Loperazione, sia chiaro, con-dotta da Della Corte con la debita prudenza, molto maggiore di quella che forse potrebbe apparire da questa mia sintesi. Ma resta il fatto che anche in questo caso linterprete moderno, posto di fronte ad un agglo-merato testuale che appare rispondere solo alla logica del puro e sempli-ce accumulo di riboboli linguistici senza preoccupazioni ulteriori, reagi-sce cercando una chiave, magari parziale ma che comunque cerchi di disserrare uno spiraglio di senso.
Sin qui ho parlato di esperienze trecentesche, anzi, prevalentemente tardo-trecentesche: ci si chieder quindi come mai il Duecento sia rima-sto fuori dal discorso. In realt per il XIII secolo il raccolto , se possibile, con ancor meno frutti. Andranno intanto escluse in primo luogo dal no-stro orizzonte le prove di vera e propria enigmistica letteraria ad opera di Guittone e di alcuni altri autori a lui in varia misura riconducibili, perch appunto di enigmi che prevedono una soluzione si tratta.35 Non sembra richiamabile qui neppure il Rustico filippi comico, che pure presenta zone non limpidissime e che ha perci suggerito di recente una lettura, al solito, in chiave equivoco-erotico che ha suscitato resistenze penso condivisibili nella sostanza.36 Allo stesso alveo, e con le stesse p