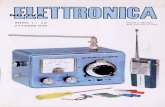N 20130827 LAS 30 T NA CLT 003 - Nuovo Realismo – Il ... · Ma il percorso si legge molto bene...
Transcript of N 20130827 LAS 30 T NA CLT 003 - Nuovo Realismo – Il ... · Ma il percorso si legge molto bene...
U n luogo in cui discuteredi filosofia ha un signi-ficato storico certa-mente importante èElea, l’antica patria di
Parmenide e Zenone, oggi chiama-ta con il nome latino di Velia. Maesiste ancora, davvero, un legametra quel che è oggi la filosofia e quelche poteva iniziare a essere nel-l’epoca degli eleati? Sicuramentesì. E forse il legame non potrebbeessere più stretto, anche non volen-do aderire alle tesi di Martin Hei-degger ed Emanuele Severino, teo-rici del «ritorno a Parmenide».In un senso abbastanza ragione-
vole e forse non difficile da condivi-dere, «filosofia» oggi come sempreè l’arte di trattare alcuni concettifondamentali, trasversali a qualsia-si attività umana, come: realtà (oessere), verità, bene, e i loro deriva-ti e sinonimi. E proprio Elea è il luo-go in cui furono «scoperti» conPar-menide i primi due (essere e veri-tà), e fu scoperta anche, con il suoallievoZenone, la loro grande fragi-lità, e la loro tendenza a scompari-re, o a trasformarsi nel propriocontrario, non appena «urtano» illinguaggio e il senso comune.Nel suo poema Sulla natura, Par-
menide crea in certo modo il vero(tò alethés) e l’essere (tò ón), ma benpresto i suoi seguaci scoprono che
il linguaggio fa strani scherzi, postoa contatto con simili creature, edecco nascere i paradossi di Zenone,e in seguito le molte antinomie deisofisti e dei megarici. Per districar-si tra queste antinomie, diventateestremamente importanti nella vi-ta pubblica democratica, si affer-ma l’insegnamento di Socrate, daallora chiamato «filosofia», inquanto contrapposto alla sofistica.È una narrazione, naturalmen-
te. La vicenda fu senz’altro piùcomplessa. Ma il percorso si leggemolto bene nelle Lezioni di storiadella filosofia di Hegel, in cui emer-ge in tutta chiarezza, per dirla pa-rafrasando Nietzsche: la nascitadella filosofia dallo spirito della de-mocrazia, vale a dire: dallo spiritodella dialettica.Dunque Elea come momento
germinale della razionalità occi-dentale, e del suo gioco di illumina-zioni e ombre. Ma discutere in par-ticolare di verità ed essere è oggil’esercizio più d’attualità che si pos-sa pensare, ai confini dell’ovvio. Co-me sappiamo, i giornali sono pienidi notizie che esplicitamente ri-guardano il vero e il falso, e la diffi-coltà di distinguerli, e i tentativi difar valere o nascondere il primo, o ilsecondo, rispettivamente o alter-nativamente. Perché sia così è faci-le capirlo, se ricordiamo la premes-sa molto semplice: che verità e
menzogna, e i loro contenuti esisten-ti e giusti, o inesistenti e ingiusti,hanno, che lo si voglia o no, un enor-me potere in democrazia, visto cheproprio su di essi si basano le cre-denze individuali e collettive che gui-dano le decisioni pubbliche.Proprio su questo punto però mi
sembra particolarmente importan-te il confronto con Gianni Vattimo,le cui posizioni sono decisamente
Nonci libereremomaidiParmenide
Lascuola eleatica ha creato le nozioni di “verità” e “essere”con cui continuaa confrontarsi la filosofia contemporanea
FRANCA D’AGOSTINI
Parmenide di Elea (515-450 a.C.) è statoil maggiore esponente della scuola
eleatica. Ha sostenuto che la molteplicitàe il divenire sono illusori, e solo l’essere è
verino, che difende una visione «for-te» dell’essere. Ma Vattimo (parla-mentare europeo) non nega che visiano cose, contro cui urtiamo ognigiorno: sarebbe perlomeno strava-gante, da parte di un politico, e spe-cie un politico molto attento a que-stioni di politica «sostantiva», ma-teriale: dalla questione dell’Alta Ve-locità alla questione dei gay e delleminoranze discriminate. Non credodi essere d’accordo con Vattimo sudiversi punti, ma certo è che la suafilosofia non è «antirealista» nelsenso di negare la realtà (o di pensa-re che la realtà sia il prodotto dellamente, o di «schemi concettuali»).D’altra parte, lo scrive con molta
efficacia Pier Aldo Rovatti, che conlui negli anni Ottanta lanciò il «pen-siero debole»: «Realismo? Se signifi-ca giurare che il mondo là fuori esi-ste con quel che ne consegue, mi uni-sco subito al giuramento: non vedoperò in giro nessuno contrario, o an-che solo astenuto», come si legge inInattualità del pensiero debole(Forum, 2011).Il fatto che gli antirealisti in filoso-
fia non esistono veniva segnalatoprecisamente da Parmenide, masembra entrare con difficoltà nellamente di chi discute oggi, specie inItalia, di realismo e antirealismo. E ilfraintendimento si è esteso, pare,ben al di là delle dispute dei filosofi.Persino Luciano Violante, in Politicae menzogna (Einaudi, 2013) occupasvariate pagine a confutare certi an-tirealisti fantasmatici, senza preoc-cuparsi granché di chiarire chi sianoe quali siano le loro ragioni.Ma il fraintendimento è presto
chiarito. Vattimo, se vogliamo, insi-ste sulla «debolezza» non dell’essere,bensì del concetto di essere. La «me-tafisica» di Vattimo (si intenda: lesue idee circa l’essere) è figlia dellametafisica diNietzsche, il quale, con-fermando l’energetismo della suaepoca, vedeva la realtà come enér-gheia, energia. Nietzsche vedeva an-che che fissare il volatile e inarresta-bile movimento della realtà in parolee concetti, che si pretendono dire il
vero e catturare l’esistente, significa«irrigidire» il pensiero, imprigionar-lo in violente «scaffalature concet-tuali» (come scrive inSu verità emen-zogna in senso extramorale).Ora Vattimo toglie dalla visione di
Nietzsche le componenti naturali-stiche (dire come è fatta la realtà perun uomo del Novecento non è com-pito dei filosofi, ma dei fisici), e vi in-serisce la visione heideggeriana edermeneutica dell’essere come tem-po-storia: l’essere di cui discutiamo(non l’essere-realtà) è il diveniremultiforme della tradizione in cui ciriconosciamo. Pretendere di fer-marlo dicendone una verità ultima èun gesto violento (vedasi: la «scaffa-latura concettuale» di cui sopra). Diqui l’idea che nel riconoscere la de-bolezza del concetto di essere (esi-stenza, realtà) vi sia la premessadell’emancipazione dei più deboli,che non dominano le scaffalatureconcettuali (per così dire), e pertan-to sono vittima delle loro menzognepassate per dura verità.Non c’è molto da eccepire a que-
sto quadro. Diceva Nietzsche: «nonvi libererete mai di Dio (del potere)fino a quando siete sudditi dellagrammatica». Vero. Ma il gioco dia-lettico incomincia proprio qui, per-ché come insegna Zenone, nel tenta-tivo di liberarsi della grammatica cisi trova spesso semplicemente inun’altra grammatica.
Nonnega larealtà: insistesulla«debolezza»nondell’essere
bensìdel concettodiessere
L’ANTIREALISMO DI VATTIMO
più zenoniane che parmenidee:stanno dalla parte della fragilità deltò ón e dell’alétheia, e non della loroforza «coraggiosa» (atremés, intre-pida, dice Parmenide). Nel suo ulti-mo libro, Della realtà (Garzanti2012), come in tutte le sue opere,Vattimo sostiene una posizione chesi può dire «antirealista», ma occor-re intendersi. È vero che la filosofiadi Vattimo differisce da quella di Se-
I giornali sonopienidinotiziecheriguardano il veroe il falso
e ladifficoltàdidistinguerli
UN PROBLEMA ATTUALE